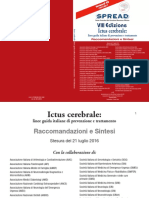Professional Documents
Culture Documents
Storia
Storia
Uploaded by
elastomania0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views5 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views5 pagesStoria
Storia
Uploaded by
elastomaniaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 5
IL CANTO
GREGORIANO
Breve storia,
teoria e pratica
acura di
Simonetta Urban
EDIZIONT URBAN
DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE,
SIGNIFICATO ESTETICO E STORICO DEL
CANTO GREGORIANO,
on la designazione di Canto Gr
( tende tutto il complesso della musica fiorita
dutante il Medioevo in seno alla Chiesa, dalle
origini del cristianesimo fino all umanesimo.
Occorre sottolineare innanzitutto che il Gregoriano
canto, e non musica, poiché non esiste e non vive se
za il legame col testo: esso nasce infatti dai testi che
accompagnano i ritiliturgici della Chiesa, trasmetten-
do loro nuova forza espressiva.
i Canto Gregoriano @ essenzialmente preghiera canta-
ta, poiché la melodia viene utilizzata nella maggior
parte dei casi per onora-
re la stessa Parola di Dio,
n particolare quella dei
Salmi; le tematiche dei
testi Sono quelle della
preghiera: la lode, il rin-
graziamento, la supplica
Caratteristica fondamer
tale del Canto Gregoria-
no @ il suo essere canto
monodico, cide eseguito
all'unisono. Questo can-
to segue il ritmo della
parola, appoggiandosi
leggermente sui suoi a
centi tonici e smorzando-
si col finire della frase.
Esso nasce su un testo latino in prosa,
enza sostegno
e accompagnamento di nessuno strumento musicale.
Per comprendere bene la natura del Gregoriano occor-
re ricordare la sua origine pratica: la necessita di un
canto facile, eseguibile da masse di fedeli, ne determi-
na alcune caratteristiche salienti, come il breve ambito
entro cui si sviluppano le melodie e la modestia degli
intervalli, che raramente si allontanano dai comuni
mutamenti di tono e di registro della voce umana. An
che il ritmo & subordinato alle leggi della parola parla~
ta, e non dipende quindi da uno schema preordinato;
cosa che iniziera a verificarsi con il sorgere della po-
a ritmico preordi:
nato @ anche testimonianza dell origine orientale del
Canto Gregoriano, il quale “ondeggia mollemente co-
me una decorazione che si genera da se stessa all/infi-
nito” (Mila): come vedremo pitt avanti, infatt, la Chie-
sa, nei primi secoli, essendo legata alle Chiese orienta-
li, soprattutto a quelle greche, ne adotta la lin
probabilmente anche i canti
Tutte le caratteristiche del Canto Gregor
mo accennato, suggeriscono idea di una espressione
musicale volutamente priva
di inutili orpelli et artifi
contrassegnata da una sol
ne semplicita. Infatti esso
prevede solamente il minimo
di musica dopo la parola nu-
da, la quale, come abbiamo
visto, non si lascia subord:
rare alla melodia, anzi fa si
che quest’ultima si modelli
sul ritmo della parola stessa
EE proprio in questa essenia-
lita che consiste la grandezza
del Canto Gregoriano: nel
suo ornare la parola con una
melodia immateriale e fluida esso sembra affermare
tuna sua incrollabile unita, divenendo simbolo dell’
nit’ dell’'uomo con se stesso e con Dio.
Nl Canto Gregoriano & quindi l'espressione i un’au-
tentica religiosita, sia perché viene impiegato nei riti
religiosi sia perché maturato attraverso una profon-
da spiritualita ed esperienza vocale di comunicazione
dell uomo con Dio. La Chiesa infatti ha sempre rico-
nosciuto il Gregoriano come il canto pitt adatto per le
celebrazioni liturgiche. A titolo di esempio, la Costitu-
zione Sacrosanctum Concilium (Concilio Vaticano ID,
sulla Liturgia, afferma: “La Chiesa riconosce il canto
fegoriano come canto proprio della liturgia romana:
percid, nelle azioni liturgiche, a parita di condizioni,
gli si riservi il posto principale
Ta Chiesa non solo rivendica la propria paternita su
questo canto, ma si @ anche occupata della pubblica-
zione delle sue melodie, servendosi della Tipografia
Poliglotta Vaticana. L’edizione vaticana delle melodie
gregoriane é detta tipica, perché, sia nella forma e di-
sposizione delle note come nella versione melodica,
costituisce il modello per tutte le eventuali pubblica-
ioni che si sarebbero eseguite a cura di altri editori
Accanto al significato spirituale clel Canto Gregoriano
come canto per eccellenza della Chiesa cattolica, oc-
corte sottolineare anche il suo ruolo storico-culturale.
Sono molte infaiti le ragioni che fanno del gregoriano,
un patrimonio di inestimabile valore per la cultura oc:
cidentale.
Si pensi innanzitutto che i primi dodici secoli di storia
della musica sono quasi esclusivamente segnati da
questo canto monodico, il cui repertorio comprende
Circa tremila melodie di epoche, forme, Iuoghi dV origi
ne differenti. Le altre manifestazioni musicali di questi
lifonia. La mancanza di uno sche
no cui abbia-
SISSIES
secoli, Ia musica religiosa laudistica ¢ la musica
profana trovadorica, di fatto prendono ispirazione
Hitmico-melodica dal gregoriano.
La composizione gregoriana rappresenta inoltre un
modello perfetto di simbiosi testo-melodia, poiché
trae origine dal testo e si attua in diversi generi nel
rispetto dello stile verbale,
Limportanza del Canto Gregoriano da un punto di
ista strettamente musicale ¢ da ravvisarsi nel fatto
che la polifonia nasce e si sviluppa sullo stesso re-
pertorio gregoriano. Il germe della polifonia @ pre-
sente infatti nelle due forme che segnano 'inizio
della decadenza del gregoriano: I’organum", cioe
Finsieme di due canti, il secondo dei quali non @ al-
tro che il primo trasportato una quarta, una quinta
© un‘ottava sopra; il “discanto”, cioe Vinsieme di
due canti, il secondo dei quali contrappunta sul pri-
mo. In questo modo, lentamente, Punisono cede il
posto alla polifonia
IL legame strettissimo con la parola ¢ quindi con la
lingua, veicolo di cultura, trova ulteriore conferma
nei riflessi che 'evoluzione linguistica genera sul
canto gregoriano. La corruzione del latino e il ger-
mogliare delle lingue volgari, la formazione della
poesia ritmica, sono fenomeni linguistici di incaleo-
labile portata, che non si possono disgiumgere da
quest’arte che privilegia la parola. Non & un caso
quindi che il delinearsi delle lingue volgari sia in-
trecciato con il sorgere delle prime esperienze della
polifonia, e che d’altra parte, la corruzione del lati-
no vada di pari passo con la progressiva decacienza
del gregoriano, Si tratta del periodo di trapasso da
una cultura medioevale, cultura di chiesa, e quindi
universale, alle culture moderne, culture nazionali,
dove nella nascita delle lingue volgari si manifesta
Findividualita crescente dei popoli
CENNI STORICI
€ radici pitt profonde al Canto Gregoriano
si spingono fino alle prime comunita cristia~
ne, che per i loro riti religiosi hanno fatto
uso del canto.
Nei Vangeli (Mt. 26,30 e Me. 14,26) si parla di Gesit
Cristo che, insieme agli apostoli canta i salmi tradi-
zionali della Cena pa-
squale: “E dopo aver can-
{ato l'inno, useirono verso.
il Monte degli Ulivi”
S. Paolo (Ef. 5,18) invita i
cristiani ad intrattenersi
tra di loro facendo uso di
“salmi, inni, cantici spiri-
tuali, cantando e inneg-
giando al Signore nostro
Gesii Cristo”
AL IL secolo risale una delle pity importanti testimo-
nianze intorno al canto. Nel De Anima (cap. IX, n.
4) Tertulliano descrive come si svolgeva allora la li
turgia, che viene suddivisa cosi: letture, canto dei
salmi, omelia, orazione. Tale schema diventera il
IRIE
aay
SPERBES
—
so
a
REIS
229%
ce
eSEERE
SISSIES
a
SSESRRISIS SIRNA ISISER IRIN
8s
se
see
OIC
snes
Soe
SSA EERE ESI ESE EOI
So
PERIRELLOBEEB ELBE BE EONS
SISSIES EY
modello per ogni celebrazione liturgica. Poiché le pri-
me comunita cristiane provenivano dall’ambiente
ebraico, con sicurezza i canti della sinagoga si posso-
no considerare all’origine del canto cristiano. E diffici-
le perd sapere in quale misura i canti della tradizione
ebraica abbiano esercitato la loro influenza sul sorgere
dello stesso. Innanzitutto perché fino al sec. IX si pud
disporre solamente della tradizione orale e poi perché
il repertorio tramandatoci si trova ad uno stadio al-
quanto evoluto. II canto liturgico cristiano nasce quin-
di in seno alle prime comunita, ma per la formazione
di tutto il repertorio dei testi della Messa occorte at-
jendere fino al sec. VIIL epoca a cui risale la prima do-
cumentazione scritta del canto gregoriano. Essa com
prende i testi cantati ma non la notazione musicale: il
canto della liturgia cristiana infatti, continua ad essere
praticato e trasmesso attraverso la tradizione orale
X partire dal sec. IX gli stessi testi si trovano nei mano-
scritti sormontati dalia notazione musicale con neumi,
vale a dire segni attia chiarire in forma ancora embrio-
nale certe formule melodiche gia entrate nell uso.
La storia del primo canto cristiano vede un importante
avvenimento: la disgregazione dell’unita liturgica. |
fatti, anche in seguito agli effetti della penetrazione bar-
barica, si crea un certo isolamento delle singole regioni,
che, in seguito alla decadenza dei centri urbani, non
possono contare sti una struttura ecclesiale accentrata.
La distanza delle Chiese tra di loro e dalla Chiesa di
Roma, le esigenze locali e le diverse tradizioni cultura-
Ii sono tutti elementi che favoriscono il sorgere di vari
riti e repertori liturgici: il beneventano, Fambrosiano,
Vaquileiese, il gallicano, il mozarabico, il cetico. Il fio-
rire di riti ¢ canti favorisce tra Valtro lo scambio di te-
anti e festiviti da regione a regione, Nel sec. VIL
con la riforma romano-carolingia, si tenta di ricondur-
re ad unitd i diversi repertori liturgici occidentali
Limperatore Carlo Magno ordina che la liturgia ¢ il
canto romano sostituiscano nel Regno Franco i rito e
il canto gallicano. Ma in Gallia non viene accettata la
completa sostituzione del canto locale con quello ro-
mano; si ha pertanto la fusione dei due repertori
Il risultato di questa fusione @ quello che noi oggi
chiamiamo “canto gregoriano”. La tradizione vuole
che la denominazione ”gregoriano” risalga aS. Grego-
rio Magno (590-604), il quale sarebbe stato Vorganiz~
zatore ¢, addirittura, Pautore stesso di questo canto,
Ma, considerando la questione gregoriana da un pun-
to di vista storico, occorre
precisare che, secondo gli
studi attuali, anche se di
qualche testo 5. Gregorio
potrebbe essere il vero au-
tore, circa la melodia non si
puo affermare nulla, sia
perché a quel tempo non
‘a ancora la notazione
sia perché nessu-
na melodia gregoriana por-
ta il nome di un qualsiasi
autore. Quindi il nome dato
al canto della Chiesa non &
da collegare direttamente a
papa Gregorio, ma deriva dalla liturgia del Sacramen-
{ario gregoriano (libro che contiene i formulari del C
ebrante). Il repertorio dei canti che risulta dalla rifor-
‘ma romano-carolingia, ha quasi lo stesso ordinamento
© calendario liturgico di quello che si trova nel Sacra-
mentario gregoriano. Di qui dunque deriverebbe il
nome “canto gregoriano”,
Un’eceezione all'unificazione romano-carolingia & co-
stituita dal canto Ambrosiano, che rimase in vita nel-
RRS TSIEN IN SEMIN ICTE SE
SSSBBRs
SSSBSISISISISS
SSSRES
SSIS ISSA SI IASI SINS
S98
Soe
SSIES
SagsSaaRSaeEEIatS
SAIS SISES INS ISIAGS ISIS ING
5.
&
Vantica area arcivescovile di Milano, proseguendo il
proprio cammino parallelamente al canto “ufficiale” &
‘mantenendo fino ad ogg la propria autonomia.
Dopo la riforma, una volta completato il repertorio
gregoriano per la liturgia, e perlezionatosi il sistema
di notazione musicale, si assiste (sec. IX) alla ricerca di
nuove creazioni, sia di testi che di forme musicali
Questa esigenza scaturisce dal desiderio di rinnovare ¢
ampliare il repertorio dei cantie di favorire il sorgere di
altri momenti devozionali al di fuori della Mesa v del-
Ufficio. Nascono in questo modo la prosa, la sequen
{adattamento sillabico di un testo ai melismi alleluiati
i), e il tropo (aggiunta di un nuovo testo letterario a
quello gia esistente nella liturgia). In questo periodo
vengono elaborati anche i generi musicali precedenti:
vengono creati la maggior parte degli Alleluja, Antilone
¢ Responsori vari, si sviluppano I'Innario e il Kyriale
Tutte queste melodie, create tra il sec. IX e il sec. XIl
vengono definite post-classiche poiché presentano i
tervalli pitt ampi, giochi e rime melodiche che testi-
moniano gli inizi del tonalismo.
I diffondersi delle nuove forme musicali (tropi,
quenze, prose ecc.) e il sorgere delle prime forme di
polifonia contribuiscono ad accelerare il processo di
decadenza del gregoriano, Infatti, unita dei brani ori-
ginari viene compromessa dalle melodie e dai testi d
opi e delle altre forme musicali. Inoltre, il Canto Gre-
goriano non pud evitare di subire i condizionamenti
recati dalla musica trovadorica ¢ dalla nascente prati-
ca polifonica, nella quale si instaura 'uso di impiegare
Ie melodie gregoriane per elaborazioni contrappunti
stiche. Dal Sec. XVI alla prima meta del XIX sha un
nuovo periodo di decadenza del gregoriano. Ora le
melodie vengono anche mutilate: ne @ un esempio I
ditio medicea (1614-15) del Graduale, ossia del Libro
che contiene i canti della messa per tutto anno eecle-
siastico. In essa i neumi sono interpretati misurata-
mente, non con la liberta di valore.
Ma anche durante i secoli di dominio assoluto dell’edi-
zione medicea (sec. XVII-XIX) vengono create alcune
nuove melodie di stampo gregoriano, come ¥Ordinario,
della Mesa VIII (De Angelis), delle Messe Henri Du
‘Mont, le Antifone mariane, in tono semplice, Alma Re-
demptoris, Ave Regina
Caelorum, Regina Coeli e
Salve Regina.
I lavoro di riscoperta &
di ripristino del canto
gregoriano, per riportarlo
allintegrita originaria, fu
iniziato a meta del secolo
scorso dai monaci bene-
dettini dell'abbazia di So-
mes. Lo studio e il
to dei codici pitt,
i (sece. IX-X) pro-
muove una pitt precisa
interpretazione delle me~
lodie e una pratica esecu-
tiva consona alla loro
semplicita e purezza. II metodo interpretative di So
smes rida al gregoriano la sua qualita primaria, che
consiste nell'essere e nel favorite la preghiera: infatti,
la linea melodica del gregoriano rifiuta tutto cid che
potrebbe distrarre dal raccoglimento.
NOTAZIONE DEL CANTO GREGORIANO.
‘ome & gid stato detto, parlando della sua sto-
ria, il Canto Gregoriano alla sua origine e per
molti secoli, viene praticato e diffuse me-
diante lo strumento della tradizione orale,
E solo a partire dal sec. IX che si trovano dei mano-
scritti con notazione musicale con neumi in campo.
aperto o senza rigo. I neumi, 0 segni musicali, sono di=
sposti liberamente sul testo che doveva essere cantato
(notazione neumatica),
~ Bai wont | “ae 3
/ ‘a
Questa prima notazione deriva dai segni grammaticali
accentazione, che vengono leggermente modificati:
Faccento acuto, grave, circonflesso, anticirconflesso. |
primi due determinano la sillaba accentata (V'acuto)
quella non aecentata (il grave). Il copista, per la fretta
nello scrivere, conserva la forma dell/accento acuto
che divenne un'asta e poi la virgr, ridusse a un punto
Yaceento grave, che poi divenne il punctum, Vaccento
circonilesso e l’anticirconflesso conservarono pitt 0
meno la loro forma e indicavano, il primo due note di-
scendenti, elvis, il secondo due note ascendenti, pes 0
podatus.
Da questi neumi deriveranno tutti gli altri pitt com-
plessi, secondo il quadro riportato pit sot:
LNEUMI
or ie 126
eee emacs! (217 i
sonata | 4 Joule of 2
"s, generata dal circonflesso
Indica die sont discendent
Peso Podatas, generato dall an
strconflesso indica due suomi |!
sseendent
New i te suomi
CClinneus, tre suont discendenti, 0
‘anche pi
Seandicus,
Pees
oni ascendent
Solcus, idem con impulso sul se
#
condo. @
8
w
N
Porectus, tre suomi col secondo
piu basso.
Tors re on a sco pi
SS
SSA g [S| es
endo allre note 2 quest
‘neti fondamentall st hanno |
Fx Rep Subpunetat
Aabbetinento
ui, due note uguali legate, ao fem| id
puna
Cdn cil 6 pruppet, tu =lela
surfs, veo ire noe ugual vi reac]
Ute fa
Lanett com nota fina sae ala az
Nella prima colonna & Faevento ong
stlizzazione secondo la srttura a Sal
Afinitiva lla serttura eclesastica; nella
notazione moderna
io; nella Seconda la sua
quarta Tequivatente in
Tra i secc. X ¢ XI i neumi in campo aperto vengono a
disporsi con pitt perfetta precisione, dapprima attorno
ad una linea immaginaria, poi attorno a una linea tira-
ta.a secco (poi in rosso) che indicava la posizione del
FA, cui segul una seconda linea (generalmente gialla)
per il DO, rendendo pitt semplice Videntificazione
dellintervallo intercorrente tra due note successive;
davanti alle linee vennero poste rispettivamente le let-
tere Ce F, dalle quali derivano le attuali chiavi di DO
FA.
II vero € proprio rigo musicale risale perd solo al sec.
XI, quando Guido d’ Arezzo propose Vadozione del te-
tragramma (rigo di quattro linee).
Nonostante gli inevitabili contrasti iniziali, il sistema
di Guido d’Arezzo a poco a poco si affermera, dando
tun modo sicuro di notazione, i cui effetti per la storia
della musica sono di portata incalcolabil.
L'ultimo periodo evolutivo della notazione del canto
gtegoriano @ dominato dalla notazione quadrata (dai
sece. XII-XIV): que-
st'ultima ha avuto il so-
pravvento su tutte le al-
tre notazioni ed & usata
nelle edizioni tipiche
vaticane.
Per agevolare la lettura
della melodia gregoria-
na attualmente pero si
fa sempre pitt spesso ri-
corso alla notazione
moderna, rotonda ¢ su
pentagramma: @ per
questo motivo che an-
che opera che stiamo
presentando adotta la
notazione suddetta.
Tuttavia, in questa introduzione compariranno anche
accenni riguardanti la notazione quadrata, poiché essa
resta comunque la notazione caratteristica del canto
gregoriano.
GLI OTTO MODI
insieme modale costituito da otto scale, che
danno origine a quattro modi detti autentici e
quattto plagali, in rapporto all’estensione melodica.
Ad ogni modo autentico corrisponde un proprio plagale:
tessi hanno in comune una nota che funge da base e da
conclusione, e che & detta finale: gli autentici hanno
un’estensione melodica di un’ettava sopra la finale:
anche i plagali hanno un‘estensione di un’ottava, ma
partendo da una quarta sotto la finale
L a teoria del Canto Gregoriano é basata su un
(© Eas. Gers 9 8-4 Cara -Bopio 182)
IL RITMO.
I | canto gregoriano ha un ritmo libero. $i trata
infatti di un ritmo oratorio, che non @ scandito
da alcuna forma determinata sia nel suo movie
mento che nella scelta e nell’ordine delle sue parti rit-
miche.
11 fattore ritmico viene determinato da due elementi
fondamentali: la parola e il neuma. Sono la scelta e la
collocazione delle parole a produrre una successione
variata ed armoniosa di cadenze ritmiche. Con la pa-
rola viene determinato il ritmo verbale binario (Dé-us
mets.) ternario (Di-mni-tus..), ec.
Da cid si deduce, come gia stato accennato, che il rit
mo del gregoriano & analogo al ritmo del linguaggio
parlato, che nel nostro caso ¢ il testo sacro. F chiaro,
quindi, che chi si accosta allo studio del canto grego-
riano debba saper leggere correttamente il testo latino,
A questo scopo riportiamo uno specchietio con alcune
avvertenze per la corretta pronuncia della lingua latina:
acs0e silegge € tae,coelo = tue ceo
ch © Christus = Cristis
Ihnonsi prominda "homo
hfmdvevocal ch mbt
i "oT Jesus
k eh Kyrie
ph "£ prophets
tr "throne
Wiseguitoda vocale "i latitia lets
x capt lewexodus = lcs egsodus
(6 tate Some ers: Bear 2
‘Con i neumi* abbiamo poi la vera liberta ritmica-me-
Jodica: ogni neuma pud essere un ritmo binario, terna-
rio, quaternario, ecc., secondo la propria composizio-
ne e struttura, avente la prima nota come arsi di lancio
e Vultima come fesi di riposo; 'insieme di pitt gruppi
neuma-ritmi costituiranno il ritmo composto 0 il grande
ritmo.
Per una corretta emissione del suono del testo occorre
jpostare Ia voce. Cid si pud ottenere con Femissione
appropriata delle vocali econ la pronuncia pronta del-
le consonanti
Il cantore deve poi fare particolare attenzione agli ac-
enti e alle pause, che sono essenzal peri ritmo del
iscOTSO.
+ Per news si intende’ “la sintesi delle note che si trovano su una
sola sila” (E-Cardine, in Prin atmo di Canto Gregorian,
«dk Musica Sacra, Roma, 1970, p. 12). Quindi una @ pha note su una
silaba formano sempre an sold nesima
ILFRASEGGIO
gregoriane 'attenzione non si deve focalizzare
sulle singole parole o note, ma va estesa al
contesto della frase. E in quest’ultima, infatti, che si ha
a completezza del significato del testo. Risulta quindi
importante identificare il fraseggio degli incisi verbo-
melodici, il grande fraseggio della frase letterario-
melodica,
I simboli principali del fraseggio sono:
P er la corretta interpretazione delle melodie
~ il quarto di stanghetta, che indica l'inciso di frase
~ la mezza stanghetta per la semifrase
~ la stanghetta intera per la frase
la doppia stanghetta che chiude il brano.
Per quanto riguarda il significato di questi simboli, ri
cordiamo che la mezza stanghetta va interpretata a se-
conda del contesto del brano in cui si trova. A volte
infatti essa comporta semplicemente una distinzione
anticolazione sillabica) tra i due membri di una frase;
altre volte invece va interpretata come un momento di
pausa, non rigido, ma variabile a seconda del conte-
sto. La stanghetta intera indica nella quasi totalita dei
‘casi una pausa vera e propria
LA CHIRONOMIA
movimenti della mano. Fin dall’antichita, il
“magister scholae”, incaricato dell’insegna-
mento e della direzione dei canti, faceva uso del gesto
chironomico, associava quindi il movimento fisico
della mano a quello del suono, comunicando cosi, in
‘maniera piti espressiva, il ritmo e le sfumature della
melodia.
I compiti della chironomia sono quindi molteplici. Es-
sa infatti, deve esprimere diversi ordini di significat:
= ortine melodico: Vespressivita dellaltezza o bas-
sezza del suono;
= Yordine verbate: i susseguirsi delle silabe toniche o
atone;
= Vordine quantitatioo:
ghe o brevi;
= Yordine intensive: Vavvicendarsi dei suoni forti e
deboli;
~ Yordine ritmico; il susseguirsi di arsi e tesi;
~ Yordine agogico: differenti qualita di movimento
della melodia.
L a chironomia @ arte di dirigere mediante
susseguirsi delle sillabe lun-
CANTIE FORME MUSICALI DEL GREGORIANO
1 Canti e le forme musicali del repertorio gregoriano
appartengono a due grandi categorie:
1) Canti della Mesa:
= canti dell Ordinario (sempre gli stessi in ogni cele-
brazione): Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus
Dei;
= canti del Proprio (diversi per ogni celebrazione,
sono in genere i pitt antichi): Introito, Graduale,
Tratto, Alleluia, Offertorio, Communio;
= recitativi del Celebrante ¢ dei Ministri: Preghiere,
Letture, Prefazio, Pater Noster, ece.
2) Canti dell’Ufficio, preghiera liturgica distribuita
nelle ore della giornata (Mattutino, Lodi, Prima, Ter-
za, Sesta, Nona, Vespro, Compieta);
= Inne, composizione con testo di libera ispirazione
suddivisa in strofe e versi;
~ Antifona, breve composizione che accompagna il Salmo;
= Salmo, di solito eseguito in forma antifonica, ma
anche in forma responsoriale o diretta;
= Canto delle Letture, col sistema del recitativo;
~ Versetto;
~ Responsorio, canto che segue le Letture (in genere &
pitt lungo nel Mattutino rispetto alle altre Ore),
Nello sviluppo dei Canti della Messa ha sempre avuto
it importanza il Proprio nel contesto liturgico.
1 canti che lo compongono, si trovano nell! Ordo Missa
iS. Gregorio (509-604) e non mancano in nessuno dei
codici antichi, mentre le cinque parti dell’Ordinario
non si trovano in essi fino al Mille. II Proprio era sem-
pre cantato dalla “Schola’, e per questo motivo i canti
sono musicalmente pitt elaborati; YOrdinario in prin-
io era cantato da clero e popolo, ¢ quindi i canti
avevano una struttura pid semplice: dopo il Mille la
“schola’ si sostituisce a clero ¢ assemblea nell'esecu-
zione dell Ordinario, e da questo momento i canti sa-
ranno pitt complessi e ornati
Infine, per ragioni pratiche, fOrdinario assumera pitt
importanza del Proprio: i compositor, infatt, preferi-
ranno musicare i canti del primo, che, essendo sempre
uuguali, si eseguivano pitt frequentemente;
invece, presentava minore interesse, poiché i suoi
tisi potevano eseguire solo una volta all'anno.
Le melodie dell’ Ufficio traggono origine dalle piit an
tiche riunioni che le prime comunita cristiane teneva-
no in preparazione alla celebrazione eucaristica della
domenica. I moment di preghiera distribuiti durante
la giornata presero il nome di Vigilia, poiché la dispo-
sizione dei partecipanti era appunto caratterizzata
dallidea di “vigilare”, cio’ di vegliare pregando.
In questo modo il canto diventava la vera e propria
preghiera dei fedeli durante la giomnata: la poesia dei
salmi ben si adattava a questa esigenza, poiché in essa
il popolo vedeva riflessi i suoi stati d’animo e le sue
paure, ma anche la speranza nella divina misericor-
dia. La melodia, come sempre, era sobria, ma nella
suia essenzialita dava risalto al senso intimo delle pax
role ¢ invitava lanimo alla meditazione.
tea) EecherC.ilrine Gregor, Ba. Carrara, Bergan, 15rd Tass
ani Ceara, Vo Le Eas Torre Orta Roma 087
risoreperalietae il Giorno del Signare
'* MISSA ORBIS FACTOR
reseatt in motaione nxn fl da esegire per
Organistae peri Cantor Test nlatin-italano
MISSA DE ANGELIS * MISSA CUM JUBILO.
* CANTI VARI per la Liturgia Domenicale
¥en ama 3 cn pe op + uo
iio tan -Via cae ems ee Ee Mikal Porsche ae
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Tavola Delle Posizioni Del Flauto Traverso PDFDocument1 pageTavola Delle Posizioni Del Flauto Traverso PDFelastomania100% (2)
- Davanti A Questo Amore AccordiDocument1 pageDavanti A Questo Amore AccordielastomaniaNo ratings yet
- Su Ali D'aquilaDocument2 pagesSu Ali D'aquilaStefano Matera100% (1)
- MSX Basic ManualDocument105 pagesMSX Basic Manualelastomania67% (3)
- AroniDocument76 pagesAronielastomaniaNo ratings yet
- Preconio Pasquale 2a ParteDocument1 pagePreconio Pasquale 2a ParteelastomaniaNo ratings yet
- Preconio Pasquale 1a ParteDocument1 pagePreconio Pasquale 1a ParteelastomaniaNo ratings yet
- Preconio PasqualeDocument7 pagesPreconio PasqualeelastomaniaNo ratings yet
- PurificamiDocument1 pagePurificamielastomaniaNo ratings yet
- Santus LecotDocument1 pageSantus LecotelastomaniaNo ratings yet
- Oggi Ti ChiamoDocument1 pageOggi Ti ChiamoelastomaniaNo ratings yet
- Lezione 25Document49 pagesLezione 25elastomaniaNo ratings yet
- Cantate Al Signore - o Luce Radiosa FrisinaDocument2 pagesCantate Al Signore - o Luce Radiosa FrisinaelastomaniaNo ratings yet
- Neurologia UnciniDocument1 pageNeurologia UncinielastomaniaNo ratings yet
- LINEE GUIDA SPREAD 8a EDIZIONE PDFDocument297 pagesLINEE GUIDA SPREAD 8a EDIZIONE PDFAldo HoxhaNo ratings yet
- Antica Eterna DanzaDocument1 pageAntica Eterna DanzaelastomaniaNo ratings yet
- Benedici Il Signore - FrisinaDocument3 pagesBenedici Il Signore - FrisinaAntonino RannoNo ratings yet
- Servo Per AmoreDocument5 pagesServo Per AmoreelastomaniaNo ratings yet
- PROGRAMMA Esame Ortopedia MedicinaDocument2 pagesPROGRAMMA Esame Ortopedia MedicinaelastomaniaNo ratings yet
- Alto e Glorioso DioDocument1 pageAlto e Glorioso DioelastomaniaNo ratings yet
- Struttura Complessa Di NeuroriabilitazioneDocument10 pagesStruttura Complessa Di NeuroriabilitazioneelastomaniaNo ratings yet
- DossologiaDocument1 pageDossologiaelastomaniaNo ratings yet