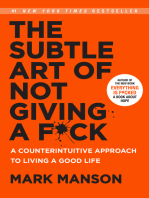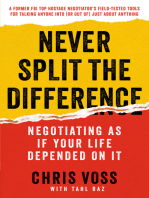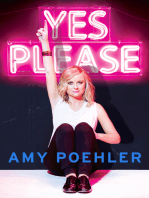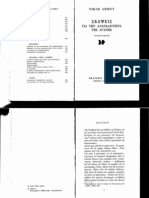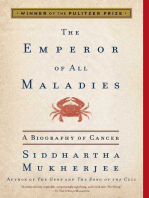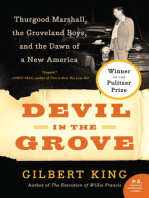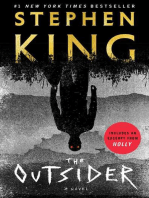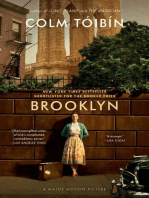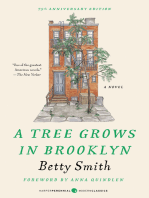Professional Documents
Culture Documents
Anticamera
Uploaded by
chucketti20 ratings0% found this document useful (0 votes)
43 views63 pagesby Erri de Luca
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentby Erri de Luca
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
43 views63 pagesAnticamera
Uploaded by
chucketti2by Erri de Luca
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 63
Nee Q 5 eee esaeeaaaeeeceeeeeemeeemermmeerermeemmmmmmrmrmmnmnnnteanininiaianiaiciaan
© Giangiacomo Felsneli Eaitore Milano ANTICAMERA
Prima edizione ne “I Narrator” setemibre 1994
Prima edizone nell “Universale Economica” sewembre 1995
Tredicesma ediione giugno 2007
BN 978-88.07.815
Libri in usta intense, reading,
‘commenti e percors di lettu
Per un breve periodo scolastico evitai ogni con-
tatto con la fisica. Non avevo ancora le obiezioni di
adesso, non chiedevo di lasciare in pace l'atomo,
che secondo il suo intento originale voleva essere
indivisibile. La parola che Democrito inaugurd era
un invito a rispettare un limite. La fisica del secolo
invece si & accanita nello smontaggio: sottoterta i
suoi edifici a cerchio affannano la materia, frantu-
mano il suo pulviscolo elettromagnetico. Da ragaz-
z0 non pensavo a questo, ma all’affannoso mucchio
di nuovi simboli, segnetti, inizialie a tutto P'alfabeto
macchinoso che ogni nuova disciplina porta con sé,
fiera di essere illegeibile.
Ero stufo di simboli. Percid nei giomi di fisica
provavo inutilmente a convincere un compagno di
classe a partirsene 2 zonzo e poi ci andavo da solo.
Prendere alle otto e mezzo un autobus ¢ andare
ontano dalla scuola: come assaggiare sangue, una
liberta feroce, da braccato. Provavo repulsione per
la calca fisica che avevo intomno, Ero in una citta del
Sud che impastava il salmastro del mare con il fiato
affumicato delle raffinerie, dei motori e con anima
santa del caffé, amico delle mosche. Tutte le mucose
del corpo erano a contagio. L’intercapedine tra una
persona ¢ ’altra era una poltiglia d’aria, come quel-
la del creatore che mescold alla polvere la sua bava
benedetta di ragno filatore. Avevo una smorfia pi
petua sulla faccia, un ictus di disgusto che raggtinzi
va a muso i centimetri frotitali che dovevano esp:
mere il carattere. La citta era un anello al naso. Ave-
vo una cartilagine sensibile come un'ulcera. I polli
ne della paretaria in primavera mi tramortiva, in
cambio il collasso della mucosa procurava tregua.
Lolfatto era il mio senso sociale e io ero ricco nel
posto sbagliato. Nell’autobus della fuga da scuola
respiravo il meno possibile, esperto di apnea all’aria
aperta come un pesce.
Non tiravo a sorte sulla direzione da prendere,
andavo sempre allo 200. Apriva alle nove, ero gia I,
qualunque tempo fosse. 11 custode in uniforme mi
rimproverava, minacciando di farmi accompagnare
a casa dai vigili urbani, In quegli anni, in mezzo ai
sessanta del secolo, ogni bidello aveva una divisa e
si sentiva membro di un ordine e titolare di un po-
tere. Un ragazzo che scansava la scubla commetteva
tun reato. Se davvero non procedeva contro di me
era per pigrizia, non per mancanza di arbitrio. AE
frontavo le sue minacce tacendo, aspettando che mi
restituisse il biglietto, senza aria di sfida o di insoffe-
renza, rassegnato al peggio che era sempre sospeso.
Infine entravo, oltrepassavo il cancello che separava
dalla citta. Allora il naso rilasciava i suoi nervi con-
tratti, riprendevo un respiro regolare e Ia faccia’
rompeva le righe irrigidite dei lineamenti, Non ave-
8
vo pitt schifo di niente in quel perimetro, Ero final-
mente libero, Chi ha della liberta un’idea di luogo
sconfinato, sa una cosa diversa dalla mia. Liberta
era stare in un giardino chiuso, o in un’isola d’esta-
te: rasentare reclusioni.
In autunno raccoglievo sul viale d’ingresso le
bacche cadute dagli eucalipti. Le rigiravo in tasca
strofinando il loro profumo sulle dita. Mi dava cal-
ma giocare con quei grani: quella di mia nonna
quando diceva lenta le preghiere contandole sui gu-
sci del rosario. Anche se era Vora di prima apertura
€ non c'era ancora nessuno, soffrivo d’ansia di esse-
re osservato, Ero nell’eta della scimmia custode che
svolazza alle spalle, non per protezione ma per in-
ciampo e per spirito di contraddizione. Era Veta dei
se stessi in piena piazza, passi storti ¢ insonnia nei
gesti. Alla prima ringhiera ero gia affrancato dalla
sindrome dello zimbello che gira con lo schemo
scritto sulla schiena. Alla prima ringhiera ero agli
elefanti, ero arrivato al vero lontano. Neanche nella
cavita del Vesuvio avrei potuto stare pitt separato
dal grasso della citta. La chiamavo 'estranea unzio-
ne, impasto di salsedine e di idrocarburi, solfatare e
altofori.
Lelefante era appena uscito di stalla ¢ avanzava
verso la pozza d’acqua dondolando la barra imbam-
bolata del sesso tra le zampe. Mi dimostrava le mie
prime masturbazioni, non sapere cosa farci, un’ab-
bondanza goffa, niente pensieri, solo uno sbatti-
mento cieco. Prima di ogni donna abbracciata ¢, se
9
F
atrivavo vecchio, anche dopo di loro, sarei rimasto
con quella came cosi centrale e cosi mal chiamata.
Pesce, anche pesce era il suo nome in citt, ma cosa
aveva dei guizzi, in cosa era mai agile il mio nasco-
sto, il mio spostato in basso a destra. Facevo pro-
porzioni, calcolavo a occhio: come lunghezza in re-
lazione al corpo non potevo competere, perd forse
nel rapporto col peso il mio poteva stare ai miei chi-
icome il suo ai suoi quintali. L’elefante era il primo
recinto, la premessa. Restavo li per i primi minuti,
me ne andavo che non gli si era ancora sgonfiato.
Poco pik avanti gli ippopotami avevano uno sta-
gno e un cortile sul quale si affacciava la balaustra
dei visitatori. D’inverno rinunciavano a uscire all’s-
perto, ma se lo facevano era per andare dritti verso
il pubblico aprendo le mascelle colossali, in attesa
di un pezzo di pane. C’era chi ne portava secco da
casa. Oggi quest usanza é vietata, eppure @ stata una
benedizione per un bambino allungare la mano con
la fetta di pane e sentirsela cogliere dalla delicata
proboscide, lanciare il tozzo nella bocca-grotta spa-
Iancata sotto, Benedetto il pane che unisce due cor-
pi cosi Iontani e li tiene per un secondo nel gioco
d'equilibrio dello scambio. Lippopotamo apriva la
sua gola inquadrata da quattro dentoni e aspettava
con la sua bocca di nonno sdentato, paziente. Tl
bambino gettava il pane nelPantro spaventoso, io
avrei voluto depositare li i miei libri. Davanti a me,
a poca distanza, c’erano le pitt grandi fauci della ter-
ra. Solo il mare ne ospitava di pitt grandi. Chiudevo
ali occhi, respiravo il fato di quella gola avvicinan-
domi a lei pid che potevo. Fiutavo limpasto di ster-
10
€o, fieno € muschio, sentivo sotto palpebra crescere
un colore, Pazzurro, chiamato a rivestire il buio
mentre annusavo. Lo schifiltoso di citta, il nasino
svenevole tra i vicoli, diventava ardito, un Tarzan
che volteggiava sul tanfo, sul tepore, sul fermento di
un’acquolina bestiale. Quel soffio usciva a sbuffi di
treno a vapore. Fiutavo come ho visto poi fare a
certi drogati. Inalavo a occhi chiusi, stordito. Avrei
avuto una donna nel tempo adulto, avremmo respi-
rato i nostri odori a occhi chiusi, come facevo li. Lei
non si sarebbe stupita di niente che veniva da me.
Ebbi vergogna una mattina dei nostri primi abbrac-
ci, quando mi scappd forte un chiasso di viscere.
Lei per consolarmi l’annusd. Credo di averla amata
per quell’estro di cortesia nasale. Ho fiutato i suoi
odori ¢ lei i miei, fragranze impastate di tutti gli
umori del corpo che sfumava I'incenso sotto pell
sotto le strette, le carezze, i gridi, i ringhi e tutti
gargarismi degli orgasmi. Mettevo la testa in bocca
al’ippopotamo per beatitudine, perché in un’altra
vita ero stato scaldato in tana da quel fiato, disteso
sopra lerba ¢ lavato nella sua lingua. Ci sono felici-
ta assurde ¢ intense che uno scopre per caso. Acca-
dono per avventura, ¢ con vergogna uno le ricerca,
a occhi buttati indietro. Inalavo in estasi la mia dose
di fiato d'ippopotamo: un oppio d’antenati. Chi
apre le sue vie di sangue per infilarsi un po’ di dro-
ghe in corpo, non conosce le proprie beatitudini,
non sa produrle.
Il fiato d’ippopotamo durava quei felici secondi
di pazienza, poi la bestia chiudeva la bocca. Mi ri-
prendevo lentamente, prima con gli occhi, poi nel
u
resto del corpo. A quel punto mi accorgevo del ri-
chiamo mattutino del leone.
Ci andavo. Prima di lui vedevo il cactus gigante-
sco che cresceva in un angolo del suo cortile. Era il
pid bell’annuncio di deserto, di un luogo senza uo-
mini. Ruggiva a conati vomitando fiato, grumo di
potenza che si formava nel ventre ¢ risaliva fino ai
denti. Lo stomaco si contraeva a ritmo. Artivavo ed
cra in piedi oltre il fossato, rivolto a un punto del-
Porizzonte, sempre quello, come un gallo allalba.
Chiamava, chiamava, per buoni minuti, mentre le
leonesse lo lasciavano fare, sdraiate, strafottenti.
Varia gli usciva a colpi caldi, anche sputi, d’inverno
saliva dalla gola un vapore di stufa. Ero lontano,
sentivo poco il suo odore. Il mio nasino umano ar
vava a stento fino a lui, Provavo a liberarlo soffian-
doci dentro e poi alzando le narici contro vento, co-
me vedevo fare a loro. Mi arrivava mischiato a urina
un debole avviso di viscere acide, corrotte da pasti
regolari, In unt punto di acredine somigliava al mio
odore, quando prima di dormire portavo al naso le
dita lasciate a impregnarsi d'inguine. Mi addormen-
tavo subito. II leone @ stato la figura araldica di una
mia solitudine: per il suo chiamare a vuoto, senza ri-
sposte. Amai cost una ragazza di dieci anni pid gio-
vane. Amai: no, la chiamai soltanto. La chiamai da
un balcone, da dieci lettere, da una barca a remi.
Non c’erano cactus ma fichi d’India.
Quando smetteva i ruggiti, lo stomaco ancora si
contraeva a tempo; ma non portava pid voce. Da ra-
gazzo eto certo di capire quel suono, percid lo chia-
mavo voce. Mi davo per sicuro che il leone chiamas-
2
se il proprio nome, il nome della sua specie, ogni
giomo: perché eta vivo. Le bestie pregano cosi.
Hanno riti che non servono a niente, a niente di im-
mediato e materiale. Il leone chiamava il suo nome
per scrivere nell’aria del nuovo giorno la sua firma
difficile, aspra, di creatura viva. Sapevo questo allo-
ta perché ero chiuso in me, nel silenzio animale che
avvolge gli assorti, gli storditi. Pitt tardi horletto casi
di malati catatonici: capivo che si erano procurati il
deserto senza andarci e che avevano perfezionato la
mia tentazione.
Dal largo dei leoni passavo alle camere di sicu-
rezza degli altri felini. Non provavo pena per lo
spreco di forza e di agilita compressa nell’ospizio,
ma qualcosa del guardare mi si guastava quando la
bestia avviava un andirivieni esatto, due passi
mezzo poi una giravolta, lungo Pinferriata. Conobbi
tun uomo negli anni della rivolta che durante le riu-
nioni andava su c gitt nel fondo della sala, a passi
svelti e dietrofront leggeri. Aveva speso tre dei suoi
anni freschi in un carcere militare per aggressione a
un ufficiale per lesioni. Andirivieni soffice, senza
rumore, identico: la bestia guardava un punto lonta-
no oltre la graticola di sbarre, una seconda linea al
di 1a della mia testa, mai che mi mettesse a fuoco.
Ceteavo i suoi occhi, mi saltava. Se mi voltavo, non
vedevo niente, forse neanche lei, ma pet certo non
voleva vedere nessuna prima linea. Da adulto ho
trovato negli occhi delle donne quella capacita di
sfondamento del campo davanti, che fa di un uomo
un ingombro @’orizzonte.
B
Centro del tempo era la gabbia degli scimpanzé.
Avevano una stanza alta e larga con attrezzi di pale-
stra selvatica, tronchi, corde. Con gli anni sarei di-
ventato scalatore, avrei salito rocce. Ho conosciuto
la differenza tra quello ¢ larrampicare sugli alberi
Forse una scimmia non riuscirebbe a passare sui mi-
nimi appigli, sugli strapiombi che ho scavalcato, né
io mai riuscirei a eseguire un percorso aereo tra i ra-
mi, Perd nei gesti che mi issano sulle asperita cerco
un po’ di quella grazia, di pura forza trattenuta, di
morso sull’esplosione di energia. Quando nel-buio
dei muscoli risento il calco di un gesto di scimpan-
22, depurato di sforzo e di spreco, allora sento un
serpente di felicita che si snoda nelle viscere. Quel
gesto ha lavorato in me senza che io l'abbia studia-
to, per viaggio naturale da una memoria di ragazzo
a una catena di muscoli adulti. Scimmia & questa
membrana di cervello che da ordini di gomma e fa
oscillare i corpo sopra un vuoto con indifferenza €
precisione. Gli scimpanzé presiedevano al mio cor-
po, maestri di eleganza che io provavo ad applicare
tiducendola a tecnica. Davanti al loro camerone un
ragazzo scappato di scuola lasciava gli occhi aperti a
guardare, come si lascia aperta una finestra per far
entrare V'aria di una giomata di sole invernale. La-
sciavo gli occhi aperti e dentro entravano le scim-
mie a sbattere laria della mia stanza, portando mo-
venze da agitare in sogno, quando il corpo pesa
molto meno. Non era solo vita quella dei loro voli,
non solo applicazione d’energia ai sostegni e, tra i
sostegni, I'aria: stavano descrivendo una geometria
infallibile per gli occhi vuoti di un’ ragazzo in fuga.
4
§
t
Lodore della gabbia era di frutta decomposta, di
noccioline abbrustolite, pulci masticate, niente che
somigliasse al nostro di ascelle dopo una gara o un
gioco. Si toccavano tra loro per un’intesa che di ra-
do ho rivisto tra le persone: con proprieta di sensi e
di distanze, come noi proviamo a fare con le parole.
Passavo da una specie all’altra per puro deside-
io di trascorrere il mio tempo davanti a loro. Ero
ii recente del loro passato remoto che si
prosciugava nell’ergastolo del giardino. To ero un
“appena” che risaliva solo al sorriso imbiancato di
un nonno.
Incontravo qualche coppia umana in cerca d’in-
timita. Gli Adamo ed Eva venivano espulsi dal re-
cinto ogni sera, a biglietto scaduto. Scrutavo quei
passanti doppi, addestrati allo stesso passo come un
cavallo allambio, bisognosi di una lontananza. Si
guardavano i piedi, poi gli occhi, poi tomavano ai
piedi. Alcuni attaccavano discorso contemporanea-
mente, altri procedevano come avvinti da manette
ai polsi. Di me avrei giurato: mai. Invece ho avuto
anch’io lingua di stoppa e occhi tondi di cernia ac-
canto a una ragazza, fingendo baldanza di aspirante.
Nel giardino i passanti erano la specie, mentre i
reclusi gli esemplari, unici anche quando erano in
gruppo. Le bestie erano il riassunto di una varieta,
noi la ripetizione di un tema, Nel giardino ero un
caso comune di uomo e gli animali mi guardavano
come io guardo una folla: senza vedere nessuno.
Diimprowviso scoppiava una rissa in una gabbi
partivano colpi veloci, meditati, che finivano subito.
Mi sono trovato in molte zuffe: mai ho avuto quella
ro
t=
prontezza d’attacco, né la sveltezza a smettere. Len-
to a sorgere, ultimo a staccarmi, non avrei possedu-
to il segreto della loro civilta di scontro: anche se
mortale, badava all’essenziale fondando una supre-
mazia col minimo di sangue.
Nel rettilario, al chiuso c’era la vasca del cocco-
drillo. Mi affacciavo sopra il suo luogo, lui era vi
no all'acqua, due metri pit in gid, sempre fermo. Se
ho un timpianto di quel tempo é di non aver scaval-
cato il limite, di non essermi calato giti a stuzzicare
Vimmobilita. Certo per paura, ma del guardiano,
non dell’animale, di essere scoperto pit che di subi-
re attacco. Mi friggeva il cervello contro il richiamo
di cento bidelli, agenti, automi di un’unica divisa,
camiciai di forza. Non temevo i coltelli dei denti ai
quali potevo sfuggire, ma i gridi, le intimazioni di
qualche ordine che mi avrebbe afferrato le orecchie.
Dai propri terrori si capisce che razza di awvenire si
apparecchia. Presto il soprassalto, il calcio di mulo
di una generazione mi avrebbe spinto a muovere
contro le figure in divisa che pid mi avevano ingom-
brato Vinfanzia.
Nei giorni di pioggia restavo in quel chiuso,
presso i vetri dei serpenti. C’era sempre un brandel-
lo di muta della loro pelle. Era cosi anche il mio
tempo, una crosta da grattare via, in attesa della
nuova, lontana da li, dal Sud delle unzioni. Dicevo
addio alle gabbie, intorno a mezzogiomo.
“Uscita” di li voleva dire ingresso: rificcarmi nel
buco di citta, lubrificato come una supposta.
IL PANNELLO.
Era stato staccato un pannello della cattedra per
guardare le gambe della supplente. Eravamo una
classe maschile, seconda liceo classico, sedicenni e
diciassettenni del Sud, seduti d’inverno nei banchi
con i cappotti addosso. La supplente era brava, an-
che bella e questo era un avvenimento. Aveva susci-
tato l'intero repertorio dell’ammirazione possibile in
giovani acerbi: dal rossore al gesto sconcio. Portava
gonne quasi corte per l'anno scolastico 1966-1967.
Si era accorta della manomissionc solo dopo es-
sersi seduta accavallando le gambe: aveva guardato
la classe, la mira di molti occhi, era arrossita ¢ poi
fuggita via sbattendo la porta. Successe il putifetio.
In quel severo istituto nessuno si era mai preso una
simile licenza. Sal il preside, figura funesta che si
mostrava solo in casi gravissimi, Nell’apnea totale
dei presenti dichiard che esigeva i colpevoli altri-
menti avrebbe sospeso Pintera classe a scadenza in-
determinata, compresi gli assenti di quel giorno. Si-
snificava in quei tempi perdere 'anno, le lezioni e i
soldi di quanti. si mantenevano agli studi superiori
con sactificio delle famiglie. Non esisteva il Tax,
19
quel tribunale amministrativo cui oggi si sottopon-
gono ricorsi per ristabilire diritti. Non c’erano dirit-
ti, le scuole superiori erano un privilegio. C’era la
disciplina caporalesca degli insegnanti, legittima
perché impersonale e a fin di bene. Il preside usci,
si ruppe quel gelido “attenti” che avevamo osserva-
to. Non riuscimmo a sputare una parola.
Accadde una cosa impensabile: sottoposti all’al-
ternativa di denunciare due nostri compagni o pati:
re conseguenze gravi nello studio, quei ragazzi si
zittirono a oltranza e nessuno riusdi a estorcere loro
quei nomi. Nessuno pazld. Questo é il racconto del
comportamento ostinato di un gruppo di studenti
tuniti solo dal fatto di essere iscriti alla sezione 8, se-
condo anno di liceo, dellIstituto Umberto 1 di Na-
poli nell’anno scolastico 1966-1967. Tranne una
combriccola composta da ragazzi di agiata famiglia
con residenza al centro, 0 un altro gruppo di ragazzi
di pochi mezzi che si trovavano nel pomeriggio per
studiare insieme, tranne qualche partita a pallonc la
domenica, niente univa quei ragazzi. Perd @ vero
che niente ancora li divideva sanguinosamente, co-
me sarebbe accaduto in pochi anni, Non ho pit vi-
sto i compagni di quella classe, non fummo amici né
soci, solo membri di un’eta costretta a essere seme
delle successive, inverno delle altre. Di colpo quei
ragazzi spaventati si irrigidirono in un silenzio im-
penetrabile.
Quando il preside usci non avevamo piti freddo.
Cominciava la tensione di un assedio ancora senza
parole tra noi. Parla il solo che si era opposto, quel
mattino prima dellinizio delle lezioni, allo svita-
20
mento del pannello. Era il pid ligio di noi e spesso
veniva preso in giro per quel suo impulso all’ordine.
Quel mattino era stato zittito, ora recriminava per-
ché aveva ragione e perché quel provvedimento
contro tutta la classe era un’ingiustizia ai suoi occhi.
Molti non erano ancora saliti in aula quando il pan-
nello era stato tolto. Protestava accorato con voce
che sbandava tra Vacuto e il grave come succede
agli adolescenti. Stavolta non faceva ridere. Non so
dire perché non si rivolse mai ai due colpevoli, non
i additd alla classe che ancora ne ignorava i nomi,
invece se la prendeva con noi, quei pochi presenti
che non Pavevano aiutato a impedire quel gesto. Si
senti solo la sua voce in quell’intervallo. Ognuno
cercava di rendersi conto delle conseguenze. Qual-
cuno aveva Ia famiglia povera che non gli avrebbe
permesso di ripetere anno. Tutti temevamo la rea-
zione che Pepisodio indifendibile avrebbe prodotto
in casa. C’era chi sarebbe stato promosso a occhi
chiusi e che vedeva sfumare il diritto alla borsa di
studio, chi aveva gia fatto spendere soldi per le le-
zioni private. Ognuno aveva un grado nel pericalo.
Eppure nessuno denuncid gli autori dello svitamen-
to, neppure sotto la nobile causa di salvare gli altri
Nessuno chiese ai due compagni di denunciarsi.
Questi si rimisero alla decisione della classe e la
classe li copri. Avrebbero altrimenti patito punizio-
ne esemplare, sarebbero stati espulsi da tutte le
scuole. Questo sembra incredibile a chi conosce
quello che @ successo nelle aule d’Ttalia solo pochi
anni dopo, eppure le cose stavano cosi: la scuola ita-
liana un quarto d’ora prima di essere sovvertita da-
2
OO CCC CCC CCC eer...
li studenti era saldamente in mano alla gerarchia
docente.
Eravamo ancora 2itti quando entré il professore
dell'ora successiva. Squadrandoci fieramente prete-
se di conoscere immediatamente i nomi dei colpe-
voli. Alzd la voce. Diede agli scdnosciuti il titolo di
vigliacchi a noi che li coprivamo attribui colpa an-
cora pitt grave, degna del piit severo provvedimen-
to. Richiese i nomi un’altra volta. Dopo il secondo
silenzio applicd la rappresaglia: interrog® alcuni di
noi che nella sua materia tentennavano, li confuse
con domande difficile atteggiamento sprezzante, li
conged@ annunciando, cosa mai prima accaduta, il
pessimo voto riportato, Quella palese ingiustizia fe-
ce del bene a tutti. Era iniziato un assedio, ne anda-
va della vita scolastica di ognuno, che era tutta la
nostra vita pubblica di cittadini.
Sotto il duro ricatto di denunciare dei compagni
© incorrere in provvedimenti disciplinari spuntd
Wimprovviso uno spirit di corpo. Ragazzi che ave-
vano in comune la frequentazione di un’aula per al-
cune ore al giorno diventarono un organismo dispo-
sto a cadere tutto intero pur di non consegnare due
suoi membri. Passé nelle fibre di uno scucito grup-
po di coetanei una di quelle scariche elettriche che
su scala pid grande trasformano varie genti in un
popolo, molte prudenze in un coraggio. C’e una so-
slia segreta di pazienza passata la quale ci si oppone
di colpo alla disciplina quotidiana. Occasione
spesso un motivo all’apparenza insignificante. Anni
dopo, partecipando a lotte operaie, avrei appreso
con stupore che la lunga catena di scioperi sponta-
2
nei di aperte rivolte di fabbrica cominciarono alla
iar, nel 1969, con richieste semplici come nuove
tute da lavoro o la distribuzione di latte nelle lavo-
tazioni tossiche. Piccole occasioni di rottura della
pazienza quotidiana contengono grandi scosse: di
colpo le strade si riempiono di scontento che sem-
bra nato di pioggia come un fungo.
Non fu una rivolta, non chiedevamo niente, ma
uno scatto di reazione contro chi voleva perquisirci
dentro
Fuori di scuola quel giomo si discusse. In mezzo
all'assembramento notammo la strana presenza dei
bidelli. Qualcuno di noi chiedeva almeno di sapere
a chi doveva il rischio di rinunciare all’anno scola-
stico. Li fuori venne zittito. Alla fine questa curiosi-
18 per vie traverse venne csaudita al nostro interno,
ma in quel primo scambio di battute prevalse una
spontanea disciplina. II pit ligio di noi trasferi il suo
impulso all’ordine a servizio di quel silenzio. Qual-
cosa tra lui e la gerarchia scolastica si era guastato
per sempre,
Quel giomo nelle nostre case si ripropose intero
Passedio. L’atmosfera fu inquisitoria come ¢ pita che
a scuola, L'unico scampo: rifugiarsi nellimpossibili-
ta di fare nomi di compagni senza esserne cert
Nessun retroterra familiare si mostrd comprensivo
nei confronti della colpa, nessuno sostenne almeno
un poco i diritti al silenzio di fronte al ricatto, Nes-
suno: tempi tutti d'un pezzo, non era solo a scuola il
campo del dovere, esso si estendeva a tutta la picco-
Ia vita privata. Da adalto ho visto le famiglie difen-
dere figli colpevoli di stupro e di linciaggio, un tem-
B
po invece stavano dalla parte dell’accusa. Se un ra-
gazzo non si trova di colpd solo al mondo, mai cre-
sce. Forse era difficile essere giovani in quei tempi
anche se, per misericordia, non lo sapevamo. Molte
pitt cose di oggi, in quegli anni erano considerate
importanti, molto del futuro di ognuno si decideva
sui banchi di quelle scuole.
Nei giomni successivi si ripeté in classe la richiesta
di denunciare i colpevoli, fino al limite dell’ultima-
tum. Arrivarono al preside anche diverse lettere
anonime coi nomi dei presunti responsabili, ma di-
scordanti tra loro. La faccenda perd non era piti fer-
ma ai colpevoli, si voleva rompere quell’inaudita
ostinazione. Ma non ci fu verso di farci denunciare
quei compagni. Penso che ci sentissimo tutti colpe-
voli, quelle gambe avevano emozionato ognund. Fu
percid un po’ di immedesimazione verso quel gesto,
anche se ce ne vergognavamno. La giusta linea di con-
dotta:proveniva da alcuni di noi che avevano gia
qualche relazione amorosa e trasmettevano agli altri
un senso di superiorita da adulti nei confronti di
quel gesto da guardoni nel buco della serratura. Ci
piaceva credere di essere superiori agli scopi di quel,
sabotaggio, anche se non era cosi. Ma questo non
contava pitt, stavamo andando dritti verso le conse-
guenze inevitabili. Ci eravamo irrigiditi dentro, pur
mostrando all’esterno la costernazione dei malcapi-
tati. Sotto quell’assedio eravamo diventati soldatini,
imparando a difenderci tutti allo stesso modo.
C’cra gi in quegli anni una specie minore di so-
lidarieta tra studenti che stava nel non farsi avanti a
dare al professore una risposta che un altro non era
24
stato in grado di fornire. Nessuno chiedeva di ri-
spondere al posto del compagno. Forse era un com-
portamento legato al pudare di mostrarsi saputelli
ed & troppo pretendere che fosse solidarieta. Questa
era voce che si applicava a grandi cause come quelle
dei terremotati, degli. affamati ¢ degli alluvionati.
Pero quel trattenersi dal dare la risposta era una
pratica che insegnava a non mortificare il proprio
compagno, a rivolgergli perci un’attenzione non
solo scolastica. Ovunque simili usanze sono sparite.
Prima dell'ora di scadenza dell'ultimatum entrd
a fare la sua lezione il professore di greco e latino.
Erano gia passati alcuni giomi e non ci aveva detto
una parola sulla faccenda, tranne al suo primo in-
gresso in aula dopo il putiferio. Era entrato, si era
seduto, ma invece di aprire il registro ci aveva guar-
dati tutti quanti a lungo, poi aveva giunto le enormi
mani in preghiera ¢ le aveva agitate in avanti e in-
dietro, secondo quel gesticolare che sta per: “Cosa
diavolo avete combinato?” Era un gesto semplice,
temperato di sollecitudine, con un piccolo acento
buffo mischiato al rimprovero muto. L’accogliem-
‘mo con gtatitudine, Subito dopo diede inizio alla
sua lezione. Bisogna ora che io nomini quest'uomo:
Giovanni La Magna, Siciliano, completo conoscito-
re della lingua greca della quale aveva redatto una
grammatica ¢ un vocabolario, mostrava un corpo
massiccio, dal passo pesante. I] volto era aperto,
cordiale ¢ i tratti gli si spianavano quando con la
sua grave voce di basso compitava i versi greci e la-
tini facendo cadere Paccento sulle sillabe con suono
incalzante di zoccolo di cavallo sul selciato. Ci inna-
2
mord di Grecia antica perché ne era innamorato.
Gli piaceva insegnare: questo verbo pet lui si realiz.
zava nell’accendere nei ragazzi la voglia di conosce-
re che sta in ognuno di loro e che aspetta a volte so-
Jo un invito sapiente. Era alla fine della sua carriera,
mostrava anche pid dei suoi sessanta. Aveva il gusto
sicuro della battuta folgorante che detta dal suo fac-
cione imperturbabile faceva esplodere la classe in
una risata improvvisa, come un colpo di frusta. Non
ne ha mai ripetuta una due volte, non le pescava da
un repertorio, le inventava. Credo che nessuno ab-
bia saputo raccontare i dialoghi tra Socrate e i suoi
discepoli meglio di lui. Nemmeno Platone, che li
serisse, poteva essere cosi bravo.
Incitava a essere leali con lui: non teneva conto di
una insufficiente preparazione se lo studente glicla
dichiarava spontaneamente prima della lezione. A
chi si avvicinava alla cattedra per bisbigliare le sue
siustificazioni, prestava a volte ascolto con gesto
scherzoso, appoggiando la mano all orecchio e stra-
buzzando gli occhi per manifestare il suo stupore.
Lo amavamo: di quel cupo Olimpo di numi da catte-
dra era il nostro buon Zeus. Quel giorno dell ultima-
tum entré nellaula e togliendosi il cappotto annun-
cid che non avremmo parlato né di greco né di lati
no, Si sedette, accantond il registro e ci parld. Confi-
do di non tradire il suo tono di voce e i suoi argo-
‘menti provando a ripeterli con le parole che ricordo:
“Voi sapete che sono siciliano. Nella mia terra
© un costume che vieta di denunciare i colpevoli
di reati: si chiama omerti. Voglio parlarvene per
stabilire i punti di contatto e quelli di differenza tra
26
questo costume ¢ lo spirito di solidarieta. L’omerta
nasce dal bisogno di difendersi da un regime sociale
di soprusi in cui la giustizia @ applicata con parziali-
18 e favoritismi, ma contrappone malauguratamente
a questo un altro regime di soprusi: la mafia. L’o-
merta @ un comportamento radicato in tutta la po-
polazione quando considera Pinter apparato stata-
Je un grande sbirro. La mafia che & nata da questa
silenziosa protezione popolare, Y’ha trasformata in
legge di sangue sicché oggi omerta é frutto princi-
pale della paura. Essa non distingue tra chi si ribella
a un sopruso ¢ chi agisce da criminale, copre tutti, il
povero cristo e il malfattore. Lomerti & diventata
cieca ed @ al servizio di un’altra prepotenza.
“Lo spirito di solidarieta @ invece un sentimento
che onora 'uomo. Non @ una legge, come 'omerta,
sorge di rado. Spunta di colpo tra persone che si
trovano in difficolt3, comporta il sactificio persona-
le, non si nasconde dietro il mucchio formato da
tutti gli altri. Nel vostro caso la solidarieta pud esse-
re quella di tutti per proteggere due, ma potrebbe
anche essere quella di due che si fanno avanti per
roteggere tutti gli altri. La solidarieta & opera pre-
ziosa di un’occasione, appena compiuto il suo dove-
re rompe le righe, lasciando in ognuno la coscienza
tranquilla. Se siete d’accordo con me su queste dif-
ferenze, allora potrete meglio conoscere quello che
vi succede in questi giorni. Io non credo che gli svi-
tatori di pannelli della seconda 8 abbiano intimorito
tutti gli altri inducendoli a tacere. Credo invece che
sia sorto tra voi in questi giorni uno spirito di squa-
dra contro un provwedimento che ritenete ingiusto.
a
CC LLDLPRPRPREPANE' SE ae
Pensate forse di stare subendo un sopruso: il ricatto
di denunciare i vostri compagni oppure essere s0-
spesi a tempo indeterminato. Ma non é stato un so-
pruso far arrossire di vergogna una donna che @ en-
trata in quest’aula per insegnare e che, per poter ac-
cedere al privilegio di mostrare a voi le sue gambe,
ha studiato per anni ed @ appena giunta all’occasio.
ne che ha tanto aspettato? Un sopruso, una prepo-
tenza di molti contro una donna, questo & accaduto
ui dentro. Non siete innocenti, nessuno qui é inno-
cente, II torto & spesso meglio distribuito di quanto
i piace credere.
“To faccio parte di questo regime scolastico con-
tro il quale avete fatto muro. Anzi sono il pitt vec-
chio insegnante di questa scuola. Noi siamo inse-
gnanti, voi studenti, siamo per questo pit forti di
voi, possiamo bocciarvi, sospendervi tutti, compro-
mettere i piani scolastici forse irrimediabilmente per
alcuni di voi. Ma vogliamo farlo? Credete che vo-
gliamo rovinarvi? Noi che siamo i pit forti ci stiamo
in verita difendendo da voi. Ritenete vostra facolta
levare un pannello di cattedra per vedere le gambe
di un’insegnante? Presto riterrete vostra facolta ab-
bassarle 1a gonna per ammirarle intere. Perché non
Pavete fatto con me? Perché sono un uomo o per-
ché non sono un supplente? Noi ci stiamo difen-
dendo da voi, voi da noi: cost le aule diventeranno
campi di battaglia, vincera il pit forte, ma la scuola
sara finita. E con profonda tristezza che vedo que-
sto accadere. E contro tutto quello che ho fatto nei
miei molti anni di insegnamento. Mi accorgo di non
avere piit un posto in un’aula ridotta a schieramen-
to, di non poter fare pid niente per voi. Mi state li-
cenziando voi, i miei colleghi, tutti. Questo spirito
di ostilita che scorgo in loro ¢ in voi mi avvisa di
tempi in cui non avrd parte.
“Non approvo un provvedimento cost drastico
nei vostri confronti, non lo fard applicare per quello
che potrd, ma non so approvare nemmeno la vostra
caparbiet’. Ce Iho con tutti voi: il vostro spirito di
corpo é la cosa pid preoccupante alla quale assisto
da quando vivo nella scuola. Il vostro serrare i ran-
ghi é il gesto pitt duro da intendere per uno come
me che pensava di stare in una classe e si ritrova a
visitare una barricata. Non credo che il vostro silen-
zio sia omerta, che stiate diventando una mafia. Pe-
19 so che questo guaio pud scaturire da ogni ostilita
di parte. Se c’t ancora una lezione che posso per-
mettermi di darvi @ quella di insegnarvi a distingue-
re nella vostra vita Pomerta e la solidariet’. Siate
pure oggi leali tra voi fino a sopportare il sacrificio
di un duro provwedimento disciplinare, ma non im-
parate domani a proteggere l'ingiusto, il prepotente,
il vendicatore. Prima che siate sospesi in blocco dal.
le lezioni, propongo a voi di fare le pitt sentite e so-
Jenni scuse all’insegnante che avete offeso. Fate
‘questo senza aspettarvi niente in cambio, fatelo solo
perché é giusto. Fatelo prima che il vostro silenzio
si indurisca troppo contro di noi, si avveleni di av-
versione, distrugga il mio lavoro con voi ¢ la vostra
possibilita di trarre profitto dalle ore trascorse insie-
me in queste aule”.
Mi perdoniy li dove riposa, P'uomo al quale attri-
buisco queste parole ¢ del quale provo a ricordare
29
tuna lezione. Essa fu certamente pid intensa ed effi-
cace di quella che posso ricostruire. La sorreggeva
uuna voce che rimaneva paterna anche nel tratto
amaro, grave senza severiti. Era voce di uomo che
si spogliava della dignita della cattedra per parlare
da pati ad altri pari. A una classe di sedicenni pieni
di brufoli ¢ di barbe ancora a chiazze sul viso, si ti.
volse come a un’assemblea, svolgendo un ordine del
giomo. Ci sentimmo spaesati, ma piti grandi, senza
parole, certo, ma finalmente spogli del bisogno di
difenderci. Quell'uomo ci trattd da uomini, Nessa.
no di noi Jo era ancora, ma tutto dentro di noi in
guei giomi spingeva a diventarlo. Ci fece provare la
responsabilita di persone che intendono Tora ¢ il
luogo in cui sono. Disfece con i suoi modi leali il
rozzo campo di battaglia nel quale ci sentivamo tin-
chiusi. Non ci addité una scappatoia, sgomberd
semplicemente l'assedio mostrando il male di quel.
ostilita, addossandosene una parte. Accese in not il
desiderio di sispondere, come gia altre volte aveva
incitato il nostro desiderio di apprendere. Uno di
noi sialzd, il pid mite, e uno trai pit diligenti, disse
a nome di tutti che le nostre scuse erano il passo mi.
nimo che ci sentivamo di fare e che Pavremmo gia
fatto se solo ne avessimo avuto la possibilita, Nessu-
no disse cosa contraria o diversa.
Le scuse vennero accettate. Le lezioni ripresero
con la palese disapprovazione di alcuni insegnanti
insoddisfatti della riparazione e contrari a quella
composizione “a tarallucci e vino”. Il partito della
fermezza contava i suoi effettivi in vista delle future
Prove. Noialtri ci considerammo scampati, rom.
30
pemmo subito le righe piegando ancora di pid il
collo sui libri. Ancora per poco Patteggiamento pre-
valente dei professori fu di rappresaglia, poi lo spi-
rito dell'insegnamento prevalse e ritorn® in vigore
la bilancia dei meriti e dei profitei. Quell'anno fum-
mo ptomossi in molti, compresi i due svitatori. Solo
allora quella pagina di calendario fu per noi voltata
del tutto.
L’anno seguente, stagione scolastica 1967-1968,
avremmo affrontato la maturita. Prima di quell’ap-
puntamento il professore Giovanni La Magna man-
cd a una lezione per la prima volta in tre anni. Si era
rotto il cuore del nostro buon Zeus, fermate le mani
enormi che ci avevano aperto le vie della Grecia clas-
sica, zittta la voce che aveva caleato per noi i versi
pit soavi della terra. Salimmo alla sua casa sulla col-
lina del Vornero come un gregge disperso. Era diste-
so eppure sembrava ritto in piedi, manteneva anche
cosi tutta la forza della sua presenza. Aveva le grandi
manj intrecciate in grembo, gli occhi molto chiusi.
Per la prima volta un ragazzo tra i tanti ebbe misura
dello spreco insensato contenuto nella morte di un
uomo. Tutta quella Grecia svisceratamente amata da
un siciliano, tutta quella sapienza si perdeva, a nes-
suno poteva pitt trasmettersi. Ne trattenevamo fram-
‘menti lucenti da un vaso in frantumi, noi suoiallievi.
Ma se tutti gli studenti che aveva avuto, avessero po-
tuto mettere insieme i loro pezzetti, non avrebbero
ricomposto V'interezza da lui posseduta. Le lacrime
che ad alcuni di noi vennero agli occhi se le era gua-
dagnate con quello che gronda dal cuore.
Mori in quei primi mesi dell’anno di subbuglio
31
PF E'S?C'’COUSS:«C=C“CS lh enn
) 1968, senza vedere le aule abbandonate sotto i colpi LA CITA NON RISPOSE
di una guerra che aveva intravisto e aveva scongiu-
rato di evitare. La scuola finiva e non solo per i ma-
turandi di quell’anno. Dopo di lui la Grecia torn a
essere la patria di una grammatica molto esigente.
i Ci sono uomini che morendo chiudono dietro di lo-
ro un mondo intero. A distanza di anni se ne accetta
Ja perdita solo concedendo che in veriti morirono
in tempo.
32
Non due volte nella vita succede di leggere in
piedi un libro di cinquecento pagine. In piedi: nel
dimesso “attenti” di chi con una mano &i regge al
sostegno di un convoglio di metropolitana e con
Paltra stringe, consuma i fogli.
Erano i mesi dell’inverno ’81, la polvere del ter- |
remoto non si era ancora posata. In molti punti la
citta era vuota, in altri fitta di accampamenti. Ero
tomato a Napoli. Ovunque ferveva il primo soccor-
so di una infermeria edilizia. Avevo trovato lavoro
in un cantiere, facevo il manovale, fuori regola, as-
sunto “a nera”. Sotto le volte, gli archi, i soffitti di
palazzi antichi issavamo a puntello una foresta di pi-
ni ancota freschi di taglio. Fornivamo stampelle a
pietre scosse pitt dal tempo che dai colpi del sotto-
suolo,
Per fare in fretta i camion scaricavano il bosco di
tronchi con la ribalta: cadevano in un tuono brusco
€ cupo, sussultava il suolo, qualcuno scendeva di
corsa per le scale, pronto com’era ad abbandonare
casa ad ogni scossa. Seguivano bestemmie.
Italiana, Oscar Mondadori 1991 . Segavamo a mano facendo a occhio sia i tagli
35
i ee
TEETER
netti che quelli a quarantacingue gradi. Scendeva-
mo a montare i puntelli negli scantinati, finivamo
opera nelle soffitte. I topi scappavano tra le gambe
su ¢ gidt per le scale. Il ribrezzo dei primi giorni si
chetd e ridemmo della commissione comunale che
scese negli scantinati a controllare il lavoro e ne uscl
di corsa buttando i fogli allaria. Restava nelle mani
Tessenza tenace di resina, faceva pensare alle mon-
tagne. Un albero é vivo come un popolo piti che co-
me un individuo, abbatterlo dovrebbe essere com-
ito solo del fulmine.
Nelle strade, nei larghi del quattiere Sanita, do-
vera il cantiere, alzavamo muretti di tufo o in calce-
struzzo, a sbarramento, a labirinto, obbedendo a
una legge misteriosa che accumulava intralci, La cit-
t8 circolava sotto le impaleature, tra le serpentine
create dai contrafforti, i vicoli sbarrati.
Come quando sulle navi borboniche si dava Por-
dine: “Facite ammuina” e chi stava a poppa correva
a prua e viceversa, chi stava sottocoperta saliva all’a-
perto e ne scendeva chi gia c’era, per dare all’occhio
distratto del re impression di pronte manovre.
Cosi quell’ordine assurdo ed efficace sembrava ese-
guito in terraferma, coprendo la citta con grucce ¢
bende 1a dove poco prima erano panni stesi e ban-
chi con la merce.
Ho lavorato in cantieri del Nord, ma non ho
Provato altrove il freddo di quell'inverno a Napoli,
36
La tramontana infilava i vicoli, i corti, attorciglian-
do i nervi, inctespando di viola il dorso delle mani
che si riscaldavano solo nel palmo stretto sulla pala.
La faccia di ognuno di noi, spazzata per ore da quel
vento, si chiudeva a muso. Non cera un posto per
tirare il fiato. Riprendevo calore nel sottosuolo della
metropolitana, nel tratto piazza Cavour-Campi Fle-
arei, dove abitavo. Allora prendevo di borsa ¢ leg-
gevo: Viaggio al termine della notte, di Louis-Ferdi-
nand Céline.
“Mai mi sono sentito tanto inutile tra tutte quel-
Ie pallottole ¢ la luce di quel sole. Avevo solo ven-
Vanni in quel momento.”
Ci sono libri che si incontrano in tempi diffic
Si acquistano su una bancarella con il pretesto di ri-
scattare dall'abbandono una vecchia edizione. Poi li
si espone alle proprie intemperie e vengono fatti a
pezzi dall'intensita con cui si leggono le righe, si
sfogliano le pagine. Nel buio della metropolitana di
Napoli, inverno asciutto dell’81, la folla scaricava i
brividi nel fiato, soffiava il naso e aveva gli occhi lu-
cidi. Esalava Podore che serviva a un lettore del
Viaggio per respirare il libro. Le pagine rispondeva-
no al fiato del vagone e dalle ascelle secche dei fogli
saliva laltro odore, tanfo di uno scrittore che in
quell’opeta si era sprecato intero, versato fino anon
avere pid altro da dire, come accade a pochi, scrit-
tori o no, che lo sappiano 0 no.
Un manovale magro stringeva in pugno il Viag-
gio, salvando il tempo dell andiivieni. Céline regge-
va il morso e rispondeva portandosi dietro folla, tre-
no ¢ lettore.
37
Non lo leggevo altrove, solo li. Quando il capito-
lo non coincideva con la fermata, lo finivo sul mar-
ciapiede. Non avevo fretta di tornare alla cucina, di
uscire dal cunicolo dei treni, giacimento che estrae-
va minatori e minati, uomini che traspiravano il ver-
de chiaro dello zolfo, sfaldati cme scorie dal picco-
ne, affumicati, spenti nella sera.
‘Acasa leggevo il giomale, apparecchiavo cena. II
sonno dalle ossa risaliva agli occhi, ma restavo sve-
gli. Aspettavo la ragazza amata, il suo ritomno a se-
ra. La perdevo un poco tutti i giomi sotto le palme
ispessite che le graffiavano la pelle senza poterla
sentire. L’abbracciavo nel letto- tenendo i pugni
chiusi. Scendevo su di lei, tronco spinto in discesa,
in corsa verso il salto. Poi rotolavo su un fianco,
precipitando nel sonno come un legno sopra una
catasta.
Céline perdeva senno dal tappo del dolore: “Ben
presto non ci saranno pid che persone e cose inof-
fensive, pietose ¢ disarmate tutt’attorno al nostro
passato, niente altro che errori diventati muti”. Cost
diventavo per lei.
Le crepe dei secoli erano giunte a rendiconto.
Gli intonaci ¢ i comicioni che erano sempre caduti
con lentezza adatta alla salvezza dei passanti, venne-
ro rimossi di colpo. La citta sperimentava Pebbrez-
za della manutenzione. L’erogazione generosa di
fondi istigava ogni condominio al restauro gratuito.
Lemergenza, condizione interiore dei tirrenici
del Sud dislocati su una graticola sismica e vulcani-
38
ca, fu accampata a regola di spesa. L’occasione di
atticchirsi disfece ’ordine precario dei commerci
leciti, Bande sorgevano e si decimavano per il con-
trollo dei metri di un marciapiede.
Nel carcere altre scosse permisero agli uomini
che si odiavano di scannarsi fin dentro le inferme-
rie, Il grado di febbre, la temperatura a terra, stava
nel bollettino dei caduti, in cronaca. Una ricchezza
fresca scendeva a pioggia e si spartiva in sangue. La
citta era scritta. Nuvole, fondi di caffé, tatuaggi, fori
di entrata e di uscita, raffiche scrivevano sulla pelle
degli ammazzati. I] vento, con un pennino di ghiac-
cio, incideva rughe sulle facce. Nessuno sapeva leg-
gere quei segni
Passavo per le vie con il Viaggio sotto il braccio,
come un salvacondotto. Mancavo al fervore, al tre-
mito della citta, non era guerra mia. Ero distante
anche dalla sorda pieti di Céline, randagio tra le
piaghe, che conservava i gesti di un medico suona-
to. Mi dava ai nervi il libro: troppo gergo metteva,
nel raccontare il male della gente, guerra ¢ seguito
di macerie.
Ora so che sbattevo la citta ¢ le pagine 'una
contro le altre. Venivano dalla stessa polvere, anco-
ra sospesa e gia intrisa di sangue, stavano bene con-
tro faccia a faccia, Scorrevano tra le mie mani senza
annullarsi, sommandosi lontano. Non mi pesavano,
restavo stanco d’altro, sporco d’altro. Un treno tie-
pido di tosse mi restituiva di sera al capolinea del
buio, a libro chiuso. Viaggio al termine della notte:
quel termine per me era solo alba successiva ¢ non
39
I _<_£__<£_
avevo fretta di arrivarci. Chiudevo per crollo gli oc-
chi accanto alla ragazza delicata.
Una mattina eravamo al lavoro, un muratore an-
ziano ed io, in uno slargo della Sanita. Impastavamo
a mano i metri cubi del giomo, sabbia e ghiaia, me-
scolandole con acqua e cemento. Le braccia anda-
vano da sole, lo sguardo nostro assorto sull’impasto,
ma anche lontano. Il respiro scendeva seguendo la
pala. Passarono due ragazzi vestiti alla spaccona su
una motocicletta. Si fermarono a guardare, poi uno
disse all'altro: “Tieni mente: chi’o ffacesse maie”.
Tl compagno alzd gli occhi dall’impasto, cercan-
do di metterli a fuoco, come se li richiamasse da
Jontano, da un libro, lentamente. Furono su di me.
Cercavano risposta, agilita di sdegno, bussavano al
mio sangue. Non risposi. Sentivo il disprezzo dei
guappi verso di noi come scaduto, logoro, niente in
confronto a qucllo fresco d’ira di Céline eonure di
loro: “Essi sono soltanto giovani al modo dei fo-
runcoli per quel pus che fa loro male dentro e li
gonfia”
Non ricambiai lo sguardo. Quelli erano anni di
sdegni sbriciolati, ognuno era solo nel suo, non c’e-
ra pid un’ira comune. Mi chinai con pit forza sul
Vimpasto, accelerai i colpi di pala: amico, questo
lieve ancora, ci caricassero del doppio e noi lo reg-
geremmo. Lascia che avvitino senza fine la manopo-
la che da corsa al loro motore, che s'impregni d
scella I'arma nella fondina. Vanno a farsi largo in
tanti in un mondo stretto, mentre noi siamo tra
quelli che non tolgono posto a nessuno. Nessuno
verrebbe a toglierlo a noi.
‘Ma non parlavo, non dicevo niente, a volte per
un giorno intero sul lavoro solo il respiro mi usciva
di bocca.
In altre citta ero stato uno di Napoli, bastava agli
altri € a me quella provenienza. A Napoli non mi
era accreditata. Tra gli operai della mia lingua ero
accolto come un forestiero. Ero per loro uno di al-
tre citta, su di me la fatica aveva lasciato altre pose,
altre usanze. Allora scaduta lasciavo il lavoro al
punto in cui era, mentre gli altri regalavano ancora
un po’ di braccia al tempo gia venduto. Allora un
saluto brusco bastava per andare a lavarmi. Si é
stranieri sul posto, proprio dove si @ nati. Solo li é
possibile sapere che non esiste terra di ritorno.
Un cono di detriti accumulati in una cavith del
sottosuolo arse tra i vecchi quartieri per giorni.
Ci sono citta che poggiano sull’acqua, altre sul
vuoto. Napoli sta su una mollica di tufo interrorta
da spelonche, cave sotterranee, canali perduti. Il
terremoto che si carica sotto di essa trova camere
@aria in cui rimbomba a onde, canta, ringhia. Gio-
vanni nell’ Apocalisse, P'ultimo dei Libri, ha provato
a scrivere quel suono.
Ogni tanto le stive di pietra cedono in un punto
el sottosuolo esala. Il cono di detriti arse per gior-
ni. Si levava in cielo il grappolo di fumo, lo vedevo
da piazza Cavour, lo annusavo. Lasciava cadere, a
41
REE TEE “sO OO OOOO ae
fiocchi scuri, ceneri di rifiuti che provavo a distin-
guere.
“Niente forza i ricordi a venir fuori, come gli
odoti ¢ le fiamme,” scriveva Céline mentre bruciava
Ja sua stanza in Africa e gli tomnava in mente un in-
cendio a Parigi. Non cosi per me: ho visto di notte
esplodete una raffineria e di giomo i fald di benzina
nelle strade, ho visto i campi in fiamme, perd quel
fuoco non somigliava a niente. Sottoterra sentivo
bruciare un cimitero: ossa, scarpe, rosari, fiori, lam-
pade, croci. Fiutavo per aggiungere sentori al cata-
logo dei combustibili. Il fumo saliva dal pozzo cre-
pato, dai tombini, dai tubi e da una cremazione ge-
nerale. Volevo imprimerla nel naso, credevo e credo
ancora che la citta in quel punto stesse esalando, se
Yaveva, Panima.
Linverno si era spinto fino a meta primavera. In
casa a sera poche frasi, cosa pensi, dove sarai doma-
ni, non aspettarmi sveglio. Non mi svegliare, aspet-
ta, verta Pestate che abbiamo messo via poco per
volta. Gia era alla finestra la chioma di capelli spar-
sa a matassa sciolta: Vasciugava al sole, era di mag-
gio. Si lavava di me, dell’odore di resina, del sonno
di legno, staccava dalla stanza le sue cose. Nean-
ch'io resto, se vai. Pianse nel cavo delle mie mani
asciutte, non cadde goccia a terra.
Tl Viaggio era finito. L’io del romanzo tornava a
Parigi nel chiasso di una festa di quartiere. Le pagi-
ne erano a brandelli, avevo perso i pezzi a forza di
sbattere il libro tra la gente. Le ultime venti le tenni
42
piegate in tasca ¢ le lessi come una lettera. Lei non
Paveva lasciata. Fuori della stazione le gettai su un
mucchio di rifiuti. Non conservavo la posta.
“Lontano un rimorchiatore ha fischiato,” Pulti-
mo capoverso del libro suonava a un battello sulla
Senna. Mi restd impresso nelle orecchie il suono im-
maginato, mentre attraversavo il piazzale. Aspettavo
un fischio, una sirena, da un treno di passaggio che
rispondesse in tempo a quel richiamo. Volevo allora
che i libri stessero al mondo come angeli custodi
degli addii. La cittd non rispose.
B
UNA SPECIE DI TRINCEA
“Nuovi Argomenti” 1992
Quando trovai la fogna fui felice, ma non potei
sortidere. Il rischio di troppi giomni mi aveva induri-
toi nervi. Con il piccone aprii una breccia sulla par-
te superiore del collettore che avevo raggiunto e re-
spirai quel tanfo come un profumo di vittoria, Non
ero impazzito, ero invece in salvo.
Da molti giomi eta cominciato lo scavo. Partiva
dalla villetta, attraversava un giardino ¢ artivava sul-
la strada, intralciandone meta. La sotto, a una pro-
fondita che ignoravamo, avremmo trovato la fogna.
Cominciammo in molti, poi, quando lo scavo diven.
ne pitt profondo di un uomo in piedi, restammo so-
Jo in due, Era largo un metro, il minimo per tigirar-
si, e nel punto in cui trovai la fogna fu profondo sei.
Bisognava collegare un condotto dalla villetta al col.
lettore.
Scavammo in due in quella fossa stretta per di-
versi giomi, ognuno dei quali era pia buio del pre-
cedente. Mettevamo lo sterro in recipienti che issa-
vano dall’alto con una carrucola. Entravamo allal-
ba, uscivamo, salvo la pausa di mezzogiomo, alle
cinque. Anche chi non @ del mestiere sa che una
a7
fossa del genere va rinforzata alle due pareti con
travi verticali bloccate da puntelli a contrasto. Altri-
menti é possibile che crolli. I! capomastro non volle
prowedere. Percid scavammo in due, facia a fac-
cia, sapendo in che diavolo di trappola eravamo fi-
on Chi eravamo e perché accettavamo quel ri-
schio?
Uno era un algerino di quarant’anni, uomo so-
brio di poche parole. Era ultimo assunto in cantie-
re € non poteva rifiutarsi, lo sapeva: lo avrebbero
messo alla porta. Che avesse bisogno di quel lavoro
non occorre ditlo: era arrivato da poco a Parigi,
parlava poche parole di francese, eta il suo primo
lavoro in terra di Francia. L’altro ero io, trentaduen-
ne manovale italiano, assunto gia da diversi mesi e
‘mal tollerato dal capomastro francese. Al mattino
ero tra i primi, ma anche a sera: ero il primo a stac-
care alle cinque. Non suonava una sirena, ognuno
doveva regolarsi da sé e questo faceva in modo che
nessun operaio smettesse i uturiv, remendo di mo-
stratsi poco attaccato al lavoro. Percid ognuno di
loro finiva per regalare del tempo non retribuito a
un datore di lavoro esperto in vari trucchi del gene-
te. Io staccavo alle cinque in punto e poi non volevo
fare gli straordinari nei giomi non lavorativi. Que-
sto andava di traverso alla comodita di disporre con
elasticita della manodopera. Non ero elastico, anzi
cro piuttosto rigido, indurito nei muscoli e nel son-
no. Mi erano percié volentieri assegnati i lavori pid
feo, i pid sporchi, Ero Punico di pelle bianca a
Alora di mensa tra brodaglie assortite con spe-
48
zie violente si chiacchierava nel rozzo francese co-
‘mune, poi ognuno tornava ai suoi pensieri in lingua-
madre. Mi chiamavano Italia, ma non mi sentivo
membro di una nazione, non difendevo i colori di
una maglia 0 di una pelle, nemmeno la mia. Accet-
tavo il soprannome, !'talia lavorava sodo e non to-
glieva il posto a nessuno, pérché nessuno voleva il
suo posto. Avevo bisogno di quel lavoro, lo avevo
trovato a stento dopo aver battuto per settimane la
periferia di Parigi. Lo avevo ottenuto, volevo tener-
melo, malgrado tutti i dannati capimastri. Se voleva
un pretesto per sbattermi fuori non gliclo avrei da-
to, sarei sceso in gola all'inferno, ma non mi sarei ti
rato indietro.
Ecco perché in quei giorni due uomini che non
si conoscevano e nemmeno sapevano chiamarsi per
nome, stettero facia a faccia in una fossa rischian-
do la pelle in cerca di una fogna. Ogni metro di
quel buco stringeva il cielo a una striscia larga quan-
to il cunicolo in cui stavamo. Ogni metro di quel
buco poteva crollarci addosso e tenerci sotto il tem-
po utile a essere sepolti vivi.
Gli altri operai al mattino non ci dicevano pitt
niente, tiravano via zitti al loro lavoro. A mezzogior-
no qualcuno ci offriva da bere. Rifiutavo, mi era
cresciuta in quei giorni una collera sorda contro tut-
ti, una furia sottopelle che mi faceva sopportare le
ore Ia sotto. Quanto durd? Nemmeno molto, una
dozzina di giorni. Alla fine della: prima settimana
Tuomo che avevo di fronte comincid a non poterne
piil. Nel buio rischiarato dalla lampada, Ia sotto era
neto anche a mezzogiomo, c’erano quegli occhi
49
scuti tondi, spalancati, la faccia che grondava, lin.
Vocazione ormai automatica che riesco ancora.
sentire se mi tappo le orecchie: “Trouvé? Tu Pac
trouvé?” voce rauca di uomo che si sente perduto,
fiato comune delle trincee di questo secolo. No, non
Tho trovata ancora, ma dev’essere vicina. Fatti sosti-
tuire, amico, il capo non ce ’ha con te, tu hai fatto
4a tua parte. Gli dicevo cos, Iuiallora stava zitto
non parlava pit. Aveva chiesto agli altri opera alge,
Tini, nessuno voleva scendere li sotto. Allora gli di-
cevo che sarebbe crollata di notte quella fossa, mai
di giorno che era bene asciutta, di notte invece, con
Pumidita. Inventavo spiegazioni, un poco mi crede
va, ero istruito. Non sarebbe crollata quella fosse,
‘non aveva varcato il mare per finire sepolto con un
napoletano, saremmo invece morti in mare, sui
monti, ma non I, Questo non glielo dicevo, non si
deve parlare di morte coi piedi nella fossa, Cereann
di calmargli la paura, ma lo facevo per me perche
avevo bisogno di Jui, in due avreinmo fatto prima
Se fosse scoppiato, se si fosse fatto licenziare ave;
dovuto finirlo da solo quello scavo, ci avrei messo df
id, avrei rischiato di pit. Ma perché un uomo dlo-
veva patire in quel modo, perché al mondo un esse.
re umano doveva guadagnars il pane peri suot fig
con una corda al collo? Per me era una questione di
orBo¢lio inferocito, ma per Ini quello era solo pane
© doveva invece bagnarlo di quell’acqua nostra eala,
ta che al gusto cosi tanto somiglia alle lacrime, Allo.
8 pensai che non mi era di nessun aiuto, me la sanei
cavata meglio da solo Ii sotto. Cosi durante ora di
mensa andai dal capomastro che mi guarda bellico,
30
s0, pronto com‘era a dirmi che quello era il lavoro
se'non lo volevo fare quella era la porta. Gliclo ave-
vo gi sentito dire ad altri, Davanti agli opera gli
dissi che Ja sotto non ci si rigirava pit, che in due
era impossibile continuare e che la fogna era ormai
vicina. Gli chiesi di lasciarmi terminare il lavoro da
solo. Mise gli occhi nel piatto e fece di si con la te-
sta.
Cosi dopo Vora di mensa entrai da solo nella fos-
sa. Per la prima volta in quei giorni fui calmo, senza
uell'vomo la sotto mi seni sollevato. Non lavora-
vo pit solo di piccone, avevo anche da spalare. Ci
avrei messo di pid, ma non avzei avuto addosso
quegli occhi, quel fiato (“Trouvé? Tu I's trouvé?”)
tutta la materia umana che sotto l'infamia gronda
di sudore e senza volerlo implora dall ultimo scono-
sciuto la salvezza. Ma questo Io intendo adesso che
per la prima volta ricordo quei giomi. Allora pensa-
vo soltanto che non avevo. hisogno di Ini, che non
avevo bisogno di nessuno per trovare quella danna-
ta fogna, Senza la sua pena mi sentivo leggero, Perd
quel collettore non lo trovavo. Passarono cosi altri
Biorni, il cielo dei mattini d’agosto in terra di Fran-
cia era splendente. Dal fondo del fosso sembrava un
canale. Sudavo poco, faceva fresco la sotto. Qualeu-
10 dallorlo dello scavo si affacciava ogni tanto chie-
dendo: “Ca va?” Rispondevo invariabilmente:
“Crest la villégiature”. Se in alto sulla strada passava
tun camion veniva git terra dai fianchi dello scavo.
Era il suo modo di sudare, di tendere i muscoli per
non crollare: grondava terra. Sta dalla mia parte,
pensavo. A volte un lavoro anche duro non basta a
51
tenere quieta la testa, petcid uno da solo per otto
ore al giomo in un fosso finisce per avere un sacco
di tempo per inventarsi frottole ¢ favole. Pensavo,
Jo ammetto, che quel budello avesse un corpo
un’intenzione, per esempio quella affettuosa di non
finirmi addosso.
Uno di quei giomi qualcuno per scherzo buttd
néllo scavo una rozza croce, due pezzi di legno lega-
tiad angolo retto da una corda. Cadde vicino al pic-
cone. Mi arredano Pambiente: provai Yimpulso di
risalire di corsa e dar la caccia a chi voleva giocare
con me al becchino. Un morto che risorge croce in
pugno’e si mette a inseguire il corteo funebre: sic-
ché sorrisi.
Quando affondai il piccone nella terra e il ferro
rimbalzd contro la volta del collettore fognario con
suono di rimbombo, fui felice. Ma non potei sorri-
dere, i nervi mi legavano stretto i muscoli del viso
come lo spago dell'arrosto al forno. Volevo gridare,
neanche quello usci. Con la pala liberai bene il pas-
saggio e con un colpo secco di piccone sfondai la
volta sulla quale finalmente poggiavo i piedi. Chissa
se qualcuno & stato mai felice di odorare la merda.
Io lo fui e anche gontfio di orgoglio feroce di averce-
la fatta, mischiando cosi a quell’odore naturale
quello innaturale della spazzatura di sentimenti che
avevo provato dentro di me in quei giomi. Merda
su merda, Ii sotto devo essermi sentito in quel mo-
mento in pace, anche se non tiesco a ticordatlo. Ci
dev'essere stato un pareggio tra me e quella fogna,
della propria vita, per cavarsela si bussa a risorse al-
Te quali in quel momento non si chiede da dove pro-
vengano. Quei pensieri di orgoglio servivano a te-
nermi fi sotto senza chiedere scampo. Mi hanno re-
so un buon servizio, ma erano pensieri di merda.
Fui felice di avercela fatta conto quel bestione di
capomastro che non avrebbe pagato niente per la
morte di un manovale sepolto sotto una galleria
crollata,
Venni fuori prima del tempo quel giomo-e
cognuno mi chiese se Vavevo trovata, temendo che
avessi deciso di mollare. Rispondevo portando al
nnaso due dita per tapparlo. E finita la villeggiatura?
Erano lieti che ce Pavessi fatta. Ognuno di loro
peva di aver tollerato la morte possibile di uno di
loro senza aver fatto niente per impedirlo. Ma fare
qualcosa per me potevano solo rischiando il loro
precario posto di lavoro oppure mettendosi al posto
mio: non si pud chiedere a nessuno di uscire dai
ranghi c alzare la voce o la croce. Perd gli uomini
che apprezzano in un altro uno scatto che essi han-
no dovuto reprimere, poi sono amici. Quel giorno
alle cinque di sera gli operai staccarono tutti insie-
me, Alle cinque in punto nessuno era pitt sul posto
di lavoro, Sortido per simpatia adesso, allora ci ba-
dai appena.
Fu necessaria una settimana per Iallaccio. Gli
operai specializzati pretesero che tutta la fossa ve-
nisse puntellata a regola d’arte. I capomastro era
fuori di sé per la perdita di tempo, mi additava loro
per dimostrare che non c’erano rischi, s'azzardd
perfino, affannato com’era, a chiedermi in loro pre-
3B
BN BL —_— EN
senza se veniva giti terra dalle pareti, sperando in LA PRIMA NOTTE
una mia compliciti. “Come grandine,” fu il mio
contributo.
Forse nella vita di ognuno capita un giorno in
cui si 2 felici di odorare la merda. So di essermi
comportato male contro la mia vita, di averla gioca-
ta per orgoglio, collera e chissa cos'altro sta nel cuo-
re di uno. Anche se poi alla tavola delle molte lin-
gue il mio posto venne tenuto in conto e molti mi
invitavano a sedere accanto a loro, vorrei che nessu-
no pid andasse con un piccone a bussare alla pro-
pria fossa sperando che non sia ancora pronta.
34
“Panta” 1993
Non era la prima notte che uscivo per un’imbo-
scata, era la prima in cui tornavo dopo avere am-
mazzato. Entrai in casa con un solo male ¢ una sola
urgenza: freddo e bisogno di stringermi a Nera. Di
tutti i pensieri immaginati prima, delle reazioni che
mi ero preparato a governare, solo quella venne: an-
dare a casa e stringerla, Nera viveva con me, magra,
di pelle opaca e capelli scuri, ciabatte ai piedi, bella
da nasconderla, vent’anni per uno noi due, soldi ap-
pena e spazio scarso, Poco sorrideva ma quando:
lora sprizzava bianco dagli occhi ner e il sorriso fa-
ceva rumore, rumore di anguria spaccata da un col-
tello, Sulla sua faccia si apriva un chiuso di dentro,
di finestre e scintillava il chiaro come luccica lo
spacco dell’anguria. Da Nera tornai svelto, non cer-
cavo il sorriso ma il suo caldo perché avevo freddo.
Non sorrise, aspettava, da un po’ aveva cominciato
ad aspettarmi, disse. Non sapeva di me, non ne vo-
leva sapere delle assenze, del dove e del cosa, ma
poi chiedeva senza mettere il punto interrogativo
nella voce: “Hai fame,” “Hai freddo,” “Hai tem-
po”. Avevo appena ammazzato un uomo, mia prima
7
volta e avevo addosso il freddo, un gelo nelle mani,
ma di pit nella schiena. Né vomito, né affanno, né
ansia, ma un vecchio freddo di bambino che veniva
agli inverni di una citta del Sud, nessuna casa ri-
scaldata e si provava caldo solo di notte, a letto.
Avevo il freddo del Sud, nelle aule coi vetri man-
canti non bastava il cappotto, la sciarpa, a farci stare
fermi nei posti, Eravamo stanze di tarantolati, sgam-
bettavamo sotto i banchi, ci soffiavamo il fiato nel
colletto. Quella notte riebbi quel freddo, riassunto
generale degli inverni del Sud.
Non sapeva dove andavo certe sere, i soldi della
aga di operaio glieli davo tutti, le bastava che non
odorassi di altre donne. Aveva un naso dritto come
una prua ¢ fiutava odori a distanza, distinguendoli
nel mucchio anche sotto il mio sudore. Non le ho
mai fatto il torto di cercare un’altra donna, avevo
vent’anni ¢ un cuore chiuso. Quella notte non mi
aveva odorato allargando le narici perfette sotto”ali
occhi cupi, ispirando come sempre faceva un breve
tiro d’aria, secco, sufficiente. Passavo quell’indagine
volentieri, non mostravo di accorgermene, era il suo
modo di accettarmi ogni volta. Mi facevo in mente
uno scherzo, mi dicevo: il giomo che mi fiutera due
volte, mi rifiutera. I giochi di parole alle volte fanno
sul serio quanto le profezie. “Hai freddo,” chiese e
dissi di s. “Andiamo a letto.” Fu mentre mi spoglia-
vo che ci pensai: non mi era venuta vicino’a tirare
su col naso. Poi mi strinsi alla sua came buia e nem-
meno un bacio mi us¢i dalle labbra. Né li cercd, né
me li diede, mi stringeva per soccorso di un corpo
pronto sempre a riscaldarne un altro. Non mi tre-
38
mava il fiato, ma la pelle, brividi mi passavano a
sciami lungo la spina dorsale. Viaggia cosi anche i
terremoto dopo che ha scaricato i suok.colpi addos-
so al suolo, sfibrandolo poi con i tremiti. Eravamo
abbracciati di fianco nel nostro incastro di amanti,
ma nessun gesto confondeva i sensi spingendoli al-
amore. Eravamo fermi, tenevo gli occhi chiusi sot-
to il liscio dei suoi capelli neri. La schiena scaricava
brividi a ondate. Non mi bastava il suo calore ma-
gro, cosi mi rigirai dando la schiena al suo petto, le
presi le braccia e me le strinsi addosso come una co-
perta, Aprii gli occhi, rividi gli spari, il crollo del-
Puomo che prima non voleva morire e poi non ci
riusciva e i colpi di grazia come calci addosso. Un
altro assassino al mondo, buono a questo come ad
avvitare il mandrino al tornio, buono a lavorare pez-
zie far saltare schegge esatte, portando via dal grez-
zo la parte necessaria. Quell’ammazzato era scarto,
eccedenza? Non questo, non ero operaio di storia,
arruolato in un reparto che doveva prevalere. Ero
un assassino per vendetta di sangue, lontana conse-
gna da dimenticare solo cosi. Levavo al pezzo parte
di carne mia, vecchio rancore di padti, storie di san-
gue nostro di Sud che si mischia con quello di chi ci
ha gjurato morte. E viene un giomo per noi tutti, in
cui non siamo stati meno cauti e in strada ’@ un ra-
gazzo che tra furia ¢ affanno ci tagliera la strada.
‘Avevo vent’anni ed ero pronto a questo da quando
ho imparato a scrivere il mio nome.
Chiusi gli occhi a un’altra scarica di freddo, lei
serrd forte il petto teso contro di me a placare la
raffica intreccid le gambe tra le mie. Nera, mia
39
fortuna che fosse li addosso a me, la stanza in perso-
na, la notte in persona. Il suo corpo paziente non
voleva capirmi ma neanche mi fraintendeva, le mie
strette non cetcavano amore, nemmeno erano vo-
slia, ma altro, Pimmenso altro che sta sotto i gesti
pid semplici.
“Hai ancora freddo” e i corpi erano un pezzo da
due che savvitava dentro il tomio e vibrava perden-
do insieme al troppo il resto, Non parlavamo, era
soltanto amore che tirava a durare, amore dei ven-
Vanni con il rasoio ‘sulle parole in pid, amore a to-
aliere, fino a scambiarsi solamente il caldo.
Non era come la volta che ero rimasto troppo a
Iungo sott’acqua a districare un polpo dalla tana ed
ero tisalito senza pitt aria e quel soffio inghiottito
appena emerso era stato bruciante come quello che
squarcia i polmoni di pesce di un neonato. Allora
avevo avuto freddo in pieno giorno di luglio e avevo
tremato come nelle ricadute di malaria e Nera mi
aveva coperto di sabia e poi si era sdraiata su di
me € mi teneva le mani sulla bocca a trattenere la
mandibola dallo sbattere in tremito contro i denti.
Mi era corsa incontro gia in mare, mi aveva tirato a
riva e io non controllavo il mio peso e mi cadeva di
dosso perché voleva sdraiarsi il peso, il corpo. E a
riva si era rovesciato al sole e li si scatenarono i ner-
vi nel tremito, raffiche di scosse che dal fondo si
scaricavano sulla superficie. Era il freddo di un cor-
po che scappa dalla morte, dalla morsa gelata che
spreme come un limone il cuore. Era il freddo fre-
60
netico della vita che riparte, ingolfata, elettrica fru-
stando i nervi dentro e l'aria fuori. Non come quel-
lo era il freddo della mia prima notte d’assassino.
Quella volta sotto la sabbia e sotto di lei ¢ sotto il
sole di luglio, quella volta sotto i piti bei panni della
vita ero riuscito a scaldarmi. E quando riebbi caldo
mi accorsi dei segni di ventose sul braccio, ulcere di
un awvinghiarsi a me del polpo in tana. Ci doveva
essere stato un momento in cui non io cercavo lui,
ma lui me, un punto sul fondo del mare in cui io
avevo smesso la caccia e lui laveva iniziata. Un pol-
po in tana, anche piccolo di pochi chili, pud tenere
fermo un uomo e prosciugargli l’apnea, se non si li-
bera dalla morsa tagliando i tentacoli. Non avevo il
coltello, mi ero liberato da solo o mi aveva lasciato
Tui. Un polpo saggio tra le rocce del fondo mi aveva
insegnato la morte. Molto pitt tardi ho pensato che
‘un assassino deve conoscerla prima di darla. Quelle
ulcere sul braccio furono il tatuaggio di un'intera
estate,
Il freddo nel letto non si placava, Vabbraccio
non bastava. Era una diarrea di gelo che contraeva i
nervi a ondate e mi lasciava spento. Nera non mi di-
ceva niente, sentivo la sua forza, aveva i muscoli tesi
¢ io serravo il suo corpo addosso al mio come una
pelliccia. Sudava per lo sforzo, era calda come per
amore, ma non soffiava forte, non fiutava come per
amore. Aveva la guancia appoggiata ai miei musco-
li dorsali e mi ascoltava battere, orecchio sulla
schiena, battere piano ¢ questo le piaceva. Le piace-
vano i colpi lenti, pieni come pugno e tamburo, me
a
lo diceva: “Vivi dentro come una machina battipa-
lo”, Era suono della sua infanzia, un padre ingegne-
re che se la portava dietro sui cantieri e quei colpi
che affondavano nel suolo per fondamento, quei
colpi ascoltati tante volte erano la sua fierezza di
bambina che passava giomnate sui lavori. Il mio bat-
tito glieli ricordava. Aveva Vorecchio sulla mia
schiena, mi ascoltava andare e non si voltava per
nessuna ragione, per nessuna tenerezza. Era li a
scaldare il corpo di un assassino, un lavoro sempli-
ce, serio, eseguito da innumerevoli donne prima di
lei, lavoro saputo senza doverlo imparare, fatto sen-
za chiedere. Era carne che soccorre con il suo forno
acceso ¢ non c'entrava amore, 'avrebbe comun-
que fatto. Voglio credere che l'avrebbe fatto anche
se le avessi detto che era la mia prima notte d’assas-
sino, Ma non parlavo, non ho parlato e anche se
adesso scrivo non @ la mia voce, non é parlare que-
sto, ma raccontare, mandarsi nel wnoto, non con
due occhi in facia a un’altra faccia. E si pud pren-
dere il vero da qui secondo i gusti, anche niente o
per intero, resta sempre racconto e non porta la mia
voce. Solo Nera sa che quella volta io le cercavo il
corpo per bisogno di stanza, perché avevo l'inverno
sulfalbero dei nervi e avrei cercato fogli di giomale,
cartoni, fieno se non avessi avuto lei. L’ho avuta, a
braccia piene ho avuta: avidita, avvinghio, avanzo,
avvento, poi ho saputo che “av” in una lingua é pa-
dre, Nera che non ha conosciuto questo di me, solo
questo, lei sola pud in ritardo sapere di avere scal-
dato un assassino, Adesso @ madre in qualche let-
to migliore e forse non ha pit stretto a sé un uomo
gelato,
I freddo non smetteva. Allora spinsi il mio sede-
re dentro il suo bacino, spinsi fino a piegarla ¢ fare
io una curva dentro di lei. Mi lascid fare, gli uomini
sono bestie da prendere a verso ele donne governa-
no bestiame da sempre. Mi tenne come una capra
malata che non bisogna perdere e che fai stare in
casa, una notte d'inverno che rischia di ammazzarla.
Cosi fui, bestia al suo fianco, dentro la sua curva,
anfratto in cui cercava puntello un uomo di ventan-
ni che si accorgeva di essere un polpo e quel freddo
eta il braccio che lo scuoteva braccandolo a tentoni
nella tana. La branda era scomoda e con un colpo
pit forte la spinsi fino a sbattere il suo sedere con-
tro il muro. Nera tise, calma, Lei rise e non ebbi pitt
freddo. Rise, colpi di gola che andavano a sfumare,
zoccoli al trotto sulla neve, reagiva ai miei colpi re-
stituendo quello, suono del suo petto scuro, riso
breve. Mi fermai, lei tornd ad appoggiare Porecchio
sulla schiena. Il freddo eta finito. Lo aspettai spian-
do i segni di un altro scroscio sui nervi. Era finito b.
Cosi dopo un poco le sciolsi le mani e mi voltai a
guardarla, Nera no, mirava al soffitto e aveva il vuo-
to in faccia, Era stata svuotata di calore, il naso drit-
to che fiutava la stanza, profilo delle denne di costa
che spartiscono il vento gia con le narici. La bocca
era seria, stanca, con una fessura che lasciava splen-
dere un rigo dal bianco dei denti.
Trovd il seguito di sé solo dopo essersi staccata a
8
forza da me, senza toccarmi. Mi piacerebbe ricorda-
re se tird su due volte con il naso il giomo che
aspettd il mio ritomo dalla fabbrica con il cappotto
addosso ¢ Ja valigia pronta. Aveva trovato una sca.
tola di cartucce mettendo a posto la mia roba, “Qua
non ci voglio pit stare.” Avevo le mani nere di gras-
so e fu una buona scusa per non toccarsi. “Nera,”
tutto quello che mi usci di bocca fu il suo nome, lei
rispose: “No”.
Cosi fu quella mia prima notte da assassino. Ave-
vo compiuto Vatto dei padri, quello che annoda un
uomo a una famiglia e gli cuce sul cuore un centrino
peril tiro al bersaglio. Ho avuto qualche altra notte
di sangue e nessuna donna nella stanza di titorno.
Non ho pit avuto freddo ad ammazzare, né urgenza
di un corpo a saldo di quelle notti. Nera mi ha scal-
dato una volta per tutte la spina dorsale, quel basto.
ne ricurvo che assomiglia allo scheletro di un ser-
pente. Perché quando uno ammazza é tutto spinto
in avanti, al frontale dell'urto, dritto senza frenare.
Poi i colpi rinculano e vanno a scaricarsi dietro, dal
dito al polso al braccio fino alle vertebre legate alla
spina dorsale e li si fermano. Tutta la morte finisce
sulla schiena.
Quella notte s'addormentd svuotata ¢ ascoltai il
fiato del suo sonno: era caldo, forte, lo chiamavo
scirocco, soffio di un vento che non aveva incontra.
to giardini nel suo viaggio ma sabbie e quel poco di
umido se era preso dentro attraversando il mare.
“4
Sentii le folate del suo sonno scirocco, mi voltai di
nuovo di schiena e le accolsi con la gratitudine di
un legno che ha una vela. La mia spina dorsale era
albero maestro, le mie spalle una tela latina e il suo
fiato era il vento delle notti che pitt mi hanno porta-
to lontano.
6
"MORE,
|
i
Era un amore ancora intero quando lo strap-
pammo, Lo squarto in tempi solamente adesso, lo
seziono in un principio, un corpo, un’estinzione.
Allora eravamo incastro a coda di rondine, da non
poter distinguere nell’angolo retto. dei corpi il suo
dal mio. Ora @ amore, una terra bruciata vista da
lontano, prima era bosco fitto, umido, senza cielo.
Mi aveva voluto. Mi aveva staccate dal mucchio
di teste in una sera d’osteria, mi aveva estratto co-
ero, ingiallito, pagina di foglia fitta di vene e ru-
ghe, fibroso come un legno di rose, spessito come
un sonno senza sogni. Era venuta a casa, avevo cuci-
nato e poi era stata a sentire una musica che sapevo
fare. Venne vicino ad ascoltare, con Porecchio sotto
Ja mia bocca, finché mise la sua sopra il canto ¢ lo
spense come fanno due dita umide e svelte sopra
una candela. Per un momento ci separd il legno del-
la chitarra, poi niente altro.
Venne da me contro la sua vita, contro la sua ca-
sa, le stanze precedenti, gli amici chiusi a coppie in
serate di mezz’et&, un marito gi pronto e inginoc-
chiato in chiesa. Contro la sua vita: quanto poteva
oo
durare, un mese? Durd un anno, uno intero contro
tutti gli altri passati e tutti quelli a seguire, un
per gridare esultando d’improwviso per una fe
di came spalancata. Stringevo senza capire: amore?
Lo chiamavamo in fretta, di sfuggita, solamente
“more, crampo di poche parole, avido d'altro. Tor-
navo dal lavoro ¢ poi ci seguivamo in ogni stanza,
solo per starsi al fianco in ogni soprappensiero, an
che leggendo, studiando io qualcosa di lingue remo-
te accarezzate per bisogno di crescere.
Fu estate, venneto notizie, “forse ti arresteran-
no,” “vattene,” “non me ne andrei” e il pensiero
che questa era per lei una soluzione. Estate in bro-
do di noi, pitt forte Pansia di trattenersi, di mi-
schiarsi, di affondare insieme nell’apnea: sotto il pe-
Jo del mare coi corpi formavamo la Ienta figura di
una stella, Non mi chiedeva niente, né il passato né
il dopo, perché non era nostro. Fingeva di rischiare
un figlio, sapevo che mentiva e non me ne importa-
va, Ammucchiavamo giorni, alcuni in montagna, at-
rampicando. Mi seguiva in tutto, senz’altra voglia
che di starmi accanto. Non le piaceva salire, afferra-
re piccoli appigli nel vuoto tenuta a me solo dall’es-
le centimetro di spessore della corda. Ai due capi
erano stretti nodi paralleli sopra l'ombelico. Non
aveva paura, di niente aveva paura con me, se le era
bruciate tutte alle spalle in quel tempo di vita con-
tro se stessa. Sbuffava per fatica e in cima si voltava
appena, senza badare allimprowviso largo d’oriz-
zonte che si apriva.nell’angolo giro della sommita,
dopo tante ore passate a mettere passetti ragionati
sull’abisso. Voleva solo raggiungermi, guadagnare
70
in fretta il punto d’arrivo del giorno per tornare alla
stanza dei nodi slegati. Scendevamo a valle lungo
ghiaie bianche abbaglianti come i grembiuli delle
balie sedute al sole del lungomare di Napoli; mi
correggeva: come uova sode e cipolle. Forzavamo la
corsa nella discesa senza un grido, veloci tra i bloc-
chi che scivolavano intomo ai nostri sali. Scendere
scale, scendere ghiaioni: improvviso un ritmo dei
passi ci faceva voltare Puno verso laltra perché bat-
teva i colpi dei nostri abbracci. Senza sorridere i
nostro corpo apparecchiava il prossimo.
‘Avvolte piangeva. La sua vita, la casa, il marito di
salgemma inginocchiato al marmo in attesa di sor-
gete al suo fianco, tutto chiamava indietzo. Invece
di scontrarla, accarezzavo la sua nostalgia, un sipo-
stiglio che non mi spettava, anche un figlio da dare
al suo ragazzo infranto sulla soglia. Ero lestraneo,
Vaffanno, cuore di un alveare inferocito, da leccargli
il fondo ma con lo sputo in gola. E io credevo che
non potesse pili smettere per tanto che ci eravamo
consegnati i corpi. Nessun distacco poteva pitt resti-
tuitceli, il mio stava nei suoi nervi ¢ lei mi aveva
stampato a caldo il suo sotto le dita, impronta digi-
tale che per maledizione non avrei pit
Parole sue scritte su biglietti e tovagliol
me sarai dannato,” “vorrei le tue cicatrici,” “mi al-
Iontano col terrore di compiere un’infamia”.
Cosi quel?autunno fu pieno di foglie che non
volevano cadere e bisognava scuotere gli alberi per
vedere Pinverno. Non soffiava un’anima di vento,
tutto si conservava in una luce tagliente. Mi aveva
controvoglia regalato un coltello, un Pattada perfet-
n
to. Controvoglia: lo chiesi non con permesso ma per
esigerlo. Quest’anno lho perduto in montagna, sca-
lando tra le Odle. Me lo dette, me lo dette aprendo-
Io e facendomelo prendere dal lato della lama. Lo
trattenne serrandolo un poco intorno al manico,
strinsi la lama nel palmo lungo il solco che i chiro-
‘manti chiamano linea della vita. Avevo spessore nel
cavo della mano, glielo tolsi senza ferirmi. “Se me
ne vado, che farai?” chiese. “Non fard niente, pro-
prio niente, non viaggerd lontano per dimenticare.
‘Mi alzerd tutti i giorni, lavorerd sodo come sempre,
a domenica andré ad arrampicare. In una settima-
na avtd di nuovo imparato a dormire da solo.” Tira-
vo a indovinare su di me, sbagliavo di poco, ma par-
avo soltanto del corpo.
Credevo non potesse pitt vivere senza il mio, ma
non era cosi, non era come in cordata sulla prima
torre del Sella, Poteva sciogliere la doppia gassa da-
mante in ogni punto e solo la vertigine di questa li-
berta la tratteneva. Ancéra, ancéra, adesso era lei
che guadagnava i giorni di un distacco che aveva
stabilito. Non capivo niente, pensavo di stare in una
sosta in parete e di recuperare la sua salita verso di
‘me tenendo tesa la corda che le finiva in vita. Ancé-
ra, ancéra, erano i giomi ancéra, io li scambiavo per
i giomi sempre. Non davano tregua, erano coltello
in pugno, dalla parte della lama, ‘more.
Sorrisi da adulto alla richiesta di andare al luna
park. Ci passammo due pomeriggi. Mancavo a quei
giocattoli giganti da bambino e fui travolto per col-
pa del sorriso sbagliato. Avessi sorriso da tagazzo
pirata non sarei barcollato in quelle machine speri-
2
colate che spingevano lo stomaco verso Puscita. Re-
spiravo con la volonta, come inghiottire. Lei in cac-
, abbarbicata a me per annusare la mia confusio-
ne, la mia sorpresa di vacillare tra i voli, i precipizi,
le centrifughe, i salti mortali e tutto Varsenale di un
addestramento da astronauti. Ne uscivo rigovernan-
do Faspetto ¢ lei ne aveva gia avvistato un altro, un
marchingegno in cui si provava V'ebbrezza di stare
in un pistone d’automobile scatenato da un accele-
ratore. Respirava la mia adrenalina: non Paveva as-
saggiata in montagna, né ai giorni degli arresti. Ve-
devo il gioco mi lasciavo fare, era il suo, per una
volta in pit era il suo e lo bruciava, scatola di fiam-
miferi, zolfo da sentir friggere. Il carrello precipita-
va a picco dal punto piti alto delle montange russe,
uno scatto mi saldava le mascelle e vomitavo un rin:
ghio nella gola. Non chiudeva gli occhi, né guarda-
va il tracciato furioso della corsa, guardava me, esul-
tava affondando le dita nel mio braccio. Le piaceva
Ja mia tensione, “hai paura” mi fiatava roca nell’o-
recchio € non trovavo scampo a quella frase in nes-
‘una resistenza, “Hai paura,” ecco in qualcosa cede-
vo, venivo meno nel gioco, nelle trappole elettriche
dei vortici, dei salt e la sua frase aguzza passava sul:
la breccia del cuore. “Hai gli occhi pieni di sangui
Due pomeriggi al luna park di fine autunno: tra i
viali svuotati le machine rotanti erano mulini e ma-
cinavano gli ultimi gridi. A casa riprendevamo a fiu-
tarci, a svaporare chimica dal sangue, tracciargli una
strada diversa dai vasi, tracciarla a fior di pelle con
unghie, ciglia, denti e vedere che il sangue seguiva il
pifferaio di superficie
B
Autunno lucente, qualche grappolo d'uva di-
menticato sotto la pergola marciva in,un ronzio di
vespe appesantite. Dall’amaca il cielo s’arrostiva
piano oltre il campo, ci staccavamo e cucinavo un
pesce. Durera cosi, sara questo, ma se provavo a im-
maginare l'oltre mi indurivo. Era Natale quando
presi i miei panni dal suo armadio perdendone in
discesa veloce per le scale. Era finito un anno, quel-
lo della sua vita contro ¢ del male di ‘more, unghia
incarnita di feliciea.
CONVERSAZIONE DI FIANCO
“Nuovi Argomenti” 1991
eseeeeeeeeceeeem
Ero tomato da Torino alla fine di novembre del
1980. La grande fabbrica si era sbarazzata in una
sola notte di ventiquattromila coperti a mensa, qua-
rantottomila braccia, forse meno perché c'erano tra
ali espulsi anche gli invalidi. “Andate a mangiare
fuori.” E fuori eravamo restati quaranta giorni, not-
ti, fuochi per riscaldarci. Nessuno usciva, nessuno
entrava nella fabbrica che avevamo bloccato. Alla f-
‘ne restammo tutti fuori, amici, sconosciuti, vinti.
Tomavo a Napoli dalle notti passate davanti al
cancello undici di una fabbrica che aveva, come-Te-
be, cento porte. Ragazzi di molte parti d'Italia erano
diventati uomini la dentro. L’autunno del 1980 si
portava via quella gente, foglie che non volevano ca-
dere. Di notte reparti organizzati di dipendenti osti-
Hi al blocco dei cancelli cercavano di sfondare gli
sbarramenti, Giravo insieme ad altri in ronde not-
ture tra i viali, le nebbie, cercando quei reparti. In-
seguimenti, colpi scambiati tra uomini che avevano
perduto il sonno, erano gli ultimi calci, li sferrava-
mo forte.
‘Tomavo a Napoli, alle macerie fresche di un al-
7
_ a
tro accampamento, tutti fuori anche hi, per non farsi
crollare in testa la citta.
Una sera andai da Alessandra. Aveva amato
qualcun altro intanto. Dopo cena mi offri da dormi-
re, sapendo che era scomodo il viaggio di ritorno al
mio alloggio. Capii bene: dormire. Non avrei potuto
chiudere occhio in una casa in cui stesse il suo cor-
po. Riffutai, ma non che mi accompagnasse con la
sua macchina a casa. Ci atrivammo senza patlare,
spense il motore. Seduti di fianco, faccia al vetro
buio, restammo a parlare.
“Non & che ti penso molto, ma spesso ti con-
fronto, amico mio, con le persone che incontro e
provo Timpressione penosa che non ti valgano. A
volte ti nomino e ti accendo un elogio, come una
candela inutile nella luce del giorno. Le frasi che la-
sciavi per aria, mezze cantate, le ho coneluse tutte,
perd lo stesso mi prende lo sconforto. Eppure non
mi manchi tu come corpo d’amore.”
Parlava lentamente, cercando di essere precisa €
di trovare un posto giusto nel campo della nostra
lontananza. Parlando le saliva la tristezza, le torna-
vano a sospiri i pomeriggi di un anno, quando da
sola in una citta straniera e comoda aspettava il ri-
toro a casa di un uomo che non conoscevo. Si
scuoteva di dosso un brivido di malinconia. “Qual-
cosa di te mi ha avvelenato i sensi, ho sempre un
po’ di febbre.”
“Non da questi confronti tra uomini ti viene ma-
Ie, ma dalla distanza dalla persona che eri con me
che non ritrovi ora, Ti aspetti di veder sorgere al
mattino dal letto quella donna che faceva sprizzare
8
pietre dure dagli occhi di un uomo. Gerchi la dedi-
zione del suo corpo chino su di te, arco su balcone,
cielo su campo. E la donna capace di questo che
non trovi.”
“Non dire queste cose e tieni su Ia voce, non la
abbassare a soffio, non siamo vicini, siamo lontani,
grida.”
“Grido a labbra chiuse, amica mia, Tu cerchi in
un uomo la disperazione e lorgoglio, i pugni, i tre-
ni, V'inferno facile che hai saputo suscitare. Avevi un
trillo in gola, caldo, infame. La dove tu eri, I si aiz-
zavano minacce ¢ io sempre temevo che uno impaz-
ito d’amore potesse ucciderti. Anch’io avrei potu-
to, mentre sorridevi d’altro o ti chiudevi in una noia
di me. Mi tratteneva lo spreco atroce della tua bel-
lezza disfatta. Ti recitavo male, cupamente: ‘Esteri-
na, i vent’anni ti minacciano’. Tu eri in pericolo per-
ché quello era il tuo stato di grazia. Dove tu passavi,
orme d’altre donne sbiadivano. Sapevi dare il nien-
te, misura adatta a chiedere ogni cosa. Non io ti
manco, tu ti manchi.”
“Forse @ cosi. Forse succede che una donna si
interrompa, a ventiquattro anni, si lasci andare a un
amore tranquillo che le offre una stanza in una citta
ontana. Ma questo non spiega perché mi fa male il
tuo nome, perché ti sei sparso nei nervie non perdo
accasione, non manco un’allusione perché qualcosa
mi punga. Perché?”
“Perché non puoi accontentarti di essere da me-
no, per un uomo, di quello che sei stata per me. Ti
vedo stasera e ho sentito il bisogno di toccare in ta-
sca il coltello per risentire almeno nell’arma la furia,
9
il salto alla gola che mi davi. Non ho paura per te
adesso. Gli uomini non ti ammazzeranno. Io non
dovrd andare di terra in terra a cercare il tuo assas-
sino per tagliargli la strada.”
Parlavamo nella sola maniera che avevamo impa-
rato, Mai con calma, mai, con febbre invece, due
che si erano aizzati in amore, estraendosi le lacrime
bollenti. Restava nel fiato il denso di abbracci che
non si erano potuti saziare. Perché con uno scarto
di violenza e pena ci eravamo staccati a viva forza.
Ripresi fiato, a fianco di Alessandra. Mi sembrd
strano riuscirci. La voce restava un soffio opaco,
continuai.
“La vita che abbiamo a vent’anni é esigente. Ap-
pena cediamo in un punto, appena le offtiamo una
debolezza, una pausa, quella erode, si incista, fa le
uova negli occhi e da quel punto muove la sconfitta
di noi stessi che all'improwviso, a distanza di anni ci
coglie. La vita dei vent’anni @ piena di parassiti an-
siosi di far nido in ogni rinuncia. Nel momento in
cui hai smesso di esigere da un uomo pid di quello
che ha, Ia tua bellezza s’@ fermata, chetata e ti pre-
para donna da marito, Eri donna su tutti gli uomini,
donna per ogni sangue. Eravamo in gabbia ¢ la tua
pelle buttava luce dal sudore. Ora sei pronta a esse-
Te una sposa.”
“Smetti. Pid niente sai di me, pid niente capisci.”
“Dawvero non posso capirlo. Indovinare forse,
ma capire no. Sei stata la fortuna e la pena, sei stata
il i nuziale e il no del mondo per la volta che rho
adorato, Sto smettendo, Alessandra. Mi sono ac-
campato fuori, sono di una porzione di uomini mes-
si alla porta. Questa citta crollata che dorme nelle
piazze @ il posto giusto.”
“Non dovevo portarti a casa. Non parlo di ora,
ma di allora, di quella sera di pizze sbadate che di-
ventavano fredde mentre ti tenevo gli occhi addos-
so. E non vedevo l’ora che tu tornassi dopo aver ac-
compagnato a casa gli altri. Non dovevo bruciare
dansia di baciarti il fiato, Varia che avevi intorno e
ti seguiva i gesti e la voce come una musica. Abi, se
cri giusto per me, se mi piacevi. E adesso, che mi
hai detto adesso? Cerchi sulla mia facia i segni di
un cedimento, sbirci le rughe precoci: ti pare questo
un dolore da sposa? Ti sei perso anche tu. Sei parte
di un crollo, e allora? Io avrd uova di mosca nel ta-
glio di una rinuncia, ma tu trascini una valigia di
macerie. Ti sei pure tenuto la barba cresciuta du-
rante il blocco della fabbrica. Si, fai bene, portalo
scritto in faccia, zitto di dentro ¢ illustrato fuori.
Non riesco a guardarti, posso parlarti solo cosi, di
fianco. Dove sono finiti i tuoi occhi che da soli por-
tavano carezze? Sembra che non abbiano pitt dor-
mito, occhi impossibil.”
Infine dopo avermi lasciato il tempo di inghiotti-
re a secco, mi prese la mano e mi disse:
“Non vedo I’ora che scendi da quella porta, dal
cuore, dalla machina. Ti prego, chiudi piano”.
Cosi mi sciolsi e uscii, restando ad aspettare che
tirasse via le marce fino in fondo alla strada. Intorno
la citta ubriaca di sonno dormiva per dimenticare.
‘Avevo trent’anni quella sera, ¢ nientaltro.
81
3
q
=
g
5
a
“Panta” 1991
Quando mor il nonno mi venne quel potere:fis-
savo il suo violino e le corde suonavano da sole.
Usciva una musica a onde, solfeggio di alveari, api
sopra un campo di margherite. Era il violino delle
sere, delle domeniche, dei balli. I nonno lo suonava
tomando a casa dal turno di lavoro in miniera. Era
la sua destrezza e la consolazione. Credo che si la-
vasse con cura e si cambiasse i panni solo per ab-
bracciare il suo violino.
“Come fai con quelle dita a suonarlo cosi bene?”
Calava preciso sulla tastiera cieca i polpastrelli an-
neriti, spessi come cucio, senza uscire di nota. Suo-
nava musiche pensate nei cunicoli, con la luce in
fronte e il buio alle spalle, quando la galleria gron-
dava come la sua fronte. Tornava a casa con quelle
note in testa e le faceva uscire a tutta forza e come
era possibile che un legno cosi piccolo avesse tanta
voce? Era musica scaturita tra un colpo di piccone e
altro, suono che stava nella terra e che si liberava
dalla scoria sotto i suoi colpi esatti. Estraeva ferro
per la miniera e musica per sé, fracassando materia.
La domenica suonava nelle feste i motivi del bal-
lo e dei canti. Mi portava con lui: ero muto ma mi
spingeva a provare un grido. Ne usciva un “la” sof-
focato sul quale accordava il violino. Mi diceva che
in galleria il piccone qualche volta produceva la no-
ta colpendo una vena di pietra pid compatta. “Tue
il ferro avete un diapason nel corpo.” Suonava sen-
za guardare la tastiera. Suonava per tutti ¢ mai per
denaro. “La musica si offende.” Restd nella galleria
crollata, sepolto lontano dal violino. Dopo che mi
finirono le lacrime, spuntd quel potere. Fissavo il
violino ¢ il violino suonava. Qualcuno mi spiava
nell’ombra, sorrideva ascoltando quel gioco. Ce
sempre un santo di sentinella a un’infanzia muta.
Ero magro, giravo per i monti, allontanandomi
dal villaggio. Crescevo arrampicandomi sulle rocce.
Conoscevo ali appigli, le asperita che accolgono ap-
pena una falange ¢ che insegnano a distribuire il pe-
so del corpo su minime sporgenze. Non facevo lega
con i ragazi del villaggio, crescevo sapendo che
non sarei andato in miniera. Preferivo i precipizi ai
cunicoli. A volte, sospeso sopra uno strapiombo,
sentivo sassi cadere sfiorandomi, fischiando nell’aria
la nota del diapason, il “la”. Nel vento veniva una
musica a onde che faceva vibrare il mio corpo teso
come una vela. Qualcuno mi osservava da una scal-
fittura dell'abisso, Seguendo la sua musica salivo
piti svelto alla cima,
Venivano stranieri a visitare le nostre montagne.
Provavano sentieri nuovi per salire le cime, tentava-
no con funi e chiodi una via nelle pareti. Volevano
che io andassi con loro con una fune attorno alla vi-
ta a insegnare un percorso. Ma scappavo lontano,
non ero un cane da stare legato a una corda, Anda-
vo su senza i loro lacci, poi riscendevo per la stessa
strada, Quello che sapevo fare in salita, ripetevo in
discesa. Una parete di roccia va carezzata a pelo e a
contropelo in discesa, quando ‘li appoggi dovevo
cercarli in basso tra le gambe. A volte andavo su di
notte per non farmi guardare dai loro cannocchiali.
Mi bastava la luna, mi affidavo pid ai polpastrelli
che agli occhi. Facevano cosi le dita del nonno che
andavano giuste sulla tastiera cieca del violino, An-
ch’io sentivo dentro il corpo un’esattezza, facendo
con i quattro punti d’appoggio la sagoma di un ac-
cordo, come le quattro dita di una mano sinistra.
Ero muto, dalla mia gola non veniva fuori nessu-
na canzone, ma nelle orecchie suonava una sfrenata
danza di nozze quando, sotto lo strapiombo di un
tetto, la mano frugava cieca Vappiglio dell uscita, al-
dila dellostacolo spiovente. Allora, se era buono,
lasciavo il corpo a dondolare sopra il verde del vuo-
to, con gli abeti lontani e le chiazze dei pascoli nel
fondovalle. Avevo dita dure da reggere due corpi,
avevo le dita del nonno.
Una volta precipitai, persi la presa e sentii il cor-
po serrarsi dentro un guscio. Veni gid chiuso come
una noce. Sotto di me un ghiaione abbagliante mi
accolse nel suo pendio, facendomi rotolare lungo le
sue rapide. Non misi le mani a protezione della ca-
duta, nel volo le strinsi sotto le ascelle perché solo
quelle ossa non volevo rompermi. Tutto quello che
mi ruppi fu il naso, sbattendo la faccia contro P'ulti-
87
mo sasso. A volte le montagne si scrollano di dosso
le formiche. Una scarica di pietre smossa in cima da
tun corvo basta a scippare via dalla parete le nostre
zampette. A volte il vento prova da solo a spingere
nel vuoto e soffia, gonfia i panni e fa venire voglia di
fare un tuffo nella sua carezza. A me basta spingere
un solo dito, il medio, in un buco, in und fessura,
per restare all’ancora.
In valle si formavano le prime guide per accom-
pagnare i forestieri sui monti. Un muto era poco
adatto. Cosi seguii un circo passato dal villaggio
imparai i numeri di destrezza degli acrobati. An-
ch’io mi guadagnai da vivere offrendo il rischio di
cadere, saltando da una corda all’altra, eseguendo
voli per un pubblico povero sotto tendoni rattop-
pati.
Dal legno si ricavano due polveri: ia segatura 0
la cenere. I circhi odorano di segatura. L'ho avuta
in bocca molte valte cadendo da un appiglio man
cato, da una presa viscida, Volteggiavo su un pub-
blico seduto, ma se precipitavo, si alzavano di scatto
secondo una misteriosa légge di contrappeso: al mio
tonfo al suolo corrispondeva il loro levarsi in piedi.
Seguiva la concitazione del soccorso ¢ nelle case di
‘ognuno potevo immaginare il racconto dell accadu-
to, la sorpresa di aver assistito a un caso singolare.
Lo spettacolo di un circo deve essere generoso di
Gli esercizi di un acrobata sono complementari
alle movenze di un torero, cercano Pesatto angolo
di scampo. C’8 un toro e un vuoto che caticano en-
trambi, sfiorandoli. In verita non so se nell'arena
88
}
Tuomo sente di roteare intomno a un abisso, so inve-
ce che il buio della pista sotto di me somigliava alla
schiena nera di una bestia infuriata.
Qualche sera potevo sentirmi leggero come l'ar-
chetto di violino del nonno che sfiorava le corde
con precisione e in fuga. Qualcuno ammansiva il
vwuoto e io passavo nellaria senza sforzo. Una musi-
ca cantata a bocca chiusa mi accompagnava in volo.
Prima di diventare vecchio ero gia tarlato di frat-
ture, Ero rimasto nel circo da inserviente, montavo
e smontavo la volta di tela sotto la quale ogni sera si
svolgeva lo spettacolo. In una citta di costa issammo
Pimpalcatura in uno slargo proprio in faccia al ma-
re. La salsedine la rese scivolosa, caddi ancora, ma
al suolo non c’era la pista con la segatura. Ebbi san-
gue in bocca, sapore come di cenere. In ospedale mi
appesero a dei fili, abi, cavi, disteso come una ma-
rionetta, Nel letto accanto un ragazzo stava peggio
di me. La sera il camerone si svuotava. Un ragazzo
non dovrebbe trovarsi da solo quando la vita @im-
provviso somiglia a un rumore di passi che in una
corsia vanno verso il fondo. Portava gli occhiali.
Durante il giomo una infermiera fece per levarglieli
¢ lui preg® di no, di no con una voce sfinita in cui si
eta irrigidito Pultimo sforzo di una volonta.
Quella notte udii i suoi rantoli, poi venne il ru-
more di ferro di branda sbattuto. Nel fremito gli
caddero gli occhiali e tinnirono un limpido, esile
“la”, urtando per terra. Allora mi scossi, risalii dal
fondo, mi tirai via dal letto staccando fili, tubi e
89,
quanto mi legava. In ginocchio cercai sul pavimento
i suoi occhiali. Volevo rimetterglieli, certo una cosa
stupida, ma sentivo un’ansia frenetica di farlo. Nel
buio si alzd a calmarmi un’aria di violino, Mi solle
vai in piedi, vestito di bende pendenti. Gli posi gli
occhiali sul naso. Appena compiuto il gesto caddi a
terra. Altri centimetri di tonfo, gli ultimi, si aggiun-
sero ai molti metri molte volte volati a precipizio. Ci
sono centimetri e secondi che contengono un rias-
sunto di abissi. Strinsi i denti, la bocca era piena di
cenere calda. La sponda del letto era lontana, la ve-
devo da terra, alta come un cancello, io fuori. Nelle
orecchie sentivo cantare il violino del nonno. L’ulti-
ma cosa udita fu il respiro del ragazo che ricomin-
cava.
“Alp” 1994
Quando sié giovani e si ha circa la stessa et del
secolo in cui & dato vivere, si prova una vertigine
impresaria: che in noi scalpiti ogni iniziativa, che ci
spetti ogni esordio di quanto le tre generazioni suc-
cessive eseguiranno nel secolo. Ci si sente pionieri
del proprio tempo, si diventa guerrieri, alpinist,
poeti dimentichi di ogni provenienza, figli di un an-
no zero, come accadde ai dispersi di Babele che in-
ventarono lingue all’ombra di una torre. Mi sentii
parte di un’umanita esordiente ¢ questo é tutto
quanto avevo da premettere al fatto che racconto.
Eravamo saliti da pochi giomni ¢ non ci eravamo
ancora abituati a quello splendore. Atrivano inverni
in montagna in cui si infila anche un mese di belle
giornate tutte di seguito. Il ghiacciaio della Lobbia
imbruniva di riflesso la nostra pelle, il gelo nottumno
ci faceva sanguinare il naso e ci brillavano gli occhi.
La roccia granulosa di Adamello scricchiolava sotto
i nostri scarponi nei camminamenti.
‘Anche da noi ci sono montagne, ma queste era-
no belle in modo piit solenne e spazioso. Respirava-
mo un’aria larga, eravamo in molti a star sotto i ven-
B
>=
Vanni lassi, lontano dai nostri luoghi e a condivide-
re tutto. Quello che ci capitd di vedere uno di quei
primi mattini non era mai sucesso prima e non si
sarebbe pid ripetuto. Si era appena alzata la nebbia
dal campo d’orizzonte quando li vedemmo: un’inte-
ra compagnia alpina si precipitava in discesa con gli
sci ai piedi lungo un fianco del ghiacciaio. Tutti ve-
stiti di bianco avrebbero dovuto confondersi con il
fondale e invece spiccavano abbaglianti sotto il pri-
mo sole del mattino a motivo delle loro nere ombre
lunghe, scroscio di virgole sopra un foglio vuoto. Le
Toro curve sul taglio degli sci alzavano la coda fru-
sciante di una cometa. Potevamo sentirla sfilare nel
silenzio imbottito della montagna. “Questo é il fo-
togramma negativo di una notte di stelle cadenti”.
mio temperamento visionario mi dette subito sui
nervi. Non era quello il momento di prendere ap-
punti per fare dei versi.
Scendevano veloci, centinaia di scie bianche si
avvicinavano al nostro rifugio, perdendo quota. Re-
stammo fermi, zitti a guardare pensando che erano
pazzi, poi che stavano rappresentando uno spetia-
colo, poi che ognuno di noi avrebbe voluto per me-
no di un minuto essere con loro. Per quel poco di
tempo, non per il seguito, ognuno di noi prov at-
trazione.
Pensai i pensieri di uno di loro. “Bella Pultima
curva, ho scaricato bene il peso sui talloni lascian-
doli andare verso valle. Ho imparato in fretta a cor-
rere con le zavorre addosso, Si, zavorre, quando
scendo in neve fresca risento inutili le armi che por-
to, soma che hanno caricato sui miei anni per il solo
torto che sono pochi ma sufficienti a essere rischiati.
Vorrei scendere un giorno con gli sci senz’altro peso
addosso che il vento, senz’altro scopo che il correre.
E stata bella P'ultima curva. Vorrei lasciare sulla ne-
ve un solco perfetto che non venga pid ricoperto
dall'inverno, lasciare dietro una traccia di cui essere
fiero. Invece mi calpesta il solco il passaggio dei
miei molti compagni che corrono con me come un
temporale, a dirotto.”
Latesa del loro arrivo fu fredda di nervi ma
febbrile di immagini negli occhi: vidi oltre di loro
un lago che si increspa e frigge di creste bianche; vi-
di quello che succede alla brace quando la si agita
con il ferro nel camino; vidi la forma compatta della
polenta quando la si copre di formaggio grattato.
Queste visioni ebbero tutto il tempo di emergere €
succedere Yuna nell’altra, mentre le nominavo a
‘mente: vento, spargimenti, saliva in bocca.
Vennero i pensieri di un altro di loro. “Vorrei
non aver traccia dietro, essere sempre pid leggero
in fondo al pendio non risalire il versante opposto,
ma scartare di lato e spiccare salto verso Val di Sole,
valle col nome pit bello della terra. Lasciammo or-
me di piedi nudi una notte di festa sulla rena del
Piave e al mattino non c’erano pit, quando la portai
a casa. Ho appena disegnato con gli sci la curva
commovente del suo polso. Vorrei che mi vedesse €
che andasse dai miei a raccontare che scendevo a sci
ben uniti, per una gara non per una guerra. E se ca-
do, vorrei che dicesse che mi ha visto fare una ca-
priola finendo faccia al cielo.”
Il sole Ji tagliava in due, li raddoppiava di un’ala
nera che li inseguiva e voleva saltare addosso a loro.
In fondo al pendio, per un cambio d’angolo tra il
sole, il suolo e la nostra visuale, non ebbero pia om-
bra. A quel punto il primo di essi cadde. Ruzzolo
nella neve la montagna ititera pass6 dal silenzio
compatto, rigato solo dal loro fruscio, al fragore di
una festa di paese. Da tutti i punti della nostra posi-
zione avevamo aperto il fuoco. Caddero appallotto-
landosi in bozzoli di neve, in pagine accartocciate.
Non cerano ombre né ripari sotto il nostro tito, so-
To bianco su bianco, nemmeno il sangue riusciva a
scolorarlo. La neve, il ghiaccio lassorbiva tutto, per
pura sete.
Sentivamo su di noi il solletico del sole, ardeva
dalle nostre canne il fumo della polvere da sparo,
profumo che saliva dritto alle narici e al cielo come
lo sbuffo di una caffettiera, come incenso. Come,
come: i cattivi poeti sono pieni di “come”, abbaci-
nati dalle somiglianze. La mitragliatrice dal fianco
strepitava con un applauso frenetico. Io, giovane
poeta austriaco di quasi vent’anni sparavo contro
tutto quel bianco senza ombre. Miravo cosi anche al
tirassegno del Prater.
Aver imparato a sciare, aver goduto delle prime
destrezze in piena velocit nelle belle giomate tra-
scorse a mettere a frutto quell abilita; aver compre-
so attraverso il corpo il difficile equilibrio di curve
strette e vicine, aver legato ai piedi con cura legni li-
sci con la prua stondata; avere messo insieme tutto
questo in pochi anni arruffati di crescite, e poi scen-
dere un giomo con tutto quel valore in sé lungo un
pendio, per andare a sfracellarsi contro i nostri sas-
solini di piombo. Bisogna aver molto amato la mon-
tagna pet potersi trovare in un mattino di sole in ci-
ma a una discesa ¢ aver pensate: “Non mi importa
di morire I sotto in neve fresca, con i miei sci, col
vento contro il fiato ¢ i sassolini in corpo”. Non un
generale, non certo un uomo esperto di guerra ave-
va stabilito quel piano, Nessuno stratega avrebbe
disposto un attacco frontale in campo aperto, in
pieno giomo e senza copertura di artiglieria. Solo
tun fegista onnipotente, per folgorazione estetica,
poteva mettere su bianco quei soldatini e scolasli da
tun monte per vederli disfatti contro i nostri fu
Ero poeta, guerriero e alpinista di un secolo nuovo
che grondava sangue fin sulle cime dei monti, dove
nessuno ne aveva sparso prima. Era facile sentirsi
primizia, frutto staccato verde, A noi spettava inau-
gurare avventi, presiedere crolli, compreso quello
della nostra patria.
Fino alPultimo continuarono ad avanzare verso
di noi, non riusci a essere mai un avanzare contro.
Non ne scampd nessuno, perdite nostre: zero.
Quello fu unico attacco in massa condotto sci ai
piedi in tutta quella guerra di fanterie assiderate.
Quella notte scrissi dei versi per le nevi bianche as-
setate, come le pagine dei poeti.
Ao aa
SESSANTATRE A UNO
I miei padri ¢ i padri dei miei padri si sono tra-
mandati la speranza di essere contemporanei del
Messia. Nelle loro vite si interrogarono: c’era un ge-
sto che potessero fare per affrettarne Pavvento? A
me é toccato in sorte di tentare risposta alla loro do-
manda, di raggiungere quel gesto. Questa é la storia
che porta fino a esso. L’ho raccontata molte volte al-
Ja mia famiglia e ai vicini riuniti intorno al tavolo
del sabato. Mi accorgo di non conoscerla pi, di
non saperla discutere, di fare confusione e tracima-
re di fantasia, Molti di quelli che l’ascoltarono per la
prima volta sono ormai morti. Da noi si scrivono le
storie quando si @ consumata la generazione che le
ha ascoltate dalla viva voce.
Racconto al passato recente, come appena acca-
duta, la cronaca di un giomo al termine del quale
cominciai ad aspettare il Messia con impazienza.
: Lialtra sera ho visto l'ultimo nipote del profeta
Elia, L’ho riconosciuto da lontano per quelle due
rughe che dal punto di attacco delle lacrime scen-
101
hese
iii ESS 'SS=‘SISS on
dono fino ai lati della bocca. Sembrano tagli, opera
di frusta. Col tempo i corpi buttano fuori un parti-
colare che si approfondisce e di definizione fisica di
una persona. Zimmer, questo 2 il suo nome, @ una
magrezza contorta ¢ due rughe frustate in facia. La
prima cosa che fece fu pizzicare i suoi sei nervi di
bue, ben tesi, come quelli con cui provarono a lega-
re Sansone. Poi fischid come Davide dietro alle pe-
core, dentro uno zufolo lucente. Con me cera Lar-
co, detto altro fienile perché abita oltre il fume
Lui va spesso dietro i passi di Zimmer, il nipote
di Elia.
A volte gli dico di stare in guardia, di badare di
pit ai suoi campi, ma mi viene in mente per ammo-
‘nimento solo quel proverbio delle nostre foreste che
dice: il quarantesimo orso segna la fine del cacciato-
re. Bisogna rispettare il numero quaranta. Larco
Paltra sera mi ha detto di essere andato dietro a
Zimmer gia sessantatré volte. Sono rimasto a bocca
chiusa, non ho potuto dire niente contro questo ec-
cesso. Per questo sono andato con lui, per conosce-
re una volta quello che lui sa e che non gli basta. E
affamato di un solo molteplice, io invece sono sem-
pre esaudito dall’esperienza di una volta sola. Il
Messia non verra in pit tempi, ma in uno e uno so-
Jo. Tra sessantatré e uno, tra lui e me si possono col-
locare i gradi delle molte nature umane
Affidai le greggi al servo, presi con me il formag-
gio salato, il coltello curvo per tagliarlo e un piccolo
otre d’acqua. Andammo a Gerusalemme. Non & un
bel posto, se ne parla tanto, ma il mare non Pho vi-
sto e una citta che non sia costretta a sbattere in fac-
402
cia alle onde, che non abbia limiti ostili come rupi o
deserti, non & una vera citta. Percorremmo insieme
la strada che dai nostri villaggi digrada verso valle.
A ogni cambio d'orizzonte Larco additava: “Quello
dev'essere il monte del cranio,” aspettandosi il pro-
filo del Golgota, ma non era quello. Conosco quel-
Paltura che d’inverno attira la neve e la trattiene. La
mia stirpe viene da Ii e ancora tramanda quel dia-
lerto.
Attraversammo la citta, passammo i suoi mercati
senza una sosta a contrattare merci. Eravamo intenti
4 raggiungere una spianata fuori delle mura. Una
folla ben serrata si era accovacciata a terra. Zimmer
venne quando tutti eravamo seduti. Faceva pochi
gesti, non guardava intorno, teneva la testa china sui
sei nervi lisci ben tesi che gli facevano compagnia
nei gridi, nei canti, nelle voci. Il cielo diventava
d'improvviso intenso, teso come un tappeto ¢ una
goceia d’acqua cadeva solo su di lui. Allora alzava
sli occhi inarcando il collo magro ¢ le due rughe si
riposavano brevemente in piano. Ma niente ho det-
to, niente di niente finora, se non dico della sua vo-
ce. Bisogna pensare agli specchi che precipitano so-
pra un suolo di marmo, poi alla punta di un como
che riga una lavagna, poi al grido della lepre arti-
sliata dal falco: tutto questo di seguito @ la sua voce,
la pid. gelata specie di misericordia. Ci vogliono
denti di ferro cardalana per reggere in bocca quel
suono, Zimmer nella nostra antica lingua era colui
che canta,
Non pud essere sua quella voce, lui dev'essere
solo lo strumento: di certo proviene da una spacca-
103
tura della terra sotto i suoi piedi, da un abisso affa-
mato di fine che sfiata risalendo la colonna vertebra-
le di Zimmer, curva come l'narco del cobra.
Va avanti ¢ indietro con pochi passi quando non
canta, ma non c’8 silenzia in quel punto. Intorno si
scatena un Sinai di schianti, colpi, crolli, & la sua
bocca chiusa a suscitarli. Perché gli elementi, la for-
za segreta della pietra, la fetta dell’acqua, il trapano
del vento, lui li ha chiamati fuori dal loro stato di
quiete con il suo grido metallico, figlio di quello che
sgretol® le torri di Gerico, grido di orfano e di ve-
dova che sale dritto al cielo a scuotere le viscere del
nostro Elohim
La folla seduta dondola le teste sotto le sue pa-
role veloci, ondeggiano i nostri colli come spighe
piene. Zimmer va di luogo in luogo e sempre nuova
folla gli si accovaccia davanti. Ma Larco dice: “Non
@ come sembra. Lui non va in nessun luogo, lui @
fermo nel centro del mondo perché esso & dov’é hui,
Zimmer lo tiene presso di sé. Ovungue lui sia, quel.
Jo 2 il luogo ¢ il mondo @ una citconferenza. Siamo
noi a passare, a muovere la pianura davanti alla sua
voce”.
Il Sinai dei frastuoni rimbomba di caverne per-
cosse, tutti desideriamo che riprenda il canto, te-
mendo di forarci le orecchie, ma nessuno porta le
mani a chiuderle. Allora Zimmer fa un passo avanti
canta, grida, straccia Paria e dice che il cielo @ in
fiamme e che ci deve andare. A niente servira la col-
Iera 0 la colpa e non sara possibile dimostrare una
104
sola parola, perché il cielo ha i brividi e bisogna an-
dare via. E dice che cinquantadue giudici hanno
venduto il loro verdetto e ora il cielo si piega e que-
sto é il tempo di andare via. Cresce senza lievito la
sua voce azzima, l’aria si squarcia velo a velo e le
nostre orecchie cominciano a sanguinare. L’intona-
co del cielo come un soffitto marcio fa piovere su di
noi una pioggia dura. Lui non guarda in alto, ma
noi per il dolore alziamo gli occhi e vediamo i cieli
eseguire gli avventi che lui annunzia di loro. Dice
ancora che cambieranno colore, diventeranno neti
dentro un sacco, come i rotoli delle pergamene si
avvolgeranno, poi si dissolveranno in fumo. Quanto
diceva, succedeva in alto, non ho mai visto tanti cie-
lisopra di me come quella sera. Come essi sovrasta-
no la terra, cost lui ci sovrastava.
‘Tutto era gid scritto in Isaia, dico a Larco, gri-
dandogli in faccia, perché restano solo gli occhi tra
noi per ascoltarci nel fragore. Tutto fu gia narrato
dal nostro profeta che pitt s‘innamord dei cieli. Lar-
co risponde a bassa voce e non so per quale prodi-
gio lo sento benissimo anche a orecchie chiuse, co-
me voce mia. “Tu hai solo letto quei versi. Zimmer
li scaraventa in grido e quelli si precipitano a com-
piersi. Aspettavano Ja sua voce. Siamo al Sinai di
tutte le parole, qui esse si incidono su di noi come
su tavole spianate e il sangue delle orecchie @ frutto
di scalpello.” Latco, tu sei sapiente e figlio di sa-
pienti, penso in cuor mio. Lui risponde come se mi
avesse ascoltato: “No, sono pietra del suo abisso,
cado da molti anni dentro di lui e non sono ancora
arrivato”.
IEEE EEE
Larco non dondola il capo come gli altri, ma re-
sta dititto a farsi scivolare il sangue lungo il collo.
Due rughe gli partono dai seni del naso e scavano
solco fino ai lati della bocca. Finché Zimmer canta,
Ja sua faccia resta sotto il calco dell’altra. E Larco
mi dice: “A volte chiedo nella mia preghiera: perché
a me la sorte di essere nato nella sua generazione? F,
questo il tempo che viene come un ladro di notte e
solo chi veglia sar’ pronto? Poi vado dietro ai suoi
passi, lo vedo e le domande se ne vanno come nuvo-
le che non hanno versato pioggia, dileguandosi. Il
cielo & sgombro e lui lo arroventa di gridi”.
Quando Zimmer sta per lasciare la folla qualcu-
no implora la domanda: “Ma come dobbiamo chia-
marti?” Senza guardarlo risponde: “Chiamami in
ogni nome che vuoi, non mi negherd in nessuno”.
Allora tutti gridano la parola che hanno serbato in
cuore, ognuno ne ha una diversa e la dice prima che
ui se ne vada. Il suo nome @ fatto di tutte le spaiate
parole che in quel momento la folla rimanda. Larco
ha gridato: “Déleth,” nome della quarta lettera del
nostro vecchio alfabeto. “Sara la sua iniziale in altra
vita, oppure lo @ gia stata in un remoto prima” e mi
insegna che non @ solo il futuro a lasciarsi rivelare,
ma anche il passato é visitabile dalle profezie: quello
che & accaduto prima di noi é altrettanto segreto.
Sulla strada del ritorno Larco mi ha raccontato
di un altro viaggio. Stava seguendo la pista di un
prossimo passaggio di Zimmer, era possibile che il
giorno seguente il mondo avrebbe avuto centro in
106
tuna localita dell’Alta Galilea, nelle terre del Nord.
Larco si era incamminato per tempo in quella dire-
zione ¢ il giomo prima di arrivarci era passato nei
dintomni di quel posto funesto in cui tanti nostri pa-
dri furono ammazzati dalla gente di Amalek. Era un
cimitero sporco, il dolore della cenere fresca dei
bruciati si era placato degradando in polvere. Larco
scelse di sviarsi dal suo cammino per entrarci. Ogni
deviazione contiene destino, anzi esso si compie so-
Jo nei punti in cui uno si trae fuori di percorso, Cost
come in una storia é la digressione ad avere valore e
splendere di senso.
“Appena spinto il passo sull’uscio di quel posto,
incontrd Zimmer da solo che ne usciva. Aveva la
schiena curva di serpente suscitato dal cesto, gli oc-
chi al suolo e due rughe che calavano dal pozzo del-
le lacrime fino alla bocca. Erano soli, due viandanti
presso un uscio, largo da non dover cedere il passo.
Zimmer fu colpito da una goccia, Larco la vide ca-
dere dall‘alto del cielo sempre opaco di quelle terre
del Nord. Dal fondo del suolo in cui erano rimasti a
lungo, quegli occhi si staccarono con colpo di collo,
con colpo che svelle una pianta dal terreno. Larco li
ebbe in faccia, bui e remoti. Il suo racconto fin} con
queste parole: “Ho visto le pupille, erano il pozzo
in cui fu chiuso il nostro profeta Geremia. Ho visto
bianco, era una tunica schizzata dal sangue dei sa-
crifici di aspersione. Il ‘Rab’ che volevo dire per sa-
Tuto mi é rimasto in gola”.
Era notte sulla via del ritorno. Il cielo era di
nuovo quieto. Le stelle che i nostri padri chiamava-
107
no “Ash, Chesil, Chima ¢ noi Orsa, Orione, Sirio,
erano tutte apparse al loro posto. Le chiamammo
per nome, rispondevano luce. “Larco - dissi -, i cie-
Ii riprendono il corso. Ancora poco fa li vedemmo
chiudersi, incendiarsi, arrotolarsi e poi perdersi in
fumo. Ora sono di nuovo gli stessi delle notti di tut-
te le generazioni prima di noi. Li vedranno cosi an-
che quelle che ci seguiranno? Ci saranno oltre di
noi generazioni? Non siamo contemporanei del
Messia e Zimmer non é la stirpe di Elia che ce'ne
awvisa?” Il cielo era placato, senza luna, Paria spat
geva dai villaggi odore abbrustolito di grano sarace-
no e di pistacchio. Larco si appoggid al bastone,
masticd una carruba, sputd, chiese: “Perché disfare
‘questo? Sono sessantatré sere’ che vedo i cieli rom-
persi contro il canto di Zimmer. Dopo la prima vol-
ta pregai soltanto con una parola: ancéra. Fui ascol-
tato”. Allora chiesi se quel continuo tornare ai gridi
come il cane al vomito, non fosse proprio quello a
impedire la fine dei cieli. Quell’“ancéra” aveva otte-
nuto di legare Zimmer a un numero ignoto di repli-
che? La profezia s’era ammansita in canti di reper-
torio e il Messia era nelle pastoie delle premesse?
“Forse tu Larco ritardi Pavvento, forse @ per la tua
preghiera che il mondo ancora sussiste ¢ il cielo ri-
toma alla quiete.” Avevo afferrato un dubbio, ’am-
mirazione per Larco mi crebbe nel sangue fino a
misurarsi con la domanda dei padri: quale gesto
pud affrertare l'avvento? Il cuore mi divenne cupo.
Larco tremé, due rughe gli scavarono i tratti e a oc-
chi bassi annui: “E possibile”. Percid, pensai, se lo
|
uuccido vedrd il Messia nella generazione. Larco si
inginocchid e mi offri la nuca: “Quello che devi, fal-
lo presto”. Avevo gia nel pugno i suoi capeli, il col-
tello travers® la sua gola insieme al “presto”.
FOGLI DELLA DOMENICA
Queste sono le domeniche delle mele: racco-
alierle, sbucciatle, cuocerle per le composte, le con-
fetture. Subito dopo verranno le domeniche della
legna da preparare per il camino e intanto sara tor-
nato il buio di pomeriggio. In questi giomni larghi in
cui si mette da parte qualcosa per Pinverno, rileggo
i fogli dei racconti scritti da mio padre. Li batteva a
macchina a vista persa, pescando a memoria sui ta-
sti. Quando ci chiedeva di leggerli non riuscivamo.a
finire una pagina per tutto il ridere degli sbagli. For-
‘mano sullo scaffale una mezza colonna di varie car-
telle colorate.
Riparto dai primi racconti, pieni di vicende che
chiamavo a intreccio di canestro e lui, per diminuir-
i ancora, li diceva: da impagliasedie. “Le storie ser-
vono per sedersi,” era una sua frase. Molte sono
ambientate nella Napoli del primo Ottocento, con
serve bellissime, avventurieri inglesi, pittori di corte
¢ delitti d'amore sul tufo di Posillipo. C’é un ro-
manzo epistolare composto di lettere anonime, ci
sono strozzini, orfani e maltrattate eroine di nome
Clelia, Marzia, Emestina. Sbrigliava a tutta festa ri-
113
tagli e dettagli della sua passione per i documenti
dell'epoca. Conosceva dinastie familiari con la pre-
cisione con cui ricostrui e scrisse la sua regalandola
a tutti i nipoti. Leggo le sue storie squillanti, tirate
via in fretta per puro slancio di correre dietro all’in-
venzione finché fioriva. Non gli importava il frutto,
il valore finale, solo il fiore contava.
Dell’anno in cui abitammo di nuovo insieme mi
mancano i molti saluti che ci scambiavamo ogni
giorno. Cominciavamo al mattino presto: alla mia
sveglia delle cinque e trenta lo trovavo gia in piedi.
Poi all’uscire di casa, al rientro, all’ora della sua pas-
seggiata e al congedo per la notte: quanti salut, in-
dispensabili, finiti. L’ultimo gliel’ho detto a cuore
appena fermo e sono sicuro che ha potuto sentitlo.
Mi accorgo solo adesso, rileggendoli, che i racconti
sono pieni di saluti
Sono tre anni che il suo corpo s’asciuga in un ci-
mitero di paese, a poca strada dalla nostra casa dei
meli e dei pioppi. Sul suo metro di terra ho messo
un rosmarino che & cresciuto con impeto. Devo
scorciare i rami per non invadere il metro degli altri,
ma, sotto, le sue radici non danno ombra a nessuno
€ sono libere. Ormai saranno arrivate a stringere le
sue dita, a forzare la scatola magica del suo sorriso.
Intreccio a canestro Je mani intorno ai rami verdi,
cupi, profumati e posso sentire, oltre le foglie ¢ il
buio che ci separa, la forma delicata del suo cranio.
IN ALTO A SINISTRA
Dormiva sotto il mio soppalco, non era neanche
una stanza. Mi addormentavo al suono ovattato dei
suoi lamenti, una nenia a bocca tappata per lasciar-
mi dormire. Qualche notte mi svegliava un sopras-
salto: si era un poco assopito e risvegliandosi sotto
un morso pid forte, non faceva in tempo a soffocare
la voce. Allora scendevo con la scusa di andare al
bagno e stavamo per un po’ a giocare al buio.
Giocavamo a bridge a mente, descrivendo un
diagramma con le cinquantadue carte. Me Paveva
insegnato lui, ero ancora ragazzo, e subito se ne
pent perché mi dedicai allo studio di quel gioco pit
che a ogni altra materia scolastica. Riuscivo bene
nel campo astratto delle combinazioni di carte, le ri
cordavo tutte, immaginavo con sufficiente precisio-
ne i giochi degli avversari. Una volta vincemmo un
torneo a coppie, noi due insieme, padre ¢ figlio. A
me sembrava normale, mi sentivo bravo a quel gio-
co, per lui fu invece una festa stringere in mano la
bella moneta d’oro del premio. Un’altra occasione
di minuscola gloria ci capitd in un torneo a squadre:
incontrammo la rappresentativa nazionale della Po-
7
Ionia e riuscimmo a pareggiare. Questi erano i no-
stri minimi trofei che in quelle notti rinfrescavamo
nel ricordo. Andavo presso il suo buio e senza ac-
cendere la luce cominciavo: “Allora tu hai in mano
quattro carte di picche formate da...” € costruivo
una giocata difficile da tisolvere. Lentamente riusci-
va a concentrarsi al di sopra del dolore delle ossa,
tentava la manovra di carte che permetteva di vince-
te anche contro la migliore difesa. In quelle notti
davo fondo a tutta la mia scienza di accanito studio-
so del superfluo, montando diagrammi con i pitt re-
moti finali di gioco: il colpo del diavolo, la riduzio-
ne d'atout, le molteplici varianti delle compressioni
semplici, doppie, triplici, di taglio, di criss-cross, la
Barco, la Bonney, la Jettison. Ci negavamo la como-
dita di disporre le carte sul tappeto, cosi approfon-
divamo la concentrazione. Era splendido vedere
che poteva migliorare nel bridge in quelle condizio-
ni, eppure era cosi: riusciva a immaginare nitida-
mente le cinquantadue carte. Gli spiegavo lo svolgi-
mento delle giocate e lui le ripeteva poi esattamen-
te. Il dolore diventava un rumore di fondo, uno
scticchiolio di travi nelle gallerie minerali del corpo
mentre lui era risalito fuori, allaperto, all’aria stella-
ta delle carte astratte. Era Punica cosa che avevamo
in comune, la sola che mi avesse insegnato diretta-
mente, come eredita. Tutto il resto Pavevo imparato
dai suoi libri, comprati a fascine e che lui aveva let-
to tutti, tutti, fino all'ultima riga.
Una notte gli descrissi un diagramma. Prima che
iassi a discuterlo aveva trovato la soluzione. Era
una manovra del gioco di difesa. “Sai che hai trova-
us
to da solo il colpo di Merrimac?” Gli scappd una ri-
sata, uno scivolone che subito si contrasse in un sin-
jozzo. Cos’era mai. “E quello che hai fatto, il sa-
ctificio di una carta alta che farebbe presa e che in-
vece butti via per distruggere le comunicazioni tra i
due avversari.” Merrimac era il pome di una nave
mercantile americana che si autoaffondd allimboc-
co del porto di Santiago di Cuba per intrappolarci
dentro la flotta spagnola, durante la guerra ispano-
americana. Il successo di quel sacrificio dette nome
a questo colpo di bridge. Gli piacque il nome, si
sentiva un poco capitano in seconda di quel mer-
cantile, In quei giorni lo colpi la paralisi dal tronco
in git, Andavamo in un sotterraneo, un cortidoio di
porte con nomi astronautici di apparecchiature me-
diche. Lo sorreggevo perché vacillava, afferrato alla
schiena dal cancro alle ossa. I passi gli costavano
trafitture, non poteva restare in piedi, doveva
sdraiarsi. La prima volta in quel corridoio lo feci
stendere sopra una barella in attesa di essere ricevu-
ti per il cerchiaggio. E una marchiatura a vernice
delle zone da irradiare con il laser. “Lei non pud oc-
cupare questa barclla.” Spiegai alla persona in cami-
ce che mio padre non poteva stare in piedi. Insistet-
te avvicinandosi a lui, allungando una mano per aiu-
tarlo a scendere. Mi piazzai a quei pochi centimetri
dalla sua faccia che precedono un bacio 0 una ca-
pocciata in bocca: “Non si alza da qui finché non
saremo ricevuti”. Non gli piacqui, se ne andd via.
Dalla barella mi urt con la mano, in segno di la-
sciar perdere. Gli impedii di alzarsi. Quando di ra-
do gli proibivo fisicamente un gesto, lo ritraeva esi-
ug
tando, ¢ a me restava lo sgomento di avergli reso
pit difficile la dignita.
Il dottore era ben collocato nel suo ufficio. Esa-
mind i dati, scrisse, telefond, sorrise, poi ci indicd
una sala. Spogliai lentamente il suo dorso, i panni
dovevano scivolare delicatamente, le ossa bruciava-
no dentro quanto una pelle scorticata dal primo so-
le d’estate. Fu steso sopra una panca ¢ gli disegna-
rono cerchietti lungo la spina dorsale. Su quei ber-
sagli si sarebbe scaricata Partiglieria invisibile del la-
ser. Cosi fu per molte volte, molti giomni. Lo porta-
vo piano dal letto di casa alla macchina, guidavo
piano, scendevamo lentamente, eseguendo le nostre
mosse secondo un rallentatore. Imparavamo quel-
Tandatura, non’come correre con un freno a mano
tirato, ma come un nuovo modo indicativo necessa-
rio a tutti i nostri verbi. Quel tempo era D'adagio.
Parlavamo anche cosi e lui sofiriva i suoi dolori sot-
tovoce, tappandosi la bocca quando erano pronti a
impennarsi in un grido. Potevamo accorgerci che al
di sotto di una minima velocita comune a tutti, si
niva fuori campo. Gli altri non facevano pitt caso a
noi, scansandoci soltanto come ingombri fissi. Noi
pure non badavamo pitt agli altri, considerandoli
come un vento, un’aria mossa e un rumore di fon-
do. La necessita di fare piano portava con sé Pisola-
mento. Eravamo in due, eravamo un due, una cella
mobilé che si aggirava per strade e corridoi in cerca
di qualche sollievo ai dolori, Eravamo stanati da
quel bisogno fisso. Ogni tanto un gesto gentile otte-
neva da noi il risarcimento di un sortiso, altre volte
un ringhio bastava a levarci di tomo gli sgatbati. Ci
120
intendevamo bene, a sorreggere il suo peso s’era
stabilito un accordo di scimmie, tocchi, smorfie,
cenni. Formavamo in due un cavallo da tiro, un
ronzino che zoccolava a ritmo i suoi quattro passi
cadenzati.
Tl turno del laser durava poco, era di pit il tem-
po di spogliarsi e rivestirsi. Non riuscivo a credere
che quel macchinario chiassoso come un tornio, po-
tesse prendere bene la mira. Lui si adagiava col mio
aiuto sulla panca e un infermiere aggiustava la posi-
zione per il tiro. A me sembrava a casaccio. Non
chiedevo, non facevo domande, non mi piaceva
quel mondo efficiente solo a sbrigarsi, organizzato
sulla parola d’ordine: “avanti un altro”. Mio padre
moriva, nelle sue ossa c'erano gia metastasi, questo
sapevo. Ogni curiosita era superflua e, per me, osce-
na. Una notte si alzé per andare al gabinetto e crol-
18 a terra. Non aveva pitt controllo del corpo al di
sotto del bacino. Era paralizzato, il laser Pavewa
spezzato in due. Lo raccolsi da terra che piangeva
di stupore. Nessuno ci aveva avvisato del rischio,
nessuno spiegd che non poteva nemmeno pisciare.
Cosi la vescica si gonfiava e lui chiedeva aiuto per
pisciare ¢ lo issavo in piedi e non usciva niente, pe-
10 lui sentiva di doverla fare. Cosi lo portai all’ospe-
dale del paese e li capirono e gli applicarono subito
il catetere ¢ riempi a litri il serbatoio di plastica.
Creatura mia ferita, sgarrettata, nemmeno la tortura
dell'urina ho potuto risparmiarti, nessuno degli ina-
midati con cravatta sotto ci aveva avvisato. Poi mi
artivé il conto del laser, poi lo restituii stracciato in
una busta, A noi restava il tempo del frattempo, un
121
participio presente che aveva fretta di diventare
passato. Resistevamo alla sua urgenza andando pi
no. Nel letto dal quale non poteva pitt alzarsi, si
contrastavano lentezza e fuga.
Ci si affida a gente sapiente con camici splen-
denti di bucato dietro scrivanie ordinate. Fanno cal-
coli, prendono la mira, programmano e non sono
buoni nemmeno a centrare la taza quando vanno al
bagno. Non mi ribello a loro, non impreco alla loro
superbia, credo a un Dio delle pene che provvede a
ripartirle. Mi fa male invece la speranza che sta ne-
ali occhi dei feriti, mi fa male la loro docilita. Non
disse una maledizione. Meta del corpo era gia per-
duta, Paltra meta picchiava alla schiena. “Lo senti?”
smi diceva: “oggi mi ha dato calci pili forti,” oppure:
“oggi mi fa scoppiare la vescica”. Era “I'operaio”, lo
chiamavamo cosi quel male che faceva i suoi turni
nella miniera del suo corpo. Anch’io ero operaio, il
suo unico figlio che aveva rinnegato lagio, il ceto, il
tetto e ora, dopo molti anni, era di nuovo insieme a
lui, La notte delle sue gambe perdute decisi che non
Jo avrei lasciato pitt, L'indomani mi licenziai dal
cantiere. Per la prima volta da quand’ero partito ra-
gazzo di casa, mi fermai, non lavorai. Non mi sareb-
be costato pitt nulla stare sveglio la notte, a distri-
buire carte immaginarie.
Gli furono applicati dei tubi e non si alz® pit.
Gli era rimasto in mente il colpo di Merrimac. Era
proprio quello che era capitato al suo corpo, tra-
sformato in una smazzata di bridge, con una mano
giocante ¢ un’altra morta di fronte. La paralisi era
stato il colpo di Merrimac, un taglio delle comuni-
122
cazioni. Fiorivano le piaghe di decubito ma non po-
teva sentirle, solo un forte odore le denunciava. Al-
lora ci accorgemmo che la pianta che avevo nel vaso
cominciava a dar segni di crescita, riempiendosi di
getti. In quelle settimane parti in altezza e in ingom-
bro, al punto che volli spostarla, ma lui mi prego di
lasciarla. Era un bene, perché di notte ripuliva l'a-
ria, assorbendo tutto Podore delle ferite. Le bastava
poca acqua.
“Presto riavrai la tua liberta.” “Riavrd la liberta
di tomnare a far muri in cantiere, di aver la casa vuo-
tae di trovarti in sogno.” “Avrai la liberta di tornare
ai libri, Punica cosa che ti lascio, oltre al bridge.
Riavrai i libri, unico posto dove Pesperienza che
uno fa nel mondo, trova le parole d’accompagna-
mento.”
Li aveva portati tutti da me quell’anno, quasi
niente vestiti. Voleva bene ai libri, tutti. Gli piaceva
Ia forma, l'ingegnoso sistema delle pagine sottili le-
gate lungo la costola, capaci di contenere tanta ma-
teria narrata, “La morte é il Messia, ha scritto Isaac
Singer. E proprio questo per me. In mancanza di fe-
de T'aspetto con questa sola ansia: capire i libri.
Ognuno capir8 quelli che ha amato. Saprd quali
avrei dovuto rileggere, quali ho mancato di cono-
scere. Mi aspetto dalla morte una biblioteca stermi-
nata ¢ anche la buona vista della gioventi.”
Gli chiedevo se pensasse di ricevere anche quelli
che sarebbero stati scritti dopo di noi. “I libri sono
il sempre. Chi li scrive pud credere di lasciarli ai
contemporanei, ai posteri, ma mentre scrive tutto i
passato é dietro le sue spalle a leggere. Se non c’&
123
questo angelo del tempo trascorso, se non ¢’é il suo
artiglio sul collo del pocta, le sue parole sono subito
cenere. Se non si scrive per essere letti dagli antena-
ti, non resta impresso niente sulla carta.” “Babbo, ci
vogliono troppi miracoli insieme per far succedere
quello che speri. Sei esigente per essere un uomo
senza fede.” “Mi @ bastata la fede degli altri. In al-
cune vite di quelle persone ho visto 'impronta digi-
tale di Dio, cost come resta nei libri sacri del loro
credo. Sono un testimone secondario, non ho visto
Porso ma ho trovato le orme, un alveare saccheggia-
to, indizi insomma di un passaggio.”
Le nostre chiacchiere nel buio non erano solo
serie. Cercava di ricostruire la genealogia, raggrup-
pando aneddoti di famiglia perché io potessi ricor-
darli, Non me ne sono mai incuriosito. “Perché non
hai figli, nessuno a cui raccontare le storie. In tanta
tua generazione poligama, tu solo sei rimasto fuori
dai registri di nozze. E povero un uomo senza don-
na, perché smette di crescere.” Diceva cose sagge,
ma le diceva a una stanza vuota. Le sentivo a eco,
come un rimbombo di malinconia, mi difendevo:
“A una moglie avrei niente da offrire, troppo da
chiedere”. Non sempre finivamo un discorso, una
frase: “Poperaio” lavorava di notte e di giomo € a
volte mi diceva di andare in camera mia, perché do-
veva gridare e doveva tapparsi la bocca e stare per
un poco a masticare il freno. Allora risalivo-al sop-
palco e mi addormentavo un poco, cullato dalla
cantilena del suo dolore. Potrei suonarla, metterla
in musica, in filastrocca: non gridava nessuna voca-
Ie, solo consonanti lunghe, prolungate, che si im-
124
pennavano in gola. Regolava il fiato dicendosi a bas-
sa voce “sh, sh”. Mai si lascid andare allo sconfor-
to di una vocale, a dare al grido la dignita di una
sillaba.
La pianta della specie delle araucarie fioriva, get-
tava in ogni direzione le foglie lunghe verdi, cupe,
lisce. In qualche notte di morfina lo sentivo parlare
a quella pianta, ormai alta come una persona ai pie-
di del letto. Le raccontava i fatti, le storie di fami-
alia, nel buio. L’arbusto di notte vegliava e asciuga-
va anche le parole. Un buon infermiere veniva di
giorno a pulire le piaghe ¢ aggiustare i vasi con cui
si irrigavano le sue vene. Di giorno parlava di libri.
“Conoscevano le mie pene, i bisogni, gli scontenti.
In ognuno di loro c’era una frase, una lettera che
era stata scritta solo per me. Sono stati la vita secon-
da, che insegna a correggere il passato, a dargli una
presenza di spirito che allora non ebbe, a dargli
un’altra possibilita. I libri insegnano ai ricordi, li
fanno camminare. Li ho letti per intero, non ne ho
lasciato nessuno a mezzo, per quanto fosse deluden-
te 0 presuntuoso I’ho seguito fino all’ultima linea.
Perché & stato bello per me girare la pagina letta e
portare lo sguardo in alto a sinistra, dove la storia
continuava. Ho girato il foglio sempre alla svelta
per proseguire da quel primo rigo, in alto a sinistra
Questo mi manchera del mondo, mi manchera pid
dite, delle tue cure e delle notti di bridge con cui
mi hai fatto uscire dal dolore delle ossa. I libri sono
un carattere ereditario e credo di avertelo trasmes-
so. Non li ami come me, sei esigente, cerchi tra essi
le pagine che restano incise nella memoria, infilzate
25
come farfalle, Ma non dire che le altre, le dimenti-
cate, sono da non leggere. Molto @ portato via dal
caso, quello che resta & appunto solo questo, un re-
sto che non dimostra e non sostituisce niente di
quello che si 2 perduto. Ami le pagine assolute, le
necessarie, al riparo dai gusti. Ma i libri siamo noi,
gente che si ammala, si sflaccia, ingiallisce ¢ viene
dimenticata. Sono a immagine della nostra vita.
Ama un poco anche i libri del tuo tempo, ama un
poco i tuoi anni che sono quelli che passano ¢ non
quelli che ti restano.”
“Non ci riesco. Mi irrita nei contemporanei
quello che apprezzo negli antichi, la leggerezza che
fa da spinta al leggere. Ho un quaderno su cui rico-
pio le frasi che mi hanno fatto scattare, che mi han-
no fatto voltare indietro forzare le cose risapute
da una diversa breccia. Le pagine che cerco hanno
questo effetto: un paio di occhiali giusti sul naso di
un bambino che finc a quel momento non aveva
mai saputo di essere miope. Allora si accorge degli
occhi del suo cane, dell’artiglio del gatto, della gola
tesa del gallo che grida. Di frase in frase il quaderno
cresce ¢ contiene non i libri, ma la felicita incontra-
ta. Cosi divento contemporaneo delle pagine amate
enon dei miei anni.”
“Lo credi ma non @ cosi. Si pud stare solo nel
tempo assegnato ¢ la tua antologia deve aiutare ad
abitarlo. Ho conosciuto persone che volevano esse-
re contemporanee del Messia. Erano uomini di fe-
de, laboriosi, non a braccia piegate in attesa. Ama-
vano il loro tempo in forza di questa speranza, scru-
tando i segni di un avvento, osservando regole diff-
cili con la convinzione di affrettarlo. Posso dire che
i vedevo in transito nel loro tempo, che avevano i
bagagli pronti come chi stia in esilio e aspetti da un
momento all’altro di tornare. Andare a dormire, se-
dersi a tavola, baciare i figli: i loro gesti erano sem-
pre tutt’altro da quello che sembravano, perché era-
no cenni d’intesa con il mondo a venire. Ho avuto
ammirazione per chi ha aspettato il Messia tutta la
vita. Persone con prole da crescere hanno in cuor
loro coltivato, per misteriosa grandezza, il desiderio
che il mondo una buona volta si schianti nel niente.
Tnsieme alla richiesta del cibo di tuttii giorni hanno
bisbigliato per secoli e millenni: ‘Fai che venga il
tuo regno,’ fine del pane quotidiano, avvento del
forno per tutta la granaglia della specie umana. Vo-
ler essere contemporanei di questo fracasso, lo capi-
sco, & la piti grande aspirazione di chi ha fede. Uno
solo di noi fu il primo, ma tutti potremo essere gli
ultimi. Poi si arriva a questa sala d’attesa, attaccati a
un impianto a goccia nelle vene, e ci si aggiusta al
rango di penultimi. Percid ti dico di amare un poco
di pid il tuo tempo, perché potrebbe essere quello
del Messia. Allora uscendo di casa al mattino per
andare al cantiere metterai le spalle a nord e vedrai
spuntare quel giomo dietro le case, il profilo dei
campi, dietro il recinto, a est, in alto a sinistra.”
“a ‘voniaa
Wu
VULSINIS V OLIV NI
Von ad THud
TOULAT PoMUOMOO OTeSTOATUN)
1348 ERRIDE LUCA IN ALTO A SINISTRA
—
You might also like
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Celebrated Crimes DumasDocument314 pagesCelebrated Crimes Dumaschucketti2No ratings yet
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (895)
- Celebrated Crimes DumasDocument314 pagesCelebrated Crimes Dumaschucketti2No ratings yet
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- En Arxh in o KazandzidisDocument123 pagesEn Arxh in o Kazandzidischucketti2No ratings yet
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (588)
- LeonisDocument89 pagesLeonischucketti2No ratings yet
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (537)
- Anthology of Polish PoetryDocument204 pagesAnthology of Polish Poetrychucketti2No ratings yet
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (838)
- 歌から学ぶ日本語Document59 pages歌から学ぶ日本語Yonathan Romero GNo ratings yet
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (73)
- Breaking Into Japanese LiteratureDocument195 pagesBreaking Into Japanese Literaturechucketti2100% (16)
- Reading Japanese Crime Articles - Stephen SmithDocument167 pagesReading Japanese Crime Articles - Stephen Smithchucketti2No ratings yet
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Less Than OneDocument16 pagesLess Than OneBilly Colburn Shears100% (1)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Mastering Greek VocabDocument186 pagesMastering Greek Vocabchucketti2100% (1)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (399)
- The FoolDocument249 pagesThe Foolchucketti2No ratings yet
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Less Than OneDocument16 pagesLess Than OneBilly Colburn Shears100% (1)
- Ahmoy: Ria THN AnarkaiothtaDocument55 pagesAhmoy: Ria THN Anarkaiothtachucketti2No ratings yet
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- DiorthotisDocument142 pagesDiorthotischucketti2No ratings yet
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (344)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1090)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2219)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (119)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)