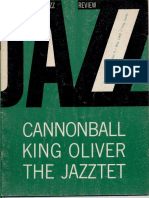Professional Documents
Culture Documents
RGG 1-2 76 PDF
RGG 1-2 76 PDF
Uploaded by
valter81020 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views113 pagesOriginal Title
RGG_1-2_76.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views113 pagesRGG 1-2 76 PDF
RGG 1-2 76 PDF
Uploaded by
valter8102Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 113
RIVISTA
DI
GRAMMATICA
GENERATIVA
Volume 1 numero 2 estate 1976
cooperative libraria editrice
degli studenti
dell'universita
di padova
RIVISTA DI GRAMMATICA GENERATIVA
Volume 1, numero 2, estate 1976
Articoli:
Larry Hyman
Maria V. Giuliani
Angela Marcantonio
Annarita Puglielli
Cristiano Castel-
franchi
Note e discussioni:
Guglielmo Cinque
Contenuti
Stati nasali e processi nasali
Ma e altre avversative
Un aspetto dell'ordine delle pa
role nell'italiano del due-tre-
cento
Sul congiuntivo nelle frasi re-
lative e il modo ipotetico
Proprio e l'unita del st
57-77
79-100
101-113
STATI NASALI E PROCESSI NASALI*
Larry H.Hyman - University of Southern California
University of California, Berkeley
1. Introduzione
In questo lavoro vorrei esaminare un modo particolare di af~
frontare lo studio dei sistemi fonetici. L'idea centrale di questo
tipo di approccio & che & necessario distinguere nel linguaggio re-
strizioni statiche e restrizioni processuali e che se non si fa que
sta distinzione, alcune generalizzazioni resteranno inspiegate, 0,
peggio ancora, verranno deltutto perdute. Alcuni aspetti di questo
inquadramento teorico possono essere ricavatidai lavori di altri
linguisti, specialmente quelli di Joseph Greenberg, mentre qui io
vorrei analizzare sistematicamente questi due tipi di spiegazione e
dimostrare la loro applicabilita a diversi problemi fonologici.
Quindi, quando ci troviamo di fronte a problemi linguistici da spie
gare, & importante fare le seguenti considerazioni: 1) il problema
richiede una spiegazione diacronica 0 sincronica? 2) a che cosa
deve la sua esistenza la spiegazione diacronica, o quella sincronica?
Nel caso della fonologia, di solito le spiegazioni si cercano
nella fonetica, benché le generalizzazioni fonologiche con base
grammaticale (p.es. i fenomeni di confine di morfema o di parola),
trovino la loro spiegazione nel lato semantico del linguaggio. Co —
munque, come vedremo in questo lavoro, non ® sufficiente spiegare
degli universali a base fonetica in termini di fonetica soltanto:
un processo assimilatorio che pud sembrare foneticamente plausibile
in superficie, pud di fatto diventare qualcosa di- completamente di-
verso. E' a questo punto che la distinzione fra stati e processi
(*) Il testo riproduce una comunicazione tenuta al Nasalfest, Sym-
posium on Nasal and Nasalization, nel 1975, per il Language
Universal Project della Stanford University e distribuita in
forma prepubblicata non definitiva, La traduzioneé di Paola Benin-
ca.
diventa importante. La relazione fra i due @ una specie di circolo
vizioso: gli-stati fonologici sono in parte soggetti a restrizioni
dovute alla natura dei processi (prevalentemente) fonetici che han-
no dato loro origine; e i processi fonetici sono soggetti a restri-
zioni dovute agli stati fonologici che li producono. Data questa di
cotomia, pud essere necessario spiegare alcuni fatti in termini di
stati e altri fatti in termini di processi.
Cosi, per prendere un esempio concreto, potremmo domandarci
perché non ci sia nessuna lingua che abbia solo consonanti sonore.
Un fonologo di orientamento sincronico potrebbe dire che questo sta
to & pid "marcato", e citare forse il relativo universale implica —
zionale scoperto da Jakobson (1941). Oppure, se & un fonologo di o-
rientamento fonetico, potrebbe parlare di uno sforzo articolatorio
maggiore necessario a mantenere la sonorita nelle ostruenti. Un fo~
nologo di orientamento diacronico pud, da parte sua, sottolineare
che non si trova un sistema fonologico con consonanti sonore sol-
tanto perché non si hanno processi fonetici che convertano tutte le
consonanti in consonanti sonore, indipendentemente dal contesto.
Cio’, prendendo una, situazione opposta, possono esistere lingue con
sole consonanti sorde (forse possiamo limitarci alle ostruenti)per
ché sappiamo che c'é una tendenza foneticamente motivata, per le o-
struenti, a diventare sorde, come @ successo per esempio nella sto-
ria del cinese.
Un sistema con /b, d, g, v, z/ma non /p, t, k, £, s/ deve
essere eliminato su basi sincroniche (statiche) o su basi diacroni-
che (processuali)? Forse c'& un modo per risolvere questo proble —
ma, almeno potenzialmente. Si consideri una lingua in cui tutte le
parole hanno la struttura V(CV)), cio8 in cui tutte le parole comin
ciano per vocale seguita da una o pil’ sequenze CV. In questa lingua
nessuna parola comincia o finisce con una consonante, e non ci sa~
r& neppure mai una sequenza di consonanti: vale a dire in questa
Lingua ogni consonante sara intervocalica, Ora, c'8 un processo fone -
ticamente motivato che sonorizza le consonanti intervocaliche. La
domanda €: questa lingua potra sonorizzare tutte le sue consonanti?
I1 processo 8 motivato, ma lo stato che ne risulta @ aberrante Sfor
tunatamente, non conosco nessun caso del genere né’ho alcun esempio
in cui un mutamento di suono foneticamente motivato sia bloccato
perché darebbe come risultato uno stato fonologico inaccettabile o
impossibile. Cid che di solito succede @ che non si ha mai un pro-
cesso motivato che minacci di produrre uno stato impossibile (cfr.
Greenberg 1966), anche se pud succedere che stati inusuali o "paz —
zi" possano essere il risultato dell'interazione di parecchi muta-
menti di suono foneticamente plausibili (Bach e Harms 1972; Hyman
1975).
In questo articolo presenterd un'analisi di vari. fenomeni na-
sali all'interno di questo inquadramento: nella sezione 2 mostrerd
che certistati nasali si possono capire solo nei termini dei proces-
si nasali da cui originano; nella sezione 3 mostrerd che alcuni pro.
cessi nasali possono essere capiti solo riferendosi agli stati nasa
li da cui originano. Infine nella sezione 4, concluderd perorando
brevemente 1'importanza della dicotomia stato/processo.
2. Neutralizzazione di vocali nasalizzate.
In una comunicazione letta alla Stanford Conference on Afri-
can Linguistics (1974) ho discusso il seguente esempio, che ha ache
fare con la nasalita. I dati del Kpelle, presi da Welmers (1962),
che si vedono in (1), mostrano che l'opposizione fra [1] e [n] a si
nistra corrisponde a una opposizione di nasalizzazione della vocale
a destra:
(1) [itu] 'nebbia" [nfui] ‘la nebbia'
[niu] ‘persona [nuui] ‘1a persona’
In Hyman (1973) proponevo le seguenti forme sottostanti e rispetti-
ve derivazioni (si veda anche Dwyer (1974)):
(2) ‘la nebbia’ ‘1a persona!
Jae 1du+ il [he ndu+ i|
bh oouu i (v>¥/n_)
honde i (.+n/n_)
Chduil thiuil awn)
Procedendo dall'alto in basso (il che rappresenta sia l'ordinamen-,
to sincronico delle regole sia la cronologia relativa del mutamen-
to fonetico diacronico) vediamo che la vocale di 'la persona’ di-
venta nasalizzata dopo una consonante nasale; poi la [1] di ‘la
nebbia' diventa [n] dopo [n]; e infine le sequenze [nn] vengono de
gemtinate.
I processi osservati in (2) sono ben attestati nelle lingue
africane, e anche altrove. Comunque, negli esempi africani che co-
nosco, per ogni lingua l'opposizione V/V dopo consonanti orali ri-
sulta essere anteriore allo sviluppo di una opposizione orale/nasa
le dopo consonanti nasali. Come si vede in (3), il Kpelle ha una
opposizione di questo tipo dopo consonanti orali:
(3) [teé]_'pescegatto' [te®] black duiker
(kpaa] 'albero (sp.)' [kpaa] 'albero di cedro'
[kala] 'scatola' [kala] 'loppa, spazzatura'
Cost, l'opposizione di vocali nasalizzate vs. vocali_ orali
in (3) @ stata generalizzata ai nuovi contesti in (1) per mezzo
dei processi in (2).
A questo punto sorge spontanea questa domanda: i mutamenti
in (2) possono verificarsi in una linguache non abbia avuto prece-
dentemente un contrasto nasale/orale dopo consonanti orali? Se (2)
dovesse operare in una lingua cosi, questo significherebbe che la
presenza contro assenza di nasalizzazione in una vocale dovrebbe
essere distintiva solo dopo consonanti nasali, Una lingua come que-
sta violerebbe direttamente l'assunzione n. 13 di Ferguson (1963),
riguardante le nasali, che riproduco in (4
(4) quando in una lingua data si ha una neutralizzazione e-
stensiva di vocali nasali con vocali orali, questa si
verifica vicino a consonanti nasali (p.59)
Cosi, in (5) vediamo che il Nupe ha una opposizione fra [al e [a]
-dopo [b], ma non dopo [m]. Dopo consonanti nasali si hanno solo
vocali nasalizzate.
(5) [bal 'tagliare'
[ba] 'rompere!
[ma] ‘dare alla luce’ PERO':*[{ma]
Come 8 formulata in (4), questa assunzione sembre una restri
zione su sistemi statici. Purtroppo, ci sono dei controesempi. Co-
si, in corrispondenza delle derivazioni Kpelle in (2) ci sono in
(6) le seguenti derivazioni del Dayak della costa (Scott 1957,1964):
6) ‘appoggiare una scala! = raddrizzare’
ina nga/ ina n a/
nanga na nd wet
nana (g>9/n—
[na na?) [na na?) (occlusione glot-
tale)
Come nel Kpelle, c'é una regola che nasalizza le vocali dopo
consonanti nasali. Nel secondo stadio della derivazione, /mb, nd,
ng/ vengono semplificati in [m, n, 1]. Il risultato @ che 1'opposi
zione soggiacente fra /m, n,-n/e/mb, nd, ng/ si realizza come
un'opposizione fra vocali nasali e vocali orali. Dal momento che
il Dayak della costa non ha contrasto fra V e ¥ dopo consonanti o
vali, sembra che si abbia una potenziale violaziohe della genera —
lizzazione di Ferguson. Benché la semplificazione di /mb,nd,ng/
sia oggi variabile, non c'é nulla che impedisca, in via di princi-
pio, che diventi obbligatoria. Una volta che questo si verifichi ,
si_pud avere un caso in cui una opposizione soggiacente fra /V/ e
/¥/ viene neutralizzata dopo consonanti oral.
Considerando questo stato di termini puramente sincronici, sa:
remmo costretti a dire che il Dayak dellacosta sta andando verso una
situazione indesiderabile, precisamente una situazione in cui i
parlanti dovranno produrre e percepire la nasalizzazione delle vo“
cali solo quando queste sono precedute da una consonante nasale.
Sarebbe come se si dovesse produrre e percepire una distinzione
fra [k] e [k*] solo davanti a[u] (e non, per esempio davanti a
[a]). Quindi, anche se sembrano esserci dei motivi per il princi:
pio (4), tuttavia,cosi come & formulato, esso- non & del tutto a
deguato.
Per individuare una formulazione pid appropriata di un prin
cipio valido riguardo alla neutralizzazione di opposizione vocale
nasale/vocale orale, & necessario riconsiderare i fatti visti so-
pra da un punto di vista diacronico (processuale). Date le oppo-
sizioni in (7)
(7) [ta] vs, [ea] [na] vs [na]
non dovremmo sorprenderci di trovare la perdita di una opposizio~
ne, come in (8):
(8) [ta]
[ta]
Ina} ov
nay > Teal
dove vocali orali e vocali nasalizzate si sono neutralizzate dopo
consonanti nasali. D'altra partenon ci si aspetterebbeinvece di tro.
vare che la perdita di questa opposizione si verifica solo dopo
consonanti orali, come in (9):
(9) [ta]
Teale eel
[na]
[na]
In altre parole, se un'opposizione fra vocali orali e voca~
li nasalizzate dovesse diventare irrilevante, cio® dovesse venire
neutralizzata, ciaspetteremmoche questo succeda in un contesto di
consonante nasale, come nell'assunzione di Ferguson.
Dal momento che non-c'é niente di proibito nello stato sin-
cronico che risulterebbe da (9), come sappiamo dal Dayak della co-
sta, deve esserci qualcosa di universale che riguarda il processo
interessato. Possiamo quindi modificare la generalizzazione espres.
sa in (4), nel modo seguente.
(10) Quando in una lingua data vocali orali e vocali nasaliz
zate vengono neutralizzate (si fondono) , storicamente,
cio’ in quanto processo, questo avviene prima in prossi_
mit@ di consonanti nasali
Quello che si viene a dire @ che dato l'inventario in (7), la ten—
denza alla nasalizzazione, come in (8), sara maggiore della tedenza
alla denasalizzazione, come in (9), Questo fatto @ chiaramente solo
un caso particolare di un principio pid generaleche ha a che fare con
la natura delle assimilazioni fonetiche., Quindi, dato L'inventario
in (11)
(11) [eu] vs [k¥ul [kal vs [ka]
ci aspettiamo che la neutralizzazione si verifichi (come processo)
prima in casi come (12)a che in casi come (12)b
12)a k
Q2)@ Tee). pawl b tkal, tye}
Tk¥u} [eval
Tuttavia, come nel caso della nasalizzazione, non vorremmo
dire che la neutralizzazione sincrontca delle consonanti labializ-
zate e non labializzate ha luogo sempre davanti a vocali arrotonda
te, dato che pud esserci una lingua che viola questa _restrizione
sincronica, come nel caso seguente:
(13) feu) > [k¥ul (ce +k/— u)
{keul > [kul (ou>u)
Prima ha luogo la labializzazione davanti vocali arrotondate,
&
e poi il dittongo [au] viene semplificato in [u] Ne risulta che siha
opposizione fra [k] e [k™] davanti a vocali arrotondate, ma non ne~
cessariamente davanti a vocali non arrotondate.
Forse possiamo fare una generalizzazione di questo tipo: un
processo di neutralizzazione pud verificarsi in due contesti logi-
camente distinti: 1) in una posizione in cui ci sia una tendenza
universale a "fonologizzare" una variazione intrinseca originata
dalla coarticolazione di due segmenti; e 2) in una posizione in
cui non ci sia questa tendenza a fonologizzare. Una vocale tendera
a essere in qualche modo nasalizzata quando si trovera accanto a u~
na consonante nasale, cosi come una consonante tendera a essere in
qualche modo labializzata davanti a vocale arrotondata. Quindi i pro
cessi visti in (8) e in (12)a rappresentano una neutral iz
zazione dovuta a fonologizzazione
Cio&, queste neutralizzazioni sono il risultato di assimilazioni;in
(8) si ha una neutralizzazione quando le vocali orali vengono nasa~
lizzate dopo consonanti nasali, e in (12)a si ha neutralizzazione
quando le consonanti vengono labializzate davanti a vocali arroton~
date. In (9) e in (12)b, d'altra parte, non @ appropriato parlare
di vocali nasali che si assimilano all'oralita delle consonanti pre
cedenti, o di consonanti labializzate che si assimilano alla non la
bialita di una vocale seguente. La neutralizzazione invece avviene
attraverso la rimozione di segmenti complessi dall'inventario fone-
tico. In termini praghesi, il primo tipo di neutralizzazione & moti
vato sintagmaticamente, il secondo tipo @ motivato paradigmaticamen
te (cfr. la distinzione di Venneman (1972) fra regole I e regole D).
In conclusione, abbiamo visto che uno stato complesso di na~
salita pud essere capito meglio nei termini del processo nasale che
gli ha dato origine, E' importante sottolineare, perd, che la "stra
na" situazione del Dayak della costa rappresenta una complessita
sincronica, come illustrano altri fatti presentati nella sez.3.
3. Denasalizaazione di consonanti nasali
In questa sezione vorrei discutere tre tipi di denasalizza—
zione di consonanti: 1) all'inizio di sillaba, 2) in fine di silla~
ba e 3) dopo consonante, Il primo tipo di denasalizzazione riguar-
der& il caso inverso di quello visto nella sez. 2; precisamente si
mostrera come la denasalizzazione all'inizio di sillaba, come pro-
cesso, pud essere spiegata solo nei termini dello stato nasale che
la’ produce.
3.1, La denasalizzazione di consonanti all'inizio di sillaba
pud avere almeno due forme, come si vede in (14)
(4am > bo m>b
n> fd ned-1
n> fe n>B
In (14)a@ si ha una denasalizzazione parziale, che converte le
consonanti nasali in occlusive sonore prenasalizzate; in (14)b si
ha una denasalizzazione completa, che converte le consonanti nasa —
li in occlusive sonore ([1] @ spesso la realizzazione della dena-
salizzazione di [n]). Come mi ha segnalato Matthew Chen (comunica-
zione personale), la denasalizzazione parziale @ caratteristica dei
dialetti mandarini sud-occidentali del Cinese, come anche di alcuni
dialetti del cantonese (p. es. il Taishan); la denasalizzazione com
pleta si trova nei dialetti Min meridionali del Cinese. La domanda
che sorge naturale &: perché le lingue subiscono la denasalizzazio-
ne all’inizio di sillaba?
Riferendoci alla distinzione fatta nella sez. 2 fra processi
motivati sintagmaticamente e processi motivati paradigmaticamente,
possiamo facilmente eliminare quest'ultima alternativa. Cioé, dato
che viene generalmente accettato che i mutamenti rappresentati in
(14)a producono segmenti che sono pid complessi dei segmenti corri,
spondenti da cui derivano, non possiamo parlare di denasalizzazione
come semplificazione paradigmatica. Qualcuno potrebbe dire allora
che i mutamenti in (14)b possono essere interpretati come semplifi-
cazioni segmentali (teniamo presente lo status cosiddetto "marca ~
to" della nasalita); tuttavia, una possibilita da considerare & che
(14)a necessariamente rappresenti uno stadio intermedio verso (14)D.
Cio& [ml prima diventa parzialmente denasalizzata in [mb], e poi
10
[G3] diventa completamente denasalizzato in [b]. Se @ corretto par
lare dei cambiamenti in (14)b' come cambiamenti che comportano uno
stadio intermedio con occlusive sonore prenasalizzate, allora il
cambiamento da [fb] a[b] pud essere considerato motivato para~
digmaticamente. Ma questo non ci spiega, perd, come comincia il mu
tamento.
Il fatto piu significativo che riguarda l'inizio della dena-
salizzazione & che questa ha luogo in lingue che oppongono vocali
orali a vocali nasali. Cosi nei dialetti cinesi di cui si parlava,
la denasalizzazione ha luogo solo davanti a vocali orali e non da~
vanti a vocali nasali (che derivano storicamente dalla perdita di
una nasale finale). Ne consegue che un primitivo [ma] sara pronun-
ciato [ba] e un primitivo [man], per esempio, sara pronunciato
{ma]. Percid non succedera mai che la denasalizzazione iniziale e-
limini completamente tutte le componenti nasali dell'inventario fo
netico, dato che [m,n,n] rimangono immutate davanti a vocali nasa-
lizzate.
Possiamo proporre di scrivere le regole di .denasalizzazione
parziale e di denasalizzazione completa nel modo seguente:
c —— w
(15) a@ [+nasale] + [+nasale] [-nasale] /_[-nasale]
c v
b [+nasale] > [-nasale]/__{-nasale]
In (15)a le consonanti nasali diventano occlusive sonore pre.
nasalizzate davanti a vocali orali (queste sono rappresentate come
singoli segmenti con un cambiamento interno di nasalita: v. Ander
son 1975); in (15)b le consonanti nasali diventano occlusive sono-
re davanti a vocali orali. Dato che il fattore rilevante di condi-
zionamento @ l'oralita della vocale seguente, non @ necessario in-
cludere in queste regole un confine iniziale. A questo punto la do.
manda 8: perché le regole di (15) sembra che non si trovino in lin
gue che non hanno opposizione di nasalizzazione nelle vocali?
La risposta ha a che fare con il fatto che la denasalizzazio
ne non & un processo motivate articolatoriamente, ma piuttosto per-
1.
cettivamente. Se ci dovesse essere unaassimilazione articolatoria
nella sequenza [ma], si dovrebbe avere [ma] e non [mba]: questo
dipende forse dall'inerzia del velo, che si abbassa troppo pre-
sto, 0 resta abbassato troppo a lungo, ma non ha una corrispon —
dente tendenza ad alzarsi troppo presto (comunicazione personale
di Jean-Marie Hombert). Allora, l'unica ragione per citi il cinese
e altre lingue denasalizzano le consonanti nasali all'inizio di
sillaba @ quella di rinforzare 1'opposizione fra vocali orali e
vocali nasalizzate (oppure in una lingua come il Guarani, che ha
lo stesso tipo di denasalizzazione parziale di (14)a (Lunt 1973),
di rinforzare 1'opposizione fra "componenti lunghe", 0 prosodie ,
orali e nasali). Nei dialetti cinesi citati sopra, la perdita di
consonanti nasali ha creato non solo un'opposizione fra[pa] e
[pa], ma anche fra [ma] e [ma] (vedi Chen 1975).
La seconda opposizione, perd, @ meno stabile della prima, a
causa dell'effetto intrinseco che ha una nasale su una vocale orale
seguente. Cid significa che [ma] pud tendere a diventare [ ma] ,nel
qual caso l'opposizione fra /a/ e /a/ viene ad essere minacciata.
La parziale denasalizzazione di /m/ in [ib] serve a ostacolare il
propagarsi della nasalita sulla vocale orale seguente. Ne risulta
che viene neutralizzato l'intrinseco effetto nasalizzante di [m].
Abbiamo visto cost che la denasalizzazione ha luogo quando
per mantenere un contrasto percettivo si impone una complessita
di articolazione. I1 contrasto fra vocali orali e vocali nasaliz~
zate, per quanto ne so, @ un prerequisito per la denasalizzazione
all'inizio di sillaba, e questo rappresenta un caso in cui un pro
cesso nasale @ vincolato a uno stato nasale. Cio& il processo di
denasalizzazione pud essere spiegato facendo riferimento allo sta
to nasale che gli ha dato origine: e questo @ un altro modo per
dire che la denasalizzazione iniziale non @ un processo puramen-
te fonetico.
3.2. Un secondo tipo di denasalizzazione di consonanti si
verifica in fine di sillaba, e di nuovo possiamo distinguere fra
denasalizzazione parziale e denasalizzazione completa, nel modo
12
seguente:
(6a m> bm bo om>p
no not
a
n> gn n>k
Una denasalizzazione parziale, come in (16)a, si trova nel
Dayak dell'interno (Scott 1964) e ha la funzione di preservare la
vocale orale che precede (1a funzione di questa regola @ dunque in
conflitto con la regola in (6), che pone una vocale nasale vicino
a una consonante nasale). Si confrontino allora le seguenti deriva
zioni:
(17) ‘un gioco’ ‘stoffa’
/pimain/ /kain/
{ pimain] Ww vino
[aida] w+ GX/[- nagalel—)
Prima si ha la progressiva nasalizzazione in 'un gioco’,
quindi si ha la parziale denasalizzazione dopo vocale orale in
‘stoffa'., Dato che (16)a rappresenta 1'immagine speculare di (14)a,
non ci dobbiamo meravigliare di trovare che le 2 regole di denasa-
lizzazione parziale hanno la stessa motivazione. In (17), /n/ di-
venta [Gi ] allo scopo di impedire che la sequenza vocalica prece-
dente venga nasalizzata. Quindi, come per la denasalizzazione ini-
ziale, non ci aspetteremo di trovare questo tipo di processo senza
che ci sia anche un'opposizione di nasalizzazione (0 per le vocali
© per unita pid ampie del segmento).
Il processo di denasalizzazione completa in fine di sillaba
rappresentata in (16)b sembra molto diversa come motivazione. I so
li esempi che conosco vengono da vari dialetti del Mbam-Nkam par-
lati nel Camerun (le generalizzazioni che seguono sono basate su
mie inchieste dirette):
13
NDA? NDA?
8) Bagam ' Bangou, Bangwa Batcha, Batoufam |
*Vm Vp Vp Vp
“Vn Vn A v
“vn qn Vn vk
Nel territorio Mbam-Nkam la denasalizzazione in fine di sil-
laba si trova in tutto il Sudest (specialmente nei villaggi Nda?
Nda?, di cui fanno parte Bangou, Bangwa , Batcha e Batoufam) e
nel Nordovest nel solo villaggio isolato di Bagam (che la popola —
zione Bagam chiama [yap]). Nel villaggio di Bagam, come pure in al
cuni dei villaggi Nda Nda?, viene denasalizzata solo *m finale.
In altri villaggi Nda ?Nda? sono denasalizzati "me "n (purtroppo
non @ sempre possibile ordinare la denasalizzazione di *n, perché
*n normalmente cade ovunque, tranne che dopo *i, dove diventa [nl).
Dato che il Bagam, da una parte, e il Bangou e il Bangwa dall'al —
tra, indipendentemente, hanno introdotto la denasalizzazione solo
per “m, possiamo intanto fare l'ipotesi che sia pid probabile che
la denasalizzazione finale colpisca prima in questo contesto. C'S
il problema di alcuni dialetti Fe?fe’, perd, che trattano la nasa~
le finale storica nella maniera seguente (Hyman 1972 b):
(19) “Im > Am “In > An “In > Ak
“am > AA(m) *an > AA(n) “an > A?
Nelle formulazioni date in (19), I e A stanno rispettivamen-
te per vocali alte e vocali non alte e AA sta per una vocale lunga
non alta. Le consonanti fra parentesi compaiono in superficie solo
se seguite da vocale, per es [cwee] 'taglia' [cween 1] 'taglialo'
(la storia delle sequenze vocaletnasale @ in realt@ un po'pid com-
plicata di quanto non si veda in (19), dato che talvolta sono perti.
nenti tre gradi di apertura: vedi Hyman 1972b). In (19) vediamo al-
lora per *me *n che le vocali alte diventano non alte, causando
l'allungamento delle vocali storicamente non alte (e la caduta di
“me “n tranne che davanti a vocale). Nel caso di *n, ‘perd, le voca
1i alte diventano non alte, ma *n diventa [x] dopo vocali storica —
14
mente alte, e diventa occlusiva glottale dopo vocali storicamente
non alte. In altre parole, la denasalizzazione si ha solo nel caso
di nasale velare. Benché nel villaggio Fe?fe? di Babouantou ci sia
denasalizzazione anche degli Am e An risultanti da (19) (che diven
tano rispettivamente Ap e At) & tuttavia chiaro dove la denasalizza—
zione colpisce prima per Fe?fe” in generale, Quindi non si vede se 1'ipo
tesi che la denasalizzazione si verifica prima per “m finale possa es
sere tenuta in piedi come tendenza generale (sarebbe bello avere
casi documentati di denasalizzazione provenienti da altre lingue).
Ci sono perd altri due fatti che vanno citati qui. Primo: di tutti
i villaggi che subiscono la denasalizzazione finale, di un tipo o
dell'altro, Batcha @ il pid vicino alla regione Fe?fe?. Dato che
ho mostrato nel mio lavoro precedente che bisogna considerare que-
sti mutamenti in termini di ondate, & possibile che prima *m sia
diventato [p] a Batcha (e altrove nella regione Nda?nda?), e poi
che la regola sia stata estesa a *n che & diventato [k] (si ricor
dino le difficolta che comporta ordinare la possibile denasalizza-
zione di *n). Questa seconda parte del processo di denasalizzazio-
ne sarebbe stato diffuso poi per contatto nel Fe?fe?. In questa
prospettiva il Fe?fe? non avrebbe iniziato il processo di denasa —
lizzazione e quindi si pud mantenere la generalizzazione secondo cui
la denasalizzazione dovrebbe aver avuto luogo prima nel caso della
nasale labiale.
Un secondo fatto & che il Fe?fe? @ situato nel territorio
Mbam-Nkam delltest, dove 1'indebolimento delle velari finali & mol
to pid forte che altrove. Cosi la proto-occlusiva orale velare che
ricostruisco come *g, benché venga pronunciato [k] in altri dialet.
ti, nel Fe?fe? diventa [h] e infine si perde completamente senza
lasciare traccia.
Altri due dialetti nella parte orientale del territorio Mbam
Nkam, subiscono pure una perdita considerevole di velar: a Ban-
gangte “n si perde dopo vocali non alte, e in Bamoun sia *n che *g
si perdono dopo tutte le vocali. Per le labiali non si nota in que
sti dialetti una corrispondente tendenza a cadere. Quindi il fatto
che la denasalizzazione di *n nel Fe?fe?, venga prima potrebbe es
15
sere in parte attribuito all'indebolimento delle velari finali in
generale - e non solo delle velari nasali.
Sembra allora che, se vogliamo cogliere qualche generalizza~
zione-valida riguardo alla denasalizzazione finale, per cominciare
dobbiamo capire qualcosa di pili riguardo al perché essa ha luogo.
Io considero la denasalizzazione come il risultato di una forte
tendenza nel Nbam-Nkam a non rilassare le consonanti finali In
Hyman (1972 b) dicevo che la [m] e 1a [n]. finali sono talvolta
(parzialmente) desonorizzate in Fe?fe?, e che la denasalizzazione
di queste consonanti nel villaggio di Babouantou avviene in questo
modo:
(20) *vm > Vg > Vp
*vn > Va > Vt
8
La denasalizzazione delle nasali finali naturalmente si pre-
sta a un successivo processo di denasalizzazione, dato che [Vm] e
(vp] vengono percettivamente confuse con [Vp] e [Vt], che normal-
mente sono occlusive non plosive.
Un fatto interessante riguardo a questo processo di denasalizzazio
ne @ che esso non lascia come residuo una vocale nasalizzata, e che
neppure la denasalizzazione parziale vista in (16)a crea una nasa~
lizzazione "compensatoria" della vocale, In conclusione, né la de~
nasalizzazione parziale, né la denasalizzazione completa che ab-
biamo visto in (14), creano vocali nasalizzate, Nessuna delle deri
vazioni di (21) & percid-attestata, per quanto ho potuto appura~
re:
a. a
(1) a ma > mba bam > abm
ma > ba am > ab
I1 solo caso in cui si pud avere un trasferimento di nasali
t@ auna vocale vicina @ quando una consonante viene cancellata
piuttosto che quando viene denasalizzata. La derivazione di Vda
VN @ ben nota. La nasalizzazione associata-con il morfema ‘prima
16
persona singolare' in Terena (vedi Bendor-Samuel 1960, e la discus
sione in Leben 1973) si pud osservare in (22):
(22) [owoku] ‘la sua casa’ [éw#dngu] ‘la mia casa’
Dato che la nasalizzazione comincia all'inizio di parola e siespan
de finché non viene bloccata da una occlusiva non bassa, siamo au~
torizzati a ricostruire 'la mia casa’ come *Nowoku, forse anche ad
arrivare fino a *n owoku. Quando si perde la prima nasale, la nasa
lizzazione diventa distintiva, un tratto prosodico di questa lin-
Qua.La possibilita di mantenere o meno la generalizzazione per cui
la nasalizzazione compensatoria non accompagna la denasalizzazione
dipendera dall'esame di un maggior nuimero di dati. Anderson (1975)
per esempio; cita il caso di certe lingue celtiche, in cui *m si
lenisce in [ ¥] (da un precedente [w]?). E' interessante che in que
sto caso il risultato @ una continua piuttosto che un'occlusiva, un
fatto che pud diventare di una certa importanza per la questione.
Tuttavia, anche in casi isolati didenasalizzazione, come quando “n
diventa [1] in Palauan (Foley 1975), non si sviluppa nasalizzazio-
ne compensatrice. Nel caso di denasalizzazione parziale questo ha
grande rilevanza, dato che abbiamo visto che (14)a e (16)a sono
motivate da un rinforzo percettivo della oralita della vocale a>
diacente. Lo scopo della denasalizzazione @ quindi di proteggere le
vocali orali adiacenti e difenderle dalla minaccia di assimilazio
ne nasale. La causa della cancellazione completa della nasale,d'al
tra parte, pud essere molto diversa. Cosi, quando “VN diventa [¥],
la motivazione primaia & di tipo articolatori:
t una tendenza a
produrre generalmente sillabe aperte. Cosi, dato che questo muta —
mento non & motivate dal bisogno di eliminare la nasalitd di N fi-
nale, ma piuttosto la sua consonanticitd, 1a cancellazione di N
pud essere (ma non necessariamente) accompagnata da nasalizzazione
compensatoria.
3.3. C'S perd un tipo di denasalizzazione che @ spesso accom
pagnato da nasalizzazione vocalica, e precisamente il passaggio da
7
*cnv a [CV]. Come @ sostenuto in Hyman (1972 a) e come viene gene-
ralmente accettato e-ulteriormente esemplificato da Williamson
(1973), la nasalizzazione vocalica nelle lingue Kwa si sviluppa il
pid delle volte’ nel modo seguente:
(23) *cvNV > CNV > CNV > c¥
Prima CVNV diventa CNV con la sincope della prima vocal
poi la
vocale diventa nasalizzata ‘e infine la consonante nasale (0, ilche
& lo stesso, la soluzione nasale della consonante orale) viene per
duta. ‘Cosi, il Gwari [gna] ‘dire’ @ in relazione con il Proto Mbam-
Nkam (non Kwa) "gama, e la forma [gi] del Nupe, che @ strettamente
collegato, potrebbe venir derivata dalla forma Gwari, attraverso i
mutamenti fonetici in (23). .
Come si @ appena visto, (23) nen rappresenta un processo di
denasalizzazione. Perd si osservano nell'Igbo mutamenti del seguen-
te tipo:
(24) *pVNV > pNV > phV > phV > (pV)
*EvNV > ENV,> EV > FV
In (24) *p sta per un'occlusiva o un'affricata, e *f sta per
una continua. Come in (23) la prima vocaie viene sincopata, dando
come risultato una sequenza CNV. A questo punto si ottengono due de
rivazioni. Le non continue diventano aspirate, e la nasalizzazione
di "N viene trasferita sulla vocal
in moltre varieta la nasaliéza
zione viene poi perduta dalla vocale. Le continue d'altra parte,non
diventano aspirate, ma trasferiscono la nasalizzazione sulla voca~
le, cancellando la *N;.anche in questo caso, la nasalizzazione qual,
che volta si perde, benché ci siano molti dialetti "centrali" il
cui sistema ha [phv] e[£V] (in altre varieta non si trovano conso-
nanti aspirate, e non @ chiaro se queste variet& sono passate 0: no
attraverso lo stadio con 1'aspirazione).
Questo stesso processo di sviluppo di CN in Ch (dove Ch rap~
presenta aspirazione nel caso di *pN e sussurro nel caso di *bN)pud
18
essere osservato in parecchie lingue della Nuova Caledonia (Haudri
court 1962), come si vede in (25):
(25) Nemi Hyénghéne — Voh-Koné
pmu fa hmu "pisello"
poYas~ fw hm¥a— “genero-suocero"
In (25) possiamo considerare le forme Nemi come proto-forme,
cio® potremmo indicarle con “pm. Haudricourt dice specificamente
che alcune forme con CN derivano da strutture pia antiche CVNV
(per esempio *tama > tna 'padre’) il che rende queste forme ancora
pid vicine agli esempi Kwa. La domanda da porre @ se il mutamento
da *pmV a [phi] (e poi 4 [ £V]) possa essere considerato un processo
di denasalizzazione. Come nei casi di denasalizzazione del Fe?fe?
dati in (20), possiamo ipotizzare uno stadio intermedio CY (cfr.
Williamson 1973). Perd questo non spiega come *bN diventa un suono
sussurrato. Probabilmente ha pid senso dire che sia “p che *
“ostruentizzano" la nasale seguente, che diventa poi una fricativa la
ringale appropriata: [h] dopo sorde non continue e[ fil dopo sonore non
continue (un processo simile a questo pud essere proposto anche per
il mutamento da *NC a Ch in alcune lingue bantu (vedi Givon 1974),
benché in questo caso sembri che debba limitarsi a combinazioni di
nasali +sorde non continue).
I fatti dovrebbero essersi svolti secondo lo schema (26):
(26) *pNV > pNV > puv > ph¥ > phv
*bNV > BNV > BNV > bhV.> bhV
Il primo mutamento, e il pid cruciale, @ l'ostruentizzazione
per cui *N diventa sorda dopo *p e sussurrata dopo *b (una nasale
sussurrata @ una nasale ostruente). Gli altri mutamenti comportano
la nasalizzazione della vocale, la denasalizzazione di [N] in [h]
edi fn] in [f], e la denasalizzazione della vocale.
19)
4. Conclusione
Nelle sezioni precedenti abbiamo esaminato casi di neutraliz~
zazione di vocali nasalizzate e di denasalizzazione di consonanti
nasali. Abbiamo visto che stati di nasalita e processi di nasalita
interagiscono in modi complessi e non sempre ovvi. Molio di pid si
pud dire sui tipi di fenomeni nasali che si trovano in varie lin-
gue. Due aree che finora ho evitato sono la cancellazione di nasa-
le in fine sillaba e la cancellazione di nasale davanti a fricative
sorde, Tutti e due questi processi sono particolarmente comuni alle
lingue africane in generale e in particolare nelle lingue Mbam-Nkam,
espero di riferire su questo in un prossimo lavoro.
Per gli scopi di questa conclusione mi limiterS a un ultimo
punto. Nella nostra ricerca di universali linguistici, abbiamo spes
so occasione di citare dati da lingue che talvolta conosciamo bene,
talvolta non conosciamo affatto. Se i pezzetti di informazione che
possediamo portano tutti verso una stessa direzione, non c'é nessun
problema. I problemi sorgono quando un frammento dei dati viene usa
“to come controesempio a una generalizzazione che @ stata raggiunta
attraverso l'esame di, lingue méglio conosciute. Cio8, frammenti- di
dati di lingue poco note devono essere elaborati sempre riferendosi
a um quadro teorico indipendentemente motivato. Il quadro teorico
all'interno del quale ho affrontato le nasali e la nasalizzazione
in questo articolo mi ha permesso di proporre alcune generalizzazio
ni che senza una dicotomia fra stato e processo potevano andare per
dute 0 offuscate. Una delle conclusioni che abbiamo tratto nella se.
zione 2 era che ci sono generalizzazioni che sono valide se applica
te a processi, ma non sono valide se applicate a stati, Le lingue
hanno regole fonologiche sincroniche che non sono talvolta diverse
per forma e per sostanza dal tipo di processi diacronici naturali
che spesso si trovano.
Vorrei concludere con un esempio abbastanza spettacolare trat
to da una lingua in cui i processi diacronici sono molto diversi
dalle regole sincroniche che normalmente verrebbero proposte. Shimi_
zu (1971) presenta i seguenti mutamenti storici.che hanno portato
dal Proto-Jukunoide al Wukari e ad altre varieta del Jukun (ho con-
20
densato un po! i dati per rendere pili facile la presentazione):
(ay (b) fe) (a)
(27) *mab > mib > ma
“mam > mam > ma
“ma > ma > ma
‘mab > Ba
‘Gam > mmam > mam > mim > ma
*Gba > fda
*bab > ba
“bam > bam > ba
*ba > ba
In (27) m sta per una delle tre proto-nasali finali *m, ‘*n,
o *n, mentre"b sta per una proto-consonanti orali *p, *t, "k, “by
*d, *g. Il proto-Jukunoide, quindi, era caratterizzato da sillabe
che potevano essere chiuse da occlusive sia nasali che orali. I
mutamenti che comporta il passaggio da queste proto-strutture sil-
labiche a quelle del Wukari e di altre varieta sono di questo ti-
pos (a) i fonemi* /mb, fd, 8/ sono passati a geminate nasali se
c'era una nasale che seguiva nella parola (un mutamento dello stes
sotipo, noto come 'Legge di Meinhof', si @ avuto in Bantu); (b) que
ste geminate nasali vengono degeminate; (c) le vocali subiscono na
salizzazione sia davanti che dopo consonanti nasali; e (d) tutte le
consonanti finali cadono.
Il risultato di questi cambiamenti @ che in un dialetto come
il Wukari, nove proto-tipi sillabici vengono ridotti ai quattro’ ti
pi che si vedono in (28):
(28) [ba] [mba]
[ba] [ma]
A causa della distribuzione complementare di [fb] che si ha
solo davanti a vocali orali, e di[m], che si ha solo davanti a vo
cali nasalizzate, @ possibile fonemizzare [mba] con /ma/ e [ma] con
[ma] . Abbiamo allora bisogno della regola (29):
21
(29) [mw Vv
fa [-nasale]
a
ne
Perd, se consideriamo i mutamenti storici di (27) vediamo che
nella storia dello Jukun, non si @ avuto diacronicamente un proces~
so di questo tip
la possibilita di rappresentare la variet@ Wuka-
ri in sincronia con 1a regola (29) @ il risultato dell 'interazione
dei vari mutamenti fonetici mostrati in (27).
(Welmers 1968 riconosce in /ba/, /bi/, /ma/ e /fba/ una regola im-
plicita che nasalizza le vocali dopo una consonante nasale). Per
fortuna la regola (29) @ attestata come processo diacronico, come
abbiamo visto in (14)a e (15)a. Tuttavia le ricerche condotte inter
Linguisticamente per individuare universali fonologici, devono sem-
pre’ tentare di: isolare processi "spéciosi" che sembrano contraddire
ben motivate restrizioni sia statiche che processuali del lin-
guaggio.
22
BIBLIOGRAFIA
Anderson $.R. (1975) "The description of nasal consonants and inter,
nal structure of segments", Nasalfest, Stanford.
Bach, E. e R, T.Harms (1972), "How do languages get crazy", In
R.P.Stockwell e R.K.S.Macaulay (eds.) Linguistic change and
generative theory. Bloomington 1-21.
Bendor~Samuel, J.T. (1960) "Some problems of segmentation in the
phonological analysis of Terena", Word, 16, 348-355, (Anche
in F.R.Palmer, (ed.) Prosodic analysis, London 214-221).
Chen, M. (1975) “An areal study of nasalization in Chinese". ‘In
Nasalfest, Stanford.
Dwyer, D. (1974) “The historical development of Southwestern Mande
consonants", Studies in African Linguistics, 5, 59-94,
Ferguson, C.A.°(1963) "Assumptions about nasals: a sample study in
phonological universals". In J.H.Greenberg, (ed.) Universals
of language, 2nda. ed. 1966, Cambridge, Mass. 53-60,
Foley, W.A. (1975) "Nasalization as universal phonological process".
Nasalfest, Stanford.
Given, T. (1974) "Rule un-ordering: generalization and de-generali-
zation in phonology". In Papers from the parasession on natu-
val phonology, Chicago Linguistic Society, 103-115.
Greenberg, J.H. (1966) "Synchronic and diachronic universals in pho-
“ nology". Language, 42. 508-517.
Haudricourt, A.G, (1962) "Les consonnes postnasalisées en Nouvelle
Caledonie". Proceedings of the Ninth International Congress
of Linguists , Tne Hague, 460-461 (Anche in A.G.Hauérivourt,
Problémes de phonologte diachronique, Paris (1972), 359-361).
Hyman, L.M. (1972a) "Nasals and nasalization in Kwa", Studies in
African Lingutstics, 3. 167-205. c
- (1972b) "A phonological study of Fe?fe? - Bamileke". Supple-
ment 4 to Studtes in African Linguistics.
- (1973) "Notes én the history of Southwestern Mande" Studies
in African Linguistics, 4, 183-196.
- (1975) Phonology: Theory and analysis. New York,
23
Jakobson, R, (1941) Child Language, aphasia, and phonological uni-
versals, trad, dall'originale tedesco di A.R.Keiler. The
Hague (1968)
Leben, W.R. (1973) "The role of tone in segmental phonology". In
L.M.Hyman (ed.) Consonant types and tone, Los Angeles (Sou—
thern California Occasional Papers in Linguistics I), 115-
149,
Lunt, H.G. (1973) "Remarks on nasality: the case of Guarani". Ih
S.R.Anderson e P,Kiparsky (eds.) Festschrift for Morris Hal-
le, New York, 131-139,
Scott, N.C, (1957) "Notes on the pronunciation of Sea Dayak", Bul-
letin of the School of Oriental and African Studies, 20,
509-512. .
- (1964) "Nasal consonants in Land Dayak (Bukar~Sadong)" In
D.Abercrombie (ed.) In honour of Daniel Jones, London,
432-436,
Shilizu, K, (1971)' Comparative Jukunotd: an introductory survey.
Tesi di dottorato, Department of Linguistics and Nigerian
Languages, University of Ibadan, Nigeria.
Vennemann, T. (1972) "Sound change and markedness theory: on the
history of the German consonant system", In R.P, Stockwell e
R.K.S.Macaulay (eds.) Linguistie change and generative theo-
ry, Bloomington, 23-274,
Welmers, W.E, (1962) "The phonology of Kpelle". Journal of African
Languages, 1. 69-93.
- (1968) "Jukun of Wukari and Jukun of Takum", Occastonal Pu
blication, 16 of the Institute of African Studies, Universi
ty of Ibadan, Nigeria,
Williamson,k, (1973) "More on nasals and nasalization in Kwa", Stu
dies in African Linguistica, 4, 115-138,
Ma £ ALTRE AVVERSATIVE?
Maria Vittoria Giuliani - Istituto di Psicologia del C.N.R., Roma.
- Comando che mi diciate cosa vuol dire quel "ma.
- Quel "ma" yuol dire che non potrai scappare se non farai
morire il re degli animali ~ disse la colonna.
Féaba Italiana
l.
(1) Sposerebbe giovane ricca, bellissima, possibilmente bionda
ma illibata, muri propri, senza difetti fisici.
L'annuncio* - oltre’al sorriso di cui spesso dobbiamo essere
grati a questo genere di prosa - ci offre lo spunto per iniziare u
na analisi del ma, dei processi mentali che ne costituiscono il si.
gnificato e ne condizionano 1'uso.
La frase presenta una prim ambiguita nell'incertezza circa
i termini della congiunzione, che potrebbero essere sia le sole pa
role contigue al ma (bionda o posstbilmente bionda e illibata),sia
tutto cié che precede e segue.
Perché il compilatore dell'annuncio ha sentito il bisogno di
un m2, anziché continuare con una semplice virgola l'elenco dei re
quisiti? Ma,dicono i dizionari, @ una congiunzione avversativa;
ra, in che senso 1'illibatezza si troverebbe in qualche rapporto
di avversazione con le altre richieste elencate nell'annuncio?
1.1. Una risposta potrebbe essere che il mi riflette una cer=
ta sfiducia nella possibilita di trovare una persona che a tutte le
altre virti unisca anche quella.dell'illibatezza; 1'autore deil'an-
nuncio pensa cio® che sia logico, naturale, ecc. aspettarsi che una
fanciulla cosi ricca di doti sia facile preda dell'altro sesso: il-
libata si opporrebbe quindi non a bionda, bellissima, ece., ma al-
L'aspettativa implicita di mancanza di verginita.
26
1.2. C'& a mio parere almeno un'altra interpretazione, meno
densa di implicazioni socicculturali, ma forse pia verosimile, se~
condo la quale il ma mette in contrapposizione non gia i requisi —
ti, bensi la maggiore o minore irrinunciabilita a qualcuno di es-
si. Tl ma cio& designerebbe 1'opposizione tra il posetbilmente che
precede bionda e 1a mancanza di un'analoga precisazione per 1'illi
batezza; con un'approssimativa esplicitazione: "se possibile, bion
da, ma in ogni caso illibata”.
2. - Le due interpretazioni sembrano corrispondere ai due ti
pi di "ma" distinti da Robin Lakoff (1971)3.
La Lakoff riduce tutti i casi di but a due tipi principali:
il but di “opposizione semantica", che corrisponde a avd simmetri-
co ed & caratterizzato dalla possibilita di invertire 1'ordine dei
termini senza cambiamento sostanziale di significato (seconda let~
tura dell'esempio); e il but di “negazione aspettativa", che corri
sponde a and asimmetrico e dove i termini non sono invertibili
(prima lettura dell'esempio).
2.1. Nel primo tipo, le due proposizioni congiunte da but
“devono avere un topte comune" e le predicazioni devono contenere
una differenza: pud trattarsi sia di una “antinomia lessicale"
(John is tall but BLL is short), e in questo caso i soggetti devo
no essere diversi, cio8 x(S,) e y(Sz) partecipano delle stesse pro
prieta tranne una; sia di opposizione di valore, cioé le predica —
‘gioni hanno, indipendentemente dagli altri tratti semantici, due
segni di valore opposti (John te rich but dumb); sia infine di una
diversita non meglio precisata (Fords can go fast, but Oldsmobiles
ave safe).
2.2, Nel secondo tipo sono invece presenti una o pid presup~
posizioni e la nozione di causalita. Secondo la formalizzazione di
George Lakoff (1971) con la frase S; but Sz, nel senso della nega-
zioné di aspettativa, si asserisce S$; and $2 e si presuppone Exp
($12 ~S2), vale a dire l'aspettativa che la prima frase implichi
27
la negazione della seconda. La frase @ grammaticale solo rela ~
tivamente alla o alle presupposizioni dalle quali pud essere dedot
to Exp (8; > ~ So).
Secondo 1'analisi di Robin Lakoff, a but vengono dunque asse
gnate almeno due rappresentazioni semantiche strutturalmente diver
se, e forse pid se si volessero spiegare anche i casi chiamti
(non so quanto giustificatamente) strani o aberranti.
3. - Lo scopo di questo lavoro é di vedere se un'analisi in
termini dinamici delle operazioni mentali corrispondenti al ma pos.
sa cogliere 1'identita costruttiva sottostante alle diverse occor-
renze della parola e che fa da sostegno ai diversi rapporti eegni-
tivi che di volta in volta si possono istituire, al mutare del con
testo o dei termini congiunti da m.
bee
4.1, L'argomento fondamentale avanzato dalla Lakoff per so-
stenere lo sdoppiamento del ma ® l'invertibilita dei termini nel
caso dell’ opposizione semantica.
Ora, prendiamo ad esempio
(2) Questa stoffa @ solida, ma costa molto.
Sembrerebbe trattarsi di un tipico caso di mzsimmetrico, data 1'a~
nalogia semantica con la frase che ne risulta invertendo i ter—
mini
(2a) Questa stoffa costa molto, ma @ solida.
Proviamo perd a inserirla in un contesto, per esempio come rispo-
sta alla domanda "Secondo te questa stoffa @ un affare?", Assumia~
mo che alla solidita sia attribuito valore positivo e all!alto
prezzo valore negativo.
Avremo allora le due possibilita:
(3) No, @ solida ma costa molto
oppure
(4) Si, costa molto ma & solida:
mentre l'inversione darebbe luogo a due frasi inaccettabili percha
incoerenti con 1'assunzione fatta:
28
(3a) *No, costa molto ma @ solida
e
(4a) *Si & solida ma costa molto.
Ltinversione sarebbe possibile solo nel caso di
(5) Non saprei, costa molto ma @ solida
(Sa) Non saprei, @ solida ma costa molto.
La frase-ma ® cio la spiegazione della risposta -"No","Si",
"Non saprei" - alla domanda "x @ un affare?". Poiché affare", | in
questa accezione, ha una connotazione positiva, il posto del rema,
cio& dell'informazione nuova, verra occupato dall'elemento connota
to anch'esso positivamente, e 1'inverso avverra nel caso della ri-
sposta negativa.* Nel caso della risposta incerta non @ possibile
invece ricavare dall'espressione linguistica quale sia l'elemento
negativo e quale il positivo: si ha solo l'informazione che i due
elementi (1'essere solida e l'essere cara) sono considerati parite
tici in rapporto all'acquisto di una stoffa.
Liinvertibilita dei termini mi sembra quindi un criterio ec~
cessivamente artificioso, valido solo se si assume come oggetto di
analisi la frase isolata dal contesto.
Pid che da una diversa struttura del "1
ma", la possibilita di
invertire i termini in alcuni casi e non in altri appare riconduci
bile a criteri pragmatici: la contrapposizione tra il valore attri,
buito alla predicazione del primo termine e quello attribuito alla
predicazione del secondo pud infatti pragmaticamente produrre due
risultati a seconda del peso relativo ad essi attribuito. In un ca
so il secondo bilancia, equilibra quello del primo termine, impe —
dendo un giudizio globale che abbia lo stesso segno di valore del
primo; nell'altro invece non solo impedisce tale giudizio, ma lo
sostituisce con un giudizio di segno opposto. La (3) e la (4) sono
appunto esempi di questo secondo tipo e richiedono, la prima, 1'as
sunzione che il prezzo abbia un peso maggiore della solidita nel
determinare il giudizio sulla stoffa e quindi il suo eventuale ac~
quisto; 1a"Seconda, l'inverso. La (5) e la (Sa) sono invece due e~
sempi, del primo tipo.
29
Non accettare il test dell'invertibilita non basta perd, di
per sé, a far cadere la distinzione tra i due tipi di ma. in real
ta, il test ha senso solo in un'impostazione di tipo logicistico,
dove per rapporti come la congiunzione, disgiunzione, ecc. l'ordi,
ne degli elementi @ indifferente - e questo sarebbe il caso del-
L'opposizione semantica: dire che "bello" si oppone a "brutto" e
quivale a dire che "brutto" si oppone a "bello" come p|q = q|p -
mentre per 1'implicazione l'equivalenza non sussiste:
poaéaq>p-
Se anziché di rapporti logici ci occupiamo di rapporti se-
mantici, l'ordine diventa ordine di costruzione delle operazioni
mentali che costituiscono il significato delle parole e assume
quindi importanza primaria. Sembra invece che solo di recente gli
studi linguistici abbiano, preso in seria considerazione il fatto
alquanto ovvio che lo sviluppo nel tempo della stringa fonica im-
pone gia di per, s& un ordine semanticamente non casuale, perlome-
no per L'ascoltatore. L'inappropriatezza di frasi come la (3a). e
la (4a) nel contesto dato mette comunque in difficolta 1'ipote-
si di un ma simmetrico proprio nei casi apparentemente meno pro —
blematici.
4.2. La differenza tra ma di opposizione semantica em di
negazione di aspettativa 8 attribuita dalla Lakoff alla struttura
del presupposto e non dell'asserito: @ vero che anche nel caso
dell'opposizione semantica vi sono delle presupposizioni, ma si
tratta di presupposizioni lessicali dei termini contrapposti.
L'opposizione non deriverebbe quindi dal gioco dioperazioni men-
tali che costituiscono il rapporto designato da ma, ma sarebbe
gia insita nei termini stessi del rapporto: "in this type of. sen-
tence the presupposition is apart of the lexical itemthat is contra
sted, rather than residing in the speaker's knowledge of the
world
" (R.Lakoff, cit., p. 134).
La differenza tra
30
(6) Bruna @ alta e Vittoria @ bassa
e
(7) Bruna @ alta ma Vittoria @ bassa
sembrerebbe derivare quindi solo dal fatto che nella (7) c'@ una
presupposizione (1'opposizione tra "alto" e "basso") assente nella
(6)
lessicali, non @ chiaro come possa essere presente in un caso eman
se si tratta perd di una presupposizione inerente alle voci
care nell'altro,
4.3. Anche nel caso dell'opposizione di valore, il tratto se
mantico [+positivo] sembrerebbe essere assegnato dalla Lakoff alle
voci lessicali prese indipendentemente dal contesto. Ora, vi sono
certamente caratteri, per esempio "bello", "onesto", ecc. associa
ti in genere ad un valoré positivo, ed altri, "stupido", "sporco",
ecc. associati ad un valore negativo, o che designano essi stessi
un valore; ma, poiché l'attribuzione di un valore avviene sempre
in funzione di un criterio, anche se tacito,nulla impedisce che,
mutato il criterio, muti anche il valore assegnato a qualcosa. Lo
stesso contenuto mentale pud quindi ricevere un valore, a seconda
del contesto, positivo o negativo, che si tratti o no di costrutti
ai quali viene di norma associato un valore.
Vediamo una frase come
(6) Non & molto caldo, ma & umido.
Se si sta parlando, per esempio, del clima di una serra, molto pro
babilmente 1a mancanza di caldo sarA considerata negativa e 1'umi-
dita positiva, mentre sara probabilmente il contrario se invece
che di piante ci si sta occupando di esseri umani. Questo natural-
mente vale anche per la semplice differenza: anch'essa risultato
di un'operazione di confronto tra due termini categorizzanti in
rapporto a un sistema di riferimento.®
Non @ quindi, come afferma Brunot (1965) a proposito delle
avversative, che l'opposizione tra btanco e mero risulti dalla na~
tura delle cose e quella tra un vesttto di lana e um vestito di co
tone'sia "fatta nascere dallo spirito a seconda delle circostan—
ze". Si tratta invece probabilmente solo di familiarita ed esten—
31°
sione del sistema di riferimento. E’ appunto sulla difficolta a ca
tegorizzare due termini in rapporto ad uno stesso. sistema di rife-
rimento che si basa 1a comicita delle freddure del tipo "sai qual @
la differenza?", per esempio:
- Sai qual & la differenza tra un bigné e un tram?
-2
~ Che il primo & pieno di crema e il secondo di gente!
4.4, Tuttavia, pid che dall'equivocita del contenuto delle
presupposizioni mi sembra che la difficolta nasca dalla nozione
stessa di presupposizione, continuamente in bilico tra una nozione
logica, definibile in termini di deducibilita tra frasi e di valo~
ri di verit&, e quindi indipendente dal'contesto, e un concetto
pid vicino a quello del parlare comune, definibile in termini di
requisiti o condizioni cognitive o situazionali per 1'esecuzione di
certe operazioni mentali.®
Una distinzione non particolarmente nuova né esauriente ma
forse utile per gli scopi inmediati di questo lavoro @ quella che
si pud istituire tra presupposizione (a) come parte delle operazio
ni costitutive del significato di una frase di contro ad asserzio-
ne, domanda, ecc. e (b) come condizione per eseguire quelle opera-
zioni.
All'interno del secondo gruppo si possono fare altre distin=
zioni: (b.1) condizioni relative alla compatibilita dei pezzi da
mettere in un rapporto designato (restriztont lessicali tra argo —
menti di un predicato e tra predicato e argomenti, ad esempio quel
le violate in La mela pensa); (b.2) condizioni relative alla com-
patibilita tra 1'operare designato e il sapere, le conoscenze enci
clopediche (restriztoné cognitive, violate ad esempio in Oggi mio
nonno compie tredici ant) ;(b.3) condizioni relative all'adeguatezza
tra l'operare designato e la situazione intesa nel senso pid ampio;
comprendente cio® contesto, scopi del parlante, rapporti tra par-
lante e ascoltatore, ece. (restriatont pragmatiche, violate ad e-
sempio in Hat Letto questo Libro?, quando sia detta al telefono).
Quando G.Lakoff assegna a
32
(9) John is Republican but he is honest
la forma
Asserzione: f(a) e g(a)
Presupposizione: (x) Exp(f(x) 2 ~ g(x))
dov
f = ts @ Republican
g = 18 honest
a = John
fla) = 8,
gla) = 8, (p- 67)
inserisce nella rappresentazione semantica una presupposizione nel
senso (b.2), che pertiene cioé alla rappresentazione cognitiva o,
come dice Ducrot (1972), al "
"componente retorico". Che "nessun re~
pubblicano @ onesto" non & infatti comunicato da (9), ma ne costi-
tuisce un'inferenza, come quando da
(10) Franco @ morto per aver mangiato cetrioli
si tragga una generalizzazione di pericolosita dei cetrioli per al,
tri esseri umani che non Franco.
Come vedremo ancora parlando delle frasi controaspettative ,
la presupposizione generaledi Lakoff @ inferibile solo in certi
contesti, e considerarla parte del significato della frase fa cor-
rere inoltre il rischio di una regressione all'infinito verso il
generale.Per esempio, per
(11) It is June, but it is snowing
perché fermarsi ad una presupposizione esplicitabile come "ci si a
spetta che in giugno non nevichi" e non risalire invece a "ci si a
spetta che d'estate non faccia freddo", ece.? Anche qui la rico~
struzione di una catena deduttiva ha un indubbio interesse quando
si studino i meccanismi dell'inferenza, ma pud essere antieconomi-~
co in un'analisi semantica.
5. - Considerate queste difficolta, cercherd di definire il
significato di ma senza far ricorso al termine presupposizione, ri.
mandando il problema al momento di proporre una formalizzazione in
termini semantico-generativi.
Assumerd come significato di ma una variante di quanto propo
ne Ducrot’, cio&: ma vuol dire "costituire un primo pensiero (p),
33
associare ad esso un secondo pensiero (r), aggiungere al primo un
terzo pensiero (q) che esclude l'assunzione del secondo". "r" non
viene mai esplicitato.
Il rapporto di ASSOCIAZIONE tra "p" e-"r" 8 un rapporto non
simmetrico nel senso che il risultato @ di un termine (r) associa
to all'altro (p), e non di due termini associati tra loro: con u~
na certa metaforicita si potrebbe dire che 8 un rapporto pid di
con" che di "e".
5.1. La modifica pili evidente della definizione di Ducrot &
che‘nella mia analisi non entra in gioco 1'ascoltatore. In realta
penso che proprio nel caso di ma il ruolo dell'ascoltatore abbia
un peso notevole, non tanto perd quale supposto soggetto di una e
ventuale conclusione da "p" a "r", quanto perch® probabilmente
con il ma alcuni elementi del pensiero corrispondente non vengono
comunicati esplicitamente proprio per il motivo che il parlante
assume che l'ascoltatore li costruisca 0 li abbia gia costruiti-o
facciano parte di un bagaglio culturale comune, ecc.
Il discorso resta quindi aperto in direzione di un'analisi pragma
tica piuttosto che semantica®.
5.2. Altre differenze riguardano la precisazione dei rap-
porti tra "p" e "r" e tra "q" e "r". Dire che da "p" di potrebbe
"concludere” "r" mi sembra rimandare ad un rapporto di consequen-
zialita trai due termini pid forte del necessario. Anche a que-
sto proposito pud essere illuminante-una situazione di dialogo:
(12) ~ C'erano Mario e Luigi?
- Clera Mario ma non Luigi.
(13) = Cosa fanno le bambine?
~ Maria gioca ma Giovanna studia.
Analizzando le frasi-ma degli esempi in termini di "conclu~
sione" da "p" a "rt", si avrebbe, per la (12), "dato che c'era Ma~
rio [1'ascoltatore concludera che] c'era Luigi” e, per la (13),
"dato che Maria gioca [1'ascoltatore concluderd che] Giovanna non
34
studia (o gioca anche lei)". Ma le domande precedenti, dove Mario
e Luigi, ele bambine, sono su uno stesso livello di richiesta di
informazione, senza che traspaiano particolari ipotesi sui rappor,
ti tra i personaggi (in un caso vi @ un rapporto di AGGIUNTA desi.
gnato dae, nell'altro un plurale),sembra escludere il sussistere
della "conclusione" anzidetta.
5.3. Per quanto riguarda invece il rapporto tra "q" e
mi sembra preferibile parlare di "esclusione" anziché di
traddizione". Poniamo per esempio che dall'analisi d
(14) Siamo andati in albergo, ma Mario era fuori
si ricavi che "r" sia "abbiamo parlato con Mario", mi sembra pid
preciso dire che "Mario era fuori" esclude, e non contraddice,
"gli abbiamo parlato".
6. - Vediamo ora di applicare lo schema delineato a diver-
se frasi-ma, cercando di dare conto di alcune possibilita di para
frasi:?
(15) Piove, ma fa caldo
(16) Giovanni & simpatico, ma Luigi @ bello
(17) L'ho inseguito, ma mi si 2 rotta 1a macchina
(18) Non si tratta di tisi, ma di bronchite
Per (15) @ possibile la parafrasi
(15a) Piove eppure fa caldo
mentre la sostituzione di ma con eppure da luogo a frasi anomle
negli altri casi:
(16a) "Giovanni @ simpatico eppure Luigi @ bello
(17a) *L'ho inseguito eppure mi si @ rotta la macchina, ecc.
Vi sono perd altre parafrasi possibili, in distribuzione
complementare:
(16b) Giovanni @ simpatico, perd Luigi @ bello
(18b) Non si tratta di tisi, bensi di bronchite,
Abbiamo poi casi in cui il ma sembra insostituibile con al-
tre avversative:
(19) Cappuccetto rosso coglieva fiori nel bosco, Ma improvvisamen-
35
te il lupo.
(20) Ma sei sordo?
In riferimento alle diverse parafrasabilita, possiamo distin
guere le frasi-ma in quattro gruppi principali:
I. Frasi valoristiche o valutative, dove ma @ sostituibile con
perd;
II. Frasi controaspettative, dove mi ® sostituibile con eppure;
III. Frasi correttivo-sostitutive, dove ma @ sostituibile con
benst;
IV. Frasi dove ma non @ sostituibile; eventuali distinzioni al-
L'interno del gruppo dovranno owviamente basarsi su criteri
diversi dalla parafrasabilita.
6.1. Frast valutative. Appartengono a questo tipo gli esempi
su cui Ducrot Confronta’ la sua analisi del ma. Ducrot fornisce ar-
gomentazioni convincenti per sostenere che vi sono probabilmente
tante letture di una frase con ma quanti sono i diversi contesti
per i quali la frase & appropriata, in quanto, pur restando identi
co lo Schema del significato, varierebbe di volta in volta il con~
tenuto di "r".. Prendiamo: 7
(21) L'appartamento @ grande ma non ha il bagno
parafrasabile con
(21a) L'appartamento @ grande perd non ha il bagno,
Secondo 1'analisi di Ducrot dovremmo dire che, a seconda dei conte’
sti, dall'asserzione che "l'appartamento @ grande" si potrebbe con
cludere, per esempio, che "risponde alle mie esigenze", oppure "
eo.
sta molto" 0 "lo posso vendere a caro prezzo" o ancora "lo prendo
in affitto", ecc., tutte cose che verrebbero "contraddette"” dal-
L'asserzione che l'appartamento "non ha il bagno". Questa interpre
tazione perd non mette in luce il fatto che (21), al contrario per
esempio di :
(22) E vissuto a Roma per dieci anni ma non sa una parola di ita-
liano,
comunica una valutazione opposta sui predicati-di Fj e Fy e non
36
spiega perché in nessuno dei contésti previsti & possibile la so-
stituzione in (21) dima con eppure, mentre per la (22) & accet-
tabilissima la parafrasi
(22a) E' vissuto a Roma per dieci anni eppure non sa una parola
d'italiano.
Parlando dell'attribuzione di valore, dicevo prima che oc-
corre sempre precisare il criterio in base al quale essa viene
fatta. A mio parere, cid che Ducrot identifica con "
"8 proprio
il criterio di valutazione, mtevole appunto a seconda delle cir-
costanze. La grandezza di un appartamento e L'assenza di bagno,
per esempio, sono elementi che possono essere valutati positiva —
mente o negativamente in funzione delle esigenze abitative, del
maggiore o minore costo di vendita o di affitto, ecc. Dalla loro
presenza come termini contrapposti del rapporto designato da ma
possiamo ricavare che si tratta di valutazioni di segno opposto
(0 dello stesso segno ma di intensit& diversa).
La valutazione positiva o negativa del primo predicato non
verrebbe perd esclusa, come invece richiede il mio schema, dal se
condo predicato, & neppure da una valutazione di segno opposto at
tribuita ad esso. Inoltre si tornerebbe in questo modo ad_uno
schema simmetrico analogo a quello della Lakoff, che avevo esclu-
so. L'operare designato da ma richiede infatti un successivo pas-
saggio costituito dal trasferimento sul soggetto!® della valuta —
zione attribuita al predicato ed @ appunto questa possibile valu-
tazione che viene esclusa dalla valutazione contraria del secondo
predicato. Essa introduce infatti un nuovo elemento che richiede
di essere preso in considerazione e che pud rovesciare completa —
mente il giudizio sul soggetto.
Se riprendiamo 1'esempio dell'appartamento avremo allora:
p = l'appartamento ha una caratteristica positiva (o negativa)
x = l'appartamento @ positivo (o negativo)
q = l'appartamento ha una caratteristica negativa (o positiva).
6.1.1. Se L'analisi 8 corretta metterebbe in luce un aspet-
to interessante del pensiero relativo ai valori, in quanto presup-
37
pone il principio generale che, dato un giudizio positivo o nega~
tivo, su una carattertstica del soggetto, vi @ la tendenza a e-
strapolare un giudizio dello stesso segno sul soggetto nel suo in
steme}?,
Un espediente retorico diffusissimo consiste infatti nel ri
spondere alla richiesta di un giudizio su qualcosa con la valuta-
zione di una sua caratteristica, a volte del tutto marginale, la~
sciando all’ascoltatore, cosi "indirizzato", il compito di trarre
da s& il giudizio complessivo, e quindi dandolo solo implicitamen
12/8 stato coniato il termine "ma
te. Nel dialetto napoletano
scarrupativo” per indicare la formula retorica usata per provoca~
re un giudizio negativo su di una persona e che consiste appunto
nel presentarne un lato positivo e poi, preceduti da ma, una se~
rie di elementi valorificati negativamente che annullano il possi
bile giudizio positivo sul soggetto, per esempio:
(23) Mario @ intelligente, ma quando comincia a parlare non lo
ferma pid nessuno, ha la testa dura, vuole avere sempre ra-
gione, ecc.
6.1.2. La lettura valutativa non @ legata solo all'assegna—
zione di due valori opposti alle predicazioni dei due termini cor,
relati: si pud trattare dello stesso valore, ma in grado diverso,
ovvero se la predicazione del primo termine & positiva, la predi-
cazione del secondo potra essere tanto negativa, quanto pid posi-
tiva o meno positiva:
(24) Bruna @ buona, ma Vittoria @ buonissima
(25) Paolo @ un bravo romanziere, ma @ un poeta ancora migliore
(26) Silvia & veloce a correre, ma meno a nuotare, ecc.
In questo caso il giudizio sul soggetto che corrisponde a "r" sa~
ra pil ricco, facendo riferimento ad una valutazione non solo
“qualitativa" ma anche "quantitativa", assoluta se si tratta di»
un solo soggetto e relativa se di due o pid.
6.2. Frast controaspettative. Ducrot, nel respingere 1'ana~
lisi di Lakoff di
38
(9) John is Republican, but he is honest
attribuisce alla frase diverse letture possibili
"Supposons que le destinataire cherche a embaucher ~ pour quelque
basse besogne ~ un homme qui aurait ces deux propriétés, rarement
conjointes, d'étre républicain et malhonnéte. Le locuteur pourrait
trés bien employer la phrase en question pour lui déconseiller
tel candidat: "I1 est républicain, mais honnéte". Ici notre de~
scription générale conviendrait: "ne tire pas de son républicani-
sme cette conclusion qu'il fait 1'affaire, car il est honnéte"
Bien plus, cette description permet de comprendre, comme un cas
particulier,l'emploi auquel pense Lakoff. On supposera que, dans
ce cas, la conclusion "r" est une évaluation de type moral. Le
mouvement de la phrase serait alors: "ne conclus pas de son répu-
blicanisme A sa valeur (ou a son absence de valeur), car il est
honnéte” (dans 1a mesure oi 1'honn@teté passe pour une qualité, il de,
vient prévisible que 1'évaluation envisagée @ partir du républi —
canisme est défavorable; et ce serait l'inverse si 1'honnéteté é-
tait jugée un défaut)". (p. 129).
Ma la lettura che Lakoff vuole prendere qui in considerazio
ne in realta @ un'altra, di pura constatazione, e non implica al-
cun giudizio di valore sull'onest& o 1'appartenenza al partito re
pubblicano: nei termini di Ducrot potrebbe essere trascritta solo
come:
p = John & repubblicano .
r John @ disonesto
q = John @ onesto.
Che questa sia una lettura non appropriata ad alcuno dei
contesti semplificati da Ducrot,, sembra confermato dal fatto che
in italiano @ questa 1'unica lettura parafrasabile con
(9a) John @ repubblicano eppure @ onesto.
D'altro canto non mi sembra che vi siano motivi per conside
rare, come fa Ducrot, letture diverse di una frase quelle in cui
sia assegnato un giudizio di valore a seconda che sia dato
in base a criteri etici o utilitaristici.
6.2.1, Se l'ultima lettura della (9) @ caratterizzata dal-
la possibilita di sostituire ma con eppure, vediamo di stabilire
le condizioni generali in cui questa parafrasi & possibile e di
“39
capire quale sia il significato di eppure e in che cosa si diffe-
renzi da quello di ma.
Per la (9) si & visto che la lettura in cui mz pud essere
sostituito da eppure @ quella in cui "r" corrisponde al contra —
rio diq", nel nostro caso appunto "John & disonesto". Si direb-
be dunque che il primo elemento di distinzione fra ma ed eppure
sia che la proposizione che segue eppure non esclude semplicemen-
te, come il secondo termine del mz, la possibilita di assumere
"rc", ma ne asserisce esattamente il contrario, o 1'opposto.
Poiché "cr" per definizione & sempre implicito, L'ipote-
si non @ verificabile direttamente: un metodo di verifica pud es~
sere di inserire le frasi in contesti che consentano in modo abba
"r"'. Per esempio, prendiamo la
stanza univoco L'individuazione di
frase
(27) Sono le cinque, ma Franco non @ arrivato,
La parafrasi con eppure,
(27a) Sono le cinque, eppure Franco non @ arrivato,
& possibile, ma solo quando il contesto fornisca indicazioni per
associare a "sono le cinque" il pensiero "Franco 8 arrivato" e
non un qualsiasi altro la cui assunzione viene esclusa dall'asser
zione che "Franco non @ arrivato"; per esempio
(27b) Non possiamo cominciare lo spettacolo. Sono le cinque
as
eppure
} Franco non @ arrivato
di fronte a
A ma ee
(27c) Sono le cinque { } Franco non @ arrivato,
eppure
Strano! Di solito alle quattro @ gia qui.
Ho parlato di contrario, di opposto e non di negazione di
q" nei .confronti di "
roe
Prendiamo infatti
(28) - Sai che le svedesi sono tutte alte?
- Non tutte; Cristina @ svedese eppure @ bassa.
40
(29) I1 medico mi ha detto che bere fa veniremal di fegato, inve~
ce io bevo tutti i giorni eppure sto. benissimo,
Mi sembra plausibile che la lessicalizzazione degli elemen-
ti impliciti nella (28) e nella (29) possa essere rispettivamente
“Cristina @ alta" (0 meglio "Cristina dovrebbe essere alta") e
"ho mal di fegato" (o meglio “dovrei avere maldi fegato"). Sareb-
be scorretto in tal caso parlare di negazion
; alta non @ la nega
zione di bassa, cosi come sto benissimo non. la negazione di ho
mat dé fegato, ma appunto l'opposto, il contrario o qualcosa di a
nalogo. Naturalmente "q" pud anche essere l'esatta negazione di
“r", ma solo come caso particolare di un pid generale rapporto di
opposto, contrario, ecc.!3. .
In ogni caso, se anche qui come per il ma l'elemento impli-
cito non pud essere ricavato premettendo non alla proposizione
che segue l'avversativa (0 togliendolo se la frase % negativa),
per l'eppure esso appartiene ad una gauma necessariamente Limita~
ta, poiché viene fornita non solo 1a proposizione a cui si oppo —
ne, ma anche il criterio in base al quale le due asserzioni pos~
sono ritenersi opposte: "r" infatti deve intrattenere con "p" lo
stesso rapporto che intrattiene con "q".
6.2.2. Per riassumere, dunque, nel ma, "q" esclude L'assun-
zione del penstero inplictto "vr", mentre nell'eppure "q" é L'oppo
sto di "p14, La differenza ha notevoli conseguenze:
Si consideri ad esempio una situazione come
(30) Hai visto Mario con il cappotto nuovo?
L'ho incontrato ieri, ma era senza cappotto.
La sostituzione nella risposta di eppure a ma da origine a una
frase inappropriata:
(30a) *L'ho incontrato ieri eppure era senza cappotto.
I1 pensiero associato in un contesto del genere della (30)
sembra non possa essere che "ho visto il cappotto di Mari|
op-
pure "ho visto Mario con il cappotto" e simili. Che "Mario fosse
senza cappotto" esclude che l'ascoltatore possa assumere che"1'tio
visto con il cappotto" o "ho visto il suo cappotto", in quanto si
41
tratta di situazioni che si escludono a vicenda,ma evidentemente
non costituisce un'asserzione contraria od opposta. La negazione
dell'elemento implicito, cio8, nel ma non viene asserita, bensi la
sciata all'attivita inferenziale dell'ascoltatore.
Questo spiega perch® siano accettabili frasi in cui cid che
precede e cid che segue il ma sembrano non avere alcun rapporto
tra loro, come potrebbe essere in
(29) Fa caldo ma Luigi ha la febbre
ove il pensiero associato sia per esempio "
potremmo andare al ma~
re", e dove per capire il ma occorre sapere o inferire che il fat
to che uno abbia la febbre ostacola 1'andare al mare.
Un altro esempio pud essere
(30) E' magro ma mangia poco.
Supponendo che chi @ magro desideri ingrassare e cerchi di
raggiungere questo scopo mangiamlo in abbondanza, avremmo una pri
ma lettura, dove ma & sostituibile con eppure, in cui "r" sarebbe
“mangia molto", cio& l'assunzione che c'é un vincolo ad associa~
re l'essere magro con il mangiare molto. Vi ® perd una seconda
lettura, caratterizzata da un'intonazione esclamativa, giustifica
toria, per cui l'essere magro non @ la possibile causa di un man-
giare abbondantemente, ma @ il mangiare poco che @ visto come cau
sa priia dello stato di magrezza; una parafrasi, potrebbe essere
(32a) E' magro, ma gia, mangia cosi poco!
In questo caso il pensiero associato, che viene escluso dall'as —
serzione "mangia poco” pud appartenere a tutta una gamma di possi
bili assunzioni "@ malato", "@ di costituzione sottile", "c'@ da
stupirsene", ecc., che vengono tutte escluse dall'’esplicitazione
del motivo della magrezza.
6.2.3. La differenza nel rapporto tra "q" e non basta
comunque a distinguere i significati di m e eppwe.
Se infatti in
(12) - C'erano Mario e Luigi?
- Cera Mario ma non Luigi
sostituiamo ma con eppure
42
(12a) C'era Mario eppure non Luigi
la frase vuol dire molto di pid che non la corrispondente con mz.
L'appropriatezza di una parafrasi con eppure implica infatti che
tra Mario e Luigi esista un particolare rapporto tale da far pen-
sare che se c'é l'uno ci sia (ci dovrebbe essere) anche l'altro.
Come si @ visto anche per la (32) l'operazione per cui dato
'p" si costruisce
non pud quindi essere di semplice associa —
zione, ma semmai di un vincolo sull'associazione. Riassumendo, po
tremmo definire il significato di eppure con questa sequenza di ©
perazioni: costituzione di un pensiero "p", attribuzione di un vin
colo all'associazione ad esso di "r", costituzione di un pensie~
ro "q" in opposizione a "
x". L'operazione che possiamo chiamare
di ASSOCIAZIONE VINCOLATA @ soggetta alla restrizione che i due
contenuti di pensiero si trovino o possano essere posti in un rap
porto di tipo condizionale, che possiamo esprimere come "se
p allora dovrebbe-esserci r".
La distinzione tra l'operazione di ASSOCIAZIONE VINCOLATA ,
espressa da eppure, e quindi parte delle operazioni costitutive
del suo designato, e il rapporto condizionale, visto come restri-
zione per l'applicabilita di tale operazione, risponde alle assun
zioni teoriche esposte parlando della nozione di presupposizione,
ma permette anche una maggiore generalizzazione esplicativa. Come
lo schema inferenziale dell'implicazione logica!® da origine a
quattro diverse soluzioni’ di uno stesso rapporto di implicazione,
cosi nel caso di eppure possiamo supporre che uno stesso rapporto
condizionale costituisca un requisito cognitivo per 1'appropria —
tezza di diverse frasi espresse con eppure, per esempio
(33) E' nuvolo, eppure non piove
(34) Piove, eppure non @ nuvolo!
(35) Non @ nuvolo eppure piove -
(36) Non piove, eppure @ nuvolo!
In questo senso possiamo dire che il rapporto condizionale
tra uno stato del cielo e il piovere costituisce la presupposizio
ne cognitiva dell'operare designato dalle diverse frasi.
La (34) e la (36) sono marcate da un'intonazione diversa ri
spetto alla (33) e alla (35): per quanto tutte le frasi con eppu-~
43
re abbiano un'intonazione leggermente esclamativa, che indica la
meraviglia per la rottura di uno schema cognitivo,'® mi sembra
che nelle due in esame tale meraviglia sia accentuata. Cercherd
in seguito di spiegare il perch, limitandomi per il momento a
contraddistinguerle con il punto esclamativo.
Un esempio particolarmente chiaro della situazione @ dato
da
(37) Pierino & pid piccolo eppure non ha pianto
(38) Pierino non ha pianto, eppure @ pid piccolo!
La differenza @ messa-in luce da diverse possibilita 0 no
di parafrasi
(37a) *Pierino @ pid piccolo, nonostante che non abbia pianto
(38a) Pierino non ha pianto, nonostante che sia pid piccolo
(37b) Pierino & pid piccolo, e cid nonostante non ha pianto
(38) *Pierino non ha pianto, e cid nonostante & pid piccolo
(37c) *Pierino & pid piccolo, pur non avendo pianto
(38c) Pierino non ha pianto pur essendo pid piccolo.
E' evidente che se per la (37) & plausibile un rapporto con
dizionale
I, "se Pierino & pid piccolo avrebbe dovuto piangere"
non sembra altrettanto accettabile per la (38):
II. “se Pierino non ha pianto avrebbe dovuto essere pid grande"
(0 "meno piccolo").
A mio parere infatti abbiamo un unico rapporto condizionale, (I),
e l'intonazione di (38) serve a marcare 1'inversione dei pensieri
associati da eppure rispetto al rapporto condizionale.!7
Questo spiegherebbe anche perché nella (38) eppure non pud
essere sostituito da ma conservando la stessa intonazione: ma in~
fatti non richiede la restrizione che i due termini siano posti
in un rapporto condizionale e quindi non ha la possibilita di mar,
care inversioni di ordine, dato che 1'unico ordine & quello di co
stituzione dei pensieri associati.
Non in tutti i casi perd l'inversione da luogo alla forma
marcata, per esempio
(42) Lo sono alto eppure mio fratello @ basso
44
(43) Mio fratello @ basso eppure io sono alto
possono avere entrambe sia la forma:neutra che quella marcata.
Infatti sono accettabili entrambi i rapporti condizionali:
III. "se io sono alto anche mio fratello dovrebbe esserlo"
Iv. "se mio fratello & alto anch'io dovrei esserlo".
A seconda che si parta dall'uno o dall'altro si avranno quin
di le due forme. Si tratta tuttavia di un'ipotesi’ provvisoria, che
per essere precisata richiede un approfondimento del rapporto chia
mato per ora "condizionale".
Sotto questo rapporto si possono infatti trovare casi molto
diversi, come gid in parte si accenna nei lavori gia citati di Gri,
ze e Matalon, che determinano un comportamento diverso quando da
formule di tipo logico si passi ad espressioni linguistiche, ove
occorre tenere conto di fattori quali tempo, aspetto, stativita,
ece.; per cui ad esempio sono accettabili
(44) Se piove mi bagno
e
(43) Se piove mi bagnerd,
ma non
(46) *Se piove mi sono bagnato;
e invece sono accettabili
(47) Se firma i progetti ha ‘una laurea in ingegneria
e :
(48) Se firma i progetti ha preso una laurea in ingegneria,
ma non
(49) *Se firma i progetti prendera una laurea.
6.2.4. Un elemento finora trascurato nella caratterizzazione
dell'operazione di ASSOCIAZIONE, presente. nelle due avversative, &
la precisazione del contenuto dei termini associati.
Se sostituiamo eppure a ma in
(50) Bruna & andata all'Universita ma sapeva che era chiusa
(51) Bruna @ andata all'Universita ma era chiusa
(52) Bruna 8 andata all'Universita, ma l'ha trovata chiusa
otteniamo frasi che hanno gradi diversi di accettabilita:
45
(50a) Bruna & andata all'Universita, eppure sapeva che era chiusa
(Sla) ?Brunaé andata all'Universita, eppure era chiusa
(52a) “Bruna & andata all'Universita, eppure 1'ha trovata chiusa,
La (51a) mi sembra accettabile solo se intesa allo . stesso
modo della (50a), cio8 ricavandone che secondo il parlante "Bruna
sapeva che 1'Universit& era chiusa", mentre non si pud giungere
alla stessa conclusione dalla corrispondente frase con ma. La
(52a) parrebbe invece decisamente inaccettabile!®.
Un tentativo di spiegazione pud essere il seguente. Nel ma,
" 8 una possibile assunzione, attribuita dal parlante all'ascol
tatore, o alla gente, o a se stesso precedentemente, che viene as
sociata alla situazione linguistica, quando "p" sia designato, o
non Linguistica, come nei casi cui si accenner& in seguito di ma
in inizio di frase. In eppure i termini associati non sono assun~
zioni relative a una situazione comunicativa ma sono le situazio
ni designate stesse ad essere poste in un rapporto condizionale
stabile, per cui data l'una, ci dovrebbe essere, o essere stata
o essere in futuro anche l'altra. Per tentare un'esemplificazione,
si pensi alla differenza tra "pensare (ed eventualmente dire) che
x & in un certo rapporto con il pensare y" e "x @ in rapporto con
y"3 0 anche: "dato il pensiero x, potrebbe darsi in associazione
il pensiero y" e di contro: "dato l'evento x, dovrebbe esserci
levento y",19 7
Nel caso della (52a) non @ possibile logicamente quella vio
lazione del rapporto condizionale che permette 1'uso di eppure,
per l'insussistenza del rapporto stesso: infatti per trovare una
Universita chiusa o aperta, bisogna esserci andati, e il verbo
“trovare" indica invece una casualita impossibile in un rapporto
condizionale.?°
Si noti la differenza con la situazione ripetitiva:
(56) Bruna @ andata all'Universita, eppure la trova sempre chiu-
sa!
che suona come un commento sulle stranezze di questa tal Bruna.
L'esempio‘concorda anche con quanto detto a proposito della marca
tura e della causa indiziale; la situazione di partenza infatti
46
mi pare sia che "se Bruna trova sempre 1'Universita chiusa, @ stra-
no che ci sia andata" e non che "se Bruna &. andata all'Universita,
allora c' da assumere che non la trovi sempre chiusa”.
Appartengono a questo tipo le frasi che potremmo chiamare
"giustificatorie" o di "tentativo fallito", ove appunto il pensie~
ro associato sembra essere 1’assunzione che lo scopo dell'azione
descritta con il primo termine @ stato raggiunto. I1 secondo termi,
ne esplicita il motivo per cui questo non @ accaduto. Per esempio
(57) Avevo deciso di troncare tutto, ma non ne ho avuto il corag-
gio
(58) Siamo andati in albergo, ma”Piero era uscito
(59) Volevo telefonargli, ma 1'apparecchio era guasto
(60) Bruna provd a parlare, ma la voce le si ruppe, ecc.
Si direbbe quindi che all'individuazione di un fine segua l'as
sunzione del suo raggiungimento, a meno che questo non venga esclu
so esplicitamente. Si tratta di un tipo di economia informativa,
per cui se il tentativo non @ riuscito 1'informazione sarebbe inu~
tile, a meno che non si faccia una cronaca degli avvenimenti (8
successo questo e poi quello) o non si voglia mettere in luce L’in
tenzione di fare qualcosa: @ per questo che ho parlato di frasi
giustificatoris
"Non eredere che non ti amt perch® ieri non mi sono fatta viva. Ho
provato a chiamarti, ma il telefono era guasto...".
La telefonata non c'é stata, ma 1'intenzione si.
6.3. Frast correttive-sostitutive.?! 11 terzo gruppodi frasi
con ma & costituito dal tipo correttivo-sostitutivo, dove ma pud
essere sostituito da benst. Le condizioni che caratterizzano que —
sto tipo sono a) la presenza nel primo termine delia negazione non
eb) che questa negazione non sia riducibile, cio® assorbibile dal
primo termine con rovesciamento di significato,
(61) Non bello ma buono”
consente infatti due letture
(61a) ‘“non-bello (=brutto) ma buono"
47
dove mi pud essere sostituito da perd, e
(61) "NON bello ma buono"
dove ma pud essere sostituito solo da benet.
E' a questa seconda lettura che mi riferisco parlando di ne~
gazione irriducibile. Quando poi le predicazioni sono’ costituite
da‘ termini antitetici, del tipo "asciutto/bagnato", "bello/brutto",
ecc., la lettura non pud essere che una, in quanto la riduzione
della negazione darebbe luogo a una tautologi.
(62) *non~bagnato (=asciutto) ma asciutto??
(63) *aon-bello (=brutto) ma brutto, ecc.
Se i due termini sono posti invece in gradazione, come "bello/bel-
lissimo" dalla riduzione risulterebbe invece una contraddizione:
(64) *non-bello (=brutto) ma bellissims,
In realta, anche negli altri casi vi sono elementi che faci-
litano la scelta di una lettura o dell'altra, per certe caratteri-
stiche della cancellazione.di pezzi. uguali in cid che precede o se
gue il ma. Prendiamo per esempio le due asserzioni "Luigi non @ in
telligente" e "Luigi @ furbo". La frase risultante dalla coordina~
zione mediante il ma sara
(65) Luigi non @ intelligente ma furbo, :
se la frase @ del tipo correttivo-sostitutivo, e
(66) Luigi non @ intelligente ma @ furbo
negli altri casi, ad esempio nella lettura valoristica.
6.3.1, Luise F. Pusch ha elaborato una serie di test per di-
stinguere i casi in cui in tedesco si pud usare aber da quelli in
cui si usa sondern, test perfettamente trasferibili all'italiano
per determinare quando ma & sostituibile da benst, per esempio:
ma
(67) Non beve ()0.;} fuma
(63a) Fortunatamente non beve {#),.,;} sfortunatamente fuma
ma A
64) Nor pad a correre ;} solo camminare
(64) Ner pud ancor ere (east?
48
ma ta A
(64a) Non pud ancora correre epensit gia camminare, ecc.
Se identifichiamo "p" con cid che precede il mz @ evidente
che in questo caso lo schema adoperato finora non funziona.
Prendiamo una frase come
(69) Giuseppe non @ brutto ma bello,
All'asserzione che "Giuseppe non @ brutto" @ possibile associare
innumerevoli pensieri, ma certamente i piii implausibili sarebbero
proprio "Giuseppe @ brutto" o "Giuseppe non @ bello", che sono i
primi ad essere esclusi dall'asserzione che "Giuseppe 8 bello".
Ma se "p" non @ il primo termine della congiunzione, come lo si rico
struisce? Ci sono due elementi che caratterizzano l'asserzione ne~
gativa che precede il ma~benst; il primo @ che si tratta di una ne
gazione refutativa, il secondo che 8 una negazione contrastiva.
La negazione refutativa si distingue dalla descrittiva per-
ché @ parafrasabile con "Nego che" oppure "Non @ vero che", ecc.
ed @ analizzabile in due tempi che corrispondono all'assunzione, ri
ferita all'ascoltatore, di un contenuto positivo, e alla negazione
di tale assunzione: Antinucci e Volterra (1973) 1’hanno rappresen~
tata come una presupposizione "Il parlante assume x" e un'asserzio
ne "Uso il linguaggio perché non voglio che tu assuma x". In que-
sto caso x @ una frase.
La negazione contrastiva qualifica un solo costituente della
frase e richiede percid un'ulteriore assunzione. Won contrastivo e
non non-contrastivo si distinguono per la posizione che possono as
sumere all'interno della frase: il primo deve sempre occorrere pri.
ma, anche se non necessariamente subito prima, dell'elemento quali
ficato, mentre il secondo occorre in posizione fissa primi del ver
bo della proposizione cui si riferisce, sia essa principale 0 su~
bordinata.
Un controllo con il test della Pusch mostra infatti che la
aggiunta nei due termini di fortunatanente e efortunatamente & am-
missibile solo quando la negazione compaia prima del verb:
(70) *Fortunatamente non Giuseppe vincera la cattedra, ma sfortuna
tamente Luigi
49
(71) *Sfortunatamente la cattedra la vincera non Giuseppe ma fortu
natamente Luigi
(72) *S£ortunatamente Giuseppe otterra non la cattedra ma fortuna~
tamente 1'incarico
(73) *S£ortunatamente non la cattedra ma fortunatamente 1'incari —
co vincera Giuseppe
(74) Sfortunatamente Giuseppe non vincera l'incarico ma fortunata-
mente lo vincera Luigi
e quindi solo nel caso che permette la lettura non parafrasabile
con benst.
E' chiaro che non & il contenuto dell'avverbio che determina
la compatibilita o meno con il bens?, quanto il fatto che si trat-
ta di avverbi che qualificano tutta la proposizione: dato che nel-
1'uso contrastivo 1a negazione non pud quaiificare che un solo co-
stituente per volta, se si tratta dell'avverbio non pud essere che
questo a cambiare, restando immutato il resto della frase:
(75) Non fortunatamente, ma sfortunatamente Giuseppe vincera 1'in
carico.
Il costituente "contrastato" viene quindi sostituite con la frase
ma-benst. Prendiamo per esempio eB
(76) Non @ Carla che & uscita?3,
In quanto negazione refutativa, essa richiede, come si @ visto, la
assunzione positiva "@ Carla che & uscita" che a sua volta, inquan
to contrastiva, richiede un'assunzione come "x @ uscito". Abbiamo
cosi tutti i pezzi richiesti per ricostruire lo schema del ma. Con
sideriamo
(77) Non @ partito Mario ma Luigi.
p" sara "x & partito"; 7
" "Mario 8 partito" e "q" “Luigi & parti.
to". La frase che precede mz non corrisponde quindi a "p", ma alla
negazione di "r"
» che viene in seguito escluso da cid che segue il
ma.
Vi @ infatti in questa costruzione una ridondanza che la ren
de particolarmente adatta per scopi retorici, anche perché crea u~
na equivalenza a volte artificiosa tra cid che segue e cid che pre
cede il ma nei confronti di "r": come si & detto, "q" infatti
50
sclude "r" sostituendone un componente.
Operativamente, "r", anziché seguire il primo termine della
congiunzione, come avviene nel caso di eppure, lo precede. Questa
ipotesi sembra confermata dal fatto che, qualora venga esplicitato
il primo termine della contrapposizione, il non potra essere prece
duto da eppure:
(78) - Di dov'é Pierre?
- Ha un nome francese, quindi sara francese!
- Ti sbagli, ha un nome francese, eppure non @ francese ma i
taliano.
Anche questo caso viene quindi ricondotto, nonostante 1'appa~
rente diversita, allo schema generale del ma.
6.4. Ma non sostituibile. 11 criterio della sostituibilita &
sempre abbastanza opinabile, poiché, come si @ visto per esempio
paragonando il ma con l'eppure, la sostituzione porta invariabil ~
mente con sé sfumature diverse, spesso assai significative.In real
tA, i casi che ho voluto raggruppare in questa classe sono in gene
re casi di ma in inizio di frase, come quelli esemplificati dalla
(19) e dalla (20).
6.4.1. la (19) (Cappuecetto rosso coglieva fiort nel bosco.
Ma improvvisamente ecc.) appartiene a un tipo molto diffuso nella
narrativa infantile, favolistica, e il ma potrebbe essere tranquil
lamente eliminato. L'avversativa, svolge perS una funzione retorica
per cui l'evento narrato dopo il ma viene ad assumere 1'aspetto di
qualcosa di nuovo, di inaspettato e che crea quindi nel lettore un
effetto di emozionante suspence. L'eppure nella stessa posizione
non avrebbe senso proprio perché, come si @ accennato, il rapporto
di opposizione non @ posto tra gli eventi narrati, ma tra 1'assun-
zione del secondo termine e possibili assunzioni inferibili dalla
vicenda precedente.
6.4.2, Pid interessanti sono forse i casi di ma preposto a
domande, siano esse domande in senso proprio, ovverc richieste di
51
informazione:
(79) Ma hai aperto la porta?
dove evidentemente qualcosa induce in parlante a pensare che l'or-
dine o la richiesta precedente non siano stati eseguiti, sia quel-
le che Crisari (1973) chiama "domande non istituzionali"
(80) Ma sei matto?
(81) Ma chi ti credi di essere?
(82) Ma non vedi che @ chiuso?
In tutti i casi direi che 1'elementé comune @ 1'atteggiamen-
to critico, negativo, del parlante rispetto ad una situazione de-
terminata dall'ascoltatore. Cid concorda con il fatto che solo a
una gamma limitata delle domande elencate da Crisari possa essere
Preposto congruentemente il ma, appunto a quelle in cui si suppo-
ne una presupposizione di non opportunita o simili. Se nella doman
da priva di ma:
(83) Ti serve davvero?
probabilmente il parlante si limita a invitare l'ascoltatore a ri-
considerare le sue proposte o decisioni, con il ma:
(77a) Ma ti serve davvero?
egli entra in primo piano comunicando anche ia sua opinione negati.
va. Poniamo che A dica a B che vuole comprare una nuova automobile
e che B giudichi 1'acquisto inutile. La frase-ma corrispondente a
tale situazione potrebbe essere qualcosa di analogo a
(83b) Vuoi comprare una macchina nuova, ma non ti serve.
B giudica antieconomico verbalizzare il primo termine’ della coordi
nazione dato che & stato-proprio 4 a dirglielo: ritiene "brutale"
dire ad A che fa male, ed "eufemizza" la sua risposta trasformando
la in una pseudo domanda da cui comunque traspare il suo giudizio
negativo; "r" potrebbe essere qualcosa come "la macchina ti dovreb
be servire"™.
L'interesse di queste frasi deriva comunque non. tanto
dalla particolare struttura, quanto dal contenuto che permette di
ricostruire i termini mancanti. Ritengo quindi pit interessante e-
saminarli dal punto di vista pragmatico.
52
NOTE
1 Ringrazio gli amici che mi hanno aiutato e incoraggiato nel
corso del lavoro, T-Musatti, L.F.Pusch, B.Zonta e soprattutto G.Ba
rosso.
L'articolo 8 apparso in una versione preliminare nel 1974 co
Rapporto Tecnico dell'Istituto di Psicologia del C.N.R., Roma.
2 La frase fa parte dei testi usati da Bortolini e Zampolli
per la compilazione del lessico di frequenza dell'italiano. Anche
altri esempi usati nel testo sono tratti, o ispirati, dal materia~
le tabulato messomi gentilmente a disposizione.
3 Ho visto troppo tardi il lavoro di Irena Bellert (1966) per
tenerne conto in questo scritto.
“ I) suggerimento.mi & stato dato da Luise F.Pusch.
5 V.S.Ceccato, "Costruzione di un soggetto celebre" in Un tec
nico tra i filosofi, vol. Il, Padova 1966; B.Zonta, "Spunti di gram
matica operativa", Centro di Cibernetica e di Attivita Linguisti
che, Milano 1973.
© Del resto, dopo anni di discussioni, la questione delle pre
supposizioni @ ben lontana dall'essere chiarita; anzi, nel passag-
gio dai logici e filosofi del linguaggio ai linguisti, si 8 forse
ancora piii complitata. Fino al 1972, si pud vedere 1a bibliografia
di Zuber (1972); negli ultimi anni si pud dire che non vi sia lin-
guista che direttamente o indirettamente non abbia toccato il pro-
blema. Citerd solo gli atti della "Texas Conference on Performati-
ves, Conversational Implicature, and Presuppositions", marzo 1973,
e l'antologia a cura di Pet®fi e Franck, Prdsuppositionen, Franco-
forte 1973, specificamente dedicata all'argomento.
7 “Le locuteur, aprés avoir prononcé la premiére proposition
P» prévoit que le destinataire en tirera une conclusion "r". La
deuxiéme proposition q, précédée d'un mais, tend alors a empécher
cette éventuelle conclusion, en signalant un nouveau fait, qui la
contradit" (p. 129).
8 v. anche L.G.Hutchinson, "Presupposition and Belief-inferen
ces" in Papers from the 7th regional meeting of the Chicago Lingut
stic Soctety,Chicago 1971.
9
Si vedra dall'uso fatto in seguito che intendo parafrasi
nel senso molto ampio di frasi che, in un determinato contesto,con
vogliamo entro certi limiti lo stesso contenuto informativo, sia
che abbiano una rappresentazione semantica analoga, cic8 con ugua-
Li componenti ma distribuiti diversamente nelle unita superficia -
li, sia che lo stesso contenuto informativo, ad esempio, in una
frase sia portato dal contesto e nella parafrasi lessicaliazato in
superficie.
53
10 Soggetto e predicato in termini di grammatica tradizionale
e, se si vuole, "superficiali"
11 cCastelfranchi e Parisi (1974) sono giunti.indipendentemen-
te ad un'analoga conclusione studiando appunto le modalita della
valutazione.
12 Ltinformazione & di Grazia Atti
13 $i potrebbe forse parlare di un componente NEG in "q", con
l'avvertenza perd di distinguerlo dalla lessicalizzazione non. I1
componente NEG potrebbe cia3 lessicalizzarsi sia con 1'aggiunta
di un mon in q, sia con la sua cancellaziéne (quando si dica ade
sempio che "8 béllo" nega "non @ bello"), sia con l'aggiunta o la
eliminazione di un prefisso (onesto/disonesto; morale/immorale,
ecc.), sia con la sostituzione di un antonimo. V. per esempio a
proposito della doppia negazione R.Martin (1974).
Direi comunque che anche nella formulazione di Lakoff l'ope
ratore di negazione dovrebbe comparire nell'asserzione di S2 enon
nella presupposizione. Sz ha infatti una funzione refutativa e ri
chiede una precedente assunzione positiva.
14 Mi 8 stato chiesto perch® parlo di pensieri "nr", "p" e "q"
© non pongo, come Lakoff, le frasi direttamente in rapporto. Una
prima obiezione superficiale riguarda, come ho appena mostrato,
l'operatore di negazione. C'8 comunque un motivo pid di fondo, a
mio parere, per tenere distinti pensiero designato e espressione
designante; infatti, che $1 implichi la negazione di S) costitui ~
sce una condizione per costruire sensatamente frasi S7 eppure Sz,
ma non ne @ l'analisi del pensiero corrispondente. Quella che in
logica o in matematica pud essere una semplificazione (appunto da
x=j e j=z si pud ottenere x=z), in una descrizione operativa si-
gnificherebbe saltare un passaggio. Un po' come se volendo descri
vere quello che & successo in una stanza si dicesse "niente" anzi
ch8, per esempio "il gatto 8 entrato e poi & uscito", dato che co
mundue il gatto non c'é.
15 Non c'é nessuna differenza a questo proposito tra implica-
zione materiale e implicazione naturale o fra valori di verita e
valori di probabilita. V. per questo Matalon (1962) e Grize e Ma-
talon. (1962).
16 Un elemento che:Lakoff non ha messo in luce, forse per la
sua ovvieta, 8 appunto che l'accettabilit& di una frase controa —
spettativa richiede che sia plausibile non solo il rapporto. condi
zionale, ma anche la sua violabilita. E’ nato a Parigt eppure non
in Francia (v. gli esempi analoghi in Hurford (1974) & accettabi
le solo se si ammette un'eccezione, ad esempio il territorio del-
le ambasciate, al principio che nascere in wna citta comporta na~
scere nella nazione cui quella citta appartiene, e via di seguito.
E' uno dei motivi per cui preferisco parlare di ‘un "vapporto con~
dizionale" anzich8 di implicazione, riservando questo secondo ter
mine all'implicazione logica.
54
17 Untaltra soluzione, analoga a quella adottata da Puglielli
e Parisi (1972) per avverbi come probabilmente, ecc., riportata
anche in Parisi e Antinucci (1973) per spiegare 1'ambiguita di fra
si come Franco @ useito perché le finestre erano chiuse, sarebbe
quella della sopra 0 sotto-performativita. In questo caso cid vor
rebbe dire solo che l'intonazione marcherebbe la trasformazione
di un indizio in una causa, inserendo come sanatore un componente
di assunzione: "che Pierino non abbia pianto" viene considerato
l'indizio che "dovrebbe essere pid grande" e quindi facilmente
trasformato nella causa di un (mio o di chicchessia)"assumere che
dovrebbe essere pid grande". La soluzione presenta a mio avviso
alcuni svantaggi: a) introdurre in forma ancora un po' oscura il
performativo in fatti che dovrebbero essere presupposizionali sen.
za ancora una netta distinzione tra la parte pil strettamente per
formativa (alla Austin) e quella "assunzionale" del componente
performativo; b) ridurre tutti i rapporti condizionali a rappor-
ti causali e indiziali. Gia Matalon parlando dell'inferenza aveva
accénnato a come il rapporto "se...allora" potrebbe essere artico
labile, oltre che in "causalita" e "indizio", anche in "condizio-
ne" e probabilmente in altri rapporti ancora; si pud pensare alla
causa finale, alla causa necessaria e non sufficiente, alla con-
temporaneita (Se sta arrtvando il dtretto da Napoli, allora [ teo-
ricanente] sta partendo il rapido per Homa), 1a compresenza (Se
e'2 la luce, allora | sicuramente] da qualche parte c'é il contato
re), ecc.;'e) occorrerebbe provare che tutti i casi di rapporto in
diziale sono marcati da quella particolare intonazione, mentre,
con tutte le incertezze che nascono quando si parla di fatti sfug
genti come 1'intonazione,m: sembrano gid possibili esempi contra-
ri
(39) Il piatto si 8 rotto, eppure non 3 mai caduto
(40) Le luei sono accese eppure in casa non c'8 nessuno
(41) Insegna all'Universita eppure non ha la licenza media.
18 Ho usato l'imperfetto negli esempi, e non il presente, per
evitare l'ulteriore ambiguita di una possibile interpretazione ri
petitiva: Bruna va sempre all'Universita e la trova sempre chiu—
eal
19 Nel modello Parisi e Antinucci (1973) questa differenza po
trebbe essere rappresentata dalla "sottoperformativita" del rap
porto di congiunzione espresso da eppure rispetto alla "sopraper-
formativita" del ma. Si giustificherebbe cosi perché siano pid a-
derenti al primo che non al secondo parafrasi con clausole subor-
dinative (ad esempic del tipo pur + gerundio) e perché solo nelle
frasi-ma F] e F2 possano avere performativi diversi:
(53) Io vado al cinema, ma tu che fa:
(53a) *Io vado al cinema, eppure tu che fai?
(54) Piove, ma va' lo stesso!
(54a) *Piove, eppure va! lo stesso!
20 Probabilmente @ per lo stesso motivo che eppure non pud so
stituirsi a ma nei casi di "presupposizioni lessicali" come:
(55) ~ Hai smesso di fumare?
= Ma io non ho mai fumato?
55
21 Luise F.Pusch (1973) ha compiuto uno studio approfondito
sulla differenza tra aber e sondern che si @ dimostrato utile an-
che per l'italiano, in particolare per individuare i contesti in
cui ma pud essere sostituito da benst.
22 Naturalmente non @ da considerare tautologica un'espressio
ne come Brutto, ma brutto...! dove i due brutto si riferiscono a
due situazioni diverse, grosso modo un “brutto come si pud immagi.
nare' e un "brutto pid di quanto si possa immaginare".
23 Se la frase negativa contrastiva non @ seguita dall'asser-
zione positiva che sostituisce il costituente "contrastato" = mi
sembra obbligatoria l’estraposizione, che serve a isolare appun-
to il costituente da sostituire. Questo spiega anche il perché
delle cancellazioni, se non obbligatorie comunque preferibili,nei
casi ma-benst; esse svolgono questa funzione di isolamento.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA.W. (1973) Papers from the Temas Conference on Performatives,
Conversational Inplicature and Presuppositions. University
of Texas at Austin. Austin, Texas.
Antinucci, F. & Volterra, V. (1973) "Lo sviluppo della negazione
nel linguaggio infantile: uno studio pragmatico". R.T. 106.
Istituto di Psicologia del CNR,Roma.
Bellert, I. (1966) "On Certain Syntactical Properties of the En~
glish Connectives and and but", ristampato in Plétz (1972).
Brunot, F. (1965) La pensée et la langue, Paris.
Castelfranchi, C. & Parisi, D. (1974) "Modi di valutare", Istitu~
to di Psicologia del CNR, Roma.
Ceccato, $. (1966) Um tecnico tra i filosofi, vol. Il, Padova.
Ceccato, S. (1968) Cébernetica per tutti, vol. I, Milano.
Crisari, M. (1973) "Sugli usi non istituzionali delle domande”,
R.T. 109, Istituto di Psicologia del CNR, Rom.
Ducrot, 0. (1972) Dire et ne pas dire. Principes de sémantique
linguietique, Paris.
Fillmore, C.J. & Langendoen, D.T. (eds.) (1971) Studies in Lin-
guistic. Semantics, New York.
Grize, J.B. & Matalon, b. (1962) "Introduction & une étude expé-
56
rimentale et formelle du raisonnement naturel", in Etudes
d'kpistémologie Génétiqie, XVI, Paris.
Hurford, J.R. (1974) "Exclusive or inclusive disjunction", Foun-
dations of Language, 11. 409-411.
Hutchinson, L.G. (1971) "Presupposition and Belief-Inferences”
in Papers from the 7th regional meeting of the Chicago
Linguistic Soctety, Chicago.
Lakoff, G. (1971) "The role of deduction in grammar", in Fillmo~
re & Langendoen (1971), pp. 62-70.
Lakoff, R. (1971) "If's, and's, and but's about conjunction", in
Fillmore & Langendoen (1971), pp. 114-149.
» comunicazion
Martin, R. (1974) "Paraphrase et double antonymi,
ne tenuta al Colloquio su "Mod&les logiques et niveaux d'a
nalyse linguistique", Université de Metz, novembre 1974.
Matalon, B. (1962) "Etude génétique de 1'implication", in Etudes
d'Epistémologie Génétique, XVI, Paris.
Parisi, D. & Antinucci, F. (1973) Elementi di granmatica, Torino.
Petfi & Franck (eds.) (1973) Présuppositionen, Frankfurt/M.
Plétz, S. (ed.) (1972) Pransformationelle Analyse: Die Trans forma
tionstheorie von Zellig Harrie wid ihre Entwicklung. Lin-
guistische Forschungen. Bd. 8, Frankfurt/M.
Puglielli, A. & Ciliberti, A. (1973) "Il condizionale", R.T. 110,
Istituto di Psicologia del CNR, Roma.
Puglielli, A. & Parisi, D. (1973) "Avverbiali performativi", R.T.
124, Istituto di Psicologia del CNR, Roma.
Pusch, L.F, (1973) “Uber den Unterschied zwischen Aber und Sondern
oder die Kunst des Widersprechens", Romanisches Seminar,
Universitat Kiel, Kiel.
Zonta, B. (1973) "Spunti di Grammatica operativa”, Centro di Ci-
bernetica e di Attivita Linguistiche dell'Universita di Mi-
lano, Milano.
Zuber, R. (1972) Structure Présuppositionelle du langage, Docu-
ments de linguistique quantitative, Paris.
UN ASPETTO DELL'ORDINE DELLE PAROLE NELL'ITALIANO
DEL DUE-TRECENTO
Angela Marcantonio ~ Universita di Roma
Con questo lavoro ci proponiamo di presentare alcuni aspet-
ti relativi all'ordine delle parole nell'italiano antico, — non-
ché al valore e alla funzione comunicativa propria di tali ordi-
ni, Inoltre si avanzera un tentativo di spiegazione dei dati pre
sentati.
I testi presi in esame sono: Il Novellino (Iw); I testd
Sangimignanest del secolo XIII e della prima meta del secolo XIV
(Sg); IL libro de' Viat e delle Virtudi (Lb); Franmenti d'un li-
bro di conti di banckiert Fiorentini e Libro delle Tavole di Rie
comanno Jacopt, tratti dai Test Fiorentint (Fr)}.
1.0 Ci siamo occupati solo dei costituenti nucleari, cioé
del verbo e dei suoi argomenti; inoltre, per poter stabilire va~
lore e funzione delle posizioni ordinarie di tali costituenti,
abbiamo ovviamente dovuto escludere i casi in cui si poteva ri-
scontrare su uno di essi un ‘accento enfatico
Iniziamo con 1'esaminare alcune frasi in cui compare una se
quenza OV:
(1) Albertino Paganelli no die dare libre xlij e soldi viiij meno
denari ij per rasione ke fue per San Brocoli ke i diede Arnol
fino a Bologna; e'l compimento de dare a Mainetto, e de paga-
re per San Pietro, (Fr 10, 30)
(2) E Simone e Lapo fratelli ebero in parte tuti i denari che Bal
dovino avea dati loro...; ¢quesstt denart aveano autt in tor-
nesi ed in altre chose. (Fr 33,4)
(3) Anzi in quel medesimo popolo, che s'apellava di Dio, v'assa—
limmo, e combattemmo con voi; e avegna che dal cominciamento
58
faceste gran pugna e vi difendeste francamente da no
dassezzo quetla pugna perdeste. (Lb 95,14)
(4) Uno borghese di Bari andd in romeaggio e lascid trecento bi-
santi aun suo amico conqueste condizioni e patti: - Io andrd,
siccome a Dio piacera; e s'io non rivenisse, dara'liper I'a
nima mia; e s'io rivegno a certo termine, dara'mene quello
che tu vorrai -.
And} il pellegrino in romeaggio, e rivenne
al termine ordinato, e radomandd i bisanti. suoi,.. - Ben di-
cesti, - disse l'amico - te’, diece bisanti ti voglio rende-
ves ¢ dugento novanta mi tengo -. (I 809, 14).
(5) Piero Tavoliere fu grande uomo d'avere, e venne tanto miseri
cordioso che'mprima tutto l'avere dispese a' poveri per Dio,
e poi, quando tutto ebbe dato, ed elli si fece vendere, eZ
prezzo diede a'povert tutto. (Mv 813, 4)
(6) Uno medico di Tolosa tolse per moglie una gentile donna di
Tolosa,... In due mesi fece una fanciulla, Il medico non ne
mostrd nullo cruccio, anzi... molto onorce la donna nel par-
to. Dopo il parto si le disse: - Madonna, io v'ho onorata
quant'i'ho potuto, Priegovi, per amore di me, che voi ritor-
niate omai a casa di vostro padre. E la vostra figliuola io
terrd a grande onore. (ity 837, 7)
(7) Ricevetti una vostra lettera di v di ferraio, ne la quale mi
scriveste che altre letter(e) ch'erano con essa io dessi a
chut dicevano, e spezialmente quella che diceva a li Anziani
© al Comune di Pisa: questa ebbi bene, altre no niuna. Quet-
la degli Anziani diedi in presente e poi tornai per la rispo
sta. (Sg 87, 3)
Leggendo le parti in corsivo, ci si accorge subito che, se
dovessimo pronunciare tali sequenze OV in italiano contempora—
neo, con lo stesso valore che esse hanno nei passi citati, valo
xe che pud essere facilmente dedotto dal contesto, aggiungerem-
mo, collocandolo in un posto opportuno, un pronome, cio® direm-
59
mo per es: e quest? denart 1i avevano avutt..., alla fine quel-
la battaglia la perdeste..., a te, diect bisantt te li voglio
render
to la terrd in grande onore, ete.
i duecento novanta me li tengo, e la vostra figliola
Questo comportamento dimostra che, da un lato, noi perce —
piamo tali sequenze come non del tutto accettabili oggi; dal-
1'altro, ne comprendiamo il significato e, soprattutto, indivi-
duiamo correttamente il valore comunicativo del nominale (N) an
temposto al V, che @ appunto quello stesso valore che in italia
no contemporaneo 1'0 anteposto assume quando @ seguito dalla
"ripresa pronominale". In altre parole, una sequenza OV dell'i-
taliano duecentesco pud avere la stessa funzione comunicativa
che nell'italiano di oggi compete alla sequenza 0 PRONOME V,
nella quale 1°0, anteposto al V per effetto di una regola di'"di
slocazione a sinistra"?
> convoglia una cosi detta informazione
DATA, Come @ noto tale regola, opzionale, opera soltanto se si
verificano le condizioni seguenti:
1) Lfelemento spostato ® gia stato introdotto precedentemente
nel discorso o nel testo; oppure il suo referente & inmedia—
tamente deducibile per 1'ascoltatore (lettore) dalla situa—
zione generale della conversazione o dal contesto situaziona
le (condizione obiettiva, necessaria ma non sufficiente);
2) il parlante (scrittore) "assume" che quancosa & "dato" o pre
sente all'attenzione del suo interlocutore (1ettore) in vir~
ta di qualcuna delle condizioni su specificate. Questo fatto
re ® soggettivo ma tuttavia determinante, poiché, se pure si
realizzano le condizioni di cui al n. 1, il parlante pud "non
assumere" che quel "qualcosa" @ presente all'attenzione del
suo interlocutore, di conseguenza si esprimer& seguendo 1'or
dine normale.
E' facile convincersi, osservando il contesto, che gliN og
getto nelle sequenze sottolineate apportano informazione DATA:
nella (1) compimento e nella (5) prezzo sono informazione DATA
60
perché facilmente deducibili dalle nozioni espresse nel conte —
sto immediatamente precedente: rispettivamente... no die dare
Libre xlij e soldi vitij meno denari ij... (sista parlando di
un debito che deve essere risarcito, e si tratta ovviamente del
compimento del debito), e ed elli st fece vendere (prezzo, nel
senso qui di "ricavato" & nozione profondamente implicata nel-
l'atto del vendere), Ugualmente nella (4) ¢ dugento novanta 8
DATO poiché designa la somma che rimane dei trecento bisanti i-
niziali meno i diece bisanti che 1'amico intende rendere al pel
legrino, Quanto poi alla prima sequenza OV cio’ diece bisantt
tt voglio rendere, si pud interpretare sia come DATA (gli ele—
menti di una "elencazione" sono DATI), sia come NUOVA (1'amico
del pellegrino potrebbe voler mettere in evidenza che egli ha
intenzione di restituirgli "solo" diece bisanti: in questo caso
neanche nell'italiano di oggi andrebbe integrato un pronome,poi.
ché la novita dell'0 & marcato dall'accento enfatico). nelle
frasi (2), (3) e (6) denart, pugna e figliuola rispettivamente
sono DATI poich® se ne parla poco prima; tra l’altro denart e
pugna sono contrassegnati da un pronome anaforico, che & porta~
tore di informazione DATA par excellence.
Lo stesso vale per questa ebbt bene e quella degli Anatant
diedi in presente nella (7), mentre altre letter(e) 8 DATO in
virtd della relativa restrittiva che le qualifica: seriveste
che altre letter(e) ch'erano con essa to desst a etc.
Dunque, anche nell'italiano duecentesco cperava una regola.
di spostamento a sinistra dell'0 quando questo era apportatore
di informazione DATA, ma la sua anteposizione al V si attuava
senza 1'intervento del pronome. Spiegheremo in seguito il moti-
vo per cui oggi, a differenza di allora, occorre la ripresa pro
nominale.
Quanto abbiamo rilevato rappresenta lo standard; tuttavia
compaiono, sebbene rari, anche casi di costrutto 0 PRONOME V:
(due in Fr, due in Nv, e due in 5y)3,
(8) Quessti denari ch'io abo auti da Bonfilgluolo, che ssono is~
61
scriti quiie, iio Manno si ZgZi isspesi per la familglia di
Baldovino. (Fr 16,9; cfr. 30, 12)
(9) -Rendi i dugento novanta bisanti al pellegrino, e'l pellegri
no ne dea a te i diece che tu li ha renduti; perd che'l patto
fu tale: cid che tu vorrai mi renderai. Onde i dugento novan-
ta ne’ wuoli, rendild, e i diece che tu non volei, prendi.
(Wo 810, 1; cfr. 801, 3)
(10) Ancho, che se avenisse, la quale cosa Idio cessi, che alchuno
della detta arte, egli od alchunodi sua famiglia Idio Zo chia
masse a 8... (Sg 122,143 cfr. 146,3)
Interessante 8 l'esempio (9) poich® offre, 1'uno accanto al-
Laltro i due costrutti OV con e senza ripresa pronominale: ren~
dilé e prendi.
1.1 Passiamo a considerare ora un altro tipo di fenomeni no-
tati nei nostri testi, relativi alla posizione del N soggetto ri-
spetto al Ve alla sua funzione comunicativa.
Come @ noto, nell'italiano di oggi in una sequenza Lineare
cid che 8 DATO tende ad occupare il primo posto, cid che & NUOVO
Ltultimo; in particolare, & stata individuata da pi parti la ten
denza a "contrassegnare la’novita comunicativa del soggetto me-
diante la sua posposizione al verbo"5, Opera dunque in italiano
una regola di spostamento del S a destra del V®, spostamento che
rende il § NUOVO, cio& oggetto della asserzione del parlante. Ta~
le spostamento, possibile tout-court con gli intransitivi, @ pos-
sibile con i transitivi solo se contemporaneamente si attua la te
matizzazione dell'O (vedi oltre):
la mela, "ha mangiata Carlo
frase con la quale il parlante mette in evidenza, “asserisce" che
Carlo e non pet es. Giovanni ® stato colui che ha mangiato la mo-
la, fatto questo considerato invece come noto.
Esaminiamo ora le frasi seguenti in cui compare un sequenca
VS:
62
(11) Item ci diede Jacopo soldi evj: rekd Jacopo, cinque di anzi
kalende ottobre. (Fr 5,2)
(12) Item ci di8 Jakopo soldi xxx: rekd Aldobrandino. (Fr 5,5)
(13) Itemci di& Orlandino libre x: rekd Kambio dalo Scotto pez~
zaio libre tre, e da Jakopo del Campo libre quattro meno
soldi tre, e le tre Libre e tre soldi diede Orlandino — di
ssua mano a quessto termine di ssopra (Fr 8,25)
(14) Amadore e Ducio fratelli, f.Marini, deono dare in picioli
libre declxv, che ne demo loro quatrociento trenta treie
fiorini d'oro... Equessti denart paghd Amadore per not. a
choloro che diraie in questa medesima faccia. (Fr 32, 5)
(15) La qual cosa ebbe Dio onnipotente si per male che tutta quel.
la gente abandond a' demoai e a! Vizi... E disse Dio onnipo.
tente a quella stagione di sua bocca: Pentomi ch'i'ho fatto
1'uomo: e andonne ad uno che si chiamava Abraam,... e dis-
se: Io vo' di te' far nascere gente la qual s'apelli mio
popolo,... E affermato il detto patto fra loro, st partio
Idio onntpotente, e servolli tutti i patti che promessi li
avea. (Lb 94, 23)
(16) -0 Superbia,... giaci oggimai abbattuta e morta,... che
ben t'@ incontrato quello che dicé il Vangelo: I superbi
abbatte Idio e falli-eadere; e a 1i umili da grazia e falli
montare. (Lb 98,15)?
(17) Tl giovane stava pensoso; vide passare per lo cammino gente
assai nobile, secondo l'arnese e secondo le persone. Il cam
mino correa a pi® del palagio. Comandd questo giovane che
fossero tutte quelle genti menate dinanzi da lui. Fue ubbi-
dita la sua voluntade, e vennero i viandanti dinanzi da lui.
(iv 807, 4)
(18) Ma innanzi ch'elli (il re Giovane) morisse vennero a lui
tutti i suoi creditori e adomandaro loro tesoro ch'a lui
aveano prestato. Il re Giovane rispose: - Signori, a mala
63
stagione venite, ché'l vostro tesoro & dispeso; ~ Morio
questi. (Iv 816, 24)
(19) Questo Saladino, al tempo del suo soldanato, ordind una trie
gua tra lui e' Cristiani, e disse di volere vedere i nostri
modi, e se gli piacessero diverrebbe cristiano. Fermossi la
triegua, Venne il Saladino in persona a vedere la costumade'
Cristiani. (Wv 821, 3)
(20) Udirono nostre parole ¢ insieme con noi ne dolsero, e cosi
insieme tucti presso .c. andaro al Conte,.., di che insomma
seguio (con)siglio di savi nel quale si prese e vinse,..,che
li p(re)gioni renduti ci fossero..., e che lo Comune di Pisa
paghi in cid quello ch(e) bisongnia,a la masnada, e nel Con~
te.si rimise di (con)tentar la masnada per lo Comune di Pi-
sa. Avemoli voluti: dcet detto lo Conte che cid farae, ma
vuole ch(e) per noi si faccia intorno a la pace cid ch(e) si
» Vero @ che
@ voluta pagaria di cee fior. lo Conte...: B volea la paga~
(con)viene, avemo risposto che cid ne piace.
ria, o di rappresentare li_p(re)gioni a sua volonta, o di
pagare li ccc fior, Crediamo oggi riaverli senga farla. E se
pur si (con)venisse fare, farannola li amici de li pregio—
ni... Rondenet certi li amiei che lo fatto ar& buon fine.
(Sg 91,3)
Come & facile constatare dal testo, gliN oggetto nella se~
quenza sottolineata della (13) sono DATI, quindi anteposti al V
(manca anche qui la ripresa pronominale); ma 1'N soggetto, seb-
bene posposto al V, non & NUOVO, cio® non @ marcato, esso solo,
come apportatore di informazione nuova, cosi come accade in ita~
liano moderno quando si trova in tale posizione. Oggi una —se~
quenza del genere risulterebbe mal formata e dovremmo esprimerci
nel modo seguente: e le tre libre e 1 tre soldi Orlandino li die
de di sua mano etc. Lo stesso discorso vale per la frase (14), e
per la (16), dove i superbi e gli wnili sono DATI per “elencazio
ne" oltre ad essere nozioni deducibili da 0 Superbia citato poco
64
prima; Idéo, d'altra parte, non & certamente marcato come NUOVO,
esso solo, valore che avrebbe se la sequenza fosse in italiano mo
derno (vale a dire, il valore: li abbatte Iddio, e non qualeunal-
tro). Tuttavia ancora una volta esso & posposto al V; oggi in una
sequenza con S non esplicitamente marcata come NUOVO, S non pud
che anteporsi al V: Iddio i superbi 1¢ abbatte etc. oppure I su~
perbi Iddio li abbatte etc, Cosi pure non sono NUOVI (e il conte~
sto lo mostra in modo equivalente) 1'N soggetto delle sequenze
sottolineate nelle rimanenti frasi, n& sembra accettabile, in ta~
li contesti, la presenza di un forte accento enfatico sui singo-
li V, artificio che, ristabilendo la corretta distribuzione di DA
TO/NUOVO, giustificherebbe la loro posizione. Per quanto riguarda
poi le frasi (11) e (13) anche esse contengono una sequenza VS con
S non marcato come NUOVO; inoltre nella seconda 1'N soggetto @
gid stato citato precedentemente.
Seguono due frasi che contengono una sequenza CVS, con 1'ar~
gomento non-soggetto anteposto al V, sicuramente per tematizzazio
ne, dove con "tematizzazione” intendiamo lo spostamento in prima
posizione della sequenza lineare di un costituente allo scopo di
renderlo DATO e "topic", (cfr. oltre p. 70 sgg.), © 1'argomento
soggetto ancora una volta posposto sebbene non sia NUOVO®., Come
ci si pud render conto leggendo tali frasi, sequenze cosi formate
risulterebbero oggi del tutto inaccettabili. Che il soggetto non
sia NUOVO nella (21) @ evidente, nella (22) novella non @ NUOVO
in quanto esprime una nozione chiaramente deducibile dal conte —
sto precedente.
(21) Ma... poscia che la Fede Pagana fu scesa in terra co la‘ sua
gente. ..da che vide che la Fede Cristiana non ebbe ardimento di
rincontrarla, venne pigliando tutta la terra in qualunque par
te andava,.., Wel reame di Francia, che stette fermo, fug —
gio la Fede Cristiana, (Lb 82,13)
(22) 1 tempo era di primavera; donne si veniano a diportare alla
fontana; videro il bello Narcis affogato. Con grandissimo
pianto lo trassero della fonte, e cosi ritto 1'appoggiaro
65
alle sponde; onde’ dinanzt allo dio d'amore andd la novella.
(Nv 836, 5)
Questa tendenza a posporre il $ al V, anche quando non lo
si voglia segnalare come NUOVO, trova conferma nella occorrenza
di sequenze VS{Q} del tutto neutre (sequenze cio’ in cui tutta
1'informazione & offerta come NUOVA) oggi non pil accettabili co
me ordini di base?. In Fr poi esse sembrano costituire quasi la
norma!®, specialmente all'inizio di paragrafo o di periodo, men-
tre Lordine SV{Q} sembra rappresentare un ordine marcato rispet
to al 8, vale a dire la sua anteposizione al V sembra il risulta
to di un processo di tematizzazione del $ stesso.
(23) Angiolino ci & dato libre xj di ssua mano quatro di anzi ka
lende giugnio. Item ct dié Benivtent galigaio per Angiolino
Libre ti,
e soldi a: vekd Albizo.da f Ferrara peazato di Lun
garno a questo termine. (Fr 8,22)
(24) Item Guidalotto die avire libre xiij:... Rekd Rieiardo soldi
wunitij e denart ij. (Fr 12,16)
(25) Anno dato Lanberto e chompangni in fiorini in kalende aprile
nel lxxiiij, libre dj. (Fr 20,33) .
Le seguenti tre “frasi contengono ugualmente una sequenza
Vs{Q}, ma con $ gia noto dal contesto precedente:
(26) -Figliuolo mio, fatte sono le battaglie tra' VizT e le Vir-
ti; sola 8 rimasa quella della Fede Cristiana co la Fede Pa
gana per racquistare la terra d'oltremare. Ma questa guerra
& ammannata gran tempo di durare,... E anche assai richiede
rd quella guerra gran gente. (Ib 100, 11)
(27) Avenne un giorno che a questo signore fu appresentato delle pa
rti di Spagna un nobile destriere di gran podere e di bella
guisa. Adomandé lo signore mariscalchi per sapere la bonta
del destriere. (lv 800,2)
(17) ...Fue ubbidita la sua voluntade, e vennero i viandanti di-
nanzt da lut.1) (Nv 807,8)
66
(28) Item anno tolto ¢ Tavernolone una pega di tera. (Sg 52,11)
(29) Item prestoa Achopo a Talento «l., a parte prestante. (Sg 61,
9)
In conclusione gli esempi recati mostrano che:
1) anche nell'italiano del Due-trecento c'era la possibilita di
spostamento in prima posizione di un N della frase per tematizza
zione, manon era diffusa ancora laripresa pronominale per0 e pro
babilmente per C 12;
2) era abbastanza frequente l'occorrenza, dopo il V, di $ sebbe~
ne non fosse il solo NUOVO. Questo fattore ci permette di affer-
mare che l'attualé régola di spostamento del $ dopo il V, allo
scopo di renderlo NUOVO, cio® oggetto dell'asserzione del parlan.
te, in tali casi non operava. Possiamo allora ipotizzare (in se-
guito mostreremo come avallare tale ipotesi) per 1'italiano anti
co lesistenza di sequenze di base in cui il V é seguito dai
suoi argomenti, per cui, se un argomento non-soggetto viene.
stratto e portato alla sinistra in funzione di tema (o topic),
tutti gli altri, soggetto compreso, rimangono ovwviamente dopo il
V, In altre parole, noi sosteniamo che se 1a posizione postverba
le del S non & effetto di una'regola di spostamento, essa non pud
che essere 1a sua posizione originaria.
Se tale assunzione @ esatta, ne consegue che VS (X) @ un or
dine non marcato. Questo @ comprovato dal fatto che esso, in quan
to tale, in qualche contesto pud costituire tutta informazione
NUOVA (ma non il solo $) come mostrano chiaramente, ed es., ° le
frasi (12), (23), (24), (25), (28), (29), mentre gli ordini mar-
cati che spostano a destra un elemento, rendono NUOVO solo quel-
lo. Tale assunzione @ inoltre corroborata dalla occorrenza del-
la frase (18) (e forse dalla (17)), dove il $ @ costituito da un
Pronome anaforico, che, per definizione, non pud apportare infor
mazione NUOVA, (si veda la discussione di talicasiin Lonzi, 1974).
1,2 Le subordixate mostrano un comportamento differente. Si
posses riscontrare infatti, nei nostri testi, fatta esclusione
67
; a eee 0 a
ai Fr!3, ordini (Q}V,e, limitati al solo Lb, ${Q}V, senza che si sia
tematizzazione dei N anteposti, come mostreranno chiaramente gli
esempi. seguenti:
(30) Chi sarebbe di tanta bonta, che conoscegse e credesse e amas:
se e ubidisse e reverisse Dio nostro signore,... e fosse si
savio... che il bene dal male e la cosa giusta da la non giu-
sta... conoscesse... © fosse d'animo temperato tanto, che li
desidert de la carne
a
+ costrignesse e temperasse ete. (Lb117,
(31) -Messere, io trovai costui in cammino: domanda'lo ove andava,
© perché. Dissemi che ad Alessandro andava perché li donasse
(Mv 802, 26)
(32) -Messere,:.. io per amore di voi volendo in tutta lasciare il
mondo e vestirmi di drappi di religione, piaccia a voi di do-
narmi una nobile grazia, cic8 che un torntamento feggia, 18
ove s'armi-la nobilta di cavalieri. (Nv 845,12)
(33) De la pena di chi aleuna villanta o inturia dicesse al conso-
lo de la detta arte. (Sg 102,13)
(34) Ancho ordiniamo che'l consolo... debbia fare richiederé tutti
giurati a la detta arte e quelli domandare se a le facgioni
detl'arte vogliono stare. (Sg 129,22)
(35) De 1a pena al consolo che proponesse e a chi aringasse, che
alcuna condennagione si rimettesse. (S$ 130,13)
(36) ...ché non era verisimile che Dio onnipotente la Fede... ta-
seiasse perire, (Lb 88,10)15,
(37) Ne sarebbe gran disinore se..:; nostro ferro di vostro sangue
st sozzasse. (Lb 96,19)16,
1,3 Abbiamo presentato finora alcuni tipi di ordine delle pa
role, cercando di coglierne, nei limiti del possibile, la funziona
lita dal punto di vista della organizzazione del discorso. Ma so-
no stati presentati isolatamente, come fossero fenomeni indipen —
68
denti 1'uno dall'altro, In realt& essi sono facilmente coordina~
bili e riducibili ad-un unico denominatore comune, se valutati
nella prospettiva di una appropriata teoria della sintassi e del
la sua evoluzione diacronica, F.Antinucci (1975) ha introdotto a
na tipologia Linguistica che possa spiegare "perché le lingue si
presentano organizzate in certi modi anziché in altri, e come
siano tra loro interrelati tali modi", Infatti, come detto da
L,Hjelmslev (1966, pag. 128-129), "solo una tipologia linguisti-~
caci permette di comprendere quali strutture linguistiche sono
possibili e perch tali strutture sono possibili mentre _altre
non lo sono..., € quali sono le leggi generali secondo le quali
le lingue cambiano e le possibilita di cambiamento che un dato
tipo comporta”.
Ogni. lingua pud essere considerata un meccanismo di proie —
zione, cio8.un meccanismo, regolare e sistematico, che proietta
il significato, composto di una serie di configurazioni semanti-
che organizzate gerarchicamente, in una sequenza di suoni, dispo
sti secondo un ordine lineare.
Se consideriamo la rappresentazione semantica di una
frase ad un solo argomento, e indichiamo con V il pre-
dicato e con N l'argomento, la linearizzazione ammettera a
priort due soluzioni: 1'elemento lessicale che linearizza N pud
precedere o seguire l"elemento che linearizza V nell'ordine 1i-
neare da sinistra a destra:
1) NV
2) VN
Se la frase & a due argomenti si avranno ben tre possibili-
tA teoriche; ma sussiste ‘un "
principio costruttivo" che prevede
che l'accrescimento della sequenza lineare, dovuta ad un accre-
scimento della rappresentazione semantica, avvenga sempre nella
stessa direzione: cio’ la proiezione dei N deve attuarsi o tutta
sulla sinistra o tutta sulla destra dell’elemento che proiettaV;
per cui delle suddette tre possibilita teoriche sono ammesse so~
lo le due seguenti:
69
3)
4) VNN
NY
Da questo punto di vista il latino @ una lingua che "co~
struisce a sinistra" 1'italiano invece @ und lingua che “costrui
sce a destra"; esse hanno dunque due strutture simmetriche, ri:
spettivamente NNV, VNN.
Per quanto riguarda poi l'ordine reciproco del N, nel caso
siano due o pit di due, tende ad occupare il posto pid vicino al
la predicazione-il N che svolge il ruolo di “Oggetto profondo"
(in termini di grammatica generativa il N che @ argomento di un
componente semantico di "Stato").
Tale N dunque sara il primo nell'ordine lineare rispetto al
la predicazione, naturalmente il primo a sinistra o a destra di
V, a seconda del principio costruttivo della lingua in questio—
ne, Qualora si verifichi un accrescimento nella rappresentazione
semantica, si verifichera, in corrispondenza, nella sequenza li:
neare, l'aggiunta di un N, e questa aggiunta avverra ovviamente
a destra o a sinistra dello Oggetto profondo.
Questa teoria,rende conto della struttura della frase dei
due tipi di lingue che di fatto si riscontrano nel mondo, a meno
vo e ov!7,
della posizione del
Ma, tale dimensione linearizzata si realizza a sua volta
nella dimensione temporale: da questo punto di vista, come @ sta
to messo in evidenza da piti parti!®, la frase si articola in una
parte "data" definita variamente "tema" o "topic' e una parte
“nuova" chiamata "rema" o "comment".
La prima contiene un elemento su cui fa perno il contenuto
informativo, la seconda apporta una informazione come relativa o
pertinente a tale elemento. A sua volta ogni informazione gid da
ta fungera da perno per ulteriori aggiunte di informazione. An~
che l'articolazione della frase in DATO/NUOVO dovra essere porta
ta in superficie dal meccanismo di proiezione, dal momento che
tale articolazione si correla strettamente col contenuto semanti
co della frase stessa.
70
Dovr& esistere dunque un principio che possa regolare 1'o~
perare del meccanismo di proiezione rispetto alla informazione
data o topicale.
Secondo questo principio, definito di "formazione del Sog-
getto" 1'informazione topicale tende universalmente ad apparire
all'inizio della sequenza lineare, tende cic® ad occupare la po
sizione pit a sinistra possibile. Questo @ ovvio dal momento
che 1"informazione data non pud che essere offerta prima della
informazione nuova, e prima, in una costruzione lineare, vuol
dire "la posizione pil a sinistra possibile”.
In linea teorica, qualunque elemento pud essere tematizza—
to, cio& spostato in prima posizione in funzione di topic, (ab
biamo gia discusso délla tematizzazione del N oggetto). Ma esi-
ste una tendenza, di natura pregmatico-psicologica, secondo ia
quale alcuni elementi sono pili suscettibili di altri ad essere
tematizeati: a parita di condizione sono tendenzialmente pre~
scelti come topic i N rispetto alla predicazione; tra iN poi,
la gerarchia naturale predilige quelli che sono “animati" ri-
spetto ai "non-animati", e quelli che svolgono una funzione di
"causa" rispetto a quelli che non hanno tale funzione. .In ter—
mini fillmoriani tale gerarchia pud schematizzarsi nel modo se~
guente:
E,
atpo
dove Z'Agent occupa il primo posto perché @ animato ed @ causa;
L'Emperiencer e L'Instrument tendono ad occupare entrambi il se
condo posto in forte conflittualita, il primo essendo animato
ma non causa, il secondo causa ma non animato.
Data ad es. una frase a due N, di cui l'uno 0 e l'altro A
(ovvero il primo argomento di "Causa"), dalle due linearizzazio
ni possibili (in virti del principio costruttivo e del princi—
pio profondo) VOA, AOV, dopo L'applicazione del principio di for
mazione del Soggetto avremo rispettivamente: AVO, AOV. L'effet-
to 2 1a produzione della tipica struttura superficiale dei due
7
tipi di lingue pia frequenti nel mondo: SVO, SOV!%; nel primo ti
po & compreso anche L'italiano, nel secondo il latino.
1.4 Tornando ora ai nostri testi, ricordiamo brevemente
punti messi in evidenza dalla nostra analisi:
1) Tematizzazione dell'0 e delC senza ripresa pronominale;
2) Occorrenza di $ dopo V con $ non NUOVO;
3) Occorrenza, limitata alle sole subordinate, di sequenze (S)XV.
Nelle lingue romanze, quindi anche nell'italiano antico, si
® completato il processo di spostamento dei N dalla sinistra (in
doeuropeo e latino) alla destra del V (vedi anche la perdita dei
casi, lo sviluppo delle preposizioni, 1a anteposizione dell'ausi
liare al verbo, etc., caratteri propri delle lingue che costrui.
scono a destra). Ma una volta completatosi tale processo, @ ne~
cessario lo spostamento a sinistra di un N in funzione di topic,
e.questo per motivi pragmatici, cio® per segnalare quale & la
informazione data. Se ipotizziamo che 1'italiano antico @ a que
sto stadio, otteniamo 1'adeguatezza con i dati presentati: qua~
lunque N (S,0,C) pud essere spostato a sinistra come topic per
segnalare 1'informazione data.
Ma lo spostamento di uno di essi lascia naturalmente tutti
gli altri dopo il V, poiché siamo di fronte ad una lingua che co
struisce a destra,
Se dunque lo spostamento riguarda un N argomento che non sia
S, (nel nostro caso 0, e, meno frequentemente, C), il S viene a
trovarsi dopo il V, ma non per effetto di un suo spostamento,
(cfr. pag. 65) bensi perché quello & il suo posto originario, e
cid spiega anche il fatto che S dopo il V, in tali casi, non ha
valore di NUOVO.
Nell'evoluzione successiva della sintassi (come nella sin~
tassi di molte altre lingue che derivano da lingue NNV), quello
che abbiamo definito lo spostamento a sinistra di un N in funzio
ne di topic (principio di formazione del Soggetto) diventa rigi-
72
do, cio® confinato al N pid alto nella gerarchia naturale dei
topic (tipicamente 1'Agente)29, E cid perch8, avendo la lingua
perso le indicazioni indipendenti delle funzioni semantiche dei
N (casi), 1a prima posizione di un N-viene a segnalare anche la
sua funzione semantica rispetto al V.
E' facile comprendere come la situazione dell'italiano an-
tico, in cui lo spostamento topicale & libero, vada incontro a
difficolta nel recupero dei ruoli semantici: in frasi del tipo
Il falco mangia il corvo
con topicalizzazione libera, non si capisce chi 8 che mangia e
chi & che viene mangiato, poich® falco potrebbe anche essere,ol
tre che S, 1'0 profondo spostato in prima posizione.
A questo punto l'ordine di-base diventa NVN, cio® SVX in
cui $ costituisce tendenzialmente 1'A, cio’ il N pid alto nella
gerarchia naturale dei topic. E proprio perché l'ordine si irri
gidisce, se viene spostato alla sinistra del V per tematizzazio
ne un N. differente da $, questo lascia dietro di s® una "trac
cia" nella forma di un pronome; infatti esso viene spostato
al di fuori del confine della struttura di frase, schematicamen
[svo] of[sve]
tet
lasciatido incompleta la struttura stessa. Per la stessa ragio-
te:
ne di rigidita del pattern SVX, la posizione postverbale del 8,
oggi, non pud che essere frutto di una regola di spostamento
del S stesso, spostamento che diventa correlato col valore prag
matico di S NUOVO, cio® come soggetto asserito.
Lo sviluppo diacronico che abbiamo delineato ® confermato
del resto dal comportamento delle subordinate. E' noto che 1a
organizzazione sintattica delle subordinate si evolve con rit
tardo rispetto a quella delle principali2!,
Allo stadio corrispondente, esse mostrano ancora tracce
della organizzazione a sinistra, cio della, "vecchia" costru—
zione, Infatti in esse si pud riscontrare anche 1'ordine NNV,con
verbo finale. Cid spiega perché 1'0 prima del V non debba esse~
re necessariamente tematizzato, e perch® @ possibile, sebbene or
stQlv, in
quanto tali N originano appunto in quella posizione: cfr. le fra
si (30)...(37)?2,
mai raro, trovare pii di un costituente prima del
NOTE
1 Tl Novellino inLa prosa del Duecento, a cura di C.Segre e M.
Marti, Verona, 1959; i Testd Sangimignanesi del secolo XIII
e della prima meta del secolo XIV, a cura di A.Castellani, Fi
renze, 1956; Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Tre
cento, a cura di A.Schiaffini, Firenze 1954; IL libro de! viz
at e delle Virtudi di Bono Giamboni, a cura di C.Segre, Tori:
no, 1968. I Testi Sangimignanesi sono una raccolta di testi
di varia natura, velativi alla vita pubblica,amministrativa,
civile del Comune; nonché di lettere di privati odi"sindaci™
© ambasciatori.. Sono compresi in essa anche gli "Ordinamenti
dell'arte della lana” testo datato 1334, Come @ noto, gli sta
tuti di corporazioni e confraternite sono per lo pid traduzio
ni dal latino; a questo proposito possiamo tener presente quan
to giustamente afferma lo Schiaffini nella sua introduzione
ai Testi Piorentini: "I due Statuti di compagnie religiose in
dubbiamente sono versioni pil o meno libere da testi in lati
no notarile, ma si tratta di quel latino appunto che, a sua
volta, risente e solo a questo patto diviene strumento dutt:
le e preciso - un ben chiaro influsso dell'invincibile e pre~
potente volgare, cosi nel lessico come nella struttura sin—
tattica". Dai Testt Piorentint abbiamo scelto solo due libri
di conti: Franmenti di un libro di conti dé banchieri Pioren~
tint (1211) e Libro delle Tavole dt‘Riccomanno Jacopt (1272-
1277), poiché, data la natura del contenuto e lo scopo cui de
vono assolvere, ci garantiscono un "volgare" alieno da artifi
ci letterari o per lo pil stilisti¢i. Invece il Libro de! viz
af e delle Virtudi, una delle "scritture originali" di Bono
Giamboni, @ un'opera letteraria, a carattere filosofico alle-
gorico-morale, direttamente ispirata dalla Paychomachia di Pru
denzio. Anche qui va messa in evidenza, come fa lo stesso Se-
gre nella sua introduzione all'opera, la autonomia di pensie-
ro e di impostazione dell'autore rispetto alle sue numerose
fonti.
cfr. G, Cinque (1974a.) cfr. inoltre P.Tekavcic (1972),vol.II
pag. 693-694: "l'inversione e dislocazione dell'oggetto, 8 pos
74
sibile anch'essa, qualora l'oggetto, per ragioni stilistiche,
debba occupare il primo posto. In tal. caso la coerenza del s
stema postula che l'oggetto sia rappresentato, al posto che
spetta normalmente al sostituto, da un sostituto personale a~
tono che lo riprende e assicura la corretta interpretazione
funzionale. E’ ben nota 1a ripresa:
Pietro conosce bene Mario: Mario, Pietro lo conosce bene,
Sebbene sia stato correttamente individuato il problema, pre-
vale ancora una volta, la tendenza ad interpretare stilisti
mente un fenomeno appartenente invece al dominio della sin~
tassi e della organizzazione della frase ai fini comunicativi.
18
La ripresa pronominale occorre in Fr solo due volte, _mentre
quindici sono i casi di 0 anteposto con funzione di DATO sen-
za vipresa, Nel Mv gli O afteposti senza ripresa sono quat—
tro. Tale calcolo, come anche gli altri che seguiranno, é sta
to fatto su uno spogiio del venti per cento.
C.Segre, ad 1. osserva: "Prima di ne 8 omesso il relativo
"che"; costruzione popolare".
5 Cr, T.Alisova, (1972),pag. 106-153, Cfr. inoltre "Gruppo di Pa
dova" in S.L.I. 1974,
© cfr, G.Cinque (1974 b).
Gli ordini OVS sono abbastanza scarsi. Oltre quelli citati se
ne contano solo altri due con S non NUOVO: My 806,8; 846,18.
I seguenti presentano invece tutti $ NUOVO: Fr 10,6,10; 14,
173 19,33 25,313 26,9; 30,12. Sg 127,25. Cli ordini VS nei
Nv con S non NUOVO costituiscono i1 trentatre~per-cento, men~
tre quelli con § NUOVO sono i1 doppio.
Cf, perd Mv 802,34; Sg 139,19 dove compare un ordine CVS con
tematizzazione di C e con S NUOVO,
° cer. "Gruppo di Padova" cit. pag. 156: "Antonio va a Roma,
“Va a Roma Antonio; Antonio picchia Carlo; *Picchia Antonio
Carlo.
10 G14 ordini VSO costituiscono nel Mv il cinque-per-cento, in
Sg il tredici~per-cento; in Fr il quarantacinque~per-cento,
mentre gli ordini SVO il quarantotto-per-cento.
11 31 contesto di questa. frase @ stato gid dato, cfr. pag. 6.
12 La tematizzazione di C @ pid difficile da individuarsi.Essa @
abbastanza rara rispetto all'alta frequenza della tematizza —
zione di 0 (come, del resto, anche nell'italiano di oggi).
Cfr, tuttavia la sequenza SCV in Sg 139,3: ...de’ grandi era~
no per fare contra al popolo di Ftrenge, e gente assai a Llo-
ro petitione era per esserci, 1'unica in cui occorre 1a ripre
sa pronominale et. i
13 'Nei due libri di conti la subordinata non @ sviluppata abba —
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- JREV3 5full PDFDocument44 pagesJREV3 5full PDFvalter8102100% (1)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- JREV3 3full PDFDocument44 pagesJREV3 3full PDFvalter81020% (1)
- Jrev3 4full2Document44 pagesJrev3 4full2valter8102100% (1)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- Jrev3 9fullDocument37 pagesJrev3 9fullvalter8102100% (1)
- Jrev3 8full PDFDocument40 pagesJrev3 8full PDFvalter8102No ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- RGG Vol 20 PDFDocument159 pagesRGG Vol 20 PDFvalter8102No ratings yet
- CommentariolumDocument21 pagesCommentariolumvalter8102No ratings yet