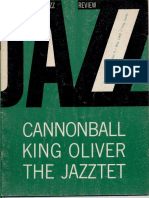Professional Documents
Culture Documents
RGG 3-1 78 PDF
RGG 3-1 78 PDF
Uploaded by
valter81020 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views142 pagesOriginal Title
RGG_3-1_78.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views142 pagesRGG 3-1 78 PDF
RGG 3-1 78 PDF
Uploaded by
valter8102Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 142
RIVISTA
DI
GRAMMATICA
GENERATIVA
Volume 3 numero 1 estate 1978
cooperativa librarie editrice
degli studenti
dell’ universita
di padova
Articoli:
Noam Chomsky
Guglielmo Cinque
RIVISTA DI GRAMMATICA GENERATIVA
Volume 3, numero 1, estate 1978
Contenuti
Una teoria della grammatica
centrale
3- 30
La sintassi dei pronomi relati
vi ‘cuit e ‘quale’ nell'itali
no moderno 31-126
Note e discussioni:
Adriana Belletti
Strutture coordinate e posses-
sivi
127-142
UNA TEORIA DELLA GRAMMATICA CENTRALE*
Noam Chomsky - Massachusetts Institute of Technology
Preliminaré
Lo scopo principale di questa conferenza & di presentare al
cuni dei presupposti e delle caratteristiche della ricerca, re-
cente ed attuale in gremmatica generativa trasformazionale.
In’ primo luogo, vorrei dire qualcosa sulle astrazioni che,
a mio parere, sono al tempo stesso legittime ed essenziali. La
prima di queste @ che dovremmo isolare le facolt. 4 linguag-
gio per uno studio indipendente, concependola come un organo men
tale con le sue proprieta specifiche geneticamente determinate,
analogo ad altri sistemi fisici del corpo come il sistema visi-
vo, il cuore, ecc. Questa, naturalmente, @ un'idealizzazione; u
na quantit® di fattori extralinguistici entrano nell'uso e nel~
Lacquisizione del linguaggio. In secondo luogo, facciamo astra
zione da differenze individuali. Anmettiamo che vi sia un equi:
paggiamento biologico fisso, e che una parté di esso sia un si-
stema di principi o condizioni sulie strutture, che potremmo con
cepire come costituente lo stato iniziale del linguaggio, vale
a dire, 1a facolt@ linguistica di ogni individuo. Ammettiamo che
la granmatica universale (GU) sia una descrizione di questo sta
to iniziale, La grammatica universale caratterizza dunque 1'e-
quipaggiemento biologico fisso che fornisce lo stato iniziale del
la facolt® del linguaggio. Cid che avviene nella crescita dell’
individuo @ che, sotto l'azione di stimolo e di controllo del
contesto sociale, l'organo del linguaz>10 cresce e si matura in
lui, raggiungendo infine, ad un certo momento, presumibilmente
nella tarda infanzia, uno stato di stabilita, dopodiché i cam-
biamenti sembrano essere piuttosto superficiali. La teoria che
mira a caratterizzare lo stato di stabililita ® chiamata grama
tica particolare.
Questo ® il quadro di idealizzazioni che vorrei adottare.
Lo stesso genere di ideal oni & normale, e neppure discus—
80, nello studio della struttura fisica del corpo, per esempio
nello studio dell'organo della vista.
La grammatica dell'individuo nello stato maturo @ conside:
rata un intricato sistema di regole e principi che assegne ad o
gni frase una struttura grammaticale completa con una specifica
zione delle sue proprieta intrinseche semantiche e fonetiche.La GU
determina le proprieta strutturali fondamentali delle grammati
che, e fornisce un quadro fisso entro cui una grammatica si svi-
luppa nella mente.
Ia caratteristica pit sorprendente del Linguaggio umano
il suo alto grado di articolazione, la sua struttura specifica
© dettagliata raggiunta allo stato di stabilita sulla base di
un'esperienza estremamente limitata e degenere, ed inoltre la
sua straordinaria uniformita una volta raggiunto quello stato.di
stabilitA. Queste propriet& generali suzgeriscono che 1a metafo
ra dell'apprendimento" generalmente utalizzata parlando della
erescita del linguaggio, potrebbe essere del tutto fuorviante,
e che, considerando la transizione dallo stato iniziale allo
stato finale, dovremmo piuttosto concepirla come analoga alla
crescita e alla maturazione biologica, In breve, quando una per,
sona conosce una lingua, sa enormemente di pid di quanto l'espe
rienza possa averle fornito, il che indica che il contributo del
L'equipaggiamento imnato deve.essere di importanza predominante,
esattamente nella stessa misura che nella crescita fisica del
corpo.
E' possibile dunque distinguere tra conpctenza grammatica-
2 e competensa pragmatica., La prima 8 caratterizzata da una
grammatica, un sistema di regole © principi. La competenza prag
matica d'altro canto, consiste di regole e di principi che de-
terminano 1'uso appropriato degli oggetti linguistici entro un
contesto di istituzioni umane. Lo studio serio della competenza
pragmatica presuppone lo studio della competenza grammaticale ,
cosa che diviene evidente non appena si consideri inconcreto lo
studio. della competenza pragmatica. L'interesse principale di
questa conferenza riguarda la competenza grammaticale: nonci si
soffermera sulla‘interazione della competenza grammaticale con
altri fattori.
Lo stile gatiletano
Gome possiamo procedere nello studio della £facolta del lin
wiggio, vale a dire, nello studio della grammatica universale?
Alcune delle possibili direzioni da seguire sono immediatamente
evidenti, e verrebbero applicate se si avesse a che fare con un
organismo indifeso, per esempio un gatto. Una delle cose essen-
ziali da fare in simili casi sarebbe di costruire un ambiente speri-
mentale in cui poter studiare la crescita del sistema senza trop
pe variabili. Cio&, si dovrebbe cercare di isolare casi ideali di
crescita del linguaggio in circostanze ideali. Per ragioni eti-
che, tuttavia, nello studio del linguaggio siamo costrettiastu
diare casi cosi come sono dati in natura, il che costituisce una Limi
tazione che non sorge nelle scienze fisiche. Cosi, al linguista
@ necessario essere pid ingegnoso; ma questo rende lo studio an
affascinante!.
cora pil
Una implicazione di tutto cid 8 che 8 difficile costruire
asserti falsificabili o scientifici, nel senso che @ possibile
predisporre un test, ma poi non si pud eseguire l'esperimento .
Questo tuttavia non diminuisce il contenuto empirico della teo-
ria, poiché essa & falsificabile in linea di principio, ed in
molti casi pud anche essere controllata in pratica:
Oltre a questa limitazione, i linguisti hanno imposto bar-
riere alla indagine razionale che non sarebbero tollerate nelle
scienze naturali, ed anzi le distruggerebbero, se vi fossero im
poste. Il salto intellettuale decisivo per le scienze avvenne
nel diciassettesimo secolo, e dette luogo a cid che & stato tal
volta chiamato lo stile galileiano: la costruzione dimodellima
tematici astratti a cui almeno i fisici accordano un grado di
realta pia alto di quello che accordano al mondo ordinario del-
le sensazioni, secondo le parole del fisico Steven Weinberg.Dal
diciassettesimo secolo lo stile galileiano ha contraddistinto le
scienze naturali, ed @ proprio l'adozione di questo stile che ha
condotto al loro enorme successo. Nel corso degli ultimi secoli
le scienze naturali sono state contraddistinte dalla ricerca di
principi esplicativi che valessero in circostanze altamente i-
dealizzate, ed anche dalla propensione a lasciare da parte fat-
ti che apparentemente confutavano i principi. Il grande succes-
so delle scienze naturali moderne pud essere attribuito alla ri
cerca di profondita esplicativa, cui molto frequentemente si at
tribuisce maggior peso che alle inadeguatezze empiriche. Questa
la vera rivoluzione intellettuale del diciassettesimo secolo.
Lo stile galileiano adotta un punto di vista assai ragione
vole, poiché spesso non possiamo sapere quale tipo di fatti @
pertinente per mettere a prova le teorie. Dunque, la nozione
di profondita esplicativa deve essere utilizzata come congettu~
ra razionale quanto al tipo di propriet& che sono pertinenti per
i modelli astratti a cui lo scienziato attribuisce un pia alto
grado di realta. Perfino la grammatica assolutamente vera, se
esistesse, sarebbe “confutata" da masse di contro-esempi, di nuo
vo perché non sappiamo a priori qual @ il tipo giusto di prove.
Quando otteniamo giudizi digrammaticalitida informatori, o
conduciamo esperimenti di psicolinguistica, non sappiamo a prio
ri che cosa dovrebbe essere attribuito alla competenza grammati
cale, ¢ distinto da innumerevoli altri fattori. Inoltre, non vi
sono parlanti che rappresentino il caso ideale di crescita del
Linguayzi0 del tipo che potremmo costruire in circostanze speri
mentali. Il punto importante 8 che il dominio della spiegazione
teorica non @ dato a priori, ma @ esso stesso un costrutto teo-
rico di alto livello. Si acquista fiducia nella pertinenza di
certi esperimenti e certe osservazioni nella misura in cui essi
risultano essere in correlazione con una teoria esplicativa, e
permettono che una simile teoria sia resa pid profonda. 6'@ una
sola alternativa a questo approccio: la collezione di farfalle,
le elaborate tassonomie di sensazioni e osservazioni
Anche lo studio del linguagzie pud avere la sua rivoluzio-
ne galileiana, se siamo disposti a permettere che questa rivolu
zione abbia luogo, e progredisca in questo modo.
Sviluppi recentt
Vorrei ora esplorare alcuni sviluppi recenti nel campo del
la linguistica che suggeriscono 1a possibilitA che si venga a
creare una situazione in cui la profonditA esplicativa diventi
un fattore nella valutazione di una teoria, ed anzi, un fattore
tanto significativo da sormontare prove apparentemente confutan
ti. Prendendo in esame i primi lavori della grammatica generati
va trasformazionale, si notera che essi erano guidati da unacer
ta intuizione che mi sembra essenzialmente corretta. I,'intuizio
ne era che la vasta e complessa proliferazione delle forme fra-
sali pud essere spiegata fattorizzandone la complessita in due
componenti fondamentali, ciascumo dei quali risulterebbe assai
semplice. I1 primo componente @ un sistema di regole di base a~
stratte che caratterizza cid che viene chiamato "strutture pro~
fonde", nelle quali le relazioni grammaticali fondamentali sono
espresse direttamente, e il secondo componente @ un sistema di
regole trasformazionali che proiettano le strutture profonde su
forme superficiali, le quali forniscono la base per (almeno) le
realizzazioni fonetiche. Si affermava inoltre che distinguendo
questi due componenti grammaticali separati ed interagenti si po
tevano scoprire i fattori che determinano le propriet& semanti
che delle frasi, nella misura in cui esse appartengovo alla fa-
colt del linguaggio.
Vi & una analogia cov i lavori imiziali nel campo che @ og
gi chiamato "fonologia geverativa". In questo campo si ipotizza
che il lessico di una lingua costituisca uma sorta di interfac~
cia tra la fonetica da una parte, e la sintassi e la semantica
dall'altra. Se consideriamo la variazione morfofonologica . in,
per esempio., electric - electricity -electriciané razionale i
potizzare che vi sia un solo elemento lessicale astratto che ha
alcune propriet@ semantiche e sintattiche, ed anche una forma fo
nologica (morfofonemica) astratta. Le tegole che danno le varia
joni semantiche sono assai arbitrarie ed idiosincratiche, men~
tre le regole che danno le variazioni fonetiche sembrano as
sai profonde ed umiformi, e sembrano avere propriet® interessan
ti. Questa @ una differenza tipica tra i due sistemi di regole.
Questa 8 anche una delle ragioni per cui la fonologia resta un
argomento intellettualmente significativo in un senso in cui, La
semantica non lo &. La rappresentazione fonologica astratta &
proiettata su varie rappresentazioni fonetiche da una serie di
regole fonologiche. GLi outputs fonetici sono vari e complessi,
ma i due componenti che determinano L'output fonetico sono sem
plici ed eleganti, e riflettono principi generali che apparten-
gono ad un grado pid alto e astratto di realta. Questi due com-
ponenti sono il sistema delle regole fonologiche che operano su
vappresentazioni mentali astratte, e il sistema delle forme les
sicali, che si discosta appena da un qualche sistema’non marca~
to di forme idealiy 1"insieme nel suo complesso ha proprieta si
stematiche che sono oscurate nelle rappresentazioni fonetiche in
quanto tali. Questo & il punto di vista della fonologia genera-
tiva, e su questa base fu sviluppato il modello della .sintassi
generativa. Cosi, possiamo concepire le strutture di base, lere
gole trasformazionali e le forme superficiali come analoghe, ri
spettivamente, alle rappresentazioni fonologiche astratte, alle
regole fonologiche e alle rappresentazioni fonetiche.
Un elemento della grammatica tradizionale, sviluppato dal
Circolo di Praga, @ la teoria della marcatezza. Questa nozione
& assai familiare nel campo della fonologia e della morfologia.
I paradigmi regolari rifiettono le regolarit@ pit profonde e ba
sithe. Analogamente, la complessita del sistema fonetico riflet
teun ‘centro’ di regole e strutture sottostanti meno marcate, e
generalmente una 'periferia' dieccezioni. Sembra assai sensato e
stendere simili idee allo studio della sintassi, in particolare
ineludendovi lo studio della sintaset della forma logiea, che
tra
a di alcune proprieta della semantica sistematica del lin-
slo naturale, ed @ percid spesso chiamata, in maniera fuor~
eu
viante, “semantica", Possiamo concepire 1a sintassi di una lin-
gua come una sorta di struttura stratificata, proprio nelmodo in
cui abbiamo analizzato 1a complessita delle forme superficiali
delle rappresentazioni fonetiche e sintattiche in termini di
strutture di base e di regole che vi si applicano iterativamen-
te. Possiamo quindi concepire i sistemi stessi come appartenen-
tia diversi tipi: in primo luogo una granmatica centrale con
strutture non mareate e regole di grande semplicita e, seconda~
riamente, una periferia di strutture e processi grawmaticali spe
ciali e spesso assai pit complicati. La grammatica universale
specifichera in primo luogo 1a variet@ permessa delle grammati
che centrali e, in secondo luogo, l'ambito dei meccanismi che
possono essere utilizzati quando ci si allontana dalla grammati
ca centrale. La teoria della grammatica centrale dovrebbe forni
10
re principi fondamentali con determinati parametri. Per esempio,
la teoria della graumatica centrale potrebbe specificare che la
base deve consistere di una qualche versione dellateoria X- barra
(&), come principio generale con parametri che potrebbero avere
a che fare con l'ordine sottostante dei costituenti*. Forse, 10
stesso ordine di base @ una opzione permessa, ma non richiesta
dalla grammatica centrale.
Se si considerano le cose in questo modo, 1'acquisizione
del linguaggio comporta diversi passi: dapprima la identifica~
zione dei parametri della grammatica centrale, e secondariamen~
te l'apprendimento di specifiche regole marcate e di strutture
che si discostano dalla grammatica centrale in una data lingua.
E’ possibile che le stesse opzioni della grammatica centrale ,
per es., le opzioni di ordine, possono éssere stratificate in
aceordo con una teoria della marcatezza. Vi sono lavori sull'or
dine dei costituenti nel linguaggio dei bambini e nelle lingue
creole che sono indicativi a questo riguardo. La grammatica cen-
trale ha una struttura rigida i cui meccanismi espressivi sono
limitati. Essa incorpora dei principi di computazione . mentale
che interagiscono per fornire lo scheletro essenziale su cui la
lingua 6 costituita, producendo in effetti il sistema fondamen-
tale delle costruzioni e la grande varieta delle espressioni in
terpretate, ma non l'intera ricchezza del linguaggio.
Possiamo ‘considerare il lavoro degli ultimi anni come una
sorta di progresso erratico verso una teoria della grammatica
centrale: si consideri per esempio il lavoro sulla teoria X al
fine di restringere la variet& delle possibili strutture di ba~
se (anche se aspetti specifici della questione rimangono assai
controversi), 0 la stessa nozione di regola trasformazionale. I
primi lavori su questa nozione miravano a sviluppare un concet~
to di regola trasformazionale che fosse abbastanza ricco da su~
perare un'ampia gamma di difficolt@ che sorgevano quando si ten
qn
tava di applicare alle lingue naturali una teoria sistematica
della struttura sintagmatica’. La meta era fin dall'inizio cid
che fu chiamato adeguateaza esplicativa, ma il concetto di rego
la trasformazionale proposto nei primi lavori era eccessivamen-
te ricco in potere espressivo, poiché permetteva un ambito trop
po ampio di grammatiche possibili, e lasciava quindi ancora as-
sai lontano quello che doveva essere il fine essenziale, vale a
dire, spiegare’ come una conoscenza dettagliata altamente speci-
fica sia di fatto conseguita sulla base di una limitata disponi,
bilita di dati. Vi era una ragione per questa sovrabbondanza con
cettuale, poiché sembrava necessario razsiungere un qualche ti~
po di adeguatezza descrittiva; ma i lavori successivi hanno mo-
strato progressivamente come la sovrabbondanza concettuale pos-
a de-
sa essere ridotta senza perdita essenziale di adeguate:
scrittiva.
Si considerino per esempio le interrogative W
(1) Who did you see?
(chi hai visto?)
(2) To whom did you give the present?
(A chi hai dato il regalo?)
In questi casi, un sintagma WH @ stato posto in posizione
iniziale di una struttura frasale che contiene un vuoto, cioa il
posto in cui un sintagma che corrisponde al sintagma WH appari,
rebbe nella frase dichiarativa corrispondente. Questi fatti es-
senziali possono essere espressi da una regola trasformazionale
che sposta un sintagma WH a quella che & chiamata la posizione
“complementatore” alla sua sinistra*. Fin dall'inizio si noto
che questa regola non avrebbe funzionato cosi com'era, e che dove-
va essere fornita di una quantita di restrizioni. Prendiamo per
esempio la frase
2
(3) Your interest in Bill surprised me
(11 tuo interesse in (nei confronti di) Bill mi ha sorpreso)
e cerchiamo di porre 1a domanda sulla posizione in cui appare
imile a (4) o a (5):
Bill, ottenendo qualcosa di
(4) *Whom did your interest in surprise me?
(Chi il tuo interesse nei confronti di mi ha sorpreso?)
(5) *In whom did your interest surprise me?
Qlei confronti di chi il tuo interesse mi ha sorpreso?)
Queste frasi devono essere eliminate in qualche modo, il
che implica che non possiamo semplicemente dire "si sposti un
sintagma WH e lo si collochi in posizione iniziale", poiché que
sta formilaz
ione dA un risultato sbagliato in (4).e (5).
Negla anni Cinquanta le restrizioni appropriate erano in-
corporate nella regola trasformazionale stessa, in quella parte
della regola che era chiamata indice o descrizione strutturale,
e che esprimeva direttamente l'insieme di costruzioni in cui il
movimento di WH poteva applicarsi. Per poter far questo, era ne
cessario incorporare ricchi strumenti descrittivi nella teoria,
essenzialmente quegli strumenti che sono presentati nelle varie
formalizzazioni che sono state sviluppate della teoria della
gramatica trasformazionale, tra le quali la pid nota @ quella
diPeterse Ritchie (1973). Ma questa ricchezza di strumenti
spressivi, benché apparentemente necessaria per render conto di-
rettamente delle restrizion1 sull'applicazione delle regole, la
sciava ancora lontana la meta dell'adeguatezza esplicativa, 0,
da un altro punto di vista, lasciava lontana una spiegazione dei
fondamenti dell'acquisizione del linguaggio (poiché vi erano a
disposizione troppi sistemi possibili). Negli ultimi quindici o
venti anni si @ prodotto uno sforzo considerevole,diretto, con
qualche successo, a ridurre la ricchezza dei mezzi descrittivi
13
senza perdite essenziali di adeguatezza descrittiva, In effetti,
l'adeguatezza descrittiva’ é stata’spesso aumentata. Questa @ la
maniera in cui possiamo avvicinarci ad una teoria dello stato i
niziale, risolvendo il problema di "come possiamo sapere cosi
tanto sulla base di dati cosi scarsi".
Una maniera assai feconda di affrontare questo problema @
stato lo studio delle condizioni generali sul funzionamento del
le trasformazioni. Buona parte di questo lavoro @ stato del ti-
po di cataloghi descrittivi di restrizioni, per es., il lavoro
di Ross (1967) sulle restriatoni di isola. Supponiamo ora che
queste restrizioni possano essere formulate in maniera generale.
In questo caso, esse non devono essere incorporate inregole par
ticolari, e 1a sovrabbondanza dei mezzi descrittivi pud essere
ridotta, poiché le regole particolari non devono pid essere co-
struite in modo tale da ésprimerle, Benché questo sia un impor-
tante passo in avanti, esso non @ ancora soddisfacente per una
quantita di ragioni. In primo luogo, molte delle restrizioni e-
spresse sono estremamente innaturali, per es., 1a Restrisztone
del Sintagma Nominale Complesso (RSNC), o la restrizione per cui
le cancellazioni in qualche dominio creano un'isola per le rego
le di movimento. Queste generalizzazioni sono approssimativamen
te corrette, ma il problema @ perché esse debbano avere proprio
questa forma. In secondo luogo, le restrizioni di isola costi-
tuiscono un catalogo descrittivo, nel senso che ciascuna di es~
se esprime una certa generalizzazione empirica su strutture os-
servate; ma noi vorremmo trovare principi unificatori pia pro-
fondi, i quali dovrebbero soddisfare le due condizioni seguenti:
a) dovrebbero essere naturali come principi di computazio~
ne mentale;
b) dovrebbero essere geminamente esplicativi nel senso di
unificare una quantit& di tali generalizzazioni e fondarie suun
sistema che abbia un certo grado di struttura deduttiva.
14
Negli ultimi anni vi sono stati alcuni passi significativi
in questa direzione, e questo mi sembra il lavoro piii incorag-
giante ¢ stimolante nel settore. Per esempio, prendiamo la tra~
sformazione di movimento di WH, e supponiamo che si voglia ap-
plicarla alla struttura (6):
(6) [F comP Tf gnvOur interes¢t[,,,in whom]] surprised me]]
WH
I1 movimento di WH sposta il sintagma WH nella posizione
del complementatore. In questo movimento, tuttavia, vengono at-
traversati un nodo F c un nodo SN. I] risultato 8 una frase a~
grammaticale;
(7) “in whom did your interest surprise me?
Supponiamo ora di identificare una classe di cid che @chia
mato "
"categorie vincolanti" (binding categories); questa classe
include SN e F, che sono simili per molti aspetti, poiché en-
trambe mettono in gioco le relazioni grammaticali fondamentali
di soggetto, oggetto, ecc., entrambe costituiscono un dominio
per le regole trasformazionali, e cosi via, Supponiamo di stipu
lare che tutte le regole trasformazionali sono limitate da un
principio dé soggiacenza, i1 quale asserisce che nulla pud esse
re estratto da pia di una sola categoria vincolante’. Allora ,.
questo principio renderebbe conto della agrammaticalita di (7).
Gia Ross (1967) aveva osservato che le regole di movimento ver-
so destra nelle frasi appaiono limitate in questo senso, e que~
sta osservazione fu estesa alle regole di movimento verso destra
nei sintagmi nominali da Adrian Akmajian (1975). Ll principio di
soggiacenza semplicemente generalizza queste osservazioni a tut,
te le regole trasformazionali. Questo principio rende conto del
fatte che il movimento di WH non pud estrarre nulla dadentroil
SN soweetto di una frase, come nel caso di (6)-(7). La condizio
15
ne di soggiacenza rende anche conto della restrizione del SN com
plesso rispetto al movimento di WH, poiché anche in questo caso
L'estrazione avviene attraverso due categorie vincolanti, come
si pud vedere nello schema che segue:
ex
(8) SN
WH
I due nodi- cerchiati sono le due categorie vincolanti che
sono attraversate nello spostamento del sintagma WH dalla frase
incassata.
Vi sono altre conseguenze interessanti. Si consideri, per
esempio, il problema del movimento di WH nelle comparative:
(9) [gq COMP [, the assignment was more difficult than [, the
teacher told [ the class] that it would be}]]
(1) compito era pit difficile di quanto 1"insegnante aves~
se detto alla classe che sarebbe stato)
Se dovessimo cercare di interrogare il sintagma the class,
il risultato sarebbe agrammaticale:
(40) *Which class was the assignment more difficult than the tea
cher told that it would be?
(A ‘che classe il compito era pid difficile di quanto 1'in
segnante avesse detto che sarebbe stato?)
I] sintagma the teacher told the class that F @ chiaramen-
te il residuo di una frase. Quindi il movimento di WH @ blocca~
to in questo caso perché il sintagma WH @ stato spostato attra
verso diversi nodi P.'Si noti dunque come il principio di sog-
giacenza renda conto di una quantita di esempi, quali la impos-
16
sibilitadel movimento di WH dalle comparative (comparative com-
plesse) e dai soggetti, la limitatezza a destra, la RSNC, ed al.
tre cose ancora, che tratterd brevemente in seguito.
Cosi il principio soddisfa la condizione di essere un prin
cipio genuinamente unificante (condizione b), nel senso che va~
rie restrizioni di isola possono essere dedotte da esso. E!
noltre un principio naturale (condizione a), poiché @ sensato
supporre che la computazione mentale sia regolata da principi
che limitano, il dominio su cui la computazione stessa ha luogo
In questo caso, 1a limitazione @ ad una singola categoria vin-
colante: i processi possono aver luogo solo localmente, e a d:
stanze non troppo grandi. Jan Koster (in preparazione) ha sostenuto
assai plausibilmente che il principio di soggiacenza ® in effetti
non sufficientementé generale e che, 18 dove funziona, esso ri-
cade in un pit ampio principio di localita da lui proposto.Prin
cipi di questo tipo sono assai naturali per un sistema di compu
tazione mentale. E' anche interessante notare il lavoro recente
di Ken Wexler e Peter Culicover (1977) sulla apprendibi
lita delle grammatiche. Essi hanno mostrato che il princi-
pio di soggiacenza contribuisce a limitare drasticamente 1'in-
sieme di dati che @ richiesto per convergere sulla granmatica
corretta di una Lingua. Il principio soddisfa quindi un buon-nu-
nero dei desiderata che sono stati recentemente formulati per u
na teoria appropriata, ed ha \l'effetto di eliminare la necessi.
ta di apparato descrittivo per la formulazione delle regole tra
sformazionali. Con questo principio, non vi @ nulla da specifi-
care sulla regola di movimento di WH, se non semplicemente "si
sposti un sintagma WH".
Henk van Riemsdijk (1978) ha recentemente presentato pro~
ve forti per 1'ipotesi che i sintagmi preposizionali siano an-
ch'essi categorie vincolanti rispetto alla suggiacenza, e ne ha
tratto alcune interessanti conclusioni per 1'olandese e 1'ingle
17
se, e per la teoria ycnerale della grammatica.
Fin qui ho tralasciato un problema evidente, e cioé che il
principio di sogejacenza sembra direttamente falsificato dal co
siddetto movimento “illimitato" di WH in frasi quali®:
11) [- What book [,, did you tell the teacher [> that [,, he
F F
F
should assign ¢ to the class]]]]
(Che libro hai detto all'insegnante che dovrebbe assegnare
alla classe?)
Questa frase assomiglia molto all'esempio (10): il sintag-
ma Wil & stato spostato attraverso diversi nodi F, eppure le fra
se & grammaticale, Tl sintagma WH @ estratto dalla frase pid pro
fondamente incassate, nella quale la sua posizione di origine @
marcata da una traccia (¢). In effetti, in simili strutture, es
so potrebbe attraversare un numero arbitrario di nodi P.
(12) [= COME [, we notice [5 that the teacher told T gy the class]
[p that it was raining] ]]]
(Notiamo che 1'insegnante ha detto alla classe che stava
piovendo)
(12) assomiglia molto a (9), ma anche in questo caso @ pos
sibile interrogare il sintagma the class, estraendolo fino alla
posizione complementatore:
a3)
a
what class [, did we notice
that [, the teacher told
that it was raining]]]]]
F
(A che classe notammo che 1'insegnante disse che stava pio
vendo?)
Anziché abbandonare il principio di soggiacenza per questi
esempi confutanti, potremmo ora domandarci che cosa deve accade
18
re perché il principio di soggiacenza valga anche in queste cir
costanze. La strategia di ipotizzare una realtA nascosta per man
tenere un principio naturale @, in casi come questo, assai com
ne néile scienze naturali. Nel nostro caso, la realta nascosta
ipotizzata @, ovviamente, 1a teoria dell'applicazione per cicli
successivi delle regole di movimento. Nel caso dell 'esempio (12),
verrebbe ipotizzato un movimento in due tappe:
(14) [ COMP [, we notice [= COMP [, the teacher told [ which
class} that it was rainingl]]]
La prima applicazione del movimento di WH sposta il sin~
tagma WH nella posizione di complementatore della frase incassa
ta, e la seconda applicazione lo sposta da questa posizione al-
1a posizione di complementatore iniziale di frase. Si osservi
che ogni singolo movimento rispetta 1a condizione di soggiacen-
za. Lo stadio intermedio
(15) [gy Comp [,, we notice [q which class [, the teacher told ¢
Lg that it was raining) ]]1]
(Notiamo a quale classe 1'insegnante ha detto che stava pio
vendo)
una frase perfettamente corretta, una interrogativa indiretta,
da cui 1a interrogativa diretta (13) @ derivata mediante una se
conda applicazione del movimento di WH.
Questo modo di concepire il problema preserva il principio
di soggiacenza e rende conto degli esempi (11) e (15). IL prin=
cipio dei cicli successivi 8 sempre stato adottato per 1'appli-
cazione del. sollevamento del soggetto. Se si considerano le ana
lisi standard di casi quali
19
(16) John seems to be certain to win
(John sembra - esserd certo ~ vincere)
(Sembra che sia certo che John vincera) .
& sempre stato ipotizzato che Jolt venga spostato in pos
iniziale mediante applicazioni successive del sollevamento del
soggetto:
(17) [It seems [it is certain [John to win]]}]
Questa linea di argomentazione @ ora estesa al caso del mo
vimento di WH.
E'.chiaro che-non tutti i verbi ammettono interrogative in
direttes per esempio, se si inserisce say (dire) al posto di no
tice in (12), si pud ancora avere una interrogativa diretta, ma
non una interrogativa indiretta. Tuttavia, questo fatto non po-
ne problemi poiché vi sono molte prove indipendenti che la for-
ma logica, cio& la sintassi della semantica, deriva dalla strut
tura superficiale. Se in struttura superficiale un verbo non am
mette una interrogativa indiretta, @ si possibile applicare il
movimento di WH sotto di esso’, ma non ne risultera alcuna fra-
se grammaticale. Si otterra qualcosa come
(18) *He said who is here
(Bgli ha detto chi @ qui)
Questa frase @ eliminata dalle regole che correlano la
struttura superficiale alla forma logica. In contrasto, la se-
guente
(19) He noticed who is here
(Bgli ha notato chi @ qui)
@ perfettamente accettabile, al pari di
20
(20) Who did he say was here?
(Chi diceva che era qui?)
(20) @ derivata da (18) mediante una seconda applicazione
del movimento di WH. Questo equivale a dire che la seconda appli
cazione del movimento di WH @ obbligatoria dopo la parola say, e
facoltativa dopo notice. Il che & in effetti quel che avviene ,
ma nulla di tutto cié deve essere stipulato nella caratterizza-
zione della regola di movimento di WH, in quanto tale,poiché se
gue da proprieta indipendenti degli elementi lessicali.
Cid che questo esempio tipico mostra @ che all'interno del
la grammatica centrale tutte Le regole sono facoltative, oppure,
per considerare la cosa differentemente, i mezzi della granmati
ca centrale possono essere ulteriormente ridotti, poiché 1'al-
ternativa tra regole facoltative ed obbligatorie pud essere eli,
minata. Per le ragioni gia menzionate, questo costituisce un ul
teriore passo verso 1'adeguatezza esplicativa.
Torniamo ora al caso delle comparative, in cui abbiamo an~
cora un problema importante, vale a dire, il bloccaggio . della
derivazione della frase agrammaticale (10). Perché L'applicazio
nedel movimento di WH per cicli successivi @ impossibile in que
sto caso? Consideriamo prima qualche altro esempio in cui il mo
vimento ciclico non pud applicarsi:
(21) lp ‘COMP [, he noticed [% who [, ¢ saw the man]]]]
F
(Zgli ha notato chi ha visto 1'uomo)
Supponiamo di cercare di interrogare il sintagma the man ,
ottenendo:
(22) Ug which man [, did he notice [= who [, t saw 4]]]
(Che uomo (egli) ha notato chi ha visto?)
21
La frase (22) @ chiaramente esclusa. Il sintagma WH non
pud essere spostato direttamente in posizione iniziale di frase,
poiché in questo caso la condizione di soggiacénza sarebbe vio~
lata (verrebbero attraversati due nodi F). Ma anche 1'applica~
zione per tappe del’ movimento di WH @ es¢lusa, per la ragione e
vidente che 1a posizione complementatore della frase incassataé
gia riempita. Cosi, entrambe le derivazioni possibili sono bloc
cate. Questo @ um caso particolare di cid che @ talvolta chiama
to “restrizione dell'isola Wi" (WH Island Constraint), ed in
effetti questa condizione segue automaticamente dalla condizio-
ne di soggiacenza. Si noti che (9) non creerebbe alcun proble-
ma se si potesse mostrare che le costruzioni comparative metto-
no in gioco il movimento di WH, e che la struttura astratta di
(9) & qualcosa di simile alla seguente:
(23) [g COMP [, the assignment was more difficult than
what [, the teacher told the class [ that’ it would be]]]]]
¥ F
(11 compito era pit difficile di quanto 1"insegnante aves~
se detto alla classe che sarebbe stato)
Se questa fosse la struttura astratta sottostante, allora
diverrebbe chiaro perché non @ possibile 1'applicazione per ci-
cli successivi del movimento di WH se viene interrogato il sin-
tagua the elass, dato che la posizione di complementatore della
frase incassata sarebbe riempita,cosi come lo era in (21).Si da
il caso che (23) sia in effetti una variante dialettale possibi
le in inglese, e vi sono prove sostanziali (che non possiamo ri
prendere qui) che l'analisi delle comparative dovrebbe realmen-
te seguire queste linee, con 1’elemento WH spostato alla manie-
ra ordinaria, e, alla fine, cancellato da una regola che appar-
tiene alla fonologia, e che varia da un dialetto all'altro®,
Possiamo quindi ipotizzare che nell'interpretare e nel for
22
mare le interrogative e le comparative la mente pud "vedere" il
sintagma WH in posizione di complementatore della frase incassa
ta, cosi che il movimento di altri sintagm: Wd in questa posi-
zione & impossibile, cosi come & impossibile nel caso della in-
terrogativa indiretta (21); il principio di soggiacenza blocca
poi ogni altro movimento. $i pud cosi vedere che un'eccezione al.
la soggiacenza da una parte (la frase (13)) e un apparente con-
troesempio dall'altra (1a frase (10)) possono essere spiegati en
trambi con una sola assunzione indipendentemente motivata, vale
a dire, un principio che dica qualcosa sulle strutture nascoste
che sono assai diverse da cid che appare in superficie. In bre~
ve, stiamo ipotizzando che la mente & un meccanismo assai sem-
plice, che fa uso diretto di regole molto elementari ed elegan~
ti, ma che opera su costruzioni astratte a cui non possiamo ac-
cedere intuitivamente.
La teoria appena discussa potrebbe rivelarsi su una pista
sbagliata, ma in ogni caso ha le proprieta corrette. Essa mette
in gioco pochi principi astratti ed assai generali, che sono na
tutali, che hanno un ruolo in spiegazioni non banali, e che uni,
ficano un ambito assai disparato di fenomeni e di generalizza-
zioni.. Di fondamentale importanza ® l'ipotesi che le rappresen-
tazioni mentali sono astratte, e sono ovviamente inaccessibili
all'introspezione. E' anche assai semplice in una teoria come
questa mostrare che lievi cambiamenti nella determinazione de:
parametri del sistema conducono a predizioni sorprendenti nel-
ltambito dei fenomeni trattati. Naturalmente, cid che vorremmo
arrivare a mostrare @ che la varieta delle lingue risulta da
cambiamenti assai lievi ad un livello pid profondo
Torniamo un'altra volta alla restrizione del SN complesso.
Questa segue automaticamente dai principi considerati, Il movi-
mento di WH direttamente fuori dalla frase dominata da un SN
complesso & bloceato dalla soggiacenza, come mostrato in (8)
23
entre 1’applicazione per cicli successivi non & possibile per
il semplice fatto che i sintagmi nomineli non hanno un comple~
nentatore.
Vi sono differenze interessanti tra restrizioni tipo quel-
la del SN complesso, quella dell'isola WH, ecc. da una parte, e
il principio di soggiacenza dell'altra. La restrizione del SN
complesso, quella dell'isola WH, ecc. sono generalizzazioni su
fenomeni osservati. Esse dicono semplicemente che costruzioni di
questo o quel tipo sono agrammaticali. La generalizzazione 8 cor
retta se i fenomeni che essa predice occorrono effettivamente .
Notiamo che le generalizzazioni di questo tipo non forniscono
delle "spiegazioni". Esse lasciano aperta 1a questione del per~
ché un fatto o un altro debbano comportarsi proprio in un dato
modo. Una generalizzazione semplicemente stabilisce o ordina i
fatti che tuttavia restano da spiegare. Non @ percid’ necessario
che una generalizzazione sia naturale. Per contro, la condizio~
ne di soggiacenza non @ affatto una generalizzazione su fenome~
ni osservati. Infatti se ritenessimo che fosse una generalizza-
gione su fenomeni osservati essa sarebbe chiaramente falsa. Es~
sa & piuttosto un principio che si applica a rappresentazioni a
stratte e governa il tipo di computazione mentale che ha luogo
su queste rappresentazioni. Essa permette una spiegazione genui
na e unifica un certo numero di generalizzazioni indipendenti ;
sembra anche un principio naturale nel senso descritto, vale a
dire un ragionevole principio di localtta della computaztone men
tale.
Possiamo ora tornare all'analogia con la fonologia genera
tiva. Il lavoro standard svolto nel quadro della fonologia gene
rativa mostra che 8 possibile spiegare le proprieta di superfi-
cie nei termini di un inventario di rappresentazioni sottostan-
ti relativamente non marcate, cio® di un inventario naturale ©
di regole naturali come l'assibilazione delle velari, la pala~
24
talizzazione, la riduzione di vocale non accentata ed altre re~
gole comunemente osservate, anche nella fonetica di superficie.
Il punto & perd che queste regole non si applicano al livellodel
la fonetica di superficie, A questo livello 1'inventario @ alta
mente marcato e le regole che descrivono le relazioni di foneti
ca di superficie sono estremanente innaturali, spesso poco pid
che una lista disordinata. Tuttavia, le regole menzionate sono
naturali e si applicano propriamente su quel livello astratto
che non @ mai realizzato, Cid & tipico della fonologia generati_
va.
Praticamente lo stesso @ vero della grammatica centrale ed
& questo quanto ho cercato di illustrare con queste osservazio-
ni. In ef:
tti, @ mia opinione che lo studio del linguaggio ab-
bia un generale interesse intellettuale soltanto se proprieta di
questa natura possono essere scoperte.
Molti altri principi generali, oltre al principio della sog
perti recentemente come, ad esempio, la
giacenza, sono stati
vestrizione delia testa e mmerosi principt di “opacita". que-
sti principi hanno molte proprieta desiderabili e questo indi~
pendentemente dal fatto che essi debbano risultare o meno fonda
ne il valore e-
mentalmente corretti. Decisivo in cid che con
sphicativo di questi principi @ 1"assunto che categorie che non
hanno alcuna rappresentazione fonetica concreta possono essere
presenti nel corso della computazione mentale, come ad esempio
il sintagma WH in frasi del tipo di (23) o le cosiddette tracce
introdotte dalla teoria della traccia per le regole di movimen-
to. Molti di questi principi fondamentali della grammatica cen~
trale si applicano anche al livello della forma logica offrendo
un certo chiarimento relativo al funzionamento della sintass.
della forma logica, lo strumento attraverso il quale @ rappre-
sentata 1'informazione semantica.
Osservaztoni conclusive
L'approccio generale’che ho discusso risulta indubbiamente
scorretto in alcuni dettagli e forse anche in aspett: fondamen-
tali. Cid che tuttavia sembra considerevolmente importante é che
a natura e iniziare ad
& ora possibile formulare ipotesi di qu
esplorare le loro conseguenze. In breve & importante che sia pos
sibile proporre varie teorie della granmatica centrale (almeno
in prima approssimazione) e mostrare che all'interno di tali teo
rie vi sono alcuni principi fondamentali che rientrano in com=
plesse strutture deduttive che unificano (forniscono spicsazio-
ni per) alcune proprieta del linguaggio che appaiono ampiamen~
te generali ed anche assai varie. Pud risultare che le opzioni
nonché l'apparato descrittivo della teoria della grammatica cen
trale siano particolarmente limitati: le regole sono non ordina
te e facoltative, le trasformazioni possono essere tutte ripor-
tate allo schema “muovi una certa categoria" con le condizion:
ili che restringono le diverse applicazioni (in
di opacita e si
direttamente, in questo caso, per mezzo della teoria della trac
cia), con cid rivelando quelle che appaiono essere le connessio
ni profonde esistenti tra le regole di movimento e 1'anafora.Mu
tando in misura minima i parametri del sistema centrale, possia
mo derivare cambiamenti sostanziali nelle forme osservate.I prin
cipi fondamentali sembrano naturali, ragionevoli candidati per
un sistema di leggi.
In alcuni casi ad una proprieta idiosincratica di una lin-
gua pud essere fornita una formulazione minimale che, in questa
forma potra. produrre risultati scorretti, a meno di non venire
incorporata in una qualche cornice di assunzioni specifiche.Per
esempio, la grammatica dell'inglese deve stabilire il fatto spe
cifico e idiosincratico secondo cui.il sintagma each other deve
avere un antecedente. E' ovvio che una simile generalizzazione
& notevolmente inesatta come generalizzazione su fenomeni osser,
26
vali, se non specifichiamo ulteriormente la scelta dell'antece-
dente. La corretta teoria della GU permette tuttavia che le re-
gole siano date precisamente in questa forma dal momento che @
L'applicazione dei principi fondamentali inmati a limitarne la
gamma delle possibili conseguenze, In tal modo possiamo spiega-
re come ogni parlante conosca interamente questa gamma di conse
guenze sebbene difficilmente egli possa averle imparate,e tanto
meno possano essergli state insegnate. Laddove @ possibile ave-
re prove empiriche significative per questa cornice di ipote-
si, vale a dire per la teoria della grammatica centrale, allora
questo costituisce una conferma di cid che @ stato chiamato, a
volte impropriamente, la realtd petcologica della grammatica.§
questo l'unico senso significativo in cui pud esservi prova del
la realt@ psicologica di strutture ¢ principi e a me sembra che
le considerazioni che si son svolte forniscano effettivamente
delle prove significative di una simile realt& psicologica.
Sono queste le proprieta che la teoria corretta dovrebbe pos
sedere e mi sembra importante che ora noi possiamo proporre ,
almeno in via preliminaré, delle teorie che hanno le proprieta
corrette e che manterranno un ampio potere descrittivo.
Per tornare alla nostra osservazione originaria, notiamo
che & possibile, nello studio della sintassi, (includendo anche
la sintassi della forma logica) raggiungere un livello in cui
la lezione fondamentale della rivoluzione scientifica del XVII
secolo pud divenire applicabile alle nostre ricerche, vale a di
re la lezione secondo cui 1a profondita esplicativa pud diveni-
re un fattore significativo nel determinare L'oggetto della ri
cerca, 1a gamma dei fenomeni rilevanti e la costruzione di teo-
rie per quel dominio. Forse tutto cid & ancora prematuro, ma @
questa la meta verso cui dobbiamo muovere e io ho la personale
sensazione che essa sia meno lontana di quanto in genere non si
ritenga.
27
NOTE DEL CURATORE
* questo articolo 8 una versione abbreviata (autorizzata dal-
L'autore) di una conferenza tenuta da Noam Chomsky all'Uni-
versit& di Leida il 9-12-1977, e apparsa nei "working papers”
dell'Universit& di Leida. Ringraziamo l'autore per avere per
messo questa traduzione italiana. Dato il carattere del te-
sto, riproducente una comunicazione informale, ci & sembrato
opportune integrarlo con brevi note esplicative e informazio
ni bibliografiche. La traduzione & dovuta a Adriana Belletet
e Luigi Rizzi. Le note sono di Imigi Rizzi.
1 EB! opportuno precisare che 1'impossibilita di portare a ter-
mine esperimenti per ragioni "etiche" riguarda il controllo
di ipotesi formulate a livello di grammatica universale, men
tre il problema ovviamente non si pone per le ipotesi form-
late a livello di grammatiche parvicolari. A questo secondo
livello, la verifica sperimentale delle ipotesi @ semplice-
mente costituita dall'ottenimento dei giudizi di granmatica-
1itQ del parlante (nel senso che il linguista! osserva un cer
to fatto "in natura" in una certa lingua, costruisce una ipo
tesi formale per renderne conto, registra le predizioni fat-
te dalla sua ipotesi al di 18 del fatto osservato in parten-
za, e infine verifica queste predizioni chiedendo al parlan-
te il suo giudizio di grammaticalit€ - o l'esplicazione di al
ere sue intuizioni linguistiche - sui fatti predetti). Al con
trario, il problema @ molto pit complesso per la verifica spe
rimentale delle ipotesi a livello di grammatica umiversale ,
verifica che, nell'impostazione chomskiana, richiederebbe ne
cessariamente una manipolazione delle condizioni di apprendi
mento. Per es., il controllo di una ipotesi di universale lin
guistico (mettiamo il principio di soggiacenza, di cui Chom
sky patla pil avanti) potrebbe essere effettuato sperimental
mente sottoponendo a bambini che apprendono una lingua dei da
ti che violino sistematicamente questo universale (pil preci
samente, dei dati la cui grammatica ottimale violi sistemati
camente questo universale), e controllando se il processo di
apprendimento ne risulta significativamente rallentato.
> per ovvie ragioni etiche, un simile esperimento non @at
tuabile.
2 Riferimenti bibliografici essenziali sulla teoria X sono Chom
sky (1970) e Jackendoff (1977): i1 primo 8 L'articolo in cui
questa teoria & stata proposta, il secondo 8, al tempo stes-
so, un buon mamuale introduttivo ed il primo tentativo di e-
laborazione sistematica della teoria.
3 Chomsky (1955) (1957).
= Sulla nozione di complementatore (COMP) si veda Bresnan (1970).
28
5 Cid vuol dire che, senel seguente schema sia A sia B sono catego-
rie vincolanti, un elemento X contenuto in A pud essere spo~
stato entro A, oppure, fuori di A ma entro 3, ma non pud es-
sere spostato direttamente fuori di B:
B
Lo™
La~
tL
«x —|
6 11 simbolo "t" dell'esempio (11) @ la "traccia" rimasta nel-
la posizione basica di what books dopo che questo sintagm=
stato spostato dal Movimento di WH. La traccia di un sin -.-
ma 8 semplicemente la categoria che domina quel sintagma ju i-
ma del movimento, e che rimane vucta dopo il movimento. Se,
come in (11), il sintagma spostato & un SN, allora il simbo-
lo "t" 8 una abbreviazione per il sintagma nominale vuoto
Igyz el Cin cui ¢ 8 L'elemento di identita rispetto alla con-
catenazione, e 2 @ 1'indice referenziale del SN spostato).La
teoria della traccia, introdotta in Chomsky (1973), @ stata
ampiamente sviluppata in Chomsky (1975), (1976), Fie
(1974), (1977), ed & attualmente uno dei capisaldi dvl.a teo
ria standard estesa. ~
7 Cio8, nella frase subordinata che dipende da questo verbo.$i
noti che la traduzione italiana di (18) @ accettabile, ché il
verbo italiano dire, contrariamente all'inglese to ,/, am-
metté una interrogativa indiretta,
® Questa analisi é sviluppata nei dettagli in Chomsky (1977).
Per un diverso punto di vista sulla questione si veda Bres-
nan (1975), (1976).
° sulla restrizione della testa si vedano Fiengo (1974),
Riemsdijk (1978). Sui principi di opacita si veda Chomsky
(g78).
29
BIBLIOGRAFIA
Akmajian, A. (1975), "More Evidence for the NP Cycle", — Lingut.
etic Inquiry, 6. 115-129.
Bresnan, J. (1970), "On Gomplementizers: towards a Syntactic
Theory of Complement Types", Foundations of Language, 6.
297-321.
Bresnan, J. (1975), "Comparative Deletion and Constraints on
Transformations", Linguistic Analysts, 1. 25-74.
Bresnan, J. (1976), "Evidence for a Theory of Unbounded Tran —
sformations", Lingutstie Analysts, 2. 353-394.
Chomsky, N, (1955), The Logteal structure of Linguistic Theory,
Pubblicato nel 1975 dalla Plenum Press, New York.
Chomsky, N. (1957), Syntactic Structures, The Hague.
Chomsky, N. (1970), "Remarks on Nomi
alization", in Jacobs-Ro —
senbaum eds., Readings in Dig'ish Transformational Grarmar,
Waltham, Mass. pp. 184-2
1, (trad. it., Torino, 1970).
Chomsky, N. (1973), "Conditions on Transformations", in Ander —
son-Kiparsky eds., A Festechrift for Morris Halle,New York,
pp. 232-286.
Chomsky, N. (1975), Reflections on Language, New York.
Chomsky, N. (1976), "Conditions on Rules of Grammar",
Analysis, 2. 303-551.
inguistic
Chomsky, N. (1977), "On Wh-movement", in Culicover-Wasow-Akma —
jian eds. Formal Syntax, New York, pp. 71-132.
Chomsky, N. (1978), "On Binding", ciclostilato M.I.T.
Fiengo, R. (1974), Semantie Conditions on Surface Structure, te-
si di dettorato non pubblicata, M.I.T.
Fienzo, R. (1977), "On Trace Theory", Linguistic Inquiry, 8.
35-63.
Jackendoff, R. (1977), X-bar Syntax: a Study of Phrase Structu-
30
ve, Linguistic Inquiry Monograph No. 2, Cambridge, Mass.
Koster, J. (in preparazione), "Conditions, Empty Nodes, and Mar
kedness", Universita di Amsterdam.
Peters, S. e Ritchie, R. (1973), "On the Generative Power of
Transformational Grammars", Information Seteres, 649-83.
Riemsdijk, H.van (1978), A Case Study in Syntacti. invkedness,
Lisse.
Ross, J.R. (1967), Constraints on Variables in Syntax, tesi di
dottorato non pubblicata, M.I.T.
Wexler, K. e Culicover, P.W. (1977), "Some Syntactic Implica~
tions of a Theory of Language Learnability", in Culicover-
Wasow-Aknajian eds. Formal Syntar, New York, pp. 7-61.
LA SINTASSI DEI PRONOMI RELATIVI CUZ E QUALE
NELL' ITALIANO MODERNO*
Guglielmo Cinque
Universita di Venezia , Universita di Padova
Se as
vaiamo momentaneamente, per ragioni che .appariranno
chiare tra breve, da quello che le grammatiche tradizionali con
cordano generalmente nel classificare come pronome relativo,cio® il
che di la ragazza che ha chiamato, nell'italiano standard con-
temporaneo & possibile isolare essenzialmente due tipi di 'pro-
nomi! relativi: il tipo eui e il tipo quale, nei paradigmi qua~
si sistematici di cui, a cui, per cut, ecc.,,del quale ( della
quale, ecc.), al quale, per 2 quale, ecc.
La sintassi dei due paradigmi, a cui limiteremo qui stret~
tameate la nostra attenzione, si presenta anche ad una prima
nalisi come contraddistinta da una duplice spaccatura di pro-
priet@ tra loro coerenti. La prima oppone l'uso restrittivo dei
costrutti relativi con cut e quale, presi assieme, all'uso appo
sitivo (o non restrittivo) degli stessi. La seconda, che si so-
vrappone e si incrocia alla prima, oppone il paradigma quale al
paradigma cuz per una variet& di comportamenti sintattici diver
genti ben noti.
Il quadro teorico di riferimento in cui si situa questa pri
ma ipotesi sistematrice della vasta fenomenologia dei costrutti
stesa
relativi dell'italiano & quello della Teoria Standard
(TSE), come emerge in particolare da alcuni lavori recenti di
Chomsky (1970, 1973, 1976, 1977a,b, 1978) e di molti altri auto
eee eee eee
32
La supposizione iniziale, che, procedendo, prendera sempre
pid consistenza @ che un'analisi unica e omogenea & insufficien
te a render conto della complessita dei comportamenti sintatti-
ci dei due paradigmi pronominali. In quanto segue illustreremo
le ragioni che ci portano a sostituirla con un'ipotesi in qual-
che misura pid articolata.
La trattazione si sviluppera con la seguente successione .
Nel par. 1, verranno esaminati assieme i costrutti relativi re-
strittivi tanto col paradigma cut che col paradigma quale, i qua
li manifestano, in generale, per quest'uso, un comportamento per
fettamente parallelo. Per essi sosterremo la sostanziale adegua
tezza dell'analisi classica (Chomsky 1955, 1965) per le costru~
zioni relative dell'inglese, indicando come 1'interpretazione o
riginaria delle regole come "dipendenti dalla struttura” (struc
ture deper st) riceva una interessante conferma dai fatti nuo~
vi dell'italiano.
Nel par. 2, la stessa analisi sara estesa a coprire 1'uso
appositivo del paradigma cui e di quella parte del paradigma qua
le che manifesta proprieta a quest'ultimo, strettamente corri-
spondenti. Si suggerira, in via sperimentale, una modifica mini
ma all'ipotesi adottata al par. 1, correlandola alle interpreta~
zioni restrittiva e appositiva del costrutto relativo per ren-
der conto di alcune proprieta differenziali dei due us
Nel par. 3, infine, verra prospettata e difesa un'analisi
pit articolata nei termini del quadro recente di "On binding”
(Chomsky 1978) per l'intero campo deile costruzioni relative con
cui e quale, che incorpori le generalizzazioni illustrate nei
par. 1 e 2 e che sia in grado di render conto delle importanti
differenze sintattiche che dividono il paradigma quale dal pa-
radigma cud. In particolare, si sosterra che un numero signifi-
cativamente ampio di proprieta dei due paradizn1 discende in mo,
do diretto dagli assunti generali della versione piii recente del
33
la TSE in congiunzione con due ipotesi particolari sulla sintas
si dell'italiano, cioé, 1) che la struttura interna del costrut
to relativo @ essenzialmente di due tipi (uno ordinario,[ su SNF,
e uno 'parentetico', SN, F,...), e 2) che il pronome eut, nei
si ordinari, @ solo ‘un elemento anaforico (anaphor) mentre (art
+)qual-@ analizzabile sia come elemento lessicale che come ele-
mento anaforico (nel senso tecnico di Chomsky (1978)).
L. IL costrutio relative restrttttvo con cui e quale
Come gid anticipato, in quanto segue, mostreremo come 1'i-
N relativizzato
potesi classica, in termini di spostamento del s
dalla posizione ordinaria che il SN occupa nella corrispondente
frase dichiarativa, sia sostanzialmente corretta per la deriva
zione delle frasi relative restrittive con e con quale.
cata e raffinata
Prenderemo le mosse dalla versione modi
dell'ipotesi classica che si ritrova in Kayne (1976) e che @ fc
data su dei fatti del francese sigmificativamente simili all'i
taliano.
Richiamerd qui solo le linee essenziali dell'analisi di
Kayne, per il resto considerandola nota.
Coinvolte nella derivazione delle frasi relative sono:
(a) una regola di wh-movement! in virta della quale il sin
tagma contenente il tratto dj relativizzazione wh viene sposta-
to nella posizione del complementatore (comp)? 1asciando una
tracciaa indicare la posizione da cui si @ mosso (Chomsky 1973,
1975, 1977a).
(b) una regola di cancellazione (obbligatoria), in COMP ,
del sintagma contenente il tratto di relativizzazione wh, sotto
le usuali condizioni imposte dal principio generale della ‘recu
perabilita';secondo cui, nella fattispecie, il sintagma cancella
to deve essere non distinto (nel senso tecnico della teoria dei
tratti di Chomsky (1965, pp-177-182)) dal sintagma 'testa' del~
34
la relativa. Una formulazione di tale regola come in
(1) (cfr. Kayne (1976,p. 83)) Coy fu C coup s -wH] X]}-——+ 19 34
34
assicura precisamente gli stessi effetti, in quanto esclude la
presenza di qualunque altro materiale lessicale alla sinistra
del SN relativizzato in COMP?, Si veda Kayne (1976 pp. 82-88)
per maggiori dettagli sullo 'spirito' di tale formulazione. La
chiameremo qui, seguendo Kayne, Cancellazione di §N relativo (Cam
sNerel).
(c) una regola, ordinata dopo Can-SN-rel, che cancella, in
COMP, il morfema che se in COMP & presente del materiale lessi
cale non nullo alla sinistra di che. Approssimativamente:
( coyp X che] —* 1 @ (dove X @ non nullo), che chiameremo Can-
cellazioné 4i che (Can-che)*.
L'ultimo assunto che @ opportuno ricordare riguarda la dif
ferenza strutturale specifica tra il tipo pronominale cut e il
tipo quale che finora non abbiamo differenziato, considerandoli
semplicemente la realizzazione tarda di uno stesso tratto di re
lativizzazione wk su di un SN (cfr. nota 5). Supporré, come gid
3 cfr. anche Kayne (1977, p.
prospettato in Kayne (1976, nota
29)), che i due tipi di pronomi differiscono semplicemente per
la posizione cui, all'interno del SN relativizzato, viene ad at
taccarsi il tratto wh. In particolare, supporré che qual- e(2)
sia la realizzazione morfologica di wh in posizione di ‘specifi
t
Ags
e eventuali 'complementi!
catore!(aggettivale) din ((.. art [ wh][]1]= per questa
SN
notazione cfr. Chomsky 1970) dove N
di N devono essere vuoti nella base®. (cfr.Kayne(1977,p.29)).
Supporré invece, che il tipo cut origini come realizzazio~
ne del tratto wh attaccato all'interno del SN nella stessa posi
zione in cui vengono a trovarsi i pronomi della serie tonica
lut, let, loro, ecc. (e forse di quella atona), nella base.
35
Da questo complesso di assunti discendono immediatamente al
cune importanti proprieta delle costruzioni relative restritti-
ve con cut e quale. Ad esempio, @ possibile spiegare unanota ir
regolarita dei due paradigmi nella costruzione restrittiva:cio&
il €atto che se il SN relativizzato & o il soggetto o 1'ogget-
to diretto della frase relativa, né cut né (art+) qual~ possono
comparire ma si trova solo che (cfr. per es. Devoto-Massaro
(1960 p. 162)). e che,se vengono relativizzati SN 'obliqui' pre~
ceduti da una preposizione, che 2 ordinariamente escluso. Si ve-
dat
che = e 3
(2) a. La proposta (47 quale! @ stata fatta & assurda
‘ che .
b. Tl vestito (47) aye! hal comprato non ti sta bene
alla quale
he } ti sei affidato non @ onestissima
c. La persona {
del quale
sche } mi voleva parlare era alquanto
delicato
con la quale
*che
d. L'argomento {
e. L'unica persona {; } devi litigare @ lui
(3) a. La proposta ey &@ stata fatta @ assurda
3
che
b. I vestito (¢h°.} hai comprato non ti sta bene
m
a cul) 4; soi afta = :
c. La persona (2°07) ti sei affidato non @ onestissima
di cui
4. L'argomento (52°
} mi voleva parlare era alquanto
delicato
con cui
Sche } devi Litigare @ lui
e. L'unica persona {
Questa distribuzione dei pronomi cut e quale (e la distri~
buzione complementare di che) discende dalla formulazione di
Can-SN-rel, che @ applicabile, in COMP, solo a SN non precedu-
ti da preposizione , e da Can-che, Sar opportuno illustrare 1"
36
operato di queste regole e di quella del wh-movement per mezzo
di due derivazioni esemplificative che per comodita daremo nei
soli dettagli qui pertinenti.
Ad esempio, 1a (2b) e la (3b) avranno la seguente derivazio
ne, da una struttura sottostante come:
(4) [gy 41 vestito
Fl comp che"IE p hai couprato [ oy wif ]1]
non ti sta bene] wh-movement —» [ ..
su il vestito [
U comp
[
SN wh] chej[, hai comprato t]]]...
Can-SN-rel (applicabile) —> [sn il vestito [ che]
OME
[
hai comprato t]I]...
Can-che (inapplicabile) —r (2b) 0 (3b) a seconda di dove
sia attaccato il tratto wh all'interno del SN, lungo le linee di
quanto appena detto.
Le frasi (2d) e (34) avranno la seguente derivazione:
l'argomento [= [ che][, mi voleva parlare [ 5, di
SN F coMP sP
Ugg VAITINI--.
uiemovement —> [ox Largomento Lz logy Ugp di L gy All
che] , mi voleva parlare t]]]...
Can~SN-rel (inapplicabile; cfr. (1))
Cc.
n~che (applicabile) —> Toy L'argomento [ [di wh)]
¥ com
[, ni voleva parlare t]]]....+ (24) 0 (3d) a seconda di do
ve sia attaccato il tratto wk, come sopra.
Nella derivazione di (2b)-(3b) la struttura derivata trami-
te il wh-movement soddisfa la descrizione strutturale di Can ~
SN-rei in quanto, in COMP, c'é un SN non preceduto da altro ma~
37
teriale. La cancellazione di tale SN non viola il principic ge-
nerale della recuperabilita data la sua 'non distinzione' dal
SN *testa' del costrutto relativo. Una successiva applicazione
di Can-che @ resa inoperante dall'inesistenza di altro materiale,
in COMP, alla sinistra di che.
Se confrontiamo, invece, la derivazione di (24)-(3d), non sa
ra difficile rilevare che l'applicazione di Can-SN-rel non pud
aver luogo per la presenza di una P alla sinistra del SN, in
COMP, la quale non @ contemplata nella formulazione della rego~
la (1), La mancata eliminazione del sintagma relativiazato in
COMP fa invece scattare la regola,ordinata successivamente, di
Can-che che in questo quadro pia conservativo andra stipulata
come obbligatoria (v. nota 4).
Come gid detto, 1'ipotesi astratta appena illustrata viene
in ultima analisi a sostenere che il che relative di frasi come
(2) e (3) altro non @ che il che,congiunzione o complementatore,
di frase subordinata; non quindi un pronome relativo, in qual-
che modo concorrente di quale soggetto © oggetto®. se fosse dav
vero un pronome, avremmo ad esempio qualche ragione di attender
ci che potesse occorrere in forme come I Rossi, avendo visto
che..., accando a I Rosst,avendo visto ¢ quali... parallelamen-
te a I Rossi, che... accante a I Rossi, i quali... . L'impossi-
bilita della prima di queste forme discende invece automatica —
mente dal complesse di ipotesi sopra delineato implicante che
il che relativo sia sole il che complementatore, il quale 'af-
fiora', per cosi dire, solo nella circostanza in cui il pronome
relativo vero e proprio sia stato indipendentemente cancellato.
I Rosst, avendo visto che..., nella supposizione che tutto il
sintagma in posizione iniziale (della frase relativa) sia in
COMP avrebbe una struttura intermedia, dopo il wh-movement, del
tipo ai
yy E Rossi [yf avendo visto [ 4 wh} che ]...]]...
Ug ¥F * coMP
38
cui Can-SN-rel non pud applicarsi, per cancellare il solo
[oy Wi]. Torneremo pid avanti su strutture di questo genere al-
l'interno di un'analisi parzialmente diversa, capace comunque di
escludere in modo motivato sequenze come I Rossi, avendo visto
che
.tipotesi vista, come osserva Kayne (1976), da esplicito
conto della sostanziale complementarita dei pronomi relativi e
di che. Pia precisamente permette di esprimere in modo signifi-
cativo una proprieté certamente non casuale dell'italiano: cioé
che esiste un'unica eccezione sistematica alla altrimenti pres-
soché tassativa presenza di un complementatore all'inizio di o-
gni frase subordinata di modo finito in italiano. E questa rap
i subordinate relative introdotte
presentata appunto dalle fra:
dai pronomi della serie cut e quale®. Questa ipotesi 1a esprime
nel modo che abbiamo illustrato. Per altre considerazioni a so-
stegno di questa analisi e altre sue conseguenze rimando nuove-
mente all'articolo di Kayne citato.
In termini un pd diversi, la correlazione interessante mes
sa in luce da questa analisi @, quindi, che la frase relativa sa
ra introdotta da che (complementatore), con un ‘buco’ nella po-
sizione che il sintagma relativizzato avrebbe occupato nella cor
rispondente frase dichiarativa, solo se il sintagma relativieca
to non @ preceduto, dopo lo spostamento in COMP, da una preposi
zione (o da altro materiale lessicale).
Siccome in italiano standard soggetti e complementi ogget-
ti diretti non sono mai preceduti da preposizione, ne segue che
le frasi relative (restrittive) in cui @ relativizzato un sog-
getto o un oggetto diretto saranno sempre introdotte da che
1.1 L'italiano, a cui abbiamo esteso qui l'ipotesi di Kay-
ne elaborata sui fatti del francese moderno, sembra offrire una
conferma ancora pid sorprendente di tale ipotesi in quanto mo-
39
stra fenomeni sufficientemente ben delimitati e chiari peri qua
1i L'ipotesi pud essere estesa a fare predizioni non banali.
stere al—
L'ovvia previsione generale & che se dovessero es
tre classi di 'complementi nominali' (oltre ai soggetti e agli
oggetti) che possono occorrere non preceduti da preposizione,la
frase relativa costruita 'relativizzando su' tali complementi do
vrebbe essere necessarianente introdotta dal complementatore chg
data la supposta obbligatorieta di Can-sN-rel.
In italiano esistono per l'appunto due classi di complemen
ti che, in un caso, devono, nell'altro, possono essere non prece
duti da preposizione, e cio’ i SN predicativi (post copulari) e
alcuni complementi-(avverbiali) temporali. L'attesa @, come det
to, che le relative (restrittive) costruite su tali complemen-
ti risulteranno invariabilmente introdotte da che.
In entrambi i casi questo si dimostra vero, in accordo con
l'ipotesi generale, anche se i fatti necessitano in qualche ca-
so di essere conmentati pid puntualmente.
Se nella struttura di base corrispondente a
(6) Pretendeva di essere un attore d'avanguardia
relativizziamo il SN predicativo (art)attore d'avanguardia la
frase relativa risultante sara:
(7) Non era L'attore d'avanguardia che pretendeva di essere
La presenza del che in apertura di frase (relativa), del re
sto ltunica possibilita, appare completamente motivata se suppo
niamo una derivazione in tutto parallela a quella vista per ica
si soggetto e oggetto, in accordo con 1'ipotesi generale:
(8) Non era [g, L'attore d'avanguardia [= [ goyp chell , preten-
deva d'essere [ 4 wh]]]}wh-movement + Non era [ 4 Ltatto~
sl
40.
re d'avanguardia [= l comp Cgy wil che]l , pretendeva d'esse
re t]]]—* Can-SN-rel —» Non era [ gy l'attore d'avanguar~
dia [
coup 9 chell , pretendeva’d'essere t]]
: : 10
(Can-che inapplicabile) —> (7).
Il caso dei complementi (avverbiali) temporali mostra una
situazione pili sfaccettata ma dei due & anche quello che permet
te di controllare la giustezza delle previsioni in modo p:
cisivo.
In italiano sono forme altrettanto possibili gli esempi
aeb di
(9) a. L'ho visto il giorno di Natale
b. L'ho visto nel giorno di Natale
(10) a. Tl mese scorso sono stato a Vienna
b, Nel mese scorso sono stato a Vienna
(11) a. Mi prendo le ferie la settimana di Pasqua
b. Mi prendo le ferie nella settimana di Pasqua
In certi casi il significato preciso dell'espressione pud
variare a seconda che sia presente o meno la preposizione. Ad
esempio la gamma di situazioni compatibili con (11b) @ legyer-
mente diversa da quella ammessa da (lla). Differenze di questo
tipo non sono per il momento pertinenti. Pid avanti, tuttavia
le vedremo interagire in modo interessante con 1'ipotesi genera
le che stiamo discutendo.
Cid che ora conta sottolineare 8 la previsione che L'ipote
si generale trae dal fatto che certi avverbiali di tempo posso-
no occorrere senza preposizioni (forse come SN isolati)
Data la possibilita di una pro-forma wh corrispondente eda
ti il wh-movement e la regola obbligatoria di Can~SN-rel si pre
vede che una frase relativa costruita relativizzando su tali av-
41
verbiali possa essere introdotta da che (in effetti, debba, nel
da derivazione in cui 1'avverbiale non @ preceduto da preposi-
zione). Questa previsione & confermata:
(12) IL giorna che i"ho visto non aveva un bell'aspetto
(13) Il mese che sono stato a.Vienna ha fatto brutto tempo
(14) La settimana che mi prendo le ferie & 1a prossima
Bisogna aver cura di notare che forme come (12)-(14) non
hanno nessuna connotazione colloquiale o substandard, al contra
A 1
rio di forme come:
(15) a. 211 posto che siamo andati ieri era affollato
b. ZLa ragazza che eri assieme non la conosco
c. ZCi sono cose che non puoi far senza
in cui i sintogmi relativizzati non sono complementi temporali.
In effetti questa asimmetria tra complementi temporali
tutti gli altri - a prima vista tanto pia sorprendente nel caso
degli avverbiali temporali e di quelli spaziali, che per il re-
sto appaiono avere comportamenti paralleli - discende natural-
mente dall'ipotesi generale qui adottata, La proprieta che di-~
stingue i temporali (oltre che i soggetti, gli oggetti e i SW
predicativi) da tutti gli altri ‘complementi', e che -rende i
primi ma non i secondi eleggibili ad una relativizzazione per
mezzo del complementatore che, @ 1a loro possibilita di occorre
re senza preposizione: una genéralizzazione non casuale della
grammatica dell'italiano che l'ipotesi qui adottata permette
di esprimere.
In quest'analisi, infatti, una frase come (12) avra la de~
rivazione schematica seguente:
il giorno [5 [ goyp Chel, L'ho visto [., wall].
SN
42
—> wi-movenent —> I gy il giorno [pL goyp U gy val che]
L'ho visto t]]]...—+ Can-sN-rel —* [ gy il giorno
| come @ che|[, l'ho visto t]]]
La differenza in colloquialita tra le frasi (12)-(14) e le
frasi di (15) @ ricondotta in questo quadro a un sistema par~
zialmente diverso di condizioni governanti le regole sintatti-
che coinvolte nella derivazione di tali frasi. Per le prime 1"
insieme di principi e condizioni che discuteremo al par. 3; per
le seconde, che qui non discuteremo,un insieme di condizioni for
se minimalmente diverse.
c' forse modo di stringere e precisare ancor di pili 1’ef-
fetto della previsione generale fatta dall'ipotesi qui assunta.
Dall'ulteriore constatazione che tra gli avverbiali temporali
oltre a quelli che possono occorrere con o senza preposizione
gia visti, ue esistono altri che non possono mat occorrere sen-
za preposizione e altri ancora che, al contrario, non océor~
rono mat con una preposizione, possiamo trarre due ulteriori pre
visioni suscettibili di controllo preciso: dobbiamo attenderci,
cio8, che dei due nuovi gruppi, al primo non corrispondano mai
relative introdotte da che e al secondo cortispondano sempre re
lative introdotte da che. Queste conclusioni sono forzate dall'
ipotesi che abbiamo assunto. A ben guardare sono un caso parti:
colare della predizione generale vista sopra.
Volendo considerare anche il caso di avverbiali con prepo-
sizione facoltativa, si hanno, ricapitolando, i tre casi distin
. 12
ti seguenti“:
(16) a. In quell'amno, si verificd una forte inflazione
b. Quell'anno, si verificd una forte inflazione
(17) a. In quelle circostanze, chi ti poteva aiutare?
>. *Quelle circostanze, chi ti poteva aiutare?
43
(18) a. *In ogni volta, mi chiede di restare a cena
b. Ogni volta, mi chiede di restare a cena
Facendo la naturale ipotesi che le stesse restrizioni che
valgono per un avverbiale lessicale (compatibilita, obbligato-
rietA o incompatibilita con una certa preposizione) valgono per
il corrispondente sintagma pronominale relativo, in base all'i-
potesi generale dobbiamo attenderci che a (16) possa corrispon~
dere tanto una relativa, con che (cfr. (19b)) che una relativa
con la serie cut.o quate (cfr. (19a)); inoltre, che a (17) non
possa in nessun caso corrispondere una relativa con che (cfr.
(20a));ma solo una con la serie cut o quale (cfr. (20a));e, in
fine, che a (18) non possa corrispondere una relativa con la se
rie eut o quale ma solo una relativa con che (cfr. (21)). Que-
sto @ quanto troviamo:
in cui
(19) a. Ltanne (oy quate
} potrd andare in vacanza, mi riterrd
felice
b. L'anno che riuscird io ad andare in montagna, tu non ci
sarail3
in cui
nelle quali
} nessuno ti da
una mano
una di quelle circostanze {
b. *?E"unadi quelle circostanze che nessuno ti d& una ma~
14
no
nella quale.
(21) a. 220gni volta (26 3 } mi chiede di restare gli de~
in cui
vo dire di nol?
b. Ogni volta che mi chiede di restare gli devo dire di no
1.2 Lo stesso complesso di ipotesi che permette una spiega
zione per i fatti di ordine sintattico appena visti, da diretta
mente modo di render conto di contrasti semantici sottili, ma,
credo, reali, tra coppie di frasi come (22) a e b:
gmella quale
a } mi son preso le ferie,tu
in cui
(22) a. Per la settimana
44
avevi gid finito il tuo lavoro
b. Per la settimana che mi son preso le ferie, tu avevi gia
finito il tuo lavoro
La maggior parte dei parlanti @ concorde nell'assegnare a
(22a) l'interpretazione univoca secondo cui il periodo di ferie
deve cadere completamente entro i due termini della settimana ;
mentre avverte che (22b) @ compatibile con due situazioni diver
se. La prima @ identica all'unica di (22a); per la seconda, le
ferie devono cominciare nella settimana menzionata, ma non sono
necessariamente comprese entro il secondo termine della settima
na.
E' interessante notare, ora, che per gli stessi parlanti
che riconoscono esplicitamente questa differenza, c'® un contra
sto parallelo di interpretazione nella coppia seguente:
(23) a. Mi sono preso le ferie nella settimana di Pasqua
b. Mi son preso le ferie la settimana di Pasqua
La simmetria di interpretazione tra (22a) e (23a) e (22b)
e (23d) discende automaticamenté dall'ipotesi proposta. In que-
sto quadro, infatti, la condizione perché la relativa possa es~
sere introdotta da che come in (22b) & che 1'awverbiale relati-~
vizzato non sia preceduto da preposizione. Quindi, se differen-
za c'é tra il caso con preposizione e quello senza, questa
deve essere necessariamente rispecchiata, nelle relative, dal
caso con preposizione pit pronome relativo e dal caso con il so,
lo che, rispetti
ente. I fatti ancora una volta confermano que
ste previsioni.
1.3 C'2 un possibile problema dell'analisi generale fin qui
difesa che merita forse di essere discusso. Esso riguarda lo sta
tus del pronome ‘dativo' ewt)® usato inalternativa (forse stili-
sticamente piti elevata) a a cut come nelle frasi sexu
(24) a. La persona cui compete questa decisione sei tu
b. La risoluzione cui pensavemo di averli costretti si ri-
veld in realt@ controproducente
Data la convenzione generale sulla obbligatorieta della can
cellazione di materiale lessicale in COMP (almeno per lingue co
me l'italiano), sotto L'usuale principio della recuperabilita ,
menzionata alla nota 4,(v.Chomsky 1978e, sotto,la sez. 3), e da
to il pid che plausibile status di SN. (non preceduto da preposi
zione) per cut in (24), l'ipotesi generale, senza 1'intervento
di altre ipotesi, prevederebbe l'agrammaticalita di (24a-b): e
per converso la graumaticalita di
25) a. *La persona che compete questa decisione sei tu
P IP q
b. *La risoluzione che pensavamo di averli costretti si ri
veld in realta controproducente
ta ee oe
in evidente contrasto con i dati'’,
Si noti che l'effettiva presenzd, sufficiente ad assicura-
re la richiesta non identita tra testa e sintagma relativizzato,
della preposizione a, in COMP, soggetta a una cancellazione mol
to tarda, 8 difficilmente conciliabile con lo spirito della con
venzione generale di cancellazione in COMP qui sotto adottata
(cfr. la sez. 3,-sotto).
Inoltre, anche adottando l'analisi dei clitici dativi come
pro-SW piuttosto che pro-SP (avanzata in Kayne (1977, p. 26)per
i corrispondenti clitici francesi), che se corretta richiede la
postulazione di una regola di cancellazione, sul posto, della
preposizione a 'sospesa', restano delle difficolta. Non @ possi,
bile, infatti, éstendere in modo naturale al problema qui in og
getto la descrizione strutturale di quest'ultima regola, che per
46
L'italiano, dovrebbe essere grossomodo formulata come [.., @ XI>
» @ (dove X & nullo) per evitare la cancellazione di a in frasi
come: Vi sand capitate [., a tutti] di fare wt incidente’® La
condizione tra parentesi dovrebbe essere sospesa per permettere
la caduta di a in Usp a cui], in COMP.
Anche se accomodabile, una soluzione del genere non sembra
comunque, il modo pid corretto per chiamare in causa la nozione
di recuperabilita, se solo consideriamo il fatto che cut (isola
to) era in grado, in fasi pid antiche deli'italiano, di relati-
vizzare anche SN oggetti diretti (v. ad esempio, Noordhof (1937
pp. 17-20), Rohlfs (1968, p. 192)).
In questo secondo caso (problematico per le stesse ragioni
per cui lo @ il cut dativo) non potremmo, tuttavia, sperare di ri
portare la mancata cancellazione di cud a una violazione della
recuperabili
che metta in gioco la presenza di una preposizio
ne in uno stadio pil astratto della derivazione. Eppure @ ragio
nevole pensare che i due casi siano esscnzialmente della stessa
tura.
Tutto cid ci induce a ricercare la soluzione del problema
in una direzione diversa. Esistono alcune risoluzioni alternati
ve.
Supponiamo, ad esempio, la sostanziale correttezza dell'i-~
potesi appena menzionata di Kayne (1977) per L’origine differen
giata dei (di alcuni) clitici accusativi/dativi e di quelli lo-
cativi/partitivi. 1 primi sarebbero dei pro~SN!% ei secondi dei
pro-SP. Gli argomenti addotti da Kayne per questa analisi sono
tutti trasferibili all'italiano (v. op. cit. pp. 106-108) e por
tano un qualche convineimento. Supponiamo inoltre una regola di
cancellazione di a simile a quella menzionata sopra.
Se ipotizziamo, ora, che il tratto di caso (contrariamente,
forse, a quanto supposto in Chomsky (1965, p. 181) conti per la
(non-) distingione tra due $N, e solo nel caso che esso abbia u
47
ma realizzazione morfologica (comunque questa condizione sia da
esprimere formalmente) si apre la possibilita di ottenere la dit
stinzione richiesta”’, ai SN soggetti ¢ oggetti relativizzati
verra assegnato il caso nominativo e accusativo, rispettivamen-
te, (v. Chomsky (1978)). Ma quest'ultimi, in quanto, supponiamo,
non ricevono una realizzazione morfologica nei due paradigmi pro
nominali, non conteranno per la (non-) distinzione, non portan-
do cosi ad una violazione della recuperabilita.
Ai SN governati da una preposizione (anche nel caso di a.
quindi) sar& assegnato il caso obliquo che, in tanto in quanto
realizzato, supponiamo, morfologicamente nel solo paradigma cut,
rendera quest'ultimo, anche quando isolato (per L'avvenuta can-
cellazione di a} cfr. nota 24), distinto dal SN testa e percid
. ee eae ;
non cancellabile salva recuperabilitate’. Questa stessa ipotesi
& direttamente estendibile al caso di SN v
ett diretti relati
vizzati con cut delltitaliano antico (e letterario fino al XIX
secolo), se interpretiamo questa situazione come il riflesso di
un sistema casuale arcaico distinguente un caso 'retto’ (nomina
tivo) e un caso’ régime’ (obliquo), per adottare la terminologia
tradizionale impiegata dai grammatici per descrivere il sistema
casuale del proto-romanzo’*. Si noti che cud non si trova mai
joordhof “1937
attestato, in italiano antico, per SN soggetti (v.
p- 15, Rohlfs 1968, p. 192)°3,
E' indubbio che la proposta qui avanzata per una soluzione
del problema del cui 'dativo' necessiti diun vaglio ben pid este
so e approfondito di quello che abbiamo potuto qui intraprende-
re”4, La terreno in via provvisoria. Altre solucioni possibili
a nostra conoscenza ci sembrano se non altro inizialmente meno
plausibili.
1.4 Prima di esténdere il nostro esame alle costruzioni re
lative appositive,non sara forse inutile soffermarsi brevemente su
48
un! implicazione che L'ipotesi qui difesa ha per questioni di ca
rattere teorico pit generale.
Se questa ipotesi, o una sua versione pid raffinata, doves
se dimostrarsi corretta, essa sarebbe di diretta pertinenza al-
la disputa o divergenza recente sulla natura delle r jle gram-
maticali (sintattiche): se esse (0 almeno alcune di esse) debba
no essere formulate in termini di funztont grarmaticalt come sog
getto, oggetto diretto, ece., 0 siano comunque sensibili a tali
funzioni (posizione tenuta dai sostenitori di quella teoria (0
teorie) che va sotto il nome di Grammatica Relazionale); oppure
se esse debbano essere esclusivamente formulate in termini di ca
tcuorze sintattiche e di struttura sintagmatica in cui queste en
trano (structure dependence) e siano comunque insensibili a in-
formazioni funzionali (1a posizione espressa dalla teoria tra~
sformazionale fin dai suoi primordi ~ Chomsky 1955).
In termini molto generali, appare chiaro che i fatti fino-
ra illustrati riguardo la formazione delle frasi relative (re~
strittive) in italiano standard portano diretta conferma, a par
tire dall'ipotesi originaria di Kayne, alla natura puramente !di
pendente dalla struttura’ della classe di regole che sono inte~
ressate nella derivazione di tali strutture (wh-movement, can-
cellazioni, ecc.).
Sulla base di considerazioni diverse da quella meramente
strutturale (presenza 0 assenza di preposizione, condizionante
una regola come Can-SN-rel) non ci sarebbe alcuna ragione di at,
tendersi che, in italiano, solo le frasi relative costruite re-
lativizzando o an soy:etto o un oggetto diretto o un SN predica
tivo o un ‘avverbiale temporale' possano essere introdotte da
che diversamente da tutti gli altri casi. In particolare, che
propriet& avrebbero in comune gli avverbiali temporali, i sog-
getti, gli eszecti e i SN predicativi che non fosse anche comu-
ne agli avverbiali spaziali, ad esempio? E' difficile trovare u
49
na risposta adeguata se non nel fatto che i primi sono gli uni-
ci ‘complementi' nominali in italiano che possono (o devono) oc
correre senza preposizione.
Se questi fatti non permettono di sostenere conclusivamen—
te 1'ipotesi pid forte (e pid interessante) che tutte le regole
sintattiche sono ‘dipendenti dalla struttura’, e cosi di mette-
re in questione la teoria classica della grammatica relazionale
(come alcune proposte recenti di J. Bresnan), essi si dimostra-
no pertinenti per valutare una recente variante della grammati-
ca relazionale, 1a quale ha avanzato la proposta che, universal
mente, la formazione delle frasi relative (restrittive) operi per
mezzo di 'strategie' fondantisi cracialmente sulle funzioni gran
maticali delle lingue (Keenan e Comrie 1977). Keenan e Comrie
propongono essenzialmente due criteri per distinguere i modi a
disposizione di una lingua per formare una frase relativa (re-
strittiva). Dato che il primo &, ai nostri fini, del tutto irri
levante”°, 10 lasceremo da parte. Il secondo riguarda 1a natura
del procedimento formale ("superficiale') impiegato per relati-
vizzare una certa posizione nominale: se la frase relativa pre-
senta un elemento (pro)nominale che “esprime inequivocabilmentd’
quale posizione (funzione) il SN relativizzato aveva in seno al-
la frase relativa, si dira che il procedimento di formazione del
la frase relativa @ una strategia che registra le distinzioni di
caso (# case RC str se tale ‘registrazione’ non avviene,
si dira che la strategia in gioco @ a non distinzione di caso
26
(- ease RC sina is
Sulla base di uno spoglio condotto su numerose lingue essi
vengono inoltre a sostenere che le lingue possono variare tra
di loro rispetto al numero, e, pid significativamente, al tipo
di posizioni nominali relativizzabili e che tale variazione ap-
pare governata da un principio implicazionale universale.
Ipotizzando una gerarchia universale di posizioni nominali
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- CommentariolumDocument21 pagesCommentariolumvalter8102No ratings yet
- RGG Vol 20 PDFDocument159 pagesRGG Vol 20 PDFvalter8102No ratings yet
- Jrev3 9fullDocument37 pagesJrev3 9fullvalter8102100% (1)
- Jrev3 8full PDFDocument40 pagesJrev3 8full PDFvalter8102No ratings yet
- Jrev3 4full2Document44 pagesJrev3 4full2valter8102100% (1)
- JREV3 5full PDFDocument44 pagesJREV3 5full PDFvalter8102100% (1)
- JREV3 3full PDFDocument44 pagesJREV3 3full PDFvalter81020% (1)