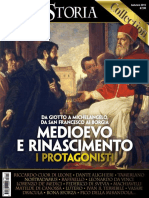Professional Documents
Culture Documents
Focus 2017 Primavera
Focus 2017 Primavera
Uploaded by
historiadigital100%(1)100% found this document useful (1 vote)
57 views148 pagesFocus 2017 Primavera
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentFocus 2017 Primavera
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
100%(1)100% found this document useful (1 vote)
57 views148 pagesFocus 2017 Primavera
Focus 2017 Primavera
Uploaded by
historiadigitalFocus 2017 Primavera
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 148
> Been
(1h, Sie
Uff
“Cy.
Architettura, politica,
arte e protagonisti
delle grandi capitali del passato
LA STORIA DEL
MONDOIN,.
20 CITTA
‘Scopri un nuovo mode di esplorare il mondo con i viaggi studiati in esclusiva per i lettori di Focus Storia e realizzati
in colaborazione con | viaggi di Maurizio Levi, tour operator speciaizzato in itinerari ad alto contenuto culturale, storico &
antropologico. Preparati a partie con Focus Storia per un'esperienza unica alla scoperta del Messico e del Guatemala.
I VIAGGI DI
STORIA
LA STORIA DEL MONDO
IN 20 CITA
[osa hanno in comune la Gerico delle origini, la colta
Aten di Price faficoendata Venezia def mercani? La no scoroTines
«aotica Roma del I secolo,Fordinara Pari del urbanista eee oa
Haussmann ela Berlin divisa dalla Guerra fred? Longacre Square.
Apparentemente non molto, se non la vicinanza aun corso d'acqua,
parecchie ambizioniarchitetoniche e andite soluzioni difensive: dalle
prime mura della Stora, edifice a Gerico, a die Mauer, il muro per
cccellenza, che divideva Berlno. Il flo rosso che accomuna le protocieh
alle moderne metropolé Yavercostituito un mondo asé, nel quale
uuomini e donne si sono identificat in valori comuni che hanno
_gencrato un senso di appartenenza a una cultura condivisa. Vedi il
paradossale fenomeno Ostafie (nell artiolo su Berlno Est): nostalgia
per un socialsmo, subito ¢ cxiato, ma dove valori come solidarete
‘welfare erano una certezza. Proprio oggi che guardiamo con terore alle
capital europee e abbiamo escluso mez20 mondo dalla nostra wish list
delle vacanze &confortante pensare che le metropoli del pasato abbiano
superato invasion, guere civil ivoluzion e crac economic, per poi
risollevarsi. Quindi, in aresa di tempi miglori, godetevi comodamente
dda casa questo giro del mondo in 17 cite (lee alle imamancabili
Gerusalemme, Mosca e Shanghai ciate nellintervista dllo storico
Franco Cardin) che hanno segnato la nostra Storia
Paola Panigas, redattore
MS METROPOLI NELLA STORIA
Le citta che hanno rappresentato al
meglio il loro tempo.
MMM) CAPITALI DELLA CULTURA
I centri urbani ad alo tasso di genialica,
BEG MEGALOPOLI D'EGITTO
‘Quando Alessandria era la capitale del
regno di Cleopatra.
LOMBELICO DEL MONDO
Colorata e multietnica, ma anche sporca
¢ peticolosa. Duemila anni fa Roma era
MHI SOTTO LE MURA DI GERICO si una vera e propria metropoli.
Una delle pit antiche cited del mondo,
resa celebre dalla Bibbia.
UN POMERIGGIO ALLE TERME
Un complesso che poteva ospitare fino
SFIDA AL CIELO a tremila persone.
Babilonia, capitale del pit grande regno
‘mesopotamico ¢culla di una cvilea
alavanguardia,
LA ROMA D'ORIENTE
Nel 330 Costantino I mise
Bisanzio: la chiam® la Nuova Roma, ma
per tutti fu Costantinopoli
OASLTRA TERRA E CIELO
I giardini pensili di Babilonia.
ISEGRETI DI ANGKOR
Lacivilea Khmer che abitava queste
terre cred i suoi templi sulla base di una
combinarione tra buddismo e induismo:
rnacque cosi, in Cambogia, la capita di
un florido regno.
CI VEDIAMO ALLAGORA
Viaggio alla scoperta dell Atene di
Price: la citti che ha inventato la
democrazia ela filosofiae edilzia
publica,
Bi
LA STORIA DEL MONDO
IN 20 CITTA
WEG IL TEMPIO NELLA GIUNGLA
Realizzato nove seco fain
‘Cambogia dal re Suryavarman IL
Per accelerare fu costruito partendo
‘contemporaneamente dai quattro lati.
(SULLA VIA DELLA SETA
Voluta da Tamerlano nel 1370,
Samarcanda per due seco fu crocevia
di commerci e sapere.
WI UN CALIFFATO DA FAVOLA
DallVIII secolo il vasto territorio della
dinastia degli Abbasid aveva il suo cuore
a Baghdad, la “cite della Pace”.
SERENISSIMA POTENZA
Richie spregiudicati, ma anche saggi
« previdenti. Per pit di cingue secoli
veneziani dominarono il Mediterranco.
A CASA DEI PATRIZI
VENEZIANI
Le nozze di Cana, uno dei capolavori
dellarte italiana, un campionario del
lussoesibito in un banchetto veneziano,
WMS L.A FIRENZE DELLE
MERAVIGLIE
‘Come vivevano ¢ lavoravano gli artisti
nella culla del Rinascimento italiano e il
ruolo dellarte nella citth dei Medici.
EH] 'UOVO DI BRUNELLESCHI
Fu la prima archistar della Storia e con il
suo genio diede il vial Rinascimento.
WO MORTE IN PIAZZA
Piazza della Signoria a Firenze: sede del
consiglio cittadino, ma anche luogo
deputato alle pubbliche esecuzioni
WOH) LA CITTA DEI MERCANTI
Amsterdam ¢il dominio dei mari
Wid VITA TRA LUCIE OMBRE
Rembrandt, il pittore olandese, ebbe
una vita in chiaroscuro, costllata di
tant success e grandi dolor
ME LONDRA VITTORIANA
Edifci pubblici, quarier residenziali
«sovraffollate baraccopoli: la capitale
inglese ela rivoluzione industriale
(WH IL FASCINO DEL DANDY
(Oscar Wilde lesteta amato da uomini e
donne che sedusse i saloti londinesi
ILLUSIONI DI FINE SE
Splendorie lati oscuri della Belle
Epoque: un‘epoca sfivillante che si
concluse con la Grande guerra.
SLO
IIE LA PARIGI OTTIMISTA
Lativoluzione urbanistica di
Haussmann plasmo la cittd dandole
il volto che ha ancora oggi
EBD LA SECESSIONE A VIENNA
Prima della Grande guerra la capitale
imperiale divenne un laboratorio di idee
che rivoluziond il pensiero occider
LA TERRA PROMESSA
New York per migliaia di emigranti
cera un sogno che sinfranse nella
miseria della Grande depressione.
(EEE CORSA ALLULTIMO PIANO.
I retroscena della gara per la costruzione
dell edificio pit alto del mondo, nella
New York del primo Novecento.
ESI EMPIRE STATE BUILDING
Fu costruto in 14 mesi, con la media
record di 14 piani ogni 10 giorni
Oggi un miglaio di aziende hanno
sede alV'interno del gratracelo.
EDI BERLINO EST
Divisi da un Muro: la linea di
separazione tra Este Ovest fu il
simbolo di un’epoca che segn’
un’intera generazione cresciuta sotto
il segno del socialismo. Ma come si
viveva davvero in quegli anni?
LETTURE
BLOT
LA STORIA DEL
. MONDO, IN.
1 ANNO som
ae:
Be ten et ent eae aera
i 4 '
ee Rak ak ee
iy
mye
“
p
L
SCEGLI COME: : [@Gje Nee) BsUssHO NP WVlNy Ke)
Si, mi abbono per’ anno. FOCUS STORIA COLLECTION (4 numeri) con lo conto del 28%. Paghero solo € 22,90
Spedisci il coupon a f; + €2,30 come contribu spese di spedizione, per un totale di €25,20 (WA indus) invece di € 31,60,
PRESS-DI ABBONAMENTI SPA ‘i pagamento delfabenamento & presto in u'unicasaluzon
/OCMP BRESCIA Peelipaamentcon cata ced o ere aaa.
VIADALMAZIA 13
25126 BRESCIA(BS) Lmiei dati
Opp iris amumere difax0307777235 ' Cognome
iia
ce oy
Vaisul
www.abbonamenti.it/collection
Telefono
Chiama il numero: 199111999"
INTERVISTA
Dalla GERUSALEMME delle origini alla Berlino della Guerra
METROPOLI
in dalla notte dei tempi l'evo-
luzione dei grandi centri ur-
bani ha accompagnato Ia sto-
ria umana, associandosi di vol-
ta in volta al sorgere di questa o quel-
Ia civil. Nel corso dei millenni hanno
‘cosi preso forma alcune “cit simbolo”
che, in determinati periodie in determi-
nate aree geografiche, si sono affermate
‘come una sorta di eapitali mondial, in
sgado di fato di rappresentare uniintera
epoca, © meglio un incero “mondo” (a-
temando peraltro momenti di grande
splendore ad alti di inesorabile decl-
no). Queste “cit mondo” si sono pas-
pe ere ei!
no al sorgere dele moderne metropoli,
Tango di grand mend ¢consadeei
ni social (presenti anche in mote citta
antiche). Per eapire quali interconnes-
sioni abbiano avuto i grandi centri ur-
bani della Storia, quali momenti de
sivi abbiano attraversato, quali eredita
cultural abbiano lasciaro ¢ quale con-
tributo abbiano dato allo sviluppo del-
la nostra civil ci tivolgiamo alo stori-
co Franco Cardin, che a molte dq)
ste cittd ha dedicato specific agg spa-
2iando da Gerusalemme a Samarcanda
eda Firenze a Istanbul
Che ruolo hanno giocato in dallan-
tichita i grandi centri urbani?
«Unruclo importantissimo, in quanto
illoro sviluppo ha coincio con quello di
‘ogni grande civil. Luoghi di incontro
‘edi confronto, dapprima commercialee
poiculturalei primi grandi centri urba-
ni sono stati di fato il terreno di coltura
dalle primordial forme di organizzazio-
ne stata, dela formazione di un sste-
del vivereinsieme. La stes-
lt deriva non a caso dal
termine Fiero a
sua olta a civis, “citadino”y
‘Quali furono le prime importanti cit-
‘thavedere la luce?
«Una delle prime fu Gerico, in Paesti-
na, lecui traccersalgono addivtcura al X
millennio a.C. seguirono leita siriane
.
Restando in Italia, qual & stata invece
Vimportanza di Firenze?
La citt toscana ives un'importanza
enorme soprattutto tra XIV e XV seco-
Jo, ossiaal tempo dei Medici, allorchédi-
venne la cull dell'Umanesimo e del Ri-
I | U
Ryn)
Wy
nascimento trasformandosi in una sorta
ria dell arte e della cultura nel pas-
saggio dal Medioevo alla moderita».
A pproposito di modernita, come so-
‘no cambiate le grandi cita con la rivo-
Iuzione industriale clo sviluppo tecno-
lgico del XIX secolo?
«Con Favvento dell'era industrial ei
sclativo trasferimento di moltilavoratori
dalle campagne alle citi siasistito allo
sviluppo di grandi metropoli come Lon-
dra, Parighe dll alta parte delf Oceano,
New York, la “Grande Mela’
Luoghi icchi di contraddizioni socia-
liedi relative diversith architertoniche,
cosmopoliti, caotic efrenetici come in
ppasato fu solamente la Roma del I seco-
To, rimasta in fondo il modell dir
mento di ogni metropoli
Dall’Europa agli Sati Uniti, passan-
do perleodierne porenzeasiatiche, ogni
grande eraltro riuscita a mante-
rere una propria originalita ¢ una pro-
pria cultura».
Inalcuni casi, come per esempio a Ge-
susalemame, é perd capitato che culture
‘on valor di rferimento oppost si sia-
‘no contese una stessa cit...
«in questi cas si sono spesso al-
2ati dei muri, come & accaduto in epo-
‘anche piit recente a Berlino, una de!-
le principali cull della cultura moderna,
capital della scienza, della tecnologia ¢
della civil industriale che nel Secon-
do dopoguerra, dopo esser stata fatico-
samente strappata al nazismo, fu con-
tesa dalle grandi potenze vincirici: Sta-
ti Uniti, Gran Bretagnae Francia da una
parte, Unione Sovietica dalPaltra. Ta i
1961 el 1989 fu quindi tagliata a me~
1 da una lunga barriera di cemento ar
mato, divenendo il triste simbolo della
Guerra fredda»
‘Yenendo al nuovo millennio, qua~
le metropoli é oggi degna del titolo di
citti-mondo?
er rispondere bisogna rivolgere lo
sguardo a Oriente: quis per spirito co
smopolita e modernita, ditei che il ti-
tolo possa andare senza alcun dubbio
a Shanghai, vivace megalopoli che &
cespressione economia eculturale del
Ia crescente potenza cinese e che, nello
stesso tempo, ha un carattere occiden-
tale: elementi che hanno fatto si che tia
spodestando New York come centro de
ali equilbri mondial. .
FRANCO CARDINI
Storicomediealta,
espero di appotita Europa csianaeistam.
Tai suo sg pifamos
Lacrocata cif Gun ecaltatoe
(ropa Dallecrodate aI mile annidpade
‘guere smb aleonzee assoc (tt.
[Ml GEOGRAFIA DELLE IDEE £
Luomo GIUSTO al posto
giusto. Non é un CASO se in \
certi LUOGHI c’ statauna |,
cosi alta concentrazione di we
benessere e GENIALITA:
ecco le citta simbolo di
questo FENOMENO
INNOVATOR!
Ades dala
Stmund Freud,
GstavKint
(protagonist
defondatad
Leonard daVind,
personaggiosimbolo
elRinscmento
italiano.
LAPOGEO DELLA GRECIA
Cresciuta economicamente dopo le Guerre persiane, Atene si impose come centro del
mondo greco. Vi giunsero filosofi, artisti e avventurieri, attratti dal mecenatismo di Pericle
PuaTone (a 348.6) PrmiiE(95-294.0)
FudsapeodlSocatee uli politica tenes pe ole enfann walls e423.
imacsod Aristotle (Ga PERCE sta ientto un medio perposter esa a democrazia Samia dence.
‘cou eRcHEcente _steietefece dela ict un centro ara.
sue dtine metasche,
fiche, police deste
“ihe haiuenzato
estno dalla flosoia ma
anche del leratra)
ident
Dewocnio wee 3708.)
‘lost riginaro dela
Trac sese diferart
aantee,
y)
soroctE(@6 6A)
‘Autoe tragln tata,
‘GIO PERCE: rotsiend
[atagediainuoducendo
‘ero attore” Con 01
SENOFOWTE(30355 4)
Det ‘ape ata uate
puryesatle ses de
‘es argoment.
‘Gao PERCE:s pu cons
ae ‘era primo divdeatore.
(en PERCH peru
teotaatemia erento
{padie deta aca. er
sisaun _ LK ProTHcoRA asest1 Ac)
eres) Nato in Trace, sopgtorn>
ee ried pid vote ad Atere
piece ‘Gamo PERCHE: el padre
feasts chepones
(ent PEROHE primo sites See
‘scopluralat‘utete aie Saesteat ik,
seneflosaca
seson0 monica.
Twaie esesoanc anstorane(s038546)
‘Review tatmassnt ‘Conmediogrtavivevala
strc deci susattit come una is=
{EM PERCH: Lo Gre sone edveatice
‘mde Peponneo® ‘Gao PERGHE conse
‘enuto uncool fata inverted sata
‘moderna ‘ocopalte,
umPmeCeas 07 Ac) SoceaTE 7039940)
Tagedogiata face dt ‘Dhctev spss nefogrh
Secale envales Sotode. ‘oni sofste con rumeo-
‘emo rent: grace Sacepal eam
Sperimentaioevatteon ‘eq PERCH To
Iedinamichepsclogce Fina aseoonc irroceaTe(se3774.c) rindpal sf ani
Con neato reais sua [Adee rope tParerone. Meco ato aos contibuiavincerela_sopratuto permet
featementat seo. EMoPERCE:dimomwoecenorak —_pesteidtenenel 2936. {Eindagine dalogo critco
denne eden Feta, abi darter eseutore [EMIOPERCHE:volinoné amen, _—_elinduzone Econsier
roma) sone "mode irerandotartsa pi ees Terandola dae nue dine. ‘elo dtetica,
olitario, malinconico € un po"
‘matto, E questa immagine 10-
mantica del genio, V'individuo
molt pit avanti dei suoi con-
temporane, che tende a isolarsi perché
il mondo non lo capiscee lo capica do-
pola sua morte. Uniimmaginerinforzata
dalldea antica, e non del tutto superat,
che un genio sia tale in dalla nascta, de-
stinatario di un “dono divino”, come si
dliceva ier, o di un patrimonio genetico
ceccerionale, come si direbbe ogg.
Ebbene, questa idea & destinataa tra
‘montare. Enon solo perché cut li stu-
i sulla genialiti dimostrano che dietroa
‘ogni talento excezionale ci sono sempre
anni eanni di impegno e una buona do-
se di stacanovismo, Ma soprattuto per-
che, Facendo un'analis storica del feno-
meno, ci si accorge che le menti pit ge-
niali non sono sparse qua eli nello spa-
ioe nel tempo, come ci si aspetterebbe
sesi trattasse di un fenomeno puramen-
te casual (un “dono” piowuto dal cielo),
ma sono concentrate in particolai luo-
¢ghi cin partcolari periodi. Insomma: se
sivaa vedere chi bazzicava nell agori di
“Atene nel V secolo a.C., perle vie di Fi
renze nel Rinascimento, nei por olan-
desi del Seicento, ne salori della Vienna
finde sicleo ne caffe parigini degli Anni
ruggenti e forse anche nelle startup del-
[aSilicon Valley di qualche anno f, viene
proprio da pensare che per diventare un
genio sia importante, prima di tuto, o-
varsinel posto giustoal momento giusto..»
BT
Fu un epoca di splendore culturale segnata da una floritura senza precedenti di
“multiformi ingegni”, il cui segno distintivo fu senza dubbio il singolare eclettismo
mucuuanceto (14751560)
Dower. (136-1666) Scultore ptr archer e poets form nella botega del mastccio (201-108)
Sct vise ear soprat- Ghandi Nel 1618andd a Fence,
‘toa renae ‘eta PERCE: con oper come t David ola Cappella Stina & ‘EMO PERCHErinovo la
GENO PENCHE:superofane ‘uo deal artstipingrandiciserpre, piturerftando ec
romana lasscacon un eco dl tempo no
‘Spresonse runes e
inquete.
ducendo igure plastehee
“eal
— —
vas ames
ee cc
ed ieee
aoe ar,
isi a
Sounannne aS
magi ‘PIERO DELLA FRANCESCA,
oo —— a
(outa) FIRENZE eee
—_ pend, GENIO PERCHE:brillo peril
fran i
GENIO PERCHE: mecenate e aa sade fore
Srna aaa
adipace ed equilibrio. sania
er
wna ene
we saa
eS Bef one
tie tron
ee smmmanmsare iis,
Ft
— ae natn
au
Cee toed: Nao a Son Sepolero (Arezzo, ne 1470 end eld francescano. Seeaeitmaibeds
fete eect See
— = fee
{EMO PERGHE pi ving Con Leonardo frequents bottega det Voce. ‘aM PeRcHE onde
Sete ee ats
Un ESSERE SPECIALE. II fenome- senza fin dalla nascita. Un'idea ripre- pio fle Vite de’ pit ecellent itor, sul-
no del genio affascina fin dall'antichi- sa nel Rinascimento, quando la fama e tar et architettri di Giorgio Vasari. Nel
1G. I Greci che diedero Pavvio al cul-Timmortlita si imposero come virti in Settecento, gli autori dell Encyclopédie
to dei grandi uomini) lo chiamava-_contrapposizione allesaltzione medioe-_dedicarono sei pagine alla voce “genio”.
no daimon e lo consideravano una sor- vale de umilti, Anni in cui siaffermava_ Confermando idea di un dono per po-
ta di voce interioreispirata dagli di. 1__unnuowo genereletteario: abiograiadi_ chi. Perino Kant (1724-1804) afferma
Romani lo chiamavano genius (da ge-_uominiillustriripreso dalle Vie parallde che il genio & una quali che non sitra-
ro, generare) per sottolinearne la pre~ del greco Plutaco) ica massimo esem-_smette ma &concess dalla natura
2
Favorite dai commerci e dall'umanesimo di Erasmo da Rotterdam,
le scienze e le arti olandesi divennero le pit: acclamate del mondo
EMBeANDT (1606160)
aoa Le vise gran
comstuunnorcens pene
(151695) ‘Astedam Fuscoperto
siceat tanta ‘alpacrediChistaon
oma amici Caresioe Hagens
Pascal GEM PERCE S10 150
‘GEO PERCH invent delaiuce eg ator
=e nefannoun maesto unica
‘lane Satu fee
Scopart sults esc
‘obdele prota.
AvrOH VAN ezUWENHOEK Hiaveuaies fineness
enim ae fn
Oricoenaualisa vse ae
Daltead Artem. {en PERCH 04
‘GEMOPERCKE: verti und sono rut d una
microscope sconrendo ‘ec unea Cnn
Couto ebatee ‘assapete dace
detandote bs dll mie ‘cao cote
Erbil Scop anche ganipeapsebya
Felobu os det sangue. lsuoldpit
A far fiorire LOLANDA contribui
LENERGIA a basso costo prodotta
dai MULINI a vento
canresio 196-650)
Flosofoe matematiofran-
‘ese lav in lands dove
pubblico so caso sal
metodo.
GENO PERCE: lsc de
"ogtoegosun’ const
deat primo pensatore
‘modema Dede vita anche
Srazonalim
Flosoa nacqueesiform®
ad Amsterdam,
Geno PERCE ccd e
Tere ranonalistche
dala Bbige tute efxme
‘dspam, seanando un
tome al acon geen
‘eanticpandoiluminisme,
GENI NON st NasCE. II primo a met-
tere in discussione idea del dono divi-
no fu Darwin. E dopo di lui diversi stu-
anne ements men noes:
tuna verithoffuscara dal mio dell"
Specie sal genio'pon€ flat un do
no clargito magicamente a pochissimi
fortunati,sostencva o psicologo inglese
‘Michael Howe.
Lanalisi delle biografie di personali-
18 eccezionali permise a Howe di indivi-
‘espaiasomercant
‘Ge PERE scsi ‘ENO PERCE mote sve
‘monumental on Alo persona plete rl de
eee depo pert.
panto ricasso(nee+973) man rarcvee976)
Spagnal nel 1900siasera Nato aPhiadebhia,segu
Ls BuRUEL (19001985) ‘Duchamp Pari Gul o-
Spagnol.esrdaParigiconilcarto» bbe lat piinflvn-
‘nente deleubsma, cambio pe revaqgoUnchenaneou (1528). sopratuto sures.
Semprelastodadelspatun.e GEMOPERGHE: surest, ¢ stato uno GEMDPERCHE oluiond
setae. Aeipingrandivegiside secon Tate defor,
toners sumENoN(19031989) _aNTOMIMARTAUD (189-1988) ‘mene marist (69 1950)
ScrtorenatoaLieg sivastria Matos Masih nel1920, spiega Nigro. «La torre eil muro acui que-
sta era collegatafurono costruitiascopo apparente-
mente difensivo. Ma qui én enigma, perché non
sia da chi quell’antichissima popolazione doves-
se difendersis. Di certo, non dal popolo di Israel.
Prororeuicione. Circa mila anni fa avvenne
trvaltrasvolta importante: le case passarono da c=
colar a rettangolai il che vuol dire che potevano
‘man mano essereaggiunte altre stanze, trasforman-
do Pabitato in un centro artcolato. Erala prova di
tuna societi che stava cambiando.
Allo stesso periodo gli archeologi fanno risalire
traltra grossa novita. A Gerico era praticato il cul
to dei mort, il primo attestato nella Storia. Qui,
infati, sono stati ritrovati scheletti sepoltiordina-
tamente ma senza testa, mentre teschi con fattezre
‘modellate in argilla edettaglidecorati con conchi
elie sono stati rinvenuti nelle case: evidentemen-
{esi usava conservare rispettosamente le teste de-
gli avi. La testimonianza pitt antica (uno di que- »
3
Situata 240 METRI sotto il livello del MARE,
Gerico é il pitt “basso” sito ABITATO sulla Terra
sticran sepolto in un reipiene di pitta apochi
ma dalton) emer propio paca
Tavera sivas pend che nel etl ied
sii, quando si stablizarone Fagrcoltra, alle
wamento e uso della ceramicae quando (nel IV
millennio aC.) si svluppd ulteriormente lacie,
fon sl trovano pil race di manifestanon eligi
se. Pochiaspti regis! appaiono anche nel Ie
I millennioa.C., quando la cia vise divers mo-
menti di splendore diventando captale dei Cana
nei, popaloimparentato con gi Hyksos che inva-
sero Ege,
Th cut questi passaggi Geico rest a “ie del-
le muta” anche nelT Eta del bronzo ra 12700 ei
2350 aC raddoppid la cinta di fortfcazione; nel
petiodo successivo (2000-1550 .C) queleprote-
Zionifurono alzate, costriteeicotruite, si calco-
le, una quindicina di volte vi apparveroe grand
pore piche delle cir sitane e paletines
‘ nds
Senza TemPL. Nonostante gli sea-
vi condotti sui resi dell acropolienel-
la necropoli di quel'epoca, di tempi
non c@ invece alcuna traccia. E po-
chissimo él materiale legato a cult
Forse i templierano in zone dell'acropoli
poi distrute? F una delle ipotes. In ogni caso,
a quali dai sarebbero stati dedicat quei templi? Per
ora le supposizioni indirizzano verso il ‘pantheon’
semitico: El, dio del cielo, e Baal, signore della cit
La necropoli,insieme alle prove del culto degli
antenati, ha tuttaviasvelato almeno un altro im.
porrante segreto legato a Gerico, Nella tomba di
tuna principessa un recente ritrovamento ha col-
pito gli studiosi: un sigillo con geroglific egii,
che ha permesso di scoprire il nome antico del:
la cite. I suoi abicant a chiamavano Ruha, cio
“Profumo”. Forse era il profumo dell'oasi, che
aleggia ancora dopo 10mila anni. .
Ald Bacc
DIVINITAE PROTOCITTA
‘Ades statue Bala
sec.a.C divin semi forse
dort a Getic. Asiist,
Geruialerme dnt fun
manos del seco.
RT UEC
Peer)
( Peery
erry
Pperetsse
peer
peer catas
psa
ee eer
Seen enn te ee en any
Peers a teen een re
Cee ea
eee ee eee
ee et eed
erty Pianeta, p
sono state trovatetracce di alla maggioredisponibil:
eee Beeemcernety
Seg esticazione
pidantichecé ¢atal yk, —ebestiame. Per esempio,
‘oggiinTurchia. Anche qui, in Gina il sitodi Hemudu
Pe PCa
dovette aspettare un altro
Pea en
Ean
aac)
eee ety
Peer
errno eels
ee
oer
aes eo ee
eee aE ny
LA CITTA
DELRECORID
Fra i quattro ei cinquemila anni
fa Gerico toccd il suo apogeo: aveva
doppie mura, un vasto abitato e
oli. Ecco come doveva—
‘Ds primitive CAPANNE
Creoailecase divennero
‘ediicin muratu
ante quadrata,
Ne 2 Lemuraeeanpale cease! eet en
ea aan Sri Sees ry
Co ‘ane fngo coer er permet
z
2
2
=
a
BABILONIA, capitale del pitt grande regno
mesopotamico e culla di una CIVILTA illuminata e
» all'avanguardia, che culmino nella costruzione della
TORRE DI BABELE
SFIDA AL
st, secondo la tradizione, nei sette
colori delfarcobaleno, alta 90 met, la Tor
re di Babele & esistta davvero, Svettava sul
territorio di Babilonia, la citel-meraviglia
del mondo antico che ste tanti grandi delfanti-
chic dalPasiro Asubanipal al macedone Alesan-
dro Magno. Sulle rive del fiume Eufrate, al centro
di una Mesopotamia culla di tante civil, sorgeva-
no meraviglie come la Porta di Ishtar (ogi rcostru-
ita nel Museo Pergamo a Berlin), la Via delle pro-
cesioni, i giardini pensii il palazzo real. E soprat-
tutto il cuore relgioso della capitale il vasto com-
plesso dedicato al dio citadino il potente Marduk.
Proprio qui, aocanto a un grande tempio “casa ter-
rena’ di Mardulk, siergeva la ziqqurat di Babilonia,
chiamata Etemenanki. La torre era una sorta di sca-
la che doveva servre alla divinich per scendere dal
cielo. Ma per incontrare chi?
Una era rane, «Fu la dinastia sumerica det-
ta“di Ur3” acodificare il modell dele ziqqurat¢
a erigerne in tute le
tomas fined mln =
rio Liverani, docente di Storia de vicino orientean-
tico alla Sapienza di Roma. A farle erigere, il “go-
tha” dei sovrani mesopotamici, da Hammurabi a
Nabucodonosor.
Dietro a quei cantieri memorabil si agitavano i
perenni confltt con inemici di Babilonia, gl Assi-
ri, La costrunione della Torre di Babele fu dunque
(anche) il simbolo del prevalee babilonese in quella
Lec)
DORGOGLIO
Lacostrione dell
St
cre)
eno
Reais
Tere
at
ee
ener’ |
romeo
IELO
lotta per la supremaria mesopotamica. «Credo che
laziqqurat rsalga almeno ad Hammurabi, il grande
sovrano che condusse Babiloniaalla sua prima epo-
«adi splendore», conferma Claudio Saporett,assi-
riologo eautore fral'altro di Le tor Babel. Ham.
smurabi (XVII secolo a.C.) 2 ogg celebre peril suo
codice di egg (trai primi al mondo) e peravere uni-
ficato la regione centro-meridionale della Mesopota-
mia. Ele sue “grandi opere” erano parte di una pre-
cisastrategia, basata sulla riforma rligiosa: mettere
alvvertice del pantheon mesopotamico proprio i dio
Marduk. Fu quindi, probabilmente, lu‘ far costru-
ire la ziqgurat ei rativo tempio,
Ne@ certalarcheologa Maria Giovanna Biga. «La
prima menzione della ziqqurat rsa allepoce di
Hammurabis,afferma a studiosa,«Nell’eplogo del
suo codice si cita un “tempi le euifondamenta sono
solide come quelle di cdo terra’, che &appunto il s-
gnificato del nome Etemenankis.
Sritara prrorous. A porre ine quel primo im
pero babilonese arrivarono, dalla lontana Anatolia
(ettuale Turchi), gi Itt, Accaddeintomo al 1530
a.C.:saccheggiarono Babilonia esi porcarono via la
statua del dio Marduk. Le peripeziedllidolo mei
tarono in seguito un poema epico. Secondo il quale
ogni volta che la statua veniva “rapita” dal suo tem-
pio, significava che Assiri ed Elamiti (altri nemi
i storici di Babilonia)avevano preso il sopravven
to; quando Marduk rientrava nel suo tempio,allo-
1 Babilonia tomava asplendere conil suo potere.
zB
Per la COSTRUZIONE dei templi mesopotamici servivano
migliaia di OPERAI e una SOCIETA ben organizzata
Dalla sua cima, dunquc, la Torre di Babele vide
‘molt popoli awvicendarsia Babilonia. DalXV seco-
Joa.C.i Cassi provenientidai mont oriental siin-
sediarono a Babilonia impregnandosi della sua cul-
turve restituendole importanza. Un secolo pit tard
Incite ela tore furono sacchepgiate dal re di Assur,
‘Tukulti-Ninurta, Nd 1155a.C. ful volta degli Ela-
‘midi (originari dellodiemo lran). Finché arsivd Na-
bbucodonosor I, intornoal 1100 2.C::i nemici di Ba-
bilonia vennero confit, templirestaurati, Marduk
tornda casa. Fu dire vero, una gloria di breve du-
rata. Nel732aC. Babilonia ricadde soto il dominio
asso. E il peggio doveva ancora venine.
Oncoctio nasitonese. | Babilonesidecsero di
ribellarsi e wecisro il fio del reassro Sennacherib.
Tpocente sovrano la prese molto male, ad in fore
ene 689 a.C.riconquist la cite “Come roa tempe-
stacolpi Babilonia, come un uragan la travel... La
cit le case, dalle fondamenta alle cime dei muri d=
strusi, devastaie died alle fiamme. H muro di cinta, i
empl degli dei la ziqgurat, di mationie tera, ras al
5 seca nel fume Neimeaze di qu cs see
‘nei canal lesuefondamenta riempiidacqua. Rei la
se daraconepcompland pepe dao
diluvio”. Cosi Sennacherib si vantava della sua cam-
pagna di devastazione. «Quella diseruzione pud spie~
gare leincongruenze tra le descrizioni pit tarde
della Torre di Babee ei restiarcheologi-
ci pitt antchie, pega Saporeti. La
rigqutat pitt antica era quadrata,
aagradoni econ rampe. Erodo-
to invece parla di una scala
spirale (che ispird poi i
dlipinti della corre bibli-
a.nd). Sicome il mo-
dello cicoidale (vedi pa-
gine precedent eraassiro,
[nuova tore, rcostrica
nell VIIL-VI secolo aC.
dai re asi Esathaddon
Assurbanipal, porebbeave-
re avuto un assetto clicoida-
Je su base quadrata». Ma perché
riostruie cid che si era distratto?
Probabilmente perché azione di
Sennacherib fu considerata sacri-
lega dagl stesisuoidiscendenti.
Runascrta & capura. Fu un
alero te di Babilonia, il caldeo
Nabucodonosor II (il Nabucco
della Bibbiac del’ omonima opera di Verdi) a “fi
‘mare i nuovo tempio Etemenanki, Ancora una vol-
ta, la torre risorta accompagnd il rinasceredellacitt.
Babiloniaestese suo potere all Asia, all Anatolia
al Mediterraneo e all Egitto. Poco dopo il 600 aC.
Nabucodonosor arivé a Gerusalemme, ras al suo-
loil Tempio di Salomone e fece deportare gli Ebrei
in Mesopotamia. Fuallora che la nuova zigqurat fu
completata, forse anche graieal lavoro dei deporta-
ti, Efuallora che Babilonia conobbe il suo ultimo
‘momento di gloria. Cerano perd altre potenze alo
rirvonte. I Persian in primis, ai quali Babilonia pa-
0 un prezzo altissimo: «'imperatore Serse dist
se per ultima volta la riqqutar, reprimendo la ri-
volta babilonese del 480 a.C.», conclude Saporet
Quando, 150 anni dopo, Alessandro Magno siin-
namord della cite al punto di conquistarla, Babi
lonia era ancora una metropoli con pit di 200mila
abitanti. Come altri prima di lui, Alessandro recht
aia di operai per rimuovere le tonnellate di ma-
ceric tentare di ricostuir la madre di tute ke sfide
ingegneristiche. Mori prima disiuscire nellimpresa
eedaallora della mitica torre rea solo un cumulo di
fango veechio ormai di quasi 4mila anni. .
Ald Bacci
RAMPEDL
RAPPRESENTANZA
Larampascainata
centrale colegaaal
tempi ed era rservata
aireacerdoveal,
funsionar sar,
LATORRE DI UR
‘Ades lapit
Imponente wale
Ziequratnote. La
suacostionee
‘comincta crea tila
annasulresidela
td sumera di ogg
atinorigine6metr,
sutre pint. suoiest
Sono seria icostrire
lestrutr dele are
equrt Inbassoa
sii Harmurabre
‘Babin cea 3800
anni Lazigqurat cera
‘gi durantelsuoregna,
UN MODELLO
PER TUT IT ox.
Le ziqqurat mesopotamiche (come la
Torre di Babele) avevano tutte strutture
simili tra loro: una serie di piattaforme
sovrapposte, il cui scopo era permettere
alle divinita di scendere sulla Terra
‘CROCEVIADI POPOL
[acceSORSeRaTo YC
| accesso RIseRVATO reg
TNGRESSO I mesapotamiciterevano che a igquat Sepusimia.
Heaney ‘osseladimora dela divin aU Nanna,
: Totus tempi ied
pore fe omar cctools
ro benesset
See
eee
ee rs
Cem
Pee eed
eerie
eed
Pr oeaie ee aes
eter end
er Coes
Peete
papeinert:
emer’
Preece
Peet
eet
Career
ere
peered
cere
Pree
prey erent
pete tral
poe ery
ey
fier etrs
et
storico dscusso, Percle
reveal
pee ees
Breer apart)
eet ey
Efalte, capo dellafazione
rd
eer
eee
atari iscepolo prese
Ppeneo tect
vane teatro di Atene, perl gare tra drammaturghi.
Peri Greci, questi spettacoli non erano solo un passa-
tempo: liconsideravano una peciedi to, cheserviva,
a raforzare lo spritocollettivo dela polis
sliautoriinfati prendevano spunto dai miti edai
raceontieoiciusandoli come metafora per Pata
per portaresullascenai problemi che agitavano lapo-
is lanciare messaggi politciea vole influenzare 'o-
pinione pubblica.[ pit famosi ad Atene farono i tra
ici Exchilo, Sofode ed Euripide eil commediografo
Aristofane: maestri nella loro arte, con le loro opere
riuscivano a scioglere anche i euot pit dui. Secon-
do quanto racconta lo storico Plutarco, sarebbe sta
toil primo coro dell letra di Euripides salvare Are-
ne dalla distruzione, alla Fine della seconda guerra del
Peloponneso (404 a.C).
agressiva politica estera,
cercando di espanderela
Seen
rent rer
erie
end
ene
Sener
everett
eee ay
aren ran
eee ia
Loreen ot
eee
pierre
I vincitori Sparcani si riftutarono infatti di cede-
reall richieste dei Tebani,che volevano vedere rasa
al suolo la polis avversara. II motivo? Quei soldatac-
ci tutti d'un pezzo sierano commoss ascoltando il
canto iniiale dela tragedia: non potevano neppure
pensare di annientae la cite che aveva prodoto an
tabelleza. Evidentemente quella di Pericle non era
solo retorica. Come Faveva definita nel Epitafi per
i caduti del primo anno della Guerra del Peloponnese,
Atene ea davvero “la scuola dell Fllade”, un model-
lo di politica democratica da imitare, ma anche un
centro culturale di prin’ordine, eapace di richiama-
reinteletcualie artist da ogni dove.
“saperi nuovi” nari in Grecia fa la fine del VI
e gl inizi del V secolo trovarono in Atene uno sta
ondinario svluppo: la filosoia in particolare Finse-
rman
FACCIAMONE
UNATRAGEDIA
Asis, Ech
Sofociee Eide
inunquaéro
‘ttocenteso dings
(1790-867.
LASCUOLA
DELLELLADE
Sop iTetodt
Dione cstatonel
seco nips
detficopotvemne
utizto dips
‘and ator ge
{ometschia Sebde
sdtuipde
gnamento di Socrate; la storia, con Erodoto di Ali-
camasso ¢ Tucidide; Poratora politica egiudiziaria,
sviluppatai per la necesst’ del cttadino di parlare
in pubblico nel consiglioe nel assemblea on tibu-
nales, dice Bearzot. influenza di questa cit sull'r-
tee sulla cultura fu enorme, sia nel tempo che nel-
lo spazio. «Filosofia, storiografia, recorca, teatro tra-
gico e comico, ati figurative dell Atene classica so-
‘no un patrimonio che ha atraversato la storia della
cultura, dall'antico al modemno, fino a nois, concha-
dela docente
‘Non solo: nel coevo mondo greco,persino i nemi-
ciambirono invano a imitamea granderza. Comeil
politico tebano Epaminonda, che nel 364 2.C. pro-
‘mise metaforicamente ai suoiconcittadini di porta
Nel IV secolo le rappresentazioni si svolgeneno nel!AGORA,
il teatro fu costruito dopo il CROLLO delle gradinate del pubblico
re sul Acropoli di Tebe i propilei (cio ingresso mo-
‘numentak) dell Acropoli ateniese.Al'epoca,infatti,
nonostante a crisi politica seguita alla morte di Pei
ce (429 aC) calla sconfittamilitare di Atene da par
tedi Sparta lacittacaraad Arena manteneva ancora
il proprio primato culturale. Circa mezzo secolo do-
po, petd, non rusci a reggere una seconda morte ec-
Cellente: quella del conquistatore macedone Alessan
ddro Magno (323 a.C.). Finita nella sfera d influenza
dei grandi regn ellenistic a sua liber scemi di pa-
ri pass alla sua grandezza politica ealla sua impor-
tanza culturale. Casilasplendida Atene di Peril f
ape tasfomarsnllacocente delusion dl poe-
10 Pseudo Dicearco.
‘Maria Leonards Leone
B33
HANNO FATT
#
a
&
#
:
:
+
f
i
H
it
:
i
I
#
ug
B
E
§
3
&
i
A
ae
Q
i
u
i
u ea
a SE HAI PERSO Re UM VAISU DAL 25 AGOSTO
u
O LA STORIA
Caterina de’ Medici, Lenin, Elisabetta 1,
Kennedy... Le biografie di grandi personaggi
che hanno cambiato la storia, in una collezione a
fumetti, tutti a colori e inediti, realizzata da
autori internazionali e storici universitari
HISTORICA
BIOGRAFIE
NEL 3° VOLUME, CATERINA DE’ MEDIC.
la “regina madre” che, per trent’anni, eserciti una
netta influenza sotto i regni dei tre figli. Una figura
controversa, in un’ opera che esamina i suce:
politici e gli errori di valutazione che portarono
alla drammatica notte di San Bartolomeo.
Un’esclusiva Mondadori Comics.
Dal 14 luglio
a soli
Ogni mese in edicola, libreria e fumetteria. Ga PANORAMA
GRUPPO 44 MONDADORI
ALESSANDRIA, o>
capitale del REGNO
di Cleopatra, duemila anni fa
era il CENTRO del mondo Kai So
per RICCHEZZA, splendore, bie
PN WOW ei ;
FARO DICIVILTA
eet)
Pores
Parry
emer
Pron
PTO n
DEGITTO
Per le STRADE si sentivano parlare le LINGUE
pitt diverse: EGIZIO, fenicio, ebraico... Ma LIDIOMA
comune a tutti era il GRECO
AI secolo a, C, era “le prima citté
del mondo civil’: parola dello storico
Diodoro Siculo, uno che se ne inten-
deva,essendo trai pit grandi viaggia-
{ori ed eruditi del tempo. Aveva forse 700mila abi
tanti, strade carrozzabilie acqua corrente, palazi,
terme e tempi rivestit di marmo; andava forte nei
commerci ma anche nella cultura, abitata com’e-
ada uno stuolo di scienriati artist, pensatori. Le
‘mode, i gustie buona parte di tutto cid che di bel-
lo e sofisticato circolava per il Mediterraneo arti-
vaava dali. Ma se pensate che si pari di Roma, sta-
te pronti a ricredervi: a quell epoca la caput muen-
di aveva ancora molt edict in legno e i suoi fast
imperial erano di Ii da venir.
No, ai tempi di Cleopatra gli occhi dei cacciato-
+i di meraviglic erano ancora tutti puntati sull’o-
pulenta eraffinata Alessandria d'Egito, polis greca
sotto un cielo africano, la prima delle molt cit
a.cui, nel 332 a. C, il defunto Alessandro Magno
aveva voluto dare il suo nome. Una metropoli na-
ta dallincrocio di due civil, cosi come la dinastia
ormai declinante che vi regna: faraoni con sangue
greco nelle vene, discendent di quel Tolomeo I So-
tere che fu braccio destro di Alessandro e che otten-
rela terra delle piramidi nella spartzione dellim-
pero del grande macedone trai soi pts fidi gene-
rali, Una schiatta di sovrani di lingua e cultura or-
gogliosamente greche, ma di abitudini egizie negli
aspett a loro pit convenienti, come la concezione
assolutisticae gl attiburidivini del proprio potere.
TetustnanTe. Per il mercante, 'avventurieto 0
il semplice viaggiatore che 2mila anni fa giunge-
va dal mare, il “bighictto da visita” di Alessandria
ra una vivida luce sulla linea dell’orizzonte, vi
bile da qualcosa come 50 chilometri di distanza. [1
suo punto d'origine era un'isola non lontana dalla
costa, chiamata Faro: un nome destinato a durare.
Man mano che la terraferma si avvicinava, diveni-
vano nett i contorni della corre quadrangolare che
eliantichi consideravano una delle Sette meraviglie
del mondo: 135 metr di altezza coperti di marmo
eadomi di colonne di granito. Incima, un'enorme
lanterna dove specchi di metallo concavo ampl
cavano la luce di un fuoco costantementealimen-
‘ato, mediante un sistema di rampe, da legna res
rosa. A collegare 'solae il fro alla costa, una di
ga chiamata Eptastadio per via della sua lunghe-
2a (7 stadi,cio8 circa 1.100 metri)e che divideva
(5)
anche la baia circostante in due spazi per attrac-
co delle navi il Gran Porto nella parte orientale e
il Porto Eunostos (“Del buon ritorno a casa”) in
quella occidentale. Adiacente alle banchine cera
Vechatresis, un‘area duty-free dove le merci in tra
sito non pagavano dato, il che favoriva le ativiea
pitt congeniali ad Alessandria: la vendita, Vacqui-
sto elo scambio.
Mercanti, armatori e banchier erano 'éitcit-
tadina, grazie anche al’ avanzato sistema valutario
introdotto dai Greci nella pre-esistente economia
di baratto degli Egii. «Da lie grandi navi “one-
rare”, cio? mercantili,ripartivano cariche di gra-
no, di schiav, ci merc di lusso verso cute le cited
del Mediterraneo», spiega Fulvio De Salvia, docen-
tedi Egitologia all’ Universiti di Bologna. «Ales-
sandra si pud considerare un mix di quel che sono
ogi New York, Parigie Londra: i gusti ele mode
della Roma imperiale continucranno a formarsi li,
e dali giungeranno gli animali esotici, i vini pre~
jati (addiritcura provvist di un sigilo di “deno-
‘Eintsioce commollan”) profil li ungosse,
il vasellame in oro e argento, le pietre preziose, gli
amu. Ad Alessandria nascet anche leurs
in senso moderno: dalla cittiricchi romani iniz
vano infatiil grand tour dell Egito»
Metropottrant. Nella capitale tolemaica, bru-
licante di vita, gli edifici si affacciavano su un sa-
pientereticolo di vie spaziose, che il genio dell ar-
chitetto Dinocrate di Rodi aveva incrociato ad an-
golo retto per incanalare le fresche brezze marine.
Aooriente della cite cera 'antico village egizio di
Canopus, dove i ricchi alessandrini avevano leloro
ville fuori porta, via Canopica si chiamava anche
il corso principale, largo ben 60 metti, che seguen-
do Passe est-ovesttagliava in duc la forma stretae
lunga del’ abita
La grande arteria costeggiava un po! tutti pu
ti-chiave della citi: il Ginnasio, dove i giovani
bbuona famiglia venivano educati ai saperi ma an-
che allo sport; il quartiere di Rakhotis, abitato da-
ali “indigeni” giz; quello real con la sua teoria
egiardini e, non lontano, le glorie cultu-
ral dell cit: la leggendaria Biblioteca e il Museo
(inteso nel senso antico di “tempio delle Muse”,
tuna sorta di universca) per secoliquartier generale
dd quella schiera di sapienti —da Archimede a Eu
clide, da Eratostene 2 Galeno ~ che fece di Alesan-
ia la numero uno del mondo antico per la ma- »
CENTRO
DIRICERCA,
Rcostusone
ipoetica dina sla
éelMousion
"tempi dela Mus),
comedichiamavale
biblioteca fondata|
sertoTolomeo|
A sON Racks Rural)
eee reer
‘ontenevalla pid grande raccolta
Peers)
antico. Lenotzie giunte fino anot parla
Pe rape ee eter
rete eres
tec
ee eee ene]
filosofo Demetrio Falereo grazie alla
Se Oey
eee renee eee ety
Pe ee ee eee
eee erred
Pee eee
ee een eal
approdatead Alessandria dilasciare una
rere
Pees ee erty
perverse etd
pee ers
rial, ricavato da una varieta di canna
Cer Cea
valavorato e poi seccatoeinfine arroto
Posie ec ete a
Ceca
Portman
poets ere
CY nar
‘ada Giulio Cesare durante Foccupa
porn tae ene
Ce ares en)
eee
Pe eee ed
pee peared
ee ec
‘radizione, furono usati come combust
bile peri bagnitermalidi Alessandria
PALAZZI REALL
PORTO REALE
La citta era divisa in tre GRANDI ZONE: le
residenze reali GRECHE, il quartiere popolare
EGIZIO e un vasto insediamento EBRAICO
tematica, la geografia, la letteratura ela medicina.
‘Ovunque, in giro, un immenso ed eterogeneo
viavai multietnico: viaggiator fenici, italici, noma-
diarabi, persian, fticani, persino qualche indiano,
Non mancano gl Ebrei, parecchi dei quai vivevano
in un quartiere tutto loro; ma non si trattava i un
ghetto, Minoranza influenteeintegrataal punto da
saper parlare ormai solamente il greco, lingua nella
quale tradusse anche la Bibbic (la Famosa versione
“dei Setanta’) i igh di Sion trapiantatiad Alessan-
dria godevano di moltiprvilegi normativie iscali in
Vint di talenti che i rendevano car i sovrani: non
quelli di mercantio banchier, come vuoleilvecchio
Tuogo comune, ma di valent soldatinell'esercito ~
tutto mercenario dei Tolomei. E
Acasa loro erano ormai citadi
tun ruolo subordinato a quello dell’éize macedone.
‘Serarari an casa. I Tolomei non si presero nep-
pure la briga di imparare a loro lingua; solo 'uli-
ae
‘ma regina, Cleopatra VIL, fece eovezione alla rego-
la, Ne resto del Egitto i matrimoni mist tra colo-
ni greci e popolazione locale non erano poi cosira-
1, maad Alessandria e negli altri due grandi centri
greci di Tolemaide e Naucrati questi sconvenien-
tissimi connubi erano proibiti per legge.
Inativi che volevano fare cartira studiavano nei
ginnasi, parlavano greco e soprattutto vestivano
all'ellenica, con tunica (bimation) ¢ mancello (i
chitone), si arricciavano icapeli asciavano latra-
dizionale tunica egizia di lino ai fellabin, i “conta-
dele" che coltivavano le terre demaniali, e ai
sacerdoti
‘Aggiungevano persino un nome ellenico al pro-
prio, e cosi facendo questi quasi-greci dalla pel
Te olivastra riuscivano spesso a piazzarsi nei gra-
dini medio-bassi della corte e della complessa bu-
rocrazia dei Tolomei. I ruoli di spicco, perd, era-
no sempre per loro, gli ellenici, che erano anche
TEMPIODIISIDE
' LA VECCHIA
aa ALESSANDRIA
agian
aantia
‘Nlesanda cont
suo quarter su
base emia.
BOULEVARD
Reosruaone
ipoeticad una
elev principal
PIAZZA AFFARI
[ala Ducle
Veneia cuore
polio fansirio
ela Sereisina,
inn dipinto
otocenteo.
Latino, il veneto e ! YTALIANO (che allora era il FIORENTINO)
storia, non cerano grandi differen tra rcchic pove-
riedove persino al vescovo veniva negato il privilegio
di abitar in centro. La basilica pit importante della
citti, quella di San Marco, non erala sede vescovile,
‘mala cappella del doge. El tesoro diSan Marco non
cera controllato dalla curia, come succedeva nel resto
«Europa, ma direttament dallo Stato veneziano. An-
che perché il vscovo di Venetia, il pariarca, non era
rnominato dal papa, ma dalla repubblicastessa, Lu-
nico simbolo religioso riconosciuto era quell di san
Marco, evangelist le cui spoglie vennero trafugate
dda Alessandria d'Egito e porrate a Venezia nell $28
Maquello che dava un valoreaggjuntoallacittaerala
sua flo grazie alla quale nel gio di qualche secolo
cttenne il dominio dell Adriatco ei giro daffar sul-
le rotte del Mediterraneo Orientale comincid a cre
scere. Le gale, tipiche imbarcazioni veneziane (vedi
pagina squente), cariche diavorio, grano, sea, prof
‘mi, speze, veto schiav,facevano la spola taimer-
catid Oriente ei resto d Europa
Veneziant b'OntENTE. Ogni cittaing era libero
dl trasferis in qualsias cit della repubblica o nelle
colonic situate nei pttimportant centri commercial
Oriente. Quando, nel 1082, Fimperatorebizantino
Alessio I Comneno, in cambio del sostegno alle sue
imprese militar, eoncesvea Venezia te banchine nel
porto di Coscantinopol e treancoragginellinsenatu-
adel Como d'Oro, oltre a privilegs fiscal, il nume-
rodivenezianili resident raggiunse le 100mila unit:
‘anti quanti vivevano in Laguna, Ma il periodo d'oro
dei rapport con F Oriente fa tail XV cil XVI sooo-
lo, quando si consolidé la rete diplomatica. Le igu-
re pit influent crano gliambasciatori della Serenissi-
ma cei bail (dal latino baiudus“teggente"), governa-
tori delle comunita mercantiiallestero.
“Tra quest spicava il bailo di Costantinopoli, che
aveva una corte privatae rsiedevain uno splendido
palazzo sulla collina di Galata. Le visite diplomatiche
avevano diverse motivarioni:dallascesaal trono diun
sultano a un matrimonio di core, ma favvenimento
pitt importante era incontrouffcale conil sultano,
scandito da ritual che andavano dal oferta di cibo
allo scambio didoni diplomatic. I pi rchiesterano
gioiel,scarpe, stoi, veri di Murano e il parmigia-
no eggiano (dettoallepoca“formaggio piacentino’),
(CervEntt pa esrortazione. Nel 1480 fi chie-
sta “in dono” persino la maestria del pittore Gentile
Bellini, cuivennero commissonatiirtrati del sulta-
no Maometto IL, Pit tari furono invitat sul Bosfo-
roanche Leonardo da Vinci e Michelangelo (mai due
non vi approderanno mai), atestimonianza di quan-
‘widue mondifossero in contatto tra loro. Nel 1551
sorseaCestantinopoi una scuol tute per de
tranai (medio inguii!” veneran) che van-
tavano un ruolo importante nelle tratative uficial.
‘Turns Lacuna. Atirati dalla posibiliti di com-
‘meri (elauti guadagni) si stabilirono a Venezia moti
stranieri provenienti dai Balcani edall’Europa Cen
trale, ma anche emissariinvat da calif esultani per
trattare questioni politiche e commercial. In po-
co tempo questo continuo passaggio di gentie cul
ture diverse decret il dffondersi di una moda tut-
ta particolare, ancora rintracciabile nell architett
raorientaleggiante che domina la cit’ (il cosiddet-
to gotico-veneziano), nel vestiario (caraterizato,
nelle class pitt abbienti, da preziose sete) ¢ persino
EO TUL LK]
I
Pao)
Cee
Pecan
paper er a
eres
eras Deeg Ee
rer
Se yar
ener eras
ey
Neen
cae en
plessa.
eeneerty)
eraser
Questieleg
poses ee
oie
Perera ari
preree iced
Speen eee
arent ie
ees
Pee et
ras?
vergae
La DECADENZA acceleré nel’600, quando i grandi
IMPERI COLONIALI europei IMPOSERO Le loro regole
nella cucina (i veneziani furono tai primi ad apprez
zareil spore inconfondibile del caff,artivato dall A
sabia a Costantinopoli a meti Cinquecento e poi
csportato in Laguna).
Inoltre gli ambasciatori oriental, che considerava-
noglianimaliesotci uno status symbol, cominciaro-
no portarlin cit, dalle loro tere, come prestigioso
dono. Fu cosi che Venezia si popold di leoni, giraffe,
clefant,rinocerontie pantere. A partite dal XVII se-
colo, poi la presenza di diplomatic ricchi mercanti
oriental i fecetalmente massicia che fu messo a lo-
1 disposizione un intero palazzo, poi detto Fondaco
dei turchi (dallarabo fiendug,“casa-magazino”) do-
ve soggiomavano e concludevano affari.
I SEGRETO DEL suCCESSo. Venezia nei secoliera
riuscia a piazzare i suoi uomini chiave nelle capital
Oriente, ma asua volta era stata in grado di acco-
afer etnie e culture da tutto il mondo: dai
‘ati musulmania una forte comunitaebraica (ospita-
tadal 1516 nel Ghetto nuovo), passando per armeni,
grec in seguito anche persian, trasformandos cos
in quella che oggi definiremmo una cit multicultu-
sale regolamentata da leg “illuminate”
LeCIME deena
eranocostite
concanapa che Venezia
imporava da aa,
cdsarusasul Don,
Detrolosperone HH
era una 0nd pote
deta PALMETA, perle
rmanovre dionmaggioe
iancoaggo.
YF
Gli scranieri che vivevano in cited per un lungo pe-
riodo crano temutia pagarc ke tasse, ma al tempo stes-
so potevano aspire allacittadinanza ea una posizio-
nedi ilevo, Una delle carattristiche di Venezia, in-
fat era proprio la mobilita sociale.
‘Affari enotzieprovenienti dalle corti dutta Euro-
paed Orientes'incrociavano sempre qui. Lasua posi-
zone seategica, stuata nel punto pit interno dell A-
diatico, aveva fatto della Setenssima il croceva idea-
lefia Occidente e Oriente, maanche fa Nord Europa
Mediterraneo: infatile sue caratteristche “Risiche”
cerano un effciente miscugio ta una cited mercantile
del Nord Europa e un porto meridionale. Sea cid si
aggfunge la tolleanza religiosa indotta dal senso per
gliaffai, si capisce il segreto del suo success.
Lastoria dll cit prosegu cos finché nuove rotte
siaprirono dall Europa verso le Americhee altri con-
tinenti, Fu cos che ini Tinesorabile dectino di Ve-
nezia: perdendo il dominio dei mari sindebol pro
grcsivamente, ma il colpo di graza artivo nel 1797
con invasione delle ruppe napoleoniche che spars
via a repubblica pit “serena” del Mediterraneo, *
Laue Brambilla
{ALBEROdimaesra
raat cia met
Dal seconda meta det
WVsecolod aggiunse
unalberd pra.
ANTENNA dunga
‘aot comelintera
nave) sosteneva
lavealtna ie‘
‘tna tangle
Unavotefamole
‘aleeranoriportate
altasenaleperle
ARTI EMESTIERL
1.Aristtaganoe
lavorozanne
‘oro imporate
aia dlc
2Ipeliciais
forma inuna
sevolaapposita deta
alVarte
3 Tnteiallavoroin
mapa dd
‘Dopo Firenze Venetia
ala plaza principale
‘Unlibraioinuna
‘afiguation del
‘Soi tipogafo Aldo
Manuze inroduse
Importantiimovazion
Inqueso store
PONTE dipoppa
servi peririposo
daequpaasia.
Settocopetacerano
rmunzione do.
(Gk ufciaie given
pti alien stavano
POPPA, protet dalle
intempetieconun
tendon clea
ECR Re CMe MK | RSCuISSIUL
Cree ore)
era vento. Lunga dai 35 ai
ee err
|
Pee eee Tear
red
ern Say
oe)
I PITTORACCONTO
A CASA DEI
PATRIZI
VENEZIANI
Le nozze di Cana di Paolo Veronese
(1562-63) ¢ uno dei capolavori dell'arte
italiana, ma anche un campionario del
Lusso esibito in un sontuoso banchetto
patrizio del tardo Rinascimento
uNapoleone, dopo aver sconfitto la Serenissima nel
I 1797, a portare in Francia Penorme tela (10 mecti
Ai base per 7 di altezza) oggi conservata al Louvre di
Parigi. Il quadro fu realizzato per i benedettini del
monasteto veneziano, sull’sola di San Giorgio Maggiore.
Extratuss0. Ilsoggetto&tratto dal Vangel di Giovanni c
descveil non reco di Gosh uraate ws penta niaale
Cana, in Galilea: la trasformazione in vino dell'acqua. Ve-
ronese, perd, ambient il eurto in una ruilante festa del suo
tempo. Bl risutato fu la “fotografia” di un pranzo lussuoso
del Cinguecento: uno di quelli che allieeavano, al suono della
musica da camera, la vita sociale delle pitt opulente familie
patrzie della ceed lagunare. Cosi i monaci, che mangiavano
insilenzio ascoltando la letura di passi delle Sacre Scritture
meditando, alzando lo sguardo dalle loro tavolateammirava-
no il usso che imperava fuori dalle mura del monastero. — *
Edoardo Monti
1.L0$P050indossa una vests
damatctascaloata secondo | -————____
tdetanidelamedsdeltempo, | {4 Acuninitstiindosano sbi
‘ccompagnata da nar che || ‘allt comel AFFETTANO.
Sernadistinguereghuomini || Eilsegrodeileganivala
dle csileate Serena elcatotamana
2. LeARCHITETTURE del tempo
sleflacevaro alfa greca
‘romana secondo esempio dt
‘Andrea Pala (1508-1580,
5. Neppure sulle taal pit
‘che commensal ave
proprio biechiee | SCTT
rempianol alice, che poi
715)
cheprogetéancelasalache organo achilorichiedeva,
‘spar latel.
r ‘6.Lefamigh patric veneine 7.Unuomo mostra dela {1 maestro dcrimone lo
3.IraviCALICINVETROerano uno | | avevanospessoasenizioSCHIAV| | | FORCHETTAalyina perpeso SCALCO eal igri importante
eiprodticiuso dela Venexia | | saace tartar rusiorecie Questa posta scondola delbancheto.Nesovtintendeva
‘anquecenesa Lafamadeveval | | circa Lispoteva acquire radon) sarebbe sata ‘uttelefs, dla sceadel mend
(specie di quel Mure) st alleast press Rate, doves introdottaa Venez da Bisancio alfordine delle porate ecoordnava
affeme presto in tutta Europa. ‘wovavan merc. rel Asecla. ilavoro del servo
12.Dala meth del Gnguecen
‘Trai MUSICIT| alent, Venexia venne uno de pinpal
sarebberoriratiostssoVeronese | | 10.Noti anchetraipaia, 11teleganteservtorecheesamina |_| cetitakanperlaprodizione
(inianco, ala viola da gamba, rmangiavana con ema. Un iio COPPIERE.Eraluiche | | eiTESSUTIdiaka qualita come
Taian in 50 con Ivilone, Servtore detoTRINGANTE era | | spettaveconserareedegustare | | velutebrocat rapincpal
anteato del corrabbsso)e addetoaltagldellacarein [vin da serve Mas orupava ‘mera desprtasione cer quello
‘Tatoretoconfalra vil orion daportareala boca anche diconrlaeacqua. damper ottomano.
Lama)
ITALIA
ee es
DELLE
Come VIVEVANO e lavoravano gli artisti nella culla
del RINASCIMENTO italiano: le BOTTEGHE, i rapporti
fra “ragazzi” che si chiamavano LEONARDO 0 Botticelli,
e il ruolo dellarte nella citta dei MEDICI
Cdddéddddddyyyy,
cuoRE
DELLA CITTA
AFIRENZE ke botteghe
erano persino troppe: cerano
pit INTAGLIATORI che
MACELLAL E ta loro non
si contavano le invidie
evrotici, appassionatie passionali, par-
ticolarmente sensibili, soggeti a colle
a improwisae sbalzi d'umore, per lo
pitt amanti della solitudine e del silen-
2io: anche nel Quattrocento fiorentino, un po! co-
‘me oggi, gli artistierano bollati come persone dal
carattere eccenttico, capriccioso e stravagante. Ma
‘non immaginiamoli osannati proprietari di eleganti
atelier, nésnob anfitrioni alla loro ultima personal:
ali artist inascimental attvi a Firenze tail 1430
e il 1530 erano “operai del bello” e a loro bottega
tuna specie di officina, in cut il lavoro si svolgeva or-
ganizzato come in una piccola impresa familie, di-
Viso tra apprendist, garzonic assstenti.
Mantin asta. Non sipoteva scappare:chiungue
volessecimentarsi con Parte doveva sporcarsi le ma-
ni, Persino un genio come Leonardo da Vinci ave-
va passatoalcuni anni chiuso in una bottegafioren-
tina: quella, famosissima, di Andrea del Verrocchio.
E non fu unica star a uscire dali: nel pit impor-
ante atelier della Signoria dei Medici, nave scuola
dei miglior arcs rinascimentali fiorentni, crebbe-
+o infatilo scultore Giovanfrancesco Rustic pit-
tori del calibro di Pietro Perugino, Domenico Gh
landaio e, per un breve periodo, Sandro Botticelli,
Cos aveva di speciale il aboratorio del Verrocchio?
Soprattutto la polivalenza. Andrea aveva compiuto
il suo apprendistato da un orafo e per questo posse-
ddeva conoscenze tecniche sfrutabil sia nella pitura
sia nella scultura. Basandosi sulla propria esperienza
fece una selta precisa: mentre i sui colleghi cerca-
vano di difendersi dalla concorrenza
nel suo atelier abbraccidecetti-
cura, scultura, oreficeria: a bortega del Ver-
rocchio sfornava opereartistiche di qualsasi genere.
Senon era impegnato su qualche cantire, ogni
giorno il maestro lavorava cn i suo‘ apprendistfin-
chéla luce lo permetteva,circondato da una mobilia
che chiunque non fosse del mestiereavrebbe giui-
cato quanto meno stravagante. Da una parte tao
dilegno, con ifilitesia formare una griglia quadret-
tata, che serviva a studiare la prospettva di oggetti
e figure da disporre sul dipinto, da ualta gi stru-
‘menti per a fsione del bronzo, i materalinecessa-
ria prepara i cartoni per gli affieschi, i pennellie
le tempere. Spars qui li alcuni manichini, spesso
715)
copert di drappi, per osservare i panneggeidiver-
siatteggiamenti del corpo umano.
Porte aPERTE. Imparare a usare questi attezi ¢
a muovers con scioltezza in un ambiente simile r-
chiedeva una lunga preparazione. Secondo il pitto-
re Cennino Cennini, autore del Libro dellarte, un
rmanuale di pittura, liter formativo ideale durava 12
anni: durante i primi set il agazzo doveva apprende-
rele basi dell'arte, ne successivi avcbbe dovuto col-
laborare con il maestro, continuando a perfezionarsi
fino ai 25 anni. Con la maggiore ct, infati, gli era
concessoiscrivesiallacorporazione di mestiere edi-
ventare un capobottega. Questa la teoria: in pratica,
per, il petiodo diformazione poteva essere pitt bre-
ve, come nel caso di Michelangelo Buonarroti, che
:malsopportdilsuo apprendistato dal Ghislandaio di
soli tre ani. «Chiunque, anche senza una prepara-
2ione specifica, poteva entrare a bortega: la decisio-
ne veniva dal padre, di solito unarcigiano o un com-
‘merciant, per seguire una predisposizione del fglio
con lasperanza i migliorame lacondirionesocia-
les, spiega Leandro Ventura, che hainsegnato Teoria
e Storia dela Produzione e della Committenza Ar-
tistica all Universita Ca’ Foscari di Venezia. oll ma-
ALLEPOCA
DILORENZO
Ecocome appatva
Firenze ne pleno
{el suo siluppo
economico eats,
rela Pant dela
‘tena mappa
11470 Fsm9
‘ucessnoalariva
poteredelMagnitico,
JFIORENZA }
stro offivaalloggio,vestiario ¢ un slaro al ragaz-
20, che in cambio si impegnava a essere obbediente,
puntuale, rispettosoe volenteras0».
‘Zero TEORIA. Ma niente banchi e libri di storia
dalfarte: Finsegnamento era esclusivamente prati-
co. Gli apprendisti cominciavano imparando a im-
pastare i pigmenti per ottenere i colori a trattare il
fondo dela tavola da disegno, prima di usatla, con
uno strato di gessoo stucco, a hucidare i manufatti
in bronzo, Ma soprateuto si esercitavano anche nel
tempo libero, copiando instancabilmentei disegni ¢
le opere del maestro ole culture classiche, Solo cost
potevano passare alla fase successva: la realizzavi-
ne, partendo dagl schizi preparatori del capobot-
tega, di modeli a grandezza naturale da traserire
sulla tavola, sul muro o sug arazzi prima di mette-
remano ai penne. Spesso gi alliev pit brav fin
vano anche per dipingere al posto del maestro: au-
reole, panneggi e vest lci e ombre a cui poiil Ver
rocchio dava soltanto il occo finale.
Discerout & marsrnu. «Gli statuti delle corpo
razioni imponevano un numero massimo diallivi,
in genere sei, per evitare lo sfruttamento del lavoro
giovaniles, sottolinea Ventura. In gener il rappor-
to che sicreava tra l'apprendistaeil maestro, spesso
scapolo esenza fig, era davvero forte:al punto che, >
Nelle corporazioni ognuno aveva il proprio posto. Tranne gli artisti
een)
cnet ee
Fa
preety
ero
_
Peer neerinty
ee Snen sepa
capone
one ee
ere
ratianello di congiunzione
Pees es
Lorenzo DE’ MEDICI manteneva i suoi artisti anche
quando non lavoravano per lui, pagando dei SUSSIDI
proprio come fece il Verrocchio, da adulti molti di
loro prendevano il cognome non dal proprio padre
rma dall'uomo che liaveva format in bottega. Cer
to, gliscrezinon mancavano, soprattuto nel prover-
biale caso in cui allievo avesse superato il maestro:
secondo Giorgio Vasari (1511-1574), quando vide
che nel Batesimo di Cristo angel dipinto da Leo-
nardo era molto pia bello dele altre figure, “Andrea
‘mai pie mon vole taccar colori, sdegnatosi che un fan-
ciullo ne sapese pedi lu.
In realti all epoca del Battesimo sembra che Da
Vinci non fosse pit apprendista, ma uno di quegli
aris gitformati che gravtavano attorno alla bot
tega per aiutat il Verrocchioin opere specifche, in
sieme a ora, scltor di bronzo ¢ petra pittori au-
‘onomn, legati alu da varie forme di collaborszione.
Nessuno perd si lamentava di questi che ogg defi-
niemmo “lavori a progetto”: era evidente, in~
fatti, che leborteghe arte a Firenze fos
ro gid troppe. Intorno al 1470 i nume-
ro dei soli intaglatori superava quello
esi grt
te, esisteva escatenava quelle che
il Vasari defin le “lingue malevo-
le degli artist”, prontea spartare
dei colleghi.
Conmrrrenti in FILA. Bisogna dite che, come
ogni legge economica insegna, tanta offerta era mo-
tivata dall'enorme richiestafiorentina. Quadri, af
fieschi, pale altar, vetrate,sculture picole e gran-
di, cassoni decorati, aazicipini venivano ordinati
da commitentisia pubblicsa privat. Da una parte
il governo della Signoria, Arte della lana (la pote
te corporazione dei lavoratori della lana) e la Cal
mala (la icca corporarione dei commerciantie mer-
canti) che finanziavano le grandi costruzioni cit
dine, come il Duomo, il Battistroe il Palazzo del-
la Signoria: dall'alta i membri delle classi ricehe e
istruitee della borghesia che ne finanziavano le de-
Che cosa li spingeva? La devozione, o meglio la
convinzione che le spese destinate aedificareea de-
corare chiese ¢ conventi fossero gradite a Di
Ma anche una maleelata vanitl: un
dificioo un affresco in cui com-
pariva lo stemma di famiglia ©
il proprio ritratto davano al
committente la garanzia di
sssere ricordato anche do-
pola mort. "Cupido pri di
fama che di rob, simese in
‘anima di fare un edifizio che
aséeatuttiisuoi in lala e
fuori dese nome’, seisse Lo-
renzo Strozzi di suo padre
lippoil Vecchio, banchiere che
dopo anni di sili fee ritornoa
Firenze ediede il viaalla costruzio-
ne dellimponente Palazzo Strozz, alla
facia de vali Medici
I pit facoltosi sentivano il mecenatismo come un
dovere di classe ¢ consideravano 'investimento di
denaro nelle pit grandiose imprese artistiche un im-
portante prvilegio che rendeva grande a cit. Lo-
renzo de’ Medici and® oltre, inviando i suoi miglio-
ri artist allestero, come ambasciatori cultural di
Firenze. Al potere dal 1469, il Magnifico fu davve-
ro amante dell'ate, capace di apprezzame il valore
estetio edi collezionasla per puro piacere personale.
Oncociio n’autorE. Pittorie scultor, grazie al
loro successo, cominciarono a prendere coscienza
del proprio valore. Ea rivendicare nel loro lavoro i
ruolo centrale del talento, effet di
emancipazione delle arti figurative: prima conside-
rate parte delle artes mechanicae medioevai, cio’ at-
tivita prevalentemente pratiche, la pittur, la scul-
‘CAPOBOTTEGA
ATTIVISSIMO
Neltondo Pio
Perugino(448-
1523, Pitorealievo
elVeocehn fs
asuavokatitolare
‘idueboteghe 2
FrenzeeaPerugia.
‘Ais vorazione
{éellegnoinbrtga
‘arpentie escutort
facevanopare dell
stesacorpoatone,
NELLA CASA FIORENTINA
Per le vie della Firenze tra il
Quattrocento e il Cinquecento
iva un grande fermento grazie
Si,
bi
uone C0)
RISVEGLIO.
GASTRONOMICO
Silletavole dele
esonepitaite
AFFACCIATI
SULLASTRADA
Macel sart,
Fabbri mail,
‘vendita
cappalicerana solo
dled del mest
patatin et.
Lebotteghe jincuse
aqueledare eno
Alveldella sada,
STRADE
BRULICANTI
Pere strade non
cicolavano solo
veditor ambulan,
rmaanche musics,
izioni economiche
‘ALAVORO
INCAMERA
‘Mute pianos
tuovavaspeszols
camerad lta.
Perales
ceraancheun
‘ura earchitettura entrarono nellorbita delle artes
Uberales le materiein cui prevaleva la creazione in-
telletuale», conclude Ventura. II nonno del Magni-
fico, Cosimo de’ Medici, laveva gid capito mezzo se-
colo prima: “Levcllenzedegh ingegni rar sono forme
celeste non asni vetturini’,diceva.
‘Mai membri appartenentialle classi superior pro-
prio non riuscivano a vederla cos, sopratturto quan-
do erano i loro fil ascegliere quella “degradazione
sociale”: era voluto, infat, intervento del Magni
fico perche il padre di Michelangelo, un patio, si
convincesse che scultore e scalpellino non erano la
stessa cos an
E forse per quella mancata accettazione patita da
giovane, proprio il Buonarroti fu uno dei primia
pretenderecon violenza, persino dal pontefice, quel-
fa considerazione che dopo la meta cel Cinguecen:
to gli artistiavrebbero finalmente ottenuto. Nono-
stante, o proprio in vrei, del loro caratteraccio. *
‘Maria Leonards Leone
Ba
I ARCHITETTURA m
=
Fu la prima
ARCHISTAR
della Storia e con
il suo GENIO
diede il via al +
RINASCIMENTO: E
ecco come fu costruita
a FIRENZE la Hai
“cupola impossibile” 2
ane, melone e Trebbiano a 42 metti di al-
tezza. IL7 agosto 1420, gli scalpelini e i
muratori della chiesa di Santa Maria del
fe, a Firenze, celebrarono cosi lo sto-
rico momento: dopo mezzo secolo di progettie ri-
pensamenti, stavano per cominciare la costruzione
dallenorme cupola. Appollaiati sul tamburo ottago-
nale su cui sarebbe sorta enorme copertura, pote
vano vedere ai loro piedi,disseminati ovunque nel-
la piazza antistant, parte dei materali che sarebbe-
ro serviti: un centinaio di abeti di 6 metri ciascuno,
il primo dei mille cari di piete previst e decine di
travi in arenaria.
BRUNELLESCHI
Nessuno di loro sapeva in che modo avrebbero ti-
rato su ultima parte del Duomo, laptilargaealta
cupola mai costruita fino adallora. Nessuno,tran-
ne il eapomastro Filippo Brunelleschi. Lui almeno
tuna vaga idea ce Faveva. Peril resto era soli dire
che “le pratica insegna quel che si ha a seguire” La
sua fa una sfida alla statica, alle conoscenze tecni-
che dell epoca, all'achitertura medioevale che gra~
zea lui spalancd la porta al Rinascimento; ai pre~
giudiz alle critichee alle rivalith personal dicom-
rittenti ¢ colleghi E, anche se gli ci vollero ptt di
15anni, Parchitetto, scultore eorafo fiorentino ne
usd vincitore.
ce
ty
ee ad
Ree
‘ Rect
See
eater
etree
La COSTRUZIONE della cupola fu una SFIDA alle
conoscenze TECNICHE di allora. E fino allultimo Brunelleschi
non RIVELO come intendesse REALIZZARLA
It soGNo ot una vita. Era un'impresa in cui si
era cimentato,almeno con la fantasia, fin da adole-
scente, quando da casa sua poteva osservare il can-
tiere della cattedrale, vicinissimo. La prima pietra
del Duomo era stata posata nel 1296, 81 anni pri
sma della sua nascita el fi
to intere foreste per ricavare il legname delle ravi,
aso al suolo un quartiere, due chiese e spostato le
sepolture intorno al batistero di San Giovanni per
far posto a quella che doveva diventare un simbolo
economico, pit che reigioso, della grandezza di Fi
rence», scrive Ross King, autore del saggio La cupo-
adi Brunelleschi (Bur)
La nuova cattedrale crebbe per pit di un seco-
lo, con quel buco enorme sopra Valtare, come
tuna vecchia rovina, Tutti erano concordi: la cu-
pola era il maggiore ostacolo alla costruzione, un
satin avevano abbateu-
gigantesco rompicapo architettonico apparente-
‘mente senza risposta. In che modo si poteva rea-
lizaare una struttura di oltre 44 metri di diametro,
Ia cui curvaturasarebbe iniziata a 52-meti di alter
za? La centina cio? Fintelaacura di legno impiega
tain genere per sostenere archi volte durante a co-
struzione, in questo caso sembrava davvero troppo
grande, costosa e inadeguata
In Gara. Nelfestate del 1418, quando ormai al
Duomo non mancava altro che la cupola, il pro-
bblema non poteva pit essere ignorato: Opera del
Duomo, amministrata dai membri dell Are della
Lana, la corporazione commerciale pit potente di
Firenze, bandi un concorso per trovare la proposta
migliore. Di tutti progetti presentati il pit ardito
era sicuramente quello di Brunelleschi:il geniaocio
toscano sosteneva infatt di poter fare a meno del- »
OOK aaa kre neal yee)
es
nee ena
ey
eee ae
Serres
ee ene)
Pneereret een
ree
eee
abottega da un orafo. Qui
a
Dee)
pea ener]
19g creando
ee ny
eer
Peay ee
SLANCIATA
Unaprocesionein
plaza del Duomo
afienze(on la
{acct original.
LuLTIN
SGUARDO
Lamored
Brunelschinun
pit inlese
<2 200:secandoit
Vast igeniinfin
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (347)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Language of DickensDocument17 pagesLanguage of DickenshistoriadigitalNo ratings yet
- Focus 2015 OtoñoDocument148 pagesFocus 2015 Otoñohistoriadigital100% (1)
- Little, Lester K - Rosenwein, Barbara H. Ed. - La Edad Media A Debate - Cap 12 PDFDocument16 pagesLittle, Lester K - Rosenwein, Barbara H. Ed. - La Edad Media A Debate - Cap 12 PDFhistoriadigital100% (1)
- Little, Lester K - Rosenwein, Barbara H. Ed. - La Edad Media A Debate - Cap 06 PDFDocument12 pagesLittle, Lester K - Rosenwein, Barbara H. Ed. - La Edad Media A Debate - Cap 06 PDFhistoriadigitalNo ratings yet