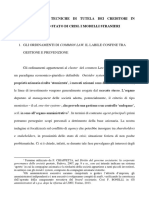Professional Documents
Culture Documents
Campanini - Islam e Politica
Campanini - Islam e Politica
Uploaded by
andrea0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views13 pagesbello
Original Title
Campanini_Islam e Politica
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentbello
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views13 pagesCampanini - Islam e Politica
Campanini - Islam e Politica
Uploaded by
andreabello
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 13
MASSIMO CAMPANINI
Islam e politica
IL MULINO
Presentazione
Papprofondimento delle tematiche politiche fornisce un aiuto
non indifferente per sfuggire a quei pregiudizi anche al
Vignoranza che troppo frequentemente ci consegnano
dell'Islam una rappresentazione deformata
cristiano vengono
ispondenza dig
PHegiea (es, 1 [622
te nel testo tra
le del calendario
entesi quadre
musulmano a partire d
10
CAPITOLO PRI
Islam e politica
In un celebre passo del primo libro della Metafisica,
Aristotele sostiene che
i uomini C.J hanno preso dalla meraviglia lo spunto per flosofare,
poiché dapprincipio essi si stupivano dei fenomeni che erano 4
tata di mano e di cui non sapevano rendersi conto, (..] Chi &
nellincertezza e nella mereviglia erede
percid anche chi ha propensione per le leggende
ual modo, filosofo, giacché il mito & un insieme di cose meravi
sliose);e quindi, se € vero che gli uomini si diedero a filosofare con
{o scopo di sfuggire allignoranza, ¢ evidente che essi perse
la scienza col puro scopo di sapere e non per qualche bis
pratico (Metaphysica 982b)
Le motivazioni della nascita della riflessione razionale
nell'slam sono piuttosto diverse da quelle suggerite da
Aristotele. La filosofia non @ sorta tanto dalla curiosita 0
dalla necesita di tazionalizzare e di scoprire le cause dei
fenomeni, A questo bastava ~ ¢ basta tuttora al musulmano
integrale ~ la parola rivelata, ché Dio, nel Corano, ammoni
sce: «In verita, nella creazione dei ciel e della terra e nell'al-
ternarsi del giomo e della noxte vi sono segni per quei che
han sano intelletto, i quali rammentano il nome santo di Dio
in piedi, seduti o coricati sui fianchi e meditano sulla crea:
zione dei cieli ¢ della terra cosi: “O Signoré! Non hai creato
tutto questo invano!”» (3: 190-191)".
L’onnipotenza ¢ la volonta di Dio sono pitt che suffi-
cienti a spiegare i perché cosmologici o metafisici. Piutto:
sto, dalla necessita di risolvere problemi giuridico-politici
che & stata stimolata Pattivita speculativa, Oliver Leaman,
* La teaducione del Corano @ sempre di Alessandro Baussnis ct. la
Bibliograia
u
Islam e politica
ad esempio, ha sostenuto che «le problematiche filosofiche
teologia islamica (il kaldm) senza un’appa-
ente connessione con la filosofia, ma piuttosto in dipen-
denza da un raffinamento delle categorie tipiche dell'argo-
mentare giuridico-legale». E un’idea la cui formulazione &
da far risalire forse gia a sit Hamilton Gibb: «Le origini
della metodologia (della cultura intellettuale musulmana]
debbono essere ritrovate nei problemi pratici con cui la
comunitd ebbe a confrontarsi, piuttosto che in una qualsiasi
tendenza filosofica
Cid & accaduto, da una parte, perché, prima ancora di
assorbire le allogene, e pitt mature, civilta della Siria, del
VEgitto o della Persia, gli arabi conquistatori mantennero
viva l'impostazione ideologica che il Profeta Muhammad
wveva impresso alla sua comunita (mmab), facendo previ
lere I'etica sulla metafisica, il governo della citta ¢ deg!
uomini sull'interrogazione degli orbi celesti: «ln veritd Id
dio ordina la giustizia, la beneficenza, Pamore ai parenti, ¢
vieta la dissolutezza, il male e la prepotenza: Ei vi ammoni-
sce, che abbiate a meditare» (Carano 16: 90).
‘Dialtra parte, perché quando si incontrarono con le
civilta dei paesi conquistati gli arabi stavano gi entrando
in possesso di una propria metodologia conoscitiva, ancora
in fieri, certo, ma fortemente caratterizzata e specifica: ne
sono testimonianza le discipline della retorica, della gram-
matica e della dialettica, particolarmente congeniali al sen-
tire arabo; le scienze delle tradizioni profetiche (hadith) €
del diritto (fiqh) derivate quasi per filogenesi dall'insegna.
mento del Profeta e dall’imitazione dei suoi ati (sunnah),
Si potrebbe sostenere ~ invero un poco iperbolicamente
tunica filosofia caratteristicamente «islamica» sia la
politica (siydsab): ma cid proprio perché la scienza politica
dipende da un input religioso. Invero, ci si pottebbe chie
dete se la politica & una dimensione della religione 0 la
jone una dimensione del politico. Non é possibile scin
dere i due termini 0 trovare reciproche antecedenze. La
teligione, pur essendosi sviluppata secondo canon politici
vanta una priorita, per cost dire, qualitativa perché costitui
sce I'asse attorno a cui si organizza il mondo islamic
12
Islam e politica
via, la politica conserva una sua autonomia, Si tratta, in
Islam, del problema ambivalente della siydsah shariyah, della
‘politica secondo la Legge teligiosa (sharizb)». Il termine
«politica» (siydsab) attiene al governo che sta oltre il campo
intervento dei giudici (gadi), e dunque al potere istituzio-
nale dello stato. Tutti i teorici musulmani si sono trovati pitt
0 meno d'accordo nello stabilire che la siydsab deve ispirar-
sialla shari‘ah ma non tuti perd hanno condiviso Videa che
la siydsab deve pedissequamente ripetere la sharf‘ah: que-
st'ultima costituisce I'orizzonte di riferimento della siydsab,
per la quale ci pud essere perd uno spazio di intervento
autonome. Il teologo hanbalita Ibn Taymiyyah (m. 728
(1328]) introdusse al proposito un criterio di intenzionalita:
‘intenzione etica, infatti, cio’ la prospettiva del comuné
bene sociale, risulta prevalente per determinare il governo
secondo la Legge religiosa. Queste osservazioni conducono
alla singolare conclusione che la politica, pur dipendendo
da un input religioso, rimane una realta «laican.
Cid potrebbe sembrare paradossale, ma solo da un pun.
to di vista eurocentrico. Nell'Islam, il sapere dell'uomo ¢
della natura, cosi come le norme del vivere sociale, hanno
finalita in quanto rapportate alle indicazioni di Dio. Tutta-
via, seé vero, come é stato suggerito, che nella Grecia antica
la parola divina @ legata al mito mentre la filosofia & l'eman-
cipazione della ragione da questa parola e dal mito, nell Islam
la parola divina & sempre dentro al sociale poiché é legata
alla giurisprudenza. Esistono due definizioni della giuri
sprudenza islamica: la prima @ sharfah, la Legge religiosa
rivelata, comprendente dogmi, siti, precetti morali e giuri
dici, comunicata a tutti i popoli del Libro (ebrei e cristiani),
mma definitivamente perfezionata con I'Islam; la seconda &
figh, termine per spicgare il quale utilizziamo una definizio-
ne del giurista e filosofo della politica Tbn Khaldain (m. 808
(14061); «il figh @ Pestrarre dalle cadici e dalle fonti le
notme relative alla qualificazione sciaraitica [della shartab,
cio] delle azioni del musulmano tenuto all’adempimento
dei suoi obblighi giuridico-religiosi». In modo consonante,
spiega Francesco Castrp che il figh @ «la conoscenza della
quintuplice ripartizione sciaraitica delle azioni umane, nel
B
Islam ¢ politica
senso di atto obbligatorio, o proibito, o consigliato, o scon
sigliato o, infine, libero». David Santillana, nelle sue Istitw
toni di diritto musulmano malichita ha notato che
Videa dominante dei giuristi musulmani & che il Ditto, fatto
eminentemente sociale, benché di le sue origini, trova nella
convivenza umana la sua ragion d'essere, la sua materia propria e
il collegamento dei vari istituti onde si compone, Anche i doveri
concerto musulmano, sono discipli
nati in vista dell uomo sociale
Stabilito come presupposto basilare che la scienza tipi
camente islamica non @ la teologia, ma il diritto — e la
politica in quanto applicazione sociale del diritto ~ delinea-
re le tappe ¢ le dottrine fondamentali della politica nel
pensiero religioso dell'Islam implica collocare alcuni paletti
di riferimento preliminari,
‘Vi é una peculiarita della ragione islamica che potrebbe
dar uogo ad antinomie sul piano etico-comportamentale.
Non esiste infattidiritto naturale, né ragione naturale: come
@ la rivelazione a indicare le vie dell interpretazione ontologica
€ perfino dell’analisi cosmologico-isica della realta, & anco:
alla rivelazione a scoprire e spiegare cid che pare it
le, 0 quanto meno inspiegabile, delle preserizioni soci
etiche e legali. Non & abene> cid che & buono in sé, ma cid
che Dic ha indicato prescritto come buono: l’etica musul
mana é fondamentalmente soggettiva. Dio non @ vincolato
ad alcun principio di giustizia che ne limiti onnipotenza: il
ctiterio di distinzione tra il giovevole ¢ il nocivo risiede
nella parola di Dio, non in un presunto diritto naturale che
valga, proprio grazie alla sua oggettivita, per tutti gli uomini.
Questo non significa che la Legge islamica sia antitetica
rispetto alla logica della realtd; significa che tutto quanto a
noi pare «naturale», in verita dev'essere riportato alla de
terminazione di Dio. Limpide a questo proposito le os
vazioni del Fratello Musulmano egiziano Sayyed Que (m.
giustiziato nel 1966; si veda il successivo cap. VI):
Dio ha stabilito per I'somo una Legge affinché egli regol la
sua vita cosciente in armonia con la sua vita naturale. Su questa
14
Islam politica
base, la Legge non @ che un settore de rdine divino universale
che fegge (govern) la natura orginaria dell wom e quella dele
stenza universale, armonizzandole in un Rae insieme. Non vi &
ne un ordine o una protbsione, né una promes
é fe odietiv, che non sia una parte
conforme, come lo sono le norme che noi chiamiamo «norme
nnaturali» ~ cioé le Norme divine e cosmiche ~ che vediamo tealiz-
zarsi in ogni istante in virti della verita eterna che Dio vi ha messo,
di queste Norme che si realizzano tramite il decreto di Dio.
Il grande modernista egiziano Ahmad Amin (m. 1954)
ha trascritto un interessante dialogo, intercorso tra due
teologi dell’ottavo e due del decimo secolo (era cristiana),
che dimostra il valore sovraeminente conferito dai pensatori,
musulmani all indicazione divina
Durantela discussione, awenuta nel secondo secolo dall Hégira
tra Ghaylan [al-Dimashgf}, uno dei primi gadaritio pactigiani del
libero atbitrio, e un certo Rabi'ah «Tu forse pretendi che Dio ami
chiese Ghaylin, «E tu pretendi che si
ppossa disobbedire a Dio contro il suo piacere?», replic® Rabt' a.
‘Due secoli pit tardi si trova un dialogo simile tra il mu'tazilita
“Abd al:Jabbar, e un suo avversario, Abt Ishag al-Isfarint: «Dio
le essere disobbedito?», domandava il primo; «Si pud disobbe-
jet obbligo?», intersogava il secondo. «Se Dio rifiuta di
assistermi e mi predestina alla morte, agisce bene o male nei miei
confronti? ~ Se Egli ti priva di cid che ti deve, agisce male; ma se
cegli ti priva di cid che Gli appartiene [e tutto appartiene a Dio), &
libero di concedere la sua misericordia a chi vuole»,
Perfino la disobbedienza ai dettami divini 2, dunque,
voluta da Dio. Perfino la ribellione di Satana (Iblis) diventa
un apologo per esaltare l'onnipotenza di Dio:
Il giorno della resurrerione (narra il mistico teopatico Aba
Sa‘id thn Abi'-Khayr] Iblis verra trascinato al gindizio con tutti i
démonie sar accusato di aver traviato le molding, False
teri di aver rivolto loro I'appello a seguirlo, ma si difendera affer-
mando che esse non avevano alcun obbligo di flo. Allora Dio
dira: «Sia pure! Ma adesso adora Adamo cosi da salvarti», I d2moni
implorersnno Satana di obbedire e di liberare loro se stesso dai
tormenti, ma Iblis rispondera piangendo: «Se fosse dipeso dalla
15
Islam e politica
lon areiadorato Adamo fin dala prima volta in ui mi
esto, Dio mi ha comandato di adorare Puomo, ma non
serio, Se ome avese permess, ave adorato vom
Se neppure Satana ha potuto sottrarsi, commetten
peceato, agli ordini di Dio, non sath luom a poter eee
minare, secondo principi naturali universalie assoluti val
di per ogni circostanza personale ¢ sociale, cid che & bene o
male; il divino arbitrio pud modificare le regole del gioco
anche sul piano civile ¢ comportamentale, oltre che sul
piano dell’ordinamento cosmico (arti). T mu‘taziliti, una
scuola di pensatori fiorita in Iraq nel II1-IV [1X-X] secolo,
la pensavano diversamente (cf. il cap. II), ma il grande
mistico e teologo Aba Hamid al-Ghazali (m, 505 [1111].
che possiamo tranquillamente scegliere come rappresen’
tante archetipico dell'Islam ortodosso (si vedra poco sotto
cosa vuol dire ortodossia nellIslam), sostenne che chi vo-
lesse sottoporre Dio alle costrizioni di una tazionalita
aprioristica, cadrebbe in profonde contraddizioni.
7 Al propos, & davveto interessante Papologo che ea
er contestare l'idea mu'tazilita che Dio sia «obbliga-
ton a face bene delle eretanes ns Des cobblige
Vorrei proprio sapere come replicherebbe il mu'tazilita che
ali, divenuto adulto, si é prodigato per la fede e
‘a questo Dio sarebbe obligato, seconde
fanciullo dicesse: «Signore, perché hi i alta la posizione di
a ae ispe eae m ae Egli tisponderebbe: «Perché que-
gil lntnao dlls gun favre ade cl ro
to?», Dio risponderebbe: «Perch coer che re cnnionc
saresti stato politeista ¢ ti saresti ribellato; il meglio per te era la
morte nella fanciullezza», e in questo modo
cherebbe Dio. Ma allora i miscredenti griderebbero dagli abissi
16
Islam e politica
dell'Inferno: «Signore, non sapevi forse che, se avessimo raggi
19 stati politeisti? Perché dunque non ci hai
fatto morice nella fanciullezza? Noi saremmo stati sodd
‘una posizione inferiore a quella del fanciullo musulmano».
ispondere a cid? Si deve soltanto asserire che le cose divine
0 della macsta divina perché possano
‘taziliti)
sono troppo elevate
essere pesate con la bilancia (dei
Attribuire a Dio le qualifiche di giusto 0 ingiusto &
assurdo, perché Dio non deve rendere conto a nessuno, La
Legge @ stata stabilita da Lui, ma Lui, sovtano assoluto del
suo Regno - il creato ~, non ne & soggetto. La sua volonta &
al disopra di ogni comprensione umana, Egli pud far soffri-
re 'uomo buono senza ricompensa e pud salvare il malvagio
dalle fiamme dell’Inferno senza motivo apparente. La sua
decisione @ comunque «piusta», perché la giustizia di Dio
non si misusa secondo parametri umani,
‘Anche le regole di culto (per fare solo un esempio,
quelle relative al pellegrinaggio con i suoi strani riti, spesso
di origine preislamica, come la deambulazione attorno alla
Ka'bah, la «corsa» tra Safwa e Marwah, la «lapidazione» del
demonio a Mina ecc.), non sono, secondo al-Ghazali, razio-
nalmente giustficabili: Dio le ha stabilite obbedendo a una
logica che non é quella umana. L’uomo non sarebbe stato in
grado di scoprire da solo la profonda connessione tra I'inte:
riore € Pesteriore che vi soggiace; tuttavia, le deve mettere
in pratica, fiducioso nella prowidenza e nella razionalica
che Dio ha impresso al cosmo. Dio & «Colui che cred sette
cieli'uno sull’altro, e tu non puoi scorgere nella creazione
del Misericordioso ineguaglianza alcuna. Voli in alto la
vista: vedi tu fenditure?» (Corano 67: 3)
Natura ¢ Legge, physis e nomos se vogliamo utilizzare
termini di origine greca ormai entrati a far parte della cultu
ra occidentale, dipendono, nell'orizzonte culturaleislamico,
dalla rivelazione (sharf'ab nel senso della Legge 0 wahy nel
senso dell’ispirazione profetica) ¢ non sono concetti «im
personali», Efficacemente ha scritto Bernard Lewis che
jonale, lo stato non cree la leg:
nella concezione musulmana tra
lla legge, che proviene
ge, ma & esso stesso creato e€ mantenuto
7
Islam e politica
da Dio ed & intexpretata
Figuardo. Dovere
smministrate da chi ha competenze al
wrano' difendereesostenere, neatenenee
ual epi stesso & sttoposto comet pis
Vi dunque una relativita dei concetti politici. Termini
come «liberti» 0 «democrazia> non possono assumere in
un otizzonte di riferimento islamico lo stesso senso che
hanno nel nostro. Discutendo di questi problemi, il sociologo
« flosofo marocchino “Abdall@h Laroui (al-‘Arawi) cita si-
icativamente questi passi di uno storico del
gaifcarivamente quest pass di uno storico del XIX secolo,
Sappi che la liber di eu parlano gli europei& prob
una invenzione degli atei, poiché @ con cia a dic di Dae
a vencions del at, piche conrad
wore
formula dat puis ei
Left & che la ibe
alcuna valenza metafisica, alcuna assoluta priorita nei di
degli individui. An-Nasiti condanna il eoncetto oceident
le lanna il concet nt
gibt psc lo identi (per alo pst) conan
iritto naturale svincolato da una superiore norma di
wollo edi diteziones Pe aca
& solo un item giutidico, non ha
3 che lo allontana dl vio loosens ae ane
lo distingue dall’animale, Di cio la concezione europea oa tisne
alcun aes permette all’uomo di abbandonarsi ad azioni
ta, salvo a lasciar fare ad altri q che lui stesso fa.
Questa prospettiva di determinismo implica, per la teo-
ria politica, un'importante conseguenza. Non esiste fonda.
mentalmente nell'lslam dimensione utopica, poiché la so.
cieta stabilita da Dio & perfetta alle origini: la sopgettivita
divina della norma etico-politica ~ ossia il fatto che le nor
tne etico-politiche siano volute e sancite da Dio fin dall'ini
18
Wy
Islam politica
zio dei tempi - impone un ordine gia dato. Dice Iddio:
‘«Oaggi vhho teso perfetta la vostra religione e ho compiuto
su di voi i miei favori e m’é piaciuto di darvi per religione
slam» (Corano 5: 3). Al proposito, il filosofo egiziano
vivente Hasan Hanafi é puntuale: siccome «il regno dei cieli
per lIslam @ sulla Terra», egli conclude che «!'Islam non @
Un’utopia ma la realizzazione del regno dei cieli sulla Ter~
ray, La cosiddetta «utopia» politica nell’Islam implica un
impegno concreto di realizzazione dellideale, anzi di re-
staurazione dell’ideale che si é gia dato e si é realizzato,
secondo la volonta di Dio, in un particolare momento storico,
1 califfato, ad esempio, la ben nota forma classica del
potere nell’Tslam, non @ un sistema «possibile», unipotesi
da costituire nel futuro, ma quello storicamente determina-
tosi dopo la morte del Profeta, modello eterno di una forma
perfetta di stato che Dio ha voluto si attuasse nel tempo. Se
gli uomini nel passato, o nel presente, hanno sbagliato ¢
sbagliano a metterne in pratica la teoria, I’aspirazione del
vero musulmano @ stata di difendere il califfato dai suoi
nemici e detrattori quando era realizzato, ovvero di ricosti-
tuirlo quando le circostanze della storia lo ebbero distrutto.
Un califfato adeguato alle esigenze della modernita, natu.
ralmente, ma comunque interprete delle pit radicate ten-
denze del pensiero ¢ della sensibilita islamica.
indicativo, al proposito, il lamento del Fratello
Musulmano tunisino Rashid GhannGshi, un teorico radica-
le contemporaneo:
I1Profeta ha fondato uno stato che incarnava in manicra mera:
vigliosa i principi dell'lslam riguardanti la giustiza, la liberti e la
fettitudine; e questo stato si € perpetuato dopo morte,
attraverso i suo Compagni, sotto il governo dei quali P'umanita ha
visto realizaarsi le sue speranze e i suotideali ..] La trasformazio:
he del califfato in un regno oppressive [produsse] la prima calami
{sil divorzio progressivo tra la religione e la politica, finché col
tempo non test6 del califfato che la forma esteriore, come disse Ibn
Khaldin.
Per riconquistare il bene perduto si tratta, per gl islamici
contemporanei, di ripercorrere una strada a ritroso:é la via
19
otek bone ong
Islam ¢ polities
dei salaf—la via degli «antichi» —, quella che bisogna imboc.
SES Bir sys reap rent at
te in pratica gli insegnamenti di Dio, in specie nel periodo
eroico € mitico che va dall'Hégira, l«emigrazione» di
Muhammad dalla Mecca a Medina (I [622] ¢.C.), almeno
fino alla Gea califfo ‘Umar (22 [644]), ma che alcuni
vorranno estendere fino a comprendere il califfato di “Alt
(m. 40 (6611). Di fatto, soprattutto durante i period mond
pili turbolenti, I'Islam ¢ stato spesso evocato per opporsi, in
home del recupero dell’autenticita, alla minaccia del sov-
vertimento (o anche solo del cambiamento) dell’ordine del
le cose. Hl problema dell autenticita silega strettamente con
quello della modernitA. E lecito trovare un «moderna» che
guardi all’indietro? La tendenza degli orientalisti di consi
derare I'Islam attuale come qualcosa di troppo legato al
ssato & bollata da Sami Zubaida come una tendenza
«essenzialista» che ignora le forze secolari ¢ secolarizzanti
di cui il mondo islamico é percorso. Allessenzialismo biso:
gnerebbe contrapporte la prospettiva che «dietro la retori
ca ¢ il simbolismo religioso, la pratica sociale e politica
rimane, per la maggior parte, irrelata rispetto alla religio-
ne», Non mi pare che questa tesi sia convincente c il presen.
te libro tentera di dimostrare esattamente 'opposto. Ma, al
di la della maggiore o minore pregnanza delle tesi critiche
Propose, arto i dibatito indica quanto dificil esfuggen
te sia il campo di un'interpretazione mon ae rene
eps z inter ie monolitica e omogenca
d'altronde, I'lslam & stato utilizzato pid volte com
strumento di controllo politico sociale delle masse da, par
te delle classi dirigenti, esso & perd setvito anche a mobi:
are le masse onde fossero parte attiva degli
specialmente li dove era in gioco la difesa dell
Cid & particolarmente evidente, e lo si accennera, in rela
zione al colonialismo (cfr. cap. V), Uno dei motivi, forse
principale, che spiega la grande diffusione dell’Islam nel
mondo povero 0 cosiddetto in via di sviluppo, in Africa
come in Asia, risiede proprio nell’uso antimperialistico
che si @ fatto di questa religione fondamentalmente
egualicaria,
20
Islam e politica
Questa globale prospettiva si differenzia profondamen.
te, nel complesso, tanto dal cosidderto «agostinismo politi-,
com, quanto dalla scissione tra potere civile e potere religioso
che'si determind nel tardo Medioevo latino. Con sant’ Ago-
stino, con papa Gelasio, e poi con i teorici politici dell’eta
carolingia, anche se bisogna ricondurre alla giv
prannaturale ogni fondamento di legittimita dell'autorita
temporale, la societi umana viene considerata sostanzial
mente frutto del peccato originale e della caduta. Se Adamo
non avesse peccato, non sarebbe stato scacciato dall’Eden
per vivere in un mondo in cui dominano l'aggressivit’ e
sopraffazione, in una citta empia, quasi sempre priva della
vera giustizia.
Nell’Islam, al contrario, il potere politico ¢ la struttura
sociale sono benefici di Dio, «grazie» che Egli ha voluto
clargire per la felicita degli uomini. La citta fondata sulla
sottomissione a Dio, ché questo significa Islam, & per
antonomasia «giustay: «lddio non ordina la turpitidine.
(..1 Di: il mio Signore ha piuttosto comandato l'equ
drizzate quindi devoti il volto al Signore» (Corano 7: 28-29)
‘A questo, nella sostanza, intendono alludere i musulmani
radicali o fondamentalisti contemporanei quando preten-
dono che «il governo é solo di Dio» (hakimeyyah, cfr. cap.
VI). Ibn Khaldain disse che la politica é stata istituita da Dio
per il pubblico interesse. Teorici come al-Mawatdi (m. 450
(1058); eft. cap. I), autore della classica opera I principi
del potere, spiegarono tutta la loro scienza per irrobustire €
confermare le istituzioni volute da Dio: «l’imamato [o
califfato supremo] é stato stabilito per la successione della
profezia, la difesa della religione e il governo de! mondo».
Musulmani radicali, come legiziano Sayyed Qutb, si ado-
perarono per rovesciare quello che al loro tempo ritenevano
tun pervertimento della vera religionee ritornare sulla «tetta
Viam. Dio lo impose come obbligo: «Guidaci per la retta v
(as-sirat al-mustagim), la via di coloro sui quali hai effuso la
Tua Grazia, [...] la via di quelli che non vagolano nell’erro-
re» (Corano 1: 6-7)
E ancora: laddove Marsilio da Padova col Defensor Pacis,
terminato nel 1324, sanzionava definitivamente lo sciogl
Islam politica
mento del legame universalistico delle «due spade», quella
religiosa e quella imperiale, ela fine dell’idea della plenitudo
Potestatis papae, avanzando una teoria positivistica della
legge, un nuovo concetto di sovranita politica, una legitti-
mazione del governo democratico, I’eliminazione dell’auto-
rith ecclesiastica dalla comunita civile -, il giurista e teologo
Ibn Taymiyyah sostenne che la religione ¢ lo stato sono
necessari l'und allaltra, Senza la forza costrittiva dello sta
19, la zeligione rischierebbe di vanificarsi; senza la regola
religiosa, lo stato si trasformerebbe inevitabilmente in siste-
ma autocratico ¢ tirannico. Lo stato deve fat trionfare la
giustizia e preparare l'avvento di una societa tutta volta
all’adotazione di Dio.
Percid l'interesse predominante del pensiero islamico —
senza con cid voler negare la profondita spirituale della
mistica (o sufismo) ~ si spostato dai problemi della meta-
fisica e della scienza naturale a quelli del diritto, dell'etica ¢
della politica, @ proposito dei quali non tanto si dibatte
sull'essenza di Dio, che rimane e deve rimanere comunque
inconoscibile, ma si interpreta la sua volonti e il suo
determinismo dentro la societa. La religione & una postur
pubblico-politica. La filosofia una declinazione della g
sprudenza
Un dato resta fermo: il pensiero islamico ha fondamenti
etico-politici. E il Corano stesso a dimostrarlo, Significativi
sono i versetti «politici» del Corano: «Obbedite a Dio ¢ al
suo Inviato ea quelli che detengono l'autorita» (4: 59). La
prima parte del versetto é ripetuta ben 18 volte, in maniera
integrale © parziale, nel testo sacro ¢ sembra implicare il
quietismo: non vié ragione di opporsi al sistema dominante.
Vié, comunque, necesita di giustizia tra gli uomini: «O.
voi che credete! State ritti innanzi a Dio come testimoni
d'equitd ¢ non vi induca lodio contro gente empia ad agire
ingiustamente. Agite con giustizia, ché questa é la cosa pid
vicina alla pieta» (5: 8). Daltro canto, «é dato permesso di
combattere a coloro che combattono perché sono stati og
getto di tirannia» (22: 39). Tl versetto & opportunamente
evocato da teologi antichi e moderni: cosi Ibn Taymiyyah e
Vex shaykh dell’ Azhar dell'epoca di Nasser Mahmad Shalt.
22
Islam ¢ politica
2 la sopraffazione.
lessuno deve accettare senza opporvisi la sop
Marat fine i giudizion (uk) appartiene solo a Dio (6:
571240) termine epiuizion va po a ndicare ilepote
c mr, bukiimab ecc.), ¢ la frase coranica é stata utiliz-
Sree eae come deh citato Sayyed Qutb per
sostenere la necessita di una islamizzazione dello stato.
Ticombattimento (gitdl)lecito, poiché «non sono uguali
agli occhi di Dio quelli fra i credenti che se ne restano a casa
eccettuati i malati - e quelli che combattono sulla via di
Dio (mujdhidiin) dando i beni ela vita» (4; 95; 8: 38-39), ma
non bisogna superare i limiti, «ché Dio non ama gli eccessi
vi» (2: 190). In ogni caso, tra i credenti & necessaria la pace
ela convivenza pacifica, «perché i credenti son tutti fratelli
mettete dunque pace tra i vostri fratelli e temete Iddio» (49:
8-10)
Il frainteso problema del jihad 0 «guerra santa», su cui
owviamente si tornera con ampiezza al momento opportuno
€ in diversi contesti storici, si radica qui. Tl jihad @ un
impegno, ad un tempo mondano ¢ spiritual, sulla «via di
Dio», Non @ tanto una «guerra santa», ma una lotta di
difesa — e talora anche di offesa — per rivendicare i diritti di
Dio ei diritti degli uomini; inoltre, una lotta interiore, etica,
per la purificazione dei costumi. La ispira lo stesso messag
gio di uguaglianza e di impegno contenuto nel Corano (3:
102-104)
voi che redete, temete Dio del timor che gli spetta e morite
da mulnmt Astaro nse tut ale cord ds Die nom
dlisperdetei, ricordatevi delle grazie che Dio vi ha elargito: er
vate nem e via posto aimona in cuore «pet la Sun raza sete
Uivenutifraeli [1 E,si formi da voi una nazione d’yomini che
ano al bene, che pfomuovono la giustziae impediscono
fiustinia, Quest! saranno i fortunat.
Se i principi sono stati stabiliti da Dio una volta per
tutte, non esistono womini deputati a cambiarli o a rivederli.
Lrazione dell’ uomo risulta nella sostanza limitata ad appli
care i principi rivelati, secondo una infinita casuistica che
solo la giurisprudenza & in grado di elaborate. La varieta
variabilita potenaiale delle opinioni giuridiche é la ragione
2B
Islam e politica )
fondamentale per cui nell'Islam non vi Chiesa né, in s 30
stretto, dogma. Non esiste un definito concetto di eresia
poiché non esiste unautorita docente centrale; Popinione
di qualsiasi giurista — pur prestigioso ~ pud venire contesta
ta dall’opinione di un altro giurista, Tale opinione (fatwa) &
valida solo all'interno di un preciso ambito: nessun sunnita
@ tenuto ad applicare la Legge di uno sciita ~ né viceversa
Khomeini, sctta, ha condannato Salman Rushdie per aver
offeso Tish im col suo libro Versetti satanict; ma il muftt
oes Tha eu nessuna delle due «sentenze» - ma
appunto meglio die sopinioni»~ha vlore vincolante per
L’evoluzione dell'Islam testimonia di un'infinita ramil
cazione del dogma, Secondo due celebri hadith, Mabasrae
avrebbe detto, da un lato, che la sua comuniti si sarebbe
suddivisa in settantatré sétte, di cui una sola si trova nella
verita; ©, dall’al Itro, che la differenza di opinioni (kbilaf 0
ikbtilaf & un bene per la comunita stessa. Nel ricostruite la
storia religiosa dell'Islam, molti piieresiografi
la pena di elencare quali fossero le settantatre sétte della
tradizione, non una ) né una di meno.
E interesante consderare i valote anche politico, e
non esclusivamente religioso, che hanno i termini che
arabo dovrebbero indicare Persia, altrttante natavalonce
quanto sfuggente il concetto di ortodossia. Bisogna distin.
suerla innanzi tutto dalla «miscredenza» o kufr (che aleuni
Blutisti definiscono anche come «ribellione agli ordini di
Dio») ¢ dall':
resia € dunque una innovazione «giuridica» ris] la
consolidata trdizione del Profs c del suolececeek ios
preti del Libro rivelato. La bid'ab si pone in certo modo a
mezzo tra la riddab 0 apostasiae l'ilhdd, termine di difficile
traduzione. L'apostasia @ Pallontanamento colpevole dalle
regole di una religione, dopo averle abbracciate: dunque,
piu che una eresia @ una ribellione. Furono accusati di
24
Islom e pol
riddab le ttibia arabe di recente conversione che, dopo la
morte d Muhammad, cercarono di spezzate il vincolo che
lelegava al Profeta; oppure gli avversari dei califfi ‘abbasidi,
saliti al porere nel 750 dopo gli omayyadi di Damasco. Da
potre in parallelo alia riddah é la fitnab o «secessione», un
termine che, nella mentalita del musulmano, evoca il disor-
dine, il caos susseguente a una crisi potenzialmente
irreversibile della comunita ¢ della sua stabilita politico-
sociale. La fitnah al-kubra, Ia «grande secessione>, & per
antonomasia la lptta civile tra omayyadi ¢ ‘alidi che laceré il
mondo islamico dopo Passassinio, nel 37 [656], del terz0
califfo ‘Uthman (cfr. cap. ID.
Lilhdd ha indicato, invece, coloro che si sono posti
fuori della religione musulmana abbracciando teotie evi
dentemente incompatibili con l'Islam: per esempio, i
manichei e i dualisti (zindig) come Ibn al-Mugatfa‘, un
Jetterato persiano di tiepida (o forse addirittura falsa e op-
portunistica) conversion; oppure gli isma‘iliti «Assassini»
che nella frangia pitt estrema giungevano a divi-
nizzate il loro imam (cfr. cap. III). Secondo Malik Ibn Anas,
fondatore di una delle quattro scuole giuridiche «ortodos:
sen, lo zindig «® un apostata che segretamente si é allonta-
nato dall'Islam celandosi sotto il mantello di un esteriore
conformismo, e deve essere decapitato come l'apostata che
non nasconde la sua apostasia»: sono tali coloro che costitui-
scono una minaccia per lo stato e la comunita, operando
come agenti corruttori al loro interno.
Se tanto impreciso @ il concetto di eresia, o meglio se
tanto politicamente connotato @ il concetto di etesia, & ne
cessatio porsi il quesito: cgs'é I'Islam «ortodosson? L'unica
risposta accettabile é che si trata dell’Islam numericamente
maggioritario, ossia, nel corso della storia cosi come oggi,
quello sunnita. Ma cid é lungi dallimplicare quel significato
universalistico, «cattolico», che il dogma ha assunto nel
Cristianesimo, anche se certamente la duttilita del dogma
ha in qualche modo favorito la compattezza della comunita
attraverso i secoli, oltre ¢ al dila delle lotte intestine ¢ dello
sfaldamento del potere centrale dei califfi, Non c'é autorita
docente nell’Islam (sunita) nel senso che la comunita
25
Islam e politica )
(ummab) ¢ i giuristi che la appresentano abbiano as:
le: funzioni istituzionali della gerarchia ecclesiastica cristana,
doo Ham, che abbiamo in questa misura definito «orto.
losso», impone una particolare forma di governo? La ti-
sposta € nettamente negativa: non tanto importa se il siste-
a 3 ontchico 4 seeubblicano,capitalisa o socialist,
juan pplica le rego ite da Dio. Il Fratell
Musulmano ‘Abd al-Qidir ‘Awdah (impiceato da Nasser
nel 1954) ha rilevato che «poco importa che il potere sia
conservatore o progressista, che il regime sia republic:
della shari‘ah perché questi non si riferiscono al potere né al
regime, ma unicamene alla tligione islamica, I quale non
si trasforma e non cambia. Ogni govern aderi yer la
fede, ogni regime bal suo serine
U modernista siro-egiziano Rashid Rida, su cui tornere-
mo nel capitolo V, ha sottolineato che
la ragione profonda per la quale il Profeta aveva lasciato alla comu:
nita Tonere dell organizzazione del consiglio deliberativo senza
precisane gi saat, (ech ake orpantzacione vate secon
Coniston i esistenza della comanita, etausione dels sea ges
polazione, della sua composizione sociale e dei suoi interessi fare
tali nelle differenti epoche. E impossibile deter
di statuti determinati che convengano in oj eal
tempo. mh * 7
1og0 € in ogni
ICorano, del resto, non offre alcuna indicazione preci
sa sulla migliore forma di governo, Un’espressi ei ‘il
potere spetta a Dio, al suo Inviato e ai credenti» & del tutto
ambigua, essendo interpretabile in ogni senso. Per questo,
nell’elaborazione di una ideale carta costituzionale del
smusulmano, non importa la libert’, ma la giustizia: se vi &
sus laliberta&n certo modo «inutile, oper lo meno
secondaria. Come ha notato giustamente Gi
goncetodibera fiasco aon eee
lunque da un criterio di giustizia ('adélab) che
nell’obbedire alle regole del pato offerto da Dio agli uoms,
8, € non da fattorl inna. La gistzia,cealizando la parola
i Dio, rende la liberta superflua: quale maggiore liberta
26
Islam e politica
che piegarsi ai voleri dell’ Altissimo? Quale maggiore liberta
dell’essere muslim, musulmani, «abbandonati» alla volonta
di Dio? Il pensatore pakistano al-Mawdadi (m. 1399 [1979];
cfr. cap. VI) ha scritto che «obbedire, vivere in accordo con
Ja volonta e la Legge di Dio o, per dirla pitt precisamente,
bssere musulmani, & un imperativo radicato nella natura
delle cose. Dio ha dato all’uomo il potere di intervenire su
queste cose, ma é necessario che esse vengano utilizzate per
Y'adempimento dei Suoi voleri, ¢ non altrimenti».
Il adiritto» del cittadino musulmano, che percié corti.
sponde al suo «dovere», @ quello di ottemperare al meglio
alle indicazioni religiose. Lo, stato si costituisce in funzione
di questa necessita, Il fondamento del potere non @ dunque
popolare, anche se, come vedremo, spesso il : Islam 0 Occidente?
L’aporia non @ risolvibile con la pura e semplice impor.
tazione del meglio della tradizione politica «europea», la
democrazia, in territori e popoli non europei, nella convin-
zione che essa sia la pid idonea forma di governo, quella che
pit coerentemente assicura la piena esplicazione dei carat
teri e delle capacit dell'individuo. La relazione tra lo stato,
individuo e la sua liberta in ambiente islamico non risulte,
rebbe, percid, nient’affatto semplificata
Bisogna tuttavia convenire di accettare espressione che
‘«l'Islam é religione e mondo» (al-Islam din wa dunya), cio®
‘che nell'Islam la differenza tra la citta celeste la’ citta
tetrena @ surrertizia. Di fatto, come sottolineano gli stessi
musulmani, la traduzione di din con -«religione» é limitativa
¢ banalizzante per il lessico islamico. «Religione» & un voca-
bolo «occidentale», € in quanto tale caricato di valenze
eminentemente cultuali, vorremmo dire «ecclesiastiche»,
| Nell'Islam, invece, din significa, in senso molto ampio, non
solo il culto e il dogma, ma anche il vivere associato e le sue
regole, in una parola Pideologia
Certamente pitt problematica @ Paltra famosa locuzio.
ne: a’Islam @ religione e stato», in auge nella dottrina del
radicalismo islamico, da Sayyed Qutb a Khomeini (cfs. cap.
V1). L'Islam é religione e stato (din wa dawlab) vuol dite
comunque feocentrismo © non «teocrazia», termine che &
veramente significativo solo nel mondo cristiano medievale
(e, in parte, nello sciismo iraniano). «Teocrazia» certo si-
gnifica che lo stato & subordinato alla religione; ma nell'Islam
parlare di subordinazione tra i due ambiti, sia della religio.
ne allo stato sia di quest'ultimo alla prima, & fuorviante
poiché i due ambiti sono considerati in un rapporto di
integrazione, non di opposizione. D’altronde, la «teocrazia»
implica una struttura ecclesiastica; il teocentrismo islamico
implica che Dio, e non Puomo o una qualsiasi istituzione
umana, pur universalistica come una Chiesa, si colloca al
centro di ogni realtd antropologica e sociale
28
Islam politica
Per altro, molti studiosi contemporanei affermano che
non si & mai dato alcun legame reale tra din © dawlab nella
storia islamica: bisognerebbe quindi leggere tale legame in
un’ottica assai sfumata e peculiare, Cosi Olivier Carré ritie-
che I’Islam maggioritario ¢ determinatosi storicamente
nella maggior parte degli stati musulmani sia una sorta di
cesaropapismo con la religione sottomessa al potere domi-
nante. Anche Nazih Ayubi scrive che
invero, I'Islam @ una religione di mi
molto poco di specifi
politica farono beni coniugate neg
senso che lo stato si approprid del
Constrio delesperienza europea dove Fue Chess ad app
si. della politica
Bernard Lewis ha un’opinione in parte divergente:
l'Islam assicura il pitt efficace sistema di simboli per una
mobilitazione politica, funzionale a sollevare le genti, sia a
difendere un regime percepito come dotato della necessaria
legittimita, sia a riprovarne uno ritenuto privo di legittimi-
2, in altre parole non islamico».
eae Lave marocchino, uno dei assim filosof
ella politica dellIskam contemporaneo, si pone da un pun-
a di vista strettamente occidentale sostenendo che «l’Islam,
esigenza etica, elo stato, organizzazione naturale, rientrano
in due ordini differenti e non dipende affatto da noi unirlin
Questa conclusione arriva al termine di un’analisi del pro-
blema dello stato ispirata da Ibn Khaldtin, dove si evidenzia
come dall’utopia del sistema califfale si sia trascotsi allo
stato patrimoniale dei sultani (cfr. il dibattito tra al-Mawardi
eal-GhazAli nel successivo cap. III) a causa di una decaden-
za dell ideale etico. Lo stato patrimoniale separa il potere
costituito dalla societa e quindi conclude alla ticannia. An-
che se Islam pretende di essere «religione e stato», di fatto
nella storia sié data una continua divaricazione c irriducibilita
trai due: percid lo stato islamico (se pure questa definizione
ha senso) non é teocratico, pur potendo essere, come si @
detto, tirannico.
29
Islam e politica \
Del resto, lo stato come organizzazione naturale, si &
visto, non é islamico. Laroui stesso ammette che «nessun
Pensatore ortodosso crede che il califfato, governo morale
per definizione, possa emergere naturalmente nel corso della
storia umana». Il califfato, infatt, si basa sulla rivelazione,
come sosterranno tutti i maggiori teorici «ortodossi» da a
Mawardi, ad al-Ghazilf, a Ibn Khaldan (cfr. ancora il cap.
III), non é un sistema politico «naturale». Come si vede, un
elemento di contraddizione ideologica ® sempre operante
negli studiosi musulmani. La conclusione di Laroui pare
Pertanto troppo netta: «Stato e comunita (wmab) non si
contraddicono, si ignorano totalmente», Che nell'Islam si
dia una dialettica tra la comunita - organismo egualitario
che parifica tuttii credenti elo stato, & cosa owvia. Ma non
sembra che cid implichi una schizofrenia irrecuperabile,
Quando i radicali sostengono che 'Islam é «religione ¢
stato» (din wa dawlah) cercano appunto di guarite tale
scissione,
Un’ opinione equilibrata, che cerca di render giustizia ai
principi fondamentali deli'Islam, mi sembra quella di
Muhammad Asad, ex direttore del Dipartimento per la
Ricostruzione islamica dello stato del Punjab e coinvolto in
prima persona nella nascita (1948) dello stato islamico in
Pakistan. Il suo ragionamento @ rigorosamente conse.
quenziale, Islam vuol dire coordinare le scelte umane alle
regole dettate da Dio: per questo Dio ha stabilito la Legge
(shari'ab). Certo, luomo @ in grado di decidere, col suo
libero arbittio, se respingere gli ordini di Dio; ma, qualora
Ii accettasse, dovra adoperarsi a creare un ambito sociale ¢
politico in cui lesistenza privata si proietti nella dimensio.
ne voluta da Dio. Si rende cosi necessario lo stato, che
veicola un'azione sociale positiva ben oltre un generico
sentimento di fratellanza. «La volonta della comunita di
cooperare in termini islamici», annota Muhammad Asad,
«timarrebbe in larga misura teorica se non esistesse un.
potere civile mondano responsabile della messa in pratica
della legge islamica». Questo stato non pud essere «secola-
re», poiché nello stato secolare non funziona alcuna norma
oggettiva che disctimini tra il bene ¢ il male; gli interessi
30
Islam e politica
individuali vi si fanno ferocemente antagonistici e dunque
potenzialmente anarchici.
‘Ancora una volta ci muoviamo in uno spazio teorico
diverso da quello occidentale, e lo stesso Asad sottolinea
incongruita dell’utilizzo, in Islam, di una terminologia
politica occidentale. I! fatto @ che, per avvicinare e com-
prendere V'lslam, bisogna adattarsi a modificare i propri
paradigmi interpretativi e a «spostare> il proprio focus in-
tellettuale. Cambiano gli schemi teorici e lo stesso linguag-
gio politico. Si registra una prevalenza della «comuniti»,
sociazione, questa volta si «naturale», degli uomini (me
glio: dei credenti) sullo stato. Il potere si esplica nella vo-
Tonta comunitaria, nel senso specificato dallo stotico at
Tabari (m. 310 923): «il senso esatto del raggrupparsi
insieme (jamd‘ab) @ la sottomissione alla collettivita che
‘obbedisce al sovrano che essa stessas'éscelto». II musulmano
crede innanzi tutto nella comunita (ummah). La preghiera
principale del venerdi a mezzogiorno é un fatto comunita
rio ¢, caratteristicamente, Ja moschea grande dove la si
pronuncia é definita masjid jami*: potremmo tradurte «luo:
g0 di prostrazione comunitario», moschea collettiva che
«raduna» il popolo. Analogamente il potere politico risiede
eminentemente nella wmmah che & anche detentrice della
propricta, per esempio terriera. Chi nel Medioevo avesse
ricevuto in affido un appezzamento (igtd’) avrebbe dovuto
~ almeno in teoria ~ alla sua morte renderlo al benessere
pubblico
Secondo Ibn ‘Abbas che lo conobbe, il Profeta avrebbe
detto: «Coloro i quali rilevano qualcosa [cli sbagliato] nel
loro sovrano, si rassegnino: poiché chiunque si allontani
dalla comunita, sia pure d’un palmo, muore in stato di
ignoranza (jahiltyyab)». Eun suggerimento quietistico, ma
anche la prova del fatto che lidentitA del singolo é realizza.
ta soprattutto sullo sfondo della comunita, che lo integra €
lo protegge.
Cosi é evidente che nel pensiero islamico classico non
esista il principio della territorialita dello stato, e nemmeno
quello di «nazione». La parola watan significava in origine
il luogo di nascita (nel Corano 9: 25, nella forma derivata
BL
Islam e politica \
mawiatin indica i «campi di battaglian); solo nel dician-
Rovesimo secolo @ divenuta un neologismo per alludere alla
«patria». Uno dei termini pid frequenti con cui si traduce
«popolo» (qawom) 2 restrittivo perché in origine indicava la
tribt o il clan,
Lislamista Panayotis Vatikiotis ha seritto
to religioso monoteistico di por
ino universale, In questo senso
ali basate su frontiere territori
ed etnico:
1¢ di uno st 14 nuova nazione,
quella dei credenti o fedeli, ummat al-mu'minin. Il fondamente
stesso di questa nuova nazione e, se si vu
@ stato la religione dellIslam. Lo stato fue rimane il suo st
Lo stato, percid, non ha valore in sé, né venne fondato con valore
femporale, come stato nazione, per un determinato popolo a esclu
sione di alte. (...] L"Islam in altri termini, mica ne, ossia
hha ambizioni di integrazione su scala universale,
Questa @ stata, ad un tempo, la forza e la debolezza del
califfato: un’istituzione che, grazie alla sua potenaiale uni-
versalita, & sopravvissuta per sei secoli (dalla morte di
Muhammad nel 10 (632] alla caduta di Baghdad sotto le
spade mongole nel 749 [1258]) e ancor nel nostro secolo ha
mobilitato le aspirazioni panislamiche; ma ch
causa di un universalismo che sempre pid difficilmente ha
otuto farsi interprete di una cultura aperta, vivace e pronta
4 particolarizzarsi, non ha saputo fornire ai popoli musulmani
tun modello funzionale di organizzazione politica,
Nella politica, come in qualsiasi altra attivita umana,
operano dei valori. B importante che questi valori non di
vengano pregiudiziali. Percid, sembra difficile essere d'ac.
cordo con Vatikiotis sulla opportunita di studiare la politi
ca dell'Islam da un punto di vista occidentale, una prospet
tiva inevitabilmente deformante. Piuttosto, @ nevessatio
correggere irrealistica einfondata immagine che dell Islam
si@ formata la mentalita corrente, grazie alla disinformazione
di cui gli strumenti di comunicazione di massa sono late,
mente responsabili. Cid non tanto significa negare le
ancora a
32
Islam politica
irriducibilita trail mondo occidentale e quello musulmano
©, peggio, assumere una posizione di pregiudizio «rovescia
to» ~ tale per cui sia necessario sottacere le indubbie con:
traddizioni di cui anche la concezione islamica é rica. Le
diversita, io credo, aiutano dialetticamente a sescors (elt
comprendersi, Piuttosto bisogna tentare di cogliere Per
ché risulta funzionale alla concezione del mondo, 0 megl 74
si direbbe al sideologiaw maa eee
lla scienza politica, che condiziona, certo, anche
Fevoluzione isttuzionele dei pacs islamici contemporan
e spiega il desiderio di autenticita che muove e tormenta i
opoli dell’Islam.
POF fronte al modello occidentale, rtenuto ~ non si sa
bene rispetto a cosa~ pitt «autentico», PIslam ha vissuto un
sentimento di frustrazione ¢ di superamento. Il teorico
islamista tunisino Rashid Ghanniishi ha puntualmente
evidenziato questo imperativo:
nostro problema & che abbiamo dovuto trattare con 'Oeci
reaper ion i debolears,nello stesso tempo mate
fale ¢ psicologica. Ammirandolo in modo eccessivo,pacalizati
dal nostro complesso dt infeiorts, abbiamo cereao di scimmiot
tarlo in tutto piuttosto che raccogliere i suoi contributi in questo
uel campo To afermo che tale telarone impale perverse
non ha niente di fatale, (..] Una volta ! Europa non aveva bisogno
di sinunciare ai suoi valori per attingere a piene mani allOriente
‘musulmano, Perché dobbiamo essere i soli a gustare i benefic
jodernita per il tramite o feseartes © di Marx:
Feraccder lode non von fae eae ch
la nostra, quella che hanno tracciato per noi la nostra religione, la
nostra storis e la nostra civilta
Nella medesima ottica,ritengo che proprio la ricerca di
un rinnovato equilibrio, spesso, in modo che pud apparire
paradossale, ritrovato all’indietro, nel passato perfetto e
imperfettibile dell’eta d'oro del Profeta e dei suoi Compa
gni, costituisca la chiave privilegiata dellinterpretazione
della politica nell’Islam,
33
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Relazione Francesco1Document12 pagesRelazione Francesco1andreaNo ratings yet
- Karen Horney, I Nostri Conflitti Interni, G. Martinelli Editore, Firenze, 1971 PDFDocument115 pagesKaren Horney, I Nostri Conflitti Interni, G. Martinelli Editore, Firenze, 1971 PDFandreaNo ratings yet
- TesiDocument58 pagesTesiandreaNo ratings yet
- FilosofiaDocument15 pagesFilosofiaandreaNo ratings yet
- BISANTI - A Proposito Di Alcuni Studi Re PDFDocument16 pagesBISANTI - A Proposito Di Alcuni Studi Re PDFandreaNo ratings yet
- Intellettuali Nel MedioevoDocument31 pagesIntellettuali Nel MedioevoandreaNo ratings yet
- Relazione Francesco FinaleDocument10 pagesRelazione Francesco FinaleandreaNo ratings yet
- Aristotele A ToledoDocument2 pagesAristotele A ToledoandreaNo ratings yet
- Come Essere Una Persona Di Successo EstrattoDocument28 pagesCome Essere Una Persona Di Successo EstrattoandreaNo ratings yet
- Studia Graeco-Arabica: ISSN 2239-012XDocument52 pagesStudia Graeco-Arabica: ISSN 2239-012XandreaNo ratings yet