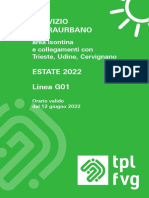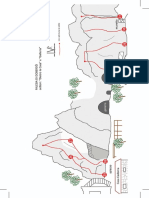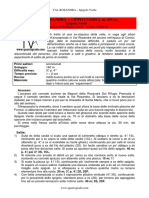Professional Documents
Culture Documents
BEGHELLI Morfologia Opera Da Rossini A Puccini PDF
BEGHELLI Morfologia Opera Da Rossini A Puccini PDF
Uploaded by
Anonymous ndDdTbAf0 ratings0% found this document useful (0 votes)
52 views14 pagesOriginal Title
BEGHELLI_morfologia_opera_da_Rossini_a_Puccini (1).pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
52 views14 pagesBEGHELLI Morfologia Opera Da Rossini A Puccini PDF
BEGHELLI Morfologia Opera Da Rossini A Puccini PDF
Uploaded by
Anonymous ndDdTbAfCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 14
‘MARCO BEGHELLI
Mosfologia dell’opera italiana da Rossini a Puccini
Com’é fatta un'opera italiana dell’Ottocento? Non & possibile una x
sposte unitatia: se per la prima meta del secolo si suocedone strategic GH
positive che accomunano grosio modo la produzione di Rossini, di Doni
Zetti, di Bellini, del giovane Verdi e dei tanti autori di contorno [Beghell
2o04cl, gli anni successivicoztispondono a un progressive superamento di
tali schemi, a favore di strutture pitt indeterminate, formalmente ir
bil [Fabbri 1988] " = formainente ner
1. Lied seteceniceif supeemenio del ea remeticementey
ica
A inizio Ottocento resiste ancora, perdurando
del stale ears dn Havent gaamense Spars bu ton tal
(endecasillabi settenari variamente alternati) destinati ai recitativi (in tere
mini musicali, formulette vocali stereotipiche, ritmicamente libere, for
malmente aperte, sostenute da scare armonie del cembalo - recitativo see-
co ~ 0, sempre piti spesso, dell'orchestra - recitativo strumentato 0 accompa
gnato) e versi lirici (perlopiti quinati, senari, settenari, ottonati o decasillabi
regolarmente rimati e raggruppati in strofe) finalizzati ai cosiddetti nume-
#i (owveto pezzi chiusi, 0 misurati, 0 cantabili come vengono dett, in ragion
Tene oa titmica ¢ melodica che li distingue dai re-
ivi). Due fondamentali differenze intervengono tuttavia rispetto al e-
colo precedente: ero pero al
1) Vinteresse sempre pid spiccato per i numeri d’assieme: non solo atie
solistiche, dunque, ma vieppisi duetti (ben rari fino a met Settecen-
to), terzetti, quartetti, nonché scene di massa cui s'unisce il coro, po-
sizionate in momenti strategici, tra i quali apertura di sipario (n-
troduzione) e la chiusura d’atto (Finale Primo, Finale Secondo);
2) il superamento della netta distinzione drammaturgica fra rectatvi
portatori dell’ szione e pezzi cantabili adibiti a sublimare liricamente
Paffetto che il recitativo ha prodotto: gi in Rossini non ¢’é, di fat=
Beghelli Morfologia dellopera italiana da Rossini a Puccini 895
to, evento d’una certa importanza per l'azione che non venga insce-
ato a tempo di musica, nei versilitici di un numero chiuso.
Di queste nuove istanze s'impadronisce ben prima l'opera buffa che
pon Topera seria: bastezebbe confrontare, in campo mozartiano, ! oppo,
om jplogia narrativa di Cos fan tute (1790) ¢ La clemenza di Tito (x792)
A farene una rgione. Se prendiamo a paradigma una partitra come Gi.
Mi Seozia di Giovanni Simone Mayr che apre il nuovo secolo (x80)
Roe per successo¢ diffusione costituira un modello melodrammatico ne~
Gh anna venie, vediamo come Iazione stent ancora a fare il suo ingres-
fet numeri chiusi dell’opera seria, sempre pi vasti, sempre pit spesso
iewati da interventi coral, ma sostanzialmente statici sul piano dram-
matico.
Non tuttavia sul piano musicale, essendosi ormai largamente diffuso il
fuovo modello di aria in due tempi che peril xrxsecolo rappresentera atia
pear courdell’opera cra, denominata eventualmente cavatina oppure rond
eiedottata, rispettivamente, come “aria di sortita”, di serena “presentazio-
Sot scenica e musicale del personaggio sul principio del primo atto, ovvero
rene “grande aria” affettivamente tormentata nel secondo atto, a ridosso
Gel déxouement, o gioiosamente risolutiva, in luogo di finale d’opera [Be-
hell 20005). Sua caratteristica musicale & appunto la giustapposizione di
OMe tinte sonore contrastanti, legate ad agogiche e affetti contrapposti: un
fempo Adagio e uno Allegro, un momento it distesamente cantabile ¢ un
ito pid rapido, con funzione di srettaconclusiva (il motivo melodico, ac-
fantivante, prendera presto il nome di cabaletta [Beghelli 2o0oa)), una se-
Gione dove dominano di preferenza i toni patetici, l’altra votata a quelli bril
Tanti o eroici, con frequente taglio virtuosistico.
‘Su questa bipartizione musicale e affetiva si attestano ben presto non
solo le arie, ma anche i pezzi a pit voci, nei quali si fa sentire sempre pit
fimpellente la necessitd di addurre una ragione drammatica plausibile per
Timprovviso cangiamento d’umore veicolato dalla musica. Non fu tuttavia
sempre facile coniugare le ragioni della forma musicale con l'opportunita
Geammatica, se ancora a meta Ottocento non mancano a Verdi le occasio-
ni per lamentarsi in proposito coi suoi librettist
[Non ce dstacco di pensiero dal'adagio a quelio della cabaleta [nel testo or
sinaiamente foritogi per la cavatina del tenote, nei Due Foca: queste son co-
eee andran bene in poesia main musica malissimo, Fa fare dopo Iadagio un pic-
Sdlissimo dialogo trai ante e Jacopo, poi un uftcale che dica « Guidate il prigi
Gierom poscia una eabaletta, ina che sia di forza (lettera a Francesco Maria Piave
del22 maggio 1844, in Cesare Luzio 1915, p. 4261
Penetrando dentro il numero chiuso, l'azione ne articola dunque la for~
"ma: non come recitativo inserito frammezz0 alle due sezioni portanti (’Ada-
fio c'Allegro), ma come parte integrante del pezzo cantato, di cui assume
806 Storie Beghelli Morfologia dell’opera italiana da Rossini a Puccini 857
ritmi verbali (versi lirici) ¢ musicali (andamento misurato). Tale “zeppat
harrativamente dinamica inserita fra un Adagio cantabile e un Allegro cq. 2. Ragioni drammatiche e convenzioni formali
balettistico tendenaialmente statici assume il nome, intuitivo, di Tempo q
mezzo, cui danno il loro apporto messaggcri, ancelle o coristi d’ogni idem.
titd sopraggiunti inattesi a interferire con Paffetto dei personagei impegnat,
nei loro numeri “a solo”. Rimane invece parzialmente irrisolto, sul pia
drammatico, il problema del successivo Allegro: quella che nell’atia in d
tempi di fine Settecento era stata una semplice Stretta giustapposta alla
zione lenta dell'aria, a mo’ di brillante conclusione [Chegai 2003], nei pa
mi decenni dell’ Ortocento cresce progressivamente per dimension’ e aut
nomia formale, sino a raggiungere I'apparente statuto di ulteriore aria age
stante (e non mancano di fatto, nei moderni testi divulgativi, improprie et
chette del tipo di “aria doppia”, a disgiungere I'unione formale di Adagio
Allegro, ovvero di “seconda aria”, per indicare quest’ ultimo). La nug
Stretta, ben evidente gid nel Rossini maturo (si vedano, per tutte, la
vatina di Malcolm nella Donna de! lago, 1819, 0 quella di Arsace in Se
tamide, 1823), si snoda a sua volta in quattro momenti successivi: la prim
esposizione della cabaletta (come s'? detto, il tema melodico portant,
ponte intermedio musicalmente piti neutro ¢ indistinto, la seconda eg
zione della stessa cabaletta, una coda che trie fila dell'intero brano. I]
lebre finale del primo atto della Traviata (1853) di Verdi, tutto incentra
su una grande aria del soprano, ben si presta a esemplificare didatticamen
te le fattezze di una stretta, essendo ponte ¢ coda facilmente individuab
¢ citcoscrivibili per la presenza inattesa anche di una voce di tenore:
Pert gli addetti ai lavori, il cimento consisteva insomma nel conciliare al
jo forma e dramma: fino a quando l’azione era rimasta esclusa dal! aia,
problema non si dava, vivendo lara in una sua dimensione peculiarmente
jcale, drammaticamente sospesa; ma nel momento stesso in cui I'aria si
ticola al suo interno per aderire all'azione, un minimo di plausiblita vie
fe pur richiesta, benché non sempre raggiunta
TTroviamo un esempio del tutto compiuto e pressoché perfetto di con-
durre una scena solistica in equilibrio fra ragioni drammatiche e conven:
fini formali nel numero conclusivo della donizettiana Lucia di Lammer
oor (1835), tutto incentrato sul tenore. Quello che in passato era stato lo
fearno recitativo secco sorretto dal cembalo & ormai divenuto un ampio e
colato recitativo strumentato (tecnicamente chiamato Scena), non pri-
od'interesse musicale (c’é tanto di preludio introduttivo), di una certa am-
wza retorica nell’orchestra e nella voce (che non si limita pit a formn-
ritmico-melodiche stereotipate), di una pregnanza espressiva ricerca-
sin nel libretto e degna d'un monologo drammatico. Non é dungue un
Edgardo» con V’incipiticastico della scena («Tombe degli avi miei»), anzi-
thé - come di consuetudine — con quello dell’aria propriamente detta («Fra
ame ricovero»)
INE pid né meno di quanto avveniva in un’opera settecentesca, il pezz0
thitso, melodicamente squadrato, ritmicamente misurato, sboceia anche
{come effusione lirica (poetica e musicale insieme) attorno all'affetto co-
io dal recitativo (nella fattispecie, V’afflizione dell'eroc che sicrede de-
fivamente tradito dall’amata, convolata ad altre nozze), ma vive di una
ddinamicitA intrinseca, musicale non meno che drammatiea, tae da supe
‘ogni sintomo di staticita: sebbene nel linguaggio corrente si tenda a
A tficare l’aria di Edgardo con questa sola prima sezione lirica, il nume-
E questa una struttura rigidamente codificata fino a meta secolo, ma dh @ musicale si prolunga infatti, con le sue articolazioni interne, fino al ter-
troppe volte nella produzione d'inizio Ottocento sentiamo come apie dell’ opera, attraverso fasi drammatiche ¢ musicali successive. All’ Ads-
cata al precedente Adagio quasi per obbligo formale. La doppia esposi gio cantabile « Fra poco a me ricovero» segue dunque un Tempo di mezzo,
ne di un medesimo motivo aveva trovato infatti in origine una giustfis
zione edonistica: il piacere di udire il cantante variare ad arte la ripresa
‘quella cabaletta; col tempo, era diventata una semplice asseverazione de
matica del concetto esposto, percepita in molti casi ~ se il dramma fat
giustificare la presenza tutta di quel!’ Allegro baldanzoso dopo l'efusio
lirica di un Adagio pateticamente cantabile ~ come un'anticaglia in
brante, quando non un vero e proprio controsenso, 1a dove la conver
della stretta costringe il personaggio a sostare in scena per limmancabi
cabaletta doppia, foss’anche in una situazione di totale urgenza.
‘abaltta (prima esposisione, preceduta da intonazione strumentale): «Sempre li
a dega’io»
ponte intermedio: canto del tenore fuori scena, poi «Follie!..follie!...»
‘abaletta (seconda esposizione): «Sempre libera degg’io»
‘coda: vocalizzi conclusivi attorno al canto del tenore
coro fail suo ingresso in scena per informare l'eroe sui nuovi sviluppi (la
pverina, costretta a nozze indesiderate, ® uscita di senno, rimanendo in-
sopraffatta dal dolore) e apportando cosf quel mutamento d’affetto - la
aggiunta disperazione per la morte della donna amata ~ che giustifica
hima sezione dell aria: Allegro o Stretta (vuigo: “la cabaletta” senza me-
‘to, secondo un facile processo di sineddoche, che identifica la parte ~ il mo-
tivo melodico ~ con il tutto). Ebene, l'esempio in esame si allontana dal-
media per una non comune aderenza alle ragioni del dramma: la strutti-
Beghelli Morfolo
898 Storie dell’opera italiana da Rossini a Puccini 899
1a di stretta sopra delineata perde infatti ogni meccanicita, ¢ la cabaletta
propriamente detta «Tu che a Dio spiegastiI'ai» viene separata dalla sua
Pinonica ripetizione attraverso un ponte drammaticamente risolutivo, in
quanto ospita nientemeno che il suicidio dell'eroe (Ia climax emotiva che
Sorta allinsano gesto viene tradotta in musica nel cosiddetto crescendo: un
Prtificio non solo dinamico, ma principalmente metrico, che consiste nella
Hpetizione concatenata, solitamente per tre volte, sempre pi fragorosa, di
tun medesimo modalo strumentale ritmico-melodico costruito appositamente
Jogica, ormai sempre o quasi di tipo accompagnato dall’orchestra), serve a
_endere chiar i termini della questione: ‘Norma, git amante pt di Pol-
fone, ch’e ora sentimentalmente unito con Adalgisa, ha deciso di farsi da
te, alfidando i due figli al loro legittimo padre e alla sua nuova sposa,
ima di togliersi la vita. Leggendo il testo, si noti la libera alternanza di
Endecasillabi e settenari, nonché il tipico fenomeno della frantumazione del
‘yerso tra i personaggi, quando il dialogo si fa serrato:
2 th Oak, Pagar questa
wa isare a ruoto suse stesso). Trafitto da parte a parte, Edgardo non po |" contaminatad prises
{rt quindi pid intonare la seconda cabaletta con la baldanza della prima vl Sein, nd tar neo pow Searle
tar alla tradizionale riesposizione letterale si sostituisce eccezionalmente quest infec. a tel afi. endecsllao fatto
cane dpetizione stentata, rammentatia: il violoncello solista viene allorain | 4Dsiom cielo: —_} farduc pnonser
soccorso del tenore languente, intonando in sua vece la ripresa della cabs. Ame li affidi? ‘endecasillabo fratto
Jetta ~ donde il doppio effetto di una “personificazione” sentimentale del. = eee } ra due personagei
Jo strumento e di una “naturalizzazione” sentimentale della forma [Zop- Shr he —— oe RI Se OA. endecasillabo
lit 85-87, 93]. Una rapidissima coda recante I'ultimo respi a? chal ie | ete ft
pelli r994, pp. 85-87, 93). Una rapidissi la recante spiro Noma Sposo frston peronags
EEll'eree conclude la partitura in poche battute musicalmente risolutive,
Strutturate su un giro di cadenze armoniche stereotipate aoaiciss —Sposo!... Ab! noa mai due versiasegalare la
tisia men erado.. io gli perdono e moro. vim bacata fre ulti’
ee Lindman | che Ta
La Scena di preparazione si chiude dunque con una situazione di con-
| fitto: ed & questa che fard scaturire il duetto, inteso come un microdram-
~ ma fra due personaggi incarnati da due voci contrapposte. Il “duello” si
consuma metaforicamente a suon di musica, di stoccate vocali concorren-
i, Si parte con il cosiddetto Tempo dattacco, una tipica sezione d'avvio,
che importa Pazione all’interno del numero misurato in versilitici (qui ot-
tonari) prima che scocchi l’ Adagio tipico dei pezzi d’assieme, il Tempo dat-
tacco non & tuttavia del tutto sconosciuto alle ari solistiche pié comples-
se, specie d’epoca rossiniana [Beghelli 2004¢; Lamacchia 1999)). Le «due
strofe pari di quantita» cui siriferiva Ritorni e che ne costituiscono lossa-
tura portante sono davvero la «proposta e risposta» con cui i personaggi si
attaccano ¢ contrattaccano, utilizzando in successione una medesima arca-
fe elodien evidensiare metaforiarentelexbisione dupa fora eto-
rca, gesto tanto pitt significativo qualora il secondo personaggio non inten-
Bittasi sopsetiare dal primo: ind :
3. La “solita forma” del duetto.
Ecco: questo brano da Lucia di Lammermoor, che sulla carta avrebbe
dovuto imporsi come modello compositivo del tutto efficace sul piano
‘Grammaturgico-musicale, spicca invece pet la sua eccezionalita, la “solita”
forma dell aria in pit sezioni successive venendo troppo spesso ripropos
per dovere d’ufficio, piuttosto che per una puntuale aderenza al decorso
Fell azione, Le istanze drammatiche risultano semmai raccolte con maggiore
consapevolezza dai brani a piti voci, a cominciare dal ductto (Balthasar
980] che, pur enucleando al suo interno la contrapposizione Adagio/ Alle:
‘gro tipica dell aria solistica, sviluppa una propria drammaturgia
temente codificata, cos{ riassunta da un commentatore del!’epoc
‘Un duetto, verbigrazia, comincierd [dopo la Scena] da duc strofe pari di quan
tia, nelle quali, con propostaerisposta si dic un libero sentiment, tanto pi de
Ul alt importante nel senso poetico, quanto meno complicato nel accompagnamen
Sp mmuseale [-1. Vera talora dopo fadagio in ci si isponderanno perketa
Go sentiment edesinenze loro i versi de” due contendenti, Terra dietro un dsl: panne somtersi
go di canto dissimulato a guisa de’ recitaivi, Finalmente nella cabaltta si combi ‘Deh! con te, con te li prendi. ‘Vado al campo, ed allingrato
Be Ghoo a cantar asseme forse le stesse parole [Ritorni 1841, p. 44 lisostieni i dies tutto root hod lamet
Non ti chiedo onot,«fasci La pietd che mai destao
‘Vediamone la realizzazione pratica in un celebrato esempio bellini a tuoi figli ei fian serbati; parlera sublimi accent.
‘«Scena e Duetto» fra Norma e Adalgisa nel secondo atto del!’ opera No pesos ea ied Spera, pera... amor, natura
(851). La Scena («Me chiami, o Norma!...»), condotta attraverso i trad Pate ce eee ae eae
ional versi sciolti da intonarsi in stile recitativo (a questa altezza cron che tradi io fui per te. Norma ancot vi regnera
900) Storie Beghelli Morfologia dell opera italiana da Rossini a Puecini gor
Si trata dungue di strofe non soltanto verbali, ma anche e soprattutt
melodiche: due periodi identici in s¢ conchiusi, articolati al loro interno se.
condo una struttura fraseologica antropomorfica, dal respiro biologicamente
ordinato: quattro cicli completi di inspirazioni ed espirazioni, uno per ogni
istico. Gli studiosi d’oltreoceano hanno coniato l'etichetta di /yric form,
riferibile ~ nella sua manifestazione piti regolare ~ a una struttura melodi.
ca di x6 bartute (due per verso) organizzate musicalmente in a,a’,,a”,(j]
numero in pedice indica le battute pertinenti a ogni frase melodica), cof le
saltante, cid dipende - v't da creder!
della necessaria consapevolezza st
{ell'aureo belcantismo primottocentesco)
‘Quando i personaggi rientrano in sé - con loro il pubblico che ha sa-
'e voluto lasciarsi sedurre — scocca il Tempo di mezzo, che come nell'atia
folistica ha il compito di create le condizioni per cui, al termine del duet-
dalla rozzezza di esecuzioni pri- |
to, le posizioni del dramma non siano pit le medesime dellinizio:
tica, lontane due secoli dai canoni
apauctss Cedi... deh! ced!
varianti possibili di un , suddiviso in b, +b’, e dell'a”, sostituito da un Noma ‘A! lasciami
4, cui fanno per solito seguito code melodiche di varia natura col libero re. Bi’ama
pero di parole gia proferite in forma lineare [Huebner r992; Pagannone anata Egil sen pente
1996], La cabaletta «Tu che a Dio spiegastil'ali» sopra ricordata é una per. et ele quateniin
fetta hric form + coda, cosi come lo sono «Di quella pira» e centinaia dpe
riodi melodici ben fissatisi negli orecchi dell'appassionato ascoltatore do.
pera, La dyric form & insomma un’unit’ metrica e nel contempo narrati
del periodare melodrammatico, un discorso organizzato retoricamente in
tun’esposizione iniziale (1° € 2° verso) con reiterazione asseverativa (3°
4°), uno svolgimento centrale di riflessione (5° e 6°) e una conclusi
d’epilogo (7° ¢ 8°): un’effusione lirica, appunto, in grado d’inearnare mu
sicalmente I'unita temporale,I'espressione di un singolo gesto scenico dila-
tata poeticamente in un ampio gesto vocale.
Espressa ognuno la propria istanza, i due personaggi tendono pian pi
no ad avvicinarsi affettivamente, con botte ¢ risposte sempre pid serrate,
fino a congiungersi nel successivo Adagio cantabile in un canto comune
due voci parallele (alla base, naturalmente, una Aric form anche qui, be
ché ampliata dalla doppia esposizione in alternanza fra i due personagai)
sol amistade or sente
Norma O giovinetta!... e wuoi?.
npavctsa Rendertii drtti cui
‘ teco al cielo e agli uomini
‘Furo celarmi ogner.
worm Hat vinto... hai vinto... Abbracciami, j
‘Trovo un’amica ancor
Sono frasi, queste, che per contenuto potrebbeto ben servire un recita-
‘tivo; mantengono tuttavia la struttura metrica di versilirici rimati (qui tutti
renari, ora sdruccioli, ora piani, ora tronchi) e ricevono un'intonazione
vyocale fintamente libera («un dialogo di canto dissimulato a guisa de’ reci-
tativi», scriveva Ritorni) su un tappeto orchestrale che al contrario di un
recitativo & perd rigidamente strutturato. Siamo insomma all'interno di quel
_genere compositivo che i contemporanei appellavano stile parlante: i perso- i
i dialogano con libertA su un’orchestra mensuralmente organizzata. i
!
cane NORMA “Proferito I'ultimo verso del Tempo di mezzo, il compito del dramma-
‘Mira, o Norms, a’ cual ginoochi ‘Ab! perché la mia costanza sarebbe concluso: in un dramma parlato i due personaggi abbando- |
binper pores fide aa sbbero la scena, catico ognuno del nuovo sentimento che lincontro/scon-
igo glia suscitato in seno. Ma siamo nel mondo del melodramma, dove an-
che leragioni estetiche della musica pretendono la loro parte, suggellando
il pezzo con un rituale sonoro confacente alla situazione: ecco dunque la
“Suretta conclusiva, dove i personaggi «si combineranno a cantar assieme
Te stesse parole»:
NORMA © ADALOISA ,
Si, fino aloreeatreme
‘ompagna tua a avra: Hl
Der Heovraelinsieme !
pia & la tezza ass |
‘Teco del Pato al onte
ferma oppor la fronte,
finché mio core a batere
fo seta sult cor.
se non hai di te pier presso a morte un cor non ha.
1 tempo drammatico tende ora a fermarsi, iretito ~ al pari del pubbl
co - dalle spire canore in cui le due vocis'intrecciano; i personaggi asc
momentaneamente il campo ai cantanti per allettare lo spettatore con md
Iie struggenti melodie: é il trionfo del beleanto, inteso come l'arte di pie
gare la voce a quanto di “idealmente” pit bello, di pit astratto dalla “real?
cdrammatica si possa immaginare. L’incantesimo culmina nella cosiddett
comune, la grande cadenza vocale in cui anche orchestra sospende
tanto di scansione temporale che ci aveva tenuti ancora legati alla realt m
teriale, per consentire infine alle voci di librarsi senza peso in volute ine
brianti che toccano il vertice espressivo concesso a questo stile musicale (se
al contrario Peffetto ci suona oggigiorno troppe volte stucchevole, anzie
You might also like
- Percorso Formativo 2022Document45 pagesPercorso Formativo 2022Anonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- Legge Regionale 11 Ottobre 2012 N. 19Document93 pagesLegge Regionale 11 Ottobre 2012 N. 19Anonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- La MigliavacaDocument2 pagesLa MigliavacaAnonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- Laurea - Allevamento - Salute - Aniamale - 2022Document8 pagesLaurea - Allevamento - Salute - Aniamale - 2022Anonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- Servizio Extraurbano Linea G01 Estate 2022Document17 pagesServizio Extraurbano Linea G01 Estate 2022Anonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- Doberdò Schizzo3Document1 pageDoberdò Schizzo3Anonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- ROSANDRA - Spigolo VerdeDocument3 pagesROSANDRA - Spigolo VerdeAnonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- MessiaenOliver PDFDocument44 pagesMessiaenOliver PDFAnonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- Be-Bop e Cool JazzDocument2 pagesBe-Bop e Cool JazzAnonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- Ashley Kahn A Love Supreme PDFDocument30 pagesAshley Kahn A Love Supreme PDFAnonymous ndDdTbAfNo ratings yet
- Arrigo Polillo Le Origini - New Orleans - ChicagoDocument4 pagesArrigo Polillo Le Origini - New Orleans - ChicagoAnonymous ndDdTbAfNo ratings yet