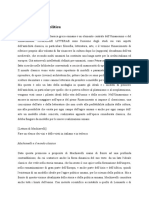Professional Documents
Culture Documents
Nomi Personaggi Mandragola
Nomi Personaggi Mandragola
Uploaded by
Angelo Pagliardini0 ratings0% found this document useful (0 votes)
71 views18 pagesOriginal Title
NomiPersonaggiMandragola
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
71 views18 pagesNomi Personaggi Mandragola
Nomi Personaggi Mandragola
Uploaded by
Angelo PagliardiniCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 18
PASQUALE STOPPELLI
La Mandragola: storia ¢ filologia
Con I’edizione critica del testo
secondo il Laurenziano Redi 129
BULZONI EDITORE
‘TUTTI I DIRITTI RISERVATI
B vietata la traduzione, la memorizzazione elttronia,
la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo
‘compres la fotocopia, anche ad uso interno 0 didattico
Lilleito sara penalmente perseguibile a norma delat 17
della Legge n, 633 del 22/04/1941
© 2005 by Bulroni Editore |
(00185 Roma, via dei Liburni, 14 ;
tp:fwwewbulzoniit
e-mail bulzoai @bulzoni it
ISBN 2570.01.
TNOMI DEI PERSONAGGI
In un frammento riportato da Ateneo!, Antifane, drammaturgo ateniese
attivo nel IV secolo a. C., sostiene che I’arté del poeta comico é ben pid diffi-
cile di quella del tragico®. Quando Edipo entra in scena, basta che sia proferi-
to il suo nome e gli spettatori sanno gia tutto di lui, Il poeta tragico non ha
bisogno di raccontare l'antefatto. I commediografo, invece, mette in scena
ogni volta una vicenda nuova’. Gli spettatori della commedia non conoscono
preventivamente i personaggi: sono costretti a scoprirli man mano che Ia rap-
1 Bnudito greco det IIL secolo d, C., autore dei Deipnosofit, opera in quindici
porta, fra altro, citea 1500 frammenti di testi di autori greci andati perduti. L'opera &
‘ata tradotta in italiano in una splendida edizione: Ateneo, I Deipnosofisti, Prima traduzio-
fe italiana commentata su progetto di L. Canfora. Introdurione di Ch. Jacob, Roma,
Salerno Editrice, 2001
a paterita del frammento (2222-b) & da alcuni atibuita ad Aristofane. Si tascrive
dall’edizionecitaa (II, pp. 541-42): «La tragedia& in tutto poesia fortuna: il pubblico / ne
‘conosce bene gli argomenti/ ancor prima che parli un personaggio: sicché il poeta / deve
Solo ricordarli. Mi bastera di Edipo faze il nome: / ogni altra cosa il pubblico conosce: che
Laio gli ® padre, / madre Giocasta, quali son le sue figlie e quali i tigi / che cosa pati
{quali imprese ha compiuto. / Se uno poi nomina Alemeone, anche i bambini subito / hanno
{ia dete tutto: che in preda a follin uccise /la madre, e che subito Adrasto adirato / giun-
fget.¢ di nuovo poi se ne andra [..] / Quando poi non riescono a dite pit nulla / per assolu-
fa mancanza di drammatiche risorse, /itragici, come un dito, sollevano la macchina, / con
fappagamento degli spettatori. / La stessa cosa non @ leita a no, che dobbiamo /invemtarci
{uto: nomi nuovi, argomenti nuovi, /discorsi nuovi, ¢ inoltre Vantefsto, / le vicende in
‘corso, Pepiloge /¢ Fesordio, Se un Cremete oun Fidone trascura/ uno qualungue di questi
lementi lo si caccia subito a fischi. / Cid si concede invece a Peleo e a Teucro.»
[Traduzione di A. Rimedio}
Cosi commenta Borsellino 1989, p. 20, in maggine al frammento di Antifane: «ll
comico percid non raccoglie una memoria colletiva, né fa riferimento a un astro maggiore
Su cui misurare le proptie distanze. TI suo nucleo originario & un buco nero, un orice in
‘cu precipita la sua prima essenza: il riso»
Soria eflologia della Mandragola
presentazione si svolge. L'argomento 0 il prologo possono tutt’al pitt dare
informazioni sommarie. Il tragico dispone di quanto gli occorre ancora prima
di cominciare. 11 comico ® tenuto a inventare ogni volta tutto: i nomi, I’argo
mento, i discorsi, ¢ poi I'antefatto, lepilogo. Nella lista di Antifane i nomi
coccupano il primo posto, come se si dovesse cominciare proprio da fi. Di
fatto in commedia il nome @ il primo segno distintivo del personaggio, il suo
cartellino, Anche per il personaggio comico il nome ha a che vedere col suo
destino, seppure in una forma meno costrittiva di quanto non avvenga in tra
gedia, 0 addirittura in modo antifrastico.
In un saggio dedicato ai nomi in commedia Anne Barton‘ sostiene che
proprio in questo genere teatrale si giocherebbe la partta pit) interessante fra
Cratilo ed Ermogene, i due personaggi del Cratilo di Platone divenuti ct
mi rispettivamente della significativita e della convenzionalita
nella commedia pid che in altri generi, come il romanzo o il raci
Vautore dispone di tempi pit distesi per la descrizione del personaggio. Se
infatti facciamo riferimento alla commedia dall’eta classica fino al teatro se
tecentesco, osserviamo che i nomi sono tendenzialmente motivati. O perché
dichiarano esplicitamente le caratteristiche del personaggio, o perché, anche
se non sono linguisticamente “parlanti”, finiscono per definire convenzional-
mente un tipo anagrafico ¢ sociale, dunque acquisiscono all'interno del gene~
re lo statuto di eponimi. Truffaldino, Tagliacame, Spaccamonti, Sbrodegona
sono nomi goldoniani che contrassegnano immediatamente un tipo; ma a chi
conosce le convenzioni del genere dicono molto anche nomi come Florindo,
Rosaura, Colombina 0 Doralice. Quando Goldoni nella lettera «A chi legge»
premessa al Sior Todero brontolon dell’edizione Pasquali, scrive: «Usavasi
tun tempo dare ai personaggi delle Commedie de” nomi ¢ de” cognomi tratt
dal loro carattere, 0 dai loro difettin’, lascia intendere di non condividere pid
questa consuetudine. L’alternativa sari di dare ai personagei nomi realistici
(Claudio, Roberto, Angelica, Camilla, ece.). L’autore sara allora costretto a
mettere in atto degli accorgimenti drammaturgici per supplire alla mancanza
di informazione che il nome-etichetta garantiva. Una lunga carriera teatrale
2 modo a Goldoni di sperimentare tutte le possibilita onomaturgiche a
disposizione di un autore di commedie
Plauto nelle sue 20 commedie da il nome a circa 175 personagsi: di que
sti solo cinque condividono il nome con un altro personaggio. Dei 75 perso-
“A. Barton, The Names of Comedy, Oxtord, Clarendon Press 1990, p. 14. Il saggio,
{dopo un capitotointroduttivo, analizza sopratutto j nomi delle eommedie di Shakespeare
"Tutte le opere di Carlo Goldoni, a cura di G. Onclani, VIll, Milano, Mondador
1948, p. SI
igi non
hanno nor
pitt creati
pitt all’in
ventiva st
con eleme
terenziana
uso di e
Chremes
Mach
nabile pe
grafo @ fi
chiavelli
tanto rist
ratio al s
capitolo,
conto dit
@ denomin
cia, Ligur
Lnon
i Callims
all’onoma
V Heautor
un po! m:
V'Heauton
gi Machis
una comp
variegata,
Dei r
bili, “Call
battaglie,
dragola ®
conquista
rma nel let
pertinente
moteo. “)
vincitore,
tutto amb
“Timoteo
mo tutt'al pid! darne
Iecorre ancora prima
futto: i nomi, I'argo-
tdi Antifane i nomi
ge proprio da li. Di
| personaggio, il suo
i che vedere col suo
ynon avvenga in tra-
Barton' sostiene che
pil interessante fra
pne divenuti emble-
Bionalita dei nomi
Fo il racconto, dove
del personaggio, Se
Ea fino al teatro set-
Smotivati. O perché
fo, © perché, anche
fire convenziona
interno del gene-
smonti, Sbrodegona
Be un tipo; ma a chi
come Florindo,
ra «A chi legge»
serive: «Usavasi
ide” cognomi tratti
condividere pit
nomi realistici
allora costretto a
fire alla mancanza
carviera teatrale
‘onomaturgiche a
maggi: di qui
Dei 75 perso-
Milano, Mondadori,
I nomi del personage
nagei nominati nelle 6 commedie di Terenzio ben 28 sono invece quelli che
hanno nomi condivisi. Plauto & dunque dal punto di vista onomaturgico ben
pid creativo di Terenzio. Egli affida la riconoscibilita del personaggio per lo
pid all’interpretazione del nome. I nomi plautini dimostrano una fantasia in-
ventiva straordinariamente fervida: nomi parlanti, antfrastici, ora composti
con elementi greci ‘ora misti. Il maggior naturalismo della poetica
terenziana fa invece che il personaggio possa rendersi riconoscibile attraverso
uso di eponimi: Sostrata @ il nome della matrona, Bacchis della meretrice,
Chremes del vecchio, Siro del servo. I modi sono diversi, il fine & lo stesso.
Machiavelli non & un autore seriale di commedie, dunque non & parago-
nabile per questo verso a quelli finora citati. La sua attivita di, commedio-
grafo é limitata, ma non per questo secondaria. L’onomastica comica di Ma-
chiavelli va di conseguenza saggiata su un campione ristretissimo di nomi
tanto ristretto da rendere incerta finanche la possibilita di individuare una
ratio al suo interno. Il tentativo di interpretazione che ® oggetto di questo
capitolo, per giunta centrato sulla sola Mandragola, & costretto dunque a far
conto di un insieme di otto personaggi e sette nomi (uno dei personaggi non
@ denominato). Cominciamo facendone I’elenco: Callimaco, Siro, Messer Ni-
cia, Ligurio, Sostrata, Frate Timoteo, Una donna, Lucrezia.
I nomi dei due personaggi minori, Siro e Sostrata, rispettivamente servo
di Callimaco e madre di Lucrezia, sono un evidente omaggio di Machiavelli
all'onomastica di Terenzio. “Sostrata” @ il nome della madre i famiglia nel-
T' Heautontimorumenos, nel Hecyra € negli Adelphoe: nella Mandragola
un po madre di famiglia, un po’ ruffiana, “Siro” & il nome del servo nel-
V'Heautontimorumenos ¢ negli Adelphoe. In relazione a questi dt
‘gi Machiavelli fa dunque propria l'eponimia terenziana. E il primo tassello di
‘una composizione onomaturgica che risulterd alla fine alquanto complessa ©
variegata,
Dei restanti cinque nomi ben quattro sono etimologicamente interpreta~
bili. “Callimaco” &, con facile scomposizione greca, il guerriero dalle belle
battaglie, il combattente valoroso e vittorioso: e il protagonista della Man:
dragola effettivamente un vincitore, riuscendo a realizzare le sue mire di
conquista, Che Callimaco combatta le sue battaglie non contro nemici armati
‘ma nel letto di Lucrezia é tuttavia un particolare che rende nello stesso tempo
pertinente ¢ antifrastico quel nome, non diversamente da quelli di Nicia e Ti
moteo, “Nicia” infatti racchiude in sé la nike, la vittoria. Ed & anche Nicia un
vincitore, avendo guadagnato con Ia certezza di un erede il trofeo che pid di
tutto ambiva. A quale costo questo avvenga lo sanno tutti, tranne Tui. Cosi pe
“Timoteo”: con etimologia greca & “colui che onora Dio”; e infatti non c"
ie personag
Storia efilotogia della Mandagola
nessuno pit sollecito del frate alle pratiche del culto. Che la sua moralita non
idissima e che sia egli pitt del lecito tentato dal denaro, sono due aspet-
ti che rendono tuttavia alquanto incerto lo statuto del nome che porta. Fin
‘qui, comungue, restiamo saldamente dentro le convenzioni proprie del gene-
re comico, seppure con una maliziosita e una capacita corrosiva che non
hanno precedenti nella tradizione plautina e terenziana, e neppure nelle com.
medie italiane avanti e dopo la Mandragola.
Ma all'interno di un'onomastica di commedia si iscrive a pieno titolo
anche il nome di Ligurio. La sua interpretazione non 2 tuttavia, come per i
precedenti, di altrettanta immediata decifrabilita. “Ligurio” deriva dal verbo
latino ligur(ririre, della stessa radice di lingere ‘leceare’*. | significati che
ligur(r}ire pd assumete sono tutti connessi con quello base di ‘leccare*, In
Orazio (Sat. 1, IIT 81) sta per ‘assaggiare, degustare’, ed & costruito transitiva
‘mente. Altre attestazioni si registrano in Cicerone, Varrone ¢ Macrobio. Te
renzio lo usa una sola volta nell” Eunuchus, in costrutto assoluto. Qui il servo
Parmenone ha introdotto il giovane Cherea in casa di una meretrice che ha in
ccustodia la fanciulla di cui Cherea & innamorato. Di questo Parmenone mena
vanto, perché oltre a far ottenere al padroncino quanto desiderava, ha per-
messo a lui di far esperienza dello squallore della vita delle meretric
Quae dum foris sunt nil videtur mundius,
nec mage compositum quicquam nec magis elegans,
‘quae cum amatore quom cenant ligurriunt
Harum videre inluviem sordes inopiam,
{quam inhonestae solae sint domi aique avidae cibi,
{quo pacto cx jure hestemo panem atrum vorent
‘nosse omnia haee salus est adulescentulis
Ligurriunt, ‘mangiano appena’, ossia ‘mangiucchiano, spilluzzicano’. E
il caso di ricordare che I’Eunuchus & la commedia di Terenzio che, Andria a
parte, lascia pid tracce nell’opera di Machiavelli: dalla rassegna dei tipi di
commedia dei vv. 35-40 (ripresi nel prologo della Cizia e nel Dialogo) alla
© Non ha alcun fondamento linterpretazione del nome di Ligurio come ‘igure, delka
Liguria’, 0 la sua connessione con “ligurio", nome di una pietra preziosa che si ieneva,
avere origine dall‘orina pietrficata della lince (vd. Sorella 1990, p. 29 sg. ripreso da S,
Melani, Polisemia nei nom della “Mandragola” di Machiavelli, «ll Nome nel testo», IV
2002, pp. 125-36).
Bun. 934-40,
disposi
v9),
preced
tori de
copia ¢
Al
Captiv
ri lasci
Al
impieg
nel cor
bona t
alla pe
0
tore” n
Callim
Io ha i
che lo
cene
attribul
ne. La
rito ch
comicc
“odios
"y
n
Saracen
1518, ¢
second
nel 149%
Einaudi
ua moraliti non
sono due aspet-
= che porta, Fin
roprie del
rosiva che non
pure nelle com
= a pieno titolo
via, come per i
eriva dal verbo
ignificati che
di *leceare’, In
ruito transitiva-
Macrobio. Te:
#0. Qui il servo
etrice che ha in
rmenone mena
derava, ha per-
retrici
iMluzzicano’.
pohe, Andria a
gna dei tipi di
| Dialogo) alla
jne ‘igure, della
is ripreso da
> nal testo», IV
disposizione in assetto militare dei personaggi dei vv. 774-76 (da cui Mand
TV 9), fino al «sati’ diu hoc iam saxum vorso» (v. 1085), che si attesta come il
precedente pitt diretto del «voltolare un sasso» della lettera a Francesco Vet
tori del 13 dicembre 1513. Del resto il giovane Machiavelli aveva tratto una
copia di sua mano dell’ Eunuchus in quello che & l’attuale Vat, Rossiano 884°
Anche Plauto usa una sola volta ligurrire. Nella scena d’apertura dei
Captivi (82-84) Ergasilus, il parassito, si lagna del fatto che col caldo i
ri lasciano la citt& per la villeggiatura, abbandonando a sé stessi i parassiti
item parasti rebus prolatis latent
dum ruri rurant homines quos ligurriant
Anche senza voler sottolineare Vimportanza del fatto che ligurrire sia
impiegato qui proprio in rclazione ai parassit, leggendo Ia glossa al verbo
nel commento a Plauto di Gian Pietro Valla® («quos ligurriant, i.e. quorum
bona turpiter absumanb», alla lettera “i beni dei quali essi portano via disone
), si ha la sensazione che il significato attibuito a ligurrire calzi
alla perfezione anche alle caratteristiche del personaggio di Ligurio.
Il Ligurio della Mandragola ® definito “parassito” nel prologo e “pappa
tore” nella prima scena; sappiamo anche che spilla talora del denaro a Nicia:
Callimaco gli promette una buona somma di denari qualora 'impresa in cui
Jo ha impegnato riesca. Un tempo Ligurio faceva il sensale di matrimoni (il
che lo rende competente in fatto di ruffianeria), poi «s'® dato a mendicare
cia tutavia la golosita, che dovrebbe essere
(0, non da Iuogo ad alcuna specifica situazio~
rio consumano nella cantina di Nicia solo un
cene e desinarin. Nell
attributo comico del person:
ne, La cena che Siro € 1
accorgimento per tenere i due persona
Tito che si sta celebrando nel piano superiore. De Sanctis notava che il lato
comico del personaggio sarebbe appena accennato: la sua figura riuscirebbe
“odiosa e spregevole””. Questo giudizio nasce da una valutazione morale.
socialmente inferiori lontani dal
*Vd. p37.
ci Acti Plauti, Comoediae is
vannis Petri Nallae ct-Nenetis, per Melchiorem Sessam et Petrum de Ravanis,
© 98y. Gian Pietro Valla, fglio del pit: noto umanista Giorgio Vala, visse tra
seconda meta del "400 ela printa del "500; & autore di un commento a Plauto pubblicato gi
nel 1499 (Venezia, per Simone Bivilagua) e poi pit volte ristampato, insieme ad altri com:
enti, nel corso del "500,
F. De Sanctis, Storia della letieratura italiana, a cura di N. Gallo, 11, Torino
inaudi, 1958, p. $99,
toriae filologia della Manragola
La dimensione di Ligurio & in effetti tutta intellettale, per nulla comica, Ma-
chiavelli attribuendogli quel nome paga un tributo alla tradizione del genere,
ma crea un personaggio che vive in una dimensione completamente diversa.
Ritornando al nome, il significato che meglio aderisce al personaggio &
proprio quello della glossa del Valla: “lo sfruttatore”. Ci si pud chiedere allo-
ra per quali vie il processo di nominalizzazione del verbo sia avvenuto. Le
Glossae greco-latinae'" attestano l'aggettivo ligurus come sinonimo di gulo-
sus, ma Machiavelli non poteva conoscerle; né sembra poter avere una qual-
che incidenza il nome di Aulus Ligurius che compare tre volte nell’epistola-
rio di Cicerone", E pid probabile invece che elemento di mediazione sia la
nota a figurire contenuta nel commento all’ Eunuchus di Guido Juvenalis'
Ligurire enim fertur ille qui cleganter et morose cumque multo fastidio suaviora
‘quaeque degustat. Nonius et dicit ligurire esse degustare. Inde abligurire: idest
avide multa consumere. Inde liguriones qui ligurientes, et suavissima edulia ac
pocula degustantes, eaque undique sibi conquirentes, patrimonia sua consum-
pserunt
Guido Juvenalis descrive i liguriones come dei golosi dal palato raffina-
to che distruggono non i patrimoni altrui, come nella glossa plautina del Val-
la, ma i propri. L'impiego di ligurire nel significato di “assaporare, assaggia-
re” (0 anche di “degustare prelibatezze”) dell’ Eunuchus ha certamente poco
a che vedere con il personaggio della Mandragola, ma il singolare ligurio,
facilmente estraibile dal plurale liguriones, era fi bell’e pronto per essere
acquisito come nome volgare.
Le incertezze sul nome di Ligurio non riguardano tuttavia solo questioni
di ordine linguistico o interpretativo. Due alire commedie fiorentine dei
primi decenni del °500 attribuiscono lo stesso nome al parassito. La prima &
Ia Commedia del geloso di Francesco Leoni, personaggio malnoto di cui
sopravvivono anche un poema latino celebrativo di Pier Soderini e alcuni ca-
pitoli in terza rima. Con il Leoni siamo nella cerchia delle possibili frequen-
Corpus glossariorum Latinorum a Gustavo Loewe incohatum auspiciis soctetatis
literarum regiae saxonicae; composuit, recensuit, edidit Georgius Goetz, IL, Lips,
Teubner, 1888, p.361 n. 48.
"pista Q. fe, WIS,9; Epist. ad fam., XVI 18, 3; Epis ad Aut, X19,
© Su Guido Juvenalis vd. p. 26,
Si ita da Terentius cum duobus commentisvidelicet Donatum et Guidone, Venetis,
per Simonem Papiensem, 1494, c.02
"Le notizie conosciute del Leoni sono quelle raccolte da Angela Piscini in Leoni
Geloso.
tazioni di M
condivide ©
levanti com
del babuass
Pindar, che
diversa. Ch
poligenetic:
stabilire un:
debito di M
qualita tra
Commedia
dalla comm
ancora aggi
tio nominis:
“logorare”,
terenziana:
un n0
E pa
ccertiss
perché
rob
aun che
salva in
Ligu
il nome
Lacco:
(uo. Egli h
tuttavia ric
riportata
la comica. Ma. tazioni di Machiavelli. La commedia del Leoni @ in versi (terzine ¢ ottave):
one del genre, condivide con la Mandragola, oltre al nome di Ligurio, due termini non irri-
nente diversa levanti come sergeri («io lo fard d’inchini e di sergeri») e babuasso («Eel ha
| personaggio & del babuasso»)', ¢ una richiesta di comparatico («Post’ho “n sodo / misser
bchiedere allo Pindar, che siate mie compare»). A parte questo, si tratta di cosa del tutto
g avvenuto. Le diversa. Che il nome di Ligurio possa avere nelle due commedie un‘ori
pnimo di gulo poligenetica improbabile. Ovviamente non abbiamo alcun elemento per
ivere una qual
e nell’ epistola-
Mliazione sia la
Juvenalis
stabilire una priorit ca. Mi sembra tuttavia difficile ipotizzare un
debito di Machiavelli nei confronti del Leoni: intanto per la differenza di
qualita tra i due testi, poi perché il sistema dei nomi dei personaggi nella
Commedia del geloso, Ligutio a p iginalita
Jalla commedia antica (otto nomi da Plauto, uno da Terenzio). Si potrebbe
ancora aggiungere la convenzionalita del parassito del Geloso eV interpreta:
tio nominis che il Leoni fa del nome di Ligurio, che & posto in relazione con
logorare”, dunque senza alcun riferimento al figurrire delle fonti plautina ¢
terenziana:
rte, & mutuato senza alcuna or
iurre: idest
issima edulia ac
Ax[AsstTo}. Io non credo sie cosa posta a caso:
palato raffina ve" se mie padre ebbe ben carestia
@utina del Val un nome ch’oggi é solo in me rimaso!
rare, a E par a dillo pure una bugia,
amente po ce certissimo egl'®: Ligurio disse
golare ligurio, perché ‘n prima la sua e poi la mi
1 E la commisse
mio per essere roba gli logorassi
‘aun che ‘n poco tempo la ridusse
solo questioni salva in un Ventre, e tutta ve la misse
fiorentine dei
fo. La prima &
palnoto di cui
i e alcuni ca-
Sibili frequen-
Ligurio in prima a dire pare il Brausse,
il nome d'un armato centurion
mia son tucte se actorno van busse
L’accostamento di Ligurio a logorare ® ripetuto poche battute pitt avanti
(us. Egli ha nome Ligurio. Oh, logorato! / ra. Chi mi chiama?). Bisogna
tuttavia riconoscere che I'accenno allo sperperare la propria roba potrebbe
avere invece relazione con la
riportata,
ppiciis societati lossa a ligurrire di Guido Juvenalis prima
bidone, Venetis, Leoni Gieloso, pp. 53 ¢ 81. IL
Laurenziano Redi 129 (vd. pp. 127-31),
assi della Man
Piscini in Leoni Anche Lucrezia (V 68) chiede a Callimaco che si faccia compare di le e del marito
* Leoni Geloso, pp. 51-2
Storia e filotogia della Mandragola
Laltra commedia che ha un Ligurio fra i suoi personaggi & I’anonima, ¢
neppure questa databile, Commedia d’Adulazione"®, uno strano miscuglio di
commedia a tesi per il soggetto e lintreccio e di commedia erudita per I'uso
della prosa (ma ci sono anche delle parti in versi), con la presenza del paras-
sito-adulatore (appunto di nome Ligurio), modellato sul personageio di Gna-
to dell’ Eunuchus. Qui il sistema onomastico dei personaggi, a parte il nome
di Ligurio, 2 in linea con quello delle commedie in versi fiorentine dei primi
due decenni del °500, dunque pitt vicino all’onomastica della sacra rappre-
sentazione che non a quella della commedia classica. Ma, almeno in questo
caso, a dirimere le questioni di precedenza ci sono due luoghi: lincipit del-
Targomento («Salvivi Dio, benigni spectatori che siate alla presenza raguna-
ti») che, dispiegando nonostante Ia prosa un doppio endecasillabo, rifa il
primo verso del prologo della Mandragola («Idio vi salvi, benigni auditoris),
il quale a sua volta aveva mutuato il “benigni auditori” dal prologo dei
Suppositi: ¢ soprattutto la seguente battuta: «Messer Silvio [...] Costui sanza
virti, homo da pocho, ignorante, benché a lui chi gli dicessi ~ egli ha a
morire el pid savio huomo del mondo — lui subito penserebbe dover esser
quello ece.»", che riadatta (stante ancora una volta la differenza di qualita fra
i due testi, sarebbe difficile immaginare il percorso inverso) una battuta della
Mandragola (IV 114): «nicia ... Poi ch’i dicessi: “Che impiceata sia la pit
savia donna di Firenze!” la direbbe: “Che tho io fatto?"
Uno dei motivi ricorrenti degli studi sulla Mandragola ® il riconosci
‘mento del carattere politico della commedia, Non mi riferisco alla cosiddetta
interpretazione allegorico-politica, su cui pili avanti ritornerd, ma pitt in
generale al fatto che Machiavelli rappresenterebbe la vita privata mettendo in
luce come in essa agiscano forze ¢ logiche identiche a quelle che regolano la
vita publica, L'opera di pitt diretto riferimento & naturalmente II Principe”
Ma se in politica e nel privato l'uomo agisce sostanzialmente allo stesso
modo, le due fondamentali dimensioni del vivere sociale possono talora
confondersi e i grandi fatti o personaggi del passato anche ripresentarsi nella
‘quotidianita del presente. «Mi pare che tutti li tempi tornino, et che noi siamo
sempre quelli medesimi», scrive Machiavelli a Guicciardini in una lettera del
» Pintor 1907, pp. 433-65.
> Pintor 1907, p. 443,
% Pintor 1907, p. 445.
® Una letra pantuale della commedia alla luce del Principe e dei Discorsi si ha in
Flaumenhafe 1978. Ma il tema ricorre in moti ext,
16-20 ott
questo av
nome div
Mandrag
confronto
seppure c
Che |
cui raccor
neppure 3
amica di
denza che
Lucrezia
nome € u!
una donn:
proprio d:
te). Esso |
pria mogh
sercito ro
di Sesto T
nore con
sgozzare |
apparisse
della Mai
delle dont
per assicu
del disonc
Liou
caLL
LIGUR
dian
Let
* Dell
1978; Rose
Sass
Sic
della V1 gic
novella 3 de
{2 anonima, e
90 miscuglio di
rudita per I’uso
enza del paras:
gio di Gna.
a parte il nome
intine dei primi
@ sacra rappre-
meno in questo
i= incipit del-
senza raguna:
asillabo, rifa il
jgni auditor»),
al prologo dei
Costui sanza
ssi —egli haa
ga di qualita fra
na battuta della
peata sia Ia pit
2 il riconosci-
alla cosiddetta
erd, ma pitt in
ula mettendo in
e Il Principe®.
ate allo stesso
possono talora
resentarsi nella
Eche noi siamo
-una lettera del
Uninet sori
16-20 ottobre 1525®. Quando la quotidianita si confonde con la storia, e
questo avviene in commedia, il tragico volge in comico e diventa parodia. Il
nome diventa anche in questo caso etichetta di riconoseimento. Nella
Mandragola non & solo il personaggio di Lucrezia a essere investito di un
confronto col passato: anche Callimaco, Nicia ¢ Timoteo sono impegnati
seppure con minore evidenza, nella stessa direzione.
Che la Lucrezia della Mandragola sia la parodia di Lucrezia romana, di
cui racconta Tito Livio (I 57-8), & cosa di tale evidenza da non dovere essere
neppure argomentata®. II fatto che Ia Riccia, la prostituta per lunghi anni
amica di Machiavelli, si chiamasse proprio Lucrezia®, 8 una curiosa coinci-
denza che consente tutt’al pid all'autore di confondere i piani. Tornando alla
Lucrezia romana, il racconto di Livio non presta a Machiavelli soltanto il
nome ¢ una situazione che lo scrittore fiorentino capovolge (nel primo caso,
una donna che difende con il suicidio l’onore violato; nel secondo, una che
proprio dall’onore violato trae occasione di una vita erotica pid soddisfacen
te). Esso ha anche un valore strutturante per I'intreccio della Mandragola, a
cominciare dall’antefatto (I'esaltazione della bellezza e dell’onesta della pro-
pria moglie fatta imprudentemente da Collatino fra i giovani ufficiali dell'e-
sercito romano all'assedio di Ardea, che & all’origine dell" incapricciamento
di Sesto Tarquinio e dei fatti tragici che seguono) fino alla minaccia del diso-
nore con cui Sesto Tarquinio vince la resistenza di Lucrezia (ucciderla e poi
sgozzare un servo ¢ lasciarlo denudato accanto al cadavere di lei, cost che
apparisse aver trovato la morte in un sordido adulterio). Anche la vicenda
della Mandragola prende avvio da un discorso fra giovani sulla bellezza
delle donne; cosi Iargomento decisivo che Ligurio fa balenare a Callimaco
per assicurarlo della conquista di Lucrezia consiste proprio nella minaccia
del disonore che la donna riceverebbe se si rifiutasse (IV 64-66)"
JGURIO Qui ti condurra tu, ma a fare che tu vi possa ritomare sta ate € non a noi
CALLIMATO Come?
LiguRI0 Che tte Ta guad
dia a conoscere, scuoprale lo "
n questa notte; che, innanzi che tu ti parta, te le
nno, mostrile amore li port, dicale el bene le
> Lewere,p. 1222,
* Della ricea bibliografia sall’argomento cito solo Je voci pitt rilevanti: Flaumenhatt
1978; Roselli 1981: Martinez 1983; Sasso 1988, pp. 140-50: Sasso 1997, pp. 299.321
5 Sasso 1997, p, 320
Si cita a proposit della minaccia del disonore anche il precedente della novella
della VI giornata del cosl, per quanto riguarda Iinnamoramento da lontano, la
novella 3 della VI giorata. Ma solo in Livio e poi nella Mandragola i due te
i somo part
della stessa sto
Storia filologia della Mandragol
associative i
di ragione. (
una sequenz
Promessi sp
altre, & lone
va gli autori
voi; © come sanza sua infamia la pud esser tua amica e con sua grande infamia
tua nimica. E impossibile che la non convenga teco e che la voglia che questa
notte sia sola
Ligurio nel far certo Callimaco che in quella notte riuscira a “guadagnar-
Lucrezia, invera il cognome dichiarato nel prologo («Un giovane, Calli-
maco Guadagnio, / venuto hor da Parigi / ...»): peraltro Guadagni é effettiva
mente un cognome fiorentino dell’etd di Machiavelli. Le cose, come si sa,
andranno proprio come Ligurio aveva previsto. Ma Callimaco non avra biso:
gno di arrivare alle minacce; smuovera la donna solo dichiarandole il suo
amore. Il discorso di Callimaco (V 39) avra gli stessi toni rassicuranti, inclu-
sa la promessa di matrimonio («qualunque volta Dio facessi altro di Nicia»,
se cio’ Dio vorra chiamare a sé il marito), di quello che Romolo, ancora se
condo i racconto di Livio (I 9), aveva fatto alle vergini sabine dopo il loro
Callima
Damone del
nome di due
erale di
dio posto d
sconfitto. In
gio, non s¢
rapimento”. Callimaco d
Ma il rapporto della Mandragola con la storia non passa solo attraverso Per il
Ponomastica dei personaggi. Né richiamerei qui come argomento a sostegno plesso. A Ni
della componente storica della commedia la battuta irrilevante sul passaggio
del Turco (Ill 32). Rilevante mi sembra invece il fatto che Machiavelli ancori
cronologicamente i fatti della Mandragola al 1494, anno della discesa in
Italia di Carlo VILL. Callimaco & nato nel 1474; a dieci anni (1484), mort
entrambi i genitori, & mandato a Parigi; a venti (1494) avrebbe dovuto far
ritomo a Firenze, ma Ia passata di re Carlo e le guerre d'Italia gliel’hanno
impedito; nel 1504, a trent’ anni, fa finalmente ritomo a Firenze, spinto dal-
Tinnamoramento a distanza per Lucrezia. La scansione degli anni per decadi
& anch’essa significativa di un’ottica storica, ma & ancora pid significativo
notare che il 1494 @ anche I’anno da cui prende avvio il primo Decennale
quello in cui si concludono le Istorie fiorentine, pet non dire dei Discorsi,
una biogral
Nicia, figli
parte alla v
moderati. S
una polit
peri) incert
Preferiva Ia
prevaricazi
Siracusa (4
decisivo qu
Discorsi di
che fanno pit volte rimando al 1494 come @ una data cruciale. Non pare Tl Nici
dubitabile alla luce di queste evidenze che Machiavelli intenda attribuire alla gia da Sum
commedia un valore esemplare rispetto ai nuovi tempi che proprio i fatti del
1494 avevano tristemente inaugurato.
Dopo queste considerazioni appare plausibile che anche i nomi di > url
veccki € nwo
Onomastica
® Sull'
Roma, Istitu
sariarferito
Callimaco, Nicia e Timoteo, gia etimologicamente motivati, possano essere
anche determinati in senso storico. Purché si tenga conto che nell’ onomastica
letteraria il meccanismo di attribuzione dei nomi pud anche seguire logiche
"Car.
Lue.
E un‘osservarione acuta di Flaumenhaft 1978, p45. » Diseo
™ Vd. a atta 7. * Sum
grande infumia
yoglia che questa
ba “guadagna
giovane, Call
genie effetiv
se, come si sa,
pon avra biso-
grandole il suo
fcuranti, inclu-
altro di Nicia»,
olo, ancora se-
ne dopo il loro
solo attraverso
|nto a sostegno
® sul passaggio
shiavelli ancori
ella discesa in
1484), morti
bbe dovuto far
lia gliel'hanno
we. spinto dal-
inni per decadi
@ significativo
je Decennale ¢
t dei Discorsi,
ale. Non pare
pattribuire alla
pprio i fatti del
she i nomi di
possano essere
ell'onomastica
eguire logiche
nomi det personage
associative imprevedibili, come tali difficilmente spiegabili fino in fondo a fil
di ragione, Quando, per esempio, Manzoni estrae dall'ordinario della messa
tuna sequenza di nomi di sante e di santi e li attribuisce a personaggi dei
Promessi sposi®, quale criterio razionale guida le sue scelte? Ma, forse pid di
altre, @ onomastica pirandelliana a dare la misura di quanta liberta associati-
va gli autori si permettano nell’ attribuire il nome ai loro personaggi.
Callimaco, Nicia e Timoteo (come del resto Cleandro, Nicomaco, Pirro e
Damone della Clizia) sono nomi presi dalle Vite di Plutarco. Callimaco @ il
nome di due uomini d'arme. Il primo, combattente a Platea°'. II secondo 8 un
generale di Mitridate, comandante della difesa della citta di Amino nell’asse-
dio posto da Lucullo™; & detto esperto di machine di difesa, ma finisce
sconfitto. In questo caso, in relazione sia al primo sia al secondo personag-
gio, non sembrano al di la del nome evidenziarsi altri riscontri con il
Callimaco della Mandragota.
Per il nome di Nicia il rapporto di Machiavelli con Plutarco & pid. com-
plesso. A Nicia, capo politico e comandante militare ateniese, Plutarco dedica
tuna biografia in parallelo con quella del romano Marco Licinio Crasso.
Nicia, figlio di Nicerato, era nato intomno al 470 a. C. Ricchissimo, prese
Parte alla vita politica della sua citta capeggiando il partito dei democratici
moderati. Si tov a dover contrastare prima Cleone, poi Alcibiade, fautore di
una politica aggressiva contro Sparta. Abile stratega militare, si dimostrd
perd incerto per eccessiva prudenza nella conduzione degli affari politici
Preferiva la mediazione e l'accordo allo scontro. Era alieno dal commettere
prevaricazioni o furberie. Mori nella disastrosa spedizione di Atene contro
Siracusa (415-13 a.C.) per non aver avuto il coraggio di sferrare I"attacco
decisive quando la situazione era favorevole agli ateniesi. Machiavelli nei
Discorsi dice Nicia «uomo gravissimo e prudentissimo»,
I Nicia della Mandragola & stato associato al personaggio di Plutarco
sid da Sumberg™. Ma i due Nicia, oltre al nome, non condividono nulla, a
™ Fu rilevato la prima volta nel 1924 da Cesare Angelini (ora in Capitol sul Manzoni
\ecchi e muevi, Milano, Mondadori, 1966, pp. 3-4) sull'arzomento vd. anche G. Contin,
(Onomastica manzoniana, in Variant’ e altro lingustica, Torino, Einav. 1970, pp. 201-05.
* Sull'onomastica pirandelliana & fondamentale L. Sedita, La maschera del nome,
Roma, Istituto del’ Enciclopedia Italiana, 1988, forse il miglior lavoro di onomasticalete
aria riferito ad autor italian,
Cat, mai. 29(2),2,
© Luc. 19,2°3
Discorsi 53, 20.
™ Sumberg 1961, p. 333,
Storia ¢ fillogia della Mandragols
meno che non si voglia contrapporre, ancora una volta antifrasticamente, 1
strema prudenza del primo con la sventantezza c la sciocchezza del secondo.
Se perd, seguendo l'indicazione successiva di Parronchi®, per il quale il Nicia
della Mandragola richiamerebbe Pier Soderini, teniamo conto anche di quello
che Machiavelli scrive nei Discorsi a proposito del gonfaloniere fiorentino,
ecco che i tre personaggi sembrano stabilire una curiosa triangolazione. Leg
gendo Ia Vita di Nicia di Plutarco e i passi dei Discorsi nei quali Machiavelli
esprime dei giudizi sul Soderini, si ha I'impressione di trovarsi dinanzi quasi a
delle vite parallele. I riscontri riguardano pid aspetti. Porto alcuni esempi: la
ricerca del consenso generale attraverso l'equilibrio e l'imparzialita*
Qui (Nicia licet etiam paulo severior haberetur, non tamen gravis erat aut
fustera nimis eius severitas, sed comitate quadam et urbanitate condita: praete-
rea timoris et cautionis similitudine ad sui amorem multitudinem alliciebat”.
ier Soderini si aveva fatto riputazione nella cittd di Firenze con questo solo, di
favorite Puniversale; il che nello universale gli dava riputazione come amatore
della liberta della cit.
Lragire con giustizia e umanita un altro elemento distintivo sia del
greco Nicia sia di Pier Soderini. Ma in politica non sempre i comportamenti
improntati a questi valori pagano; infatt il primo fu ingannato da Aleibiade,
il secondo rovind insieme allo stato:
In reipublicae vero administratione nihil unquam callide nihil iniuste nihil vio~
Jenter a Nicia factum reperiretur: sed cum esset Alcibiadis potentia ac fraudibus
circumventus, summa cum modestia ad populum quasi injuriarum vindicem
futurum confugit
Piero Soderini [...] procedeva in tutte le cose sue con umanita e parienza.
Prosperd egli e la sua patria mentre che i tempi furono conformi al modo del
procedere suo; ma come vennero dipoi tempi dove e* bisognava rompere la
pazienza e I'umilta, non lo seppe fare, tale che insieme alla sua patria rovino®.
® Parronchi 1962, pp. 59-60.
% TL testo della Vita dé Nicia di Plutarco si cita dalla traduzione Jatina di Guarino
Veronese che Machiavelli poteva leggere in una delle edizioni delle Vite disponibili nei
primi decenni del'500. Peril testo seguo: Plutarchi Vizae, Venetiis, per Bartolomeum de
Zanis de Portesio, 1496.
"Lib. He. 13r (Vic. 2,4
* Discorsi 12, 6
» Lib. Il, ¢.25v [Nic
Discorsi 19, 13-14.
5
Ip
uomini «
sard pre;
greco Ni
Non
affe
hum
Que
bene
tant
supe
viol
bast
Per
tentenna
gua di w
Sed
cffu
que
qua
relic
Anc
Pier So«
essere a
L
Pan
rid
“is
“Dp
*Li
“Mu
ticamente, I’c-
ia de! secondo.
I quale il Nicia
anche di quello
ere fiorentino,
plazione. Leg-
i Machiavelli
dinanzi quasi a
uni esempi: la
Hira
gravis erat aut
poodita: prac
alliciebat”.
questo solo, di
Scome amatore
tivo sia del
smportamenti
da Alcibiade,
uste nihil vio-
a ac fraudibus
pum vindicem
B e parienza,
ial modo del
ya rompere la
ia rovino®.
na di Guarino
disponibili nei
iolomeum de
{nomi dei personaggi
II politico che spera di ammorbidire lostilita degli avversari o degli
uomini di cattivo sentire con il beneficarli, mostra una bonta che alla fine
sara pregiudizievole per lui. Questo sarebbe stato il comportamento sia del
greco Nicia sia del Soderini:
Non minus enim his a quibus mala quispiam timeret quam his de se bene meriti
essent tribuere convenit. Itaque plurimis hominibus facultate cius utiitatem
afferebat: malis quidem timoris causa, bonis autem ob ingenitam in omnes
hhumanitatem et liberalitatis studiumy
Quell’altro [Soderini} credeva col tempo, con la bontd, con Ta fortuna sua, col
bbeneficare alcuno spegnere questa invidia, vedendosi di assaifresca et, e con
{anti nuovi favori che gli arrecava el modo suo di procedere, che credeva potere
superare quelli tanti che per invidia se gli opponevano senza alcuno scandalo,
violenza ¢ tumulto; e non sapeva che il tempo non si pub aspettare, la bont non
basta, la fortuna varia la malignita.non trova dono che la plachi®
Per finire con una davvero sorprendente coincidenza. Plutarco giudica i
tentennamenti di Nicia nel preparare la spedizione contro Siracusa alla stre-
gua di un comportamento bambinesco:
Sed postquam neque populum ad belli studio avertere neque imperandi laborem
effugere se posse conspiciebat, de utroque summa contentione laborasset, sibi-
que populus reluctant et invito magistratus gerendi onus imposuisset, non ultra
cunctari aut remisse quippiam agere oportuit, verum summo studio ac diligentia
quae ad perfectionem opus essent expedire; nec, tamquam delitiosum pucrum,
relicta post se littora e navi prospicientem collachrymare™
Anche Machiavelli, in un feroce epigramma scritto come epitaffio per
Pier Soderini, giudica questi un bambino, e come tale indegno persino di
essere accolto nell’inferno:
La notte che mori Pier Soderini
anima and® de Vinferno a la bocea;
‘grido Pluton: ~ Chinferno? anima seiocea,
Va su nel limbo fra gli alti bambini*
* Lib. Ie. 13v OWie. 4,3)
Discorsi WL 30, 21
Lib. Me. 1Sv [Nie. 14,2)
Martel 1971, p. 1008
Storia filologia della Mandragola
Se i riscontri esibiti avessero effettivamente valore di prova, il Nicia di
Plutarco diventerebbe l’anello di congiunzione tra il suo omonimo della
Mandragola e Pier Soderini, ¢ di conseguenza sarebbe rivalutata I’interpreta-
zione della commedia proposta dal Parronchi come un‘allegoria politica che
rappresenta il principe dei Medici (Callimaco) che conquista Firenze (Lucre-
Zia) con aiuto della chiesa (Timoteo) dopo aver fatto cadere la repubblica
avendone spossessato il Soderini (Nicia). Insomma i fatti fiorentini del 1512
trasferiti in commedia. Ma una rispondenza cosi puntuale, e meccanica, con-
tinua a risultare nonostante tutto poco convincente. La Mandragola ha un
respiro ben pitt ampio: se I'autore stabilisce un’associazione tra un personag-
gio storico e un personaggio di commedia, facendo trasparire in filigrana die-
tro i due la figura scialba del Soderini, & ancora una volta perché gli vomini
se non ritornano proprio gli stessi, comunque si somigliano molto. «Se nel
mondo tornassino i medesimi uomini, come tornano i medesimi casi, non
passerebbono mai cento anni che noi non ci trovassimo un’altra volta insie-
me, a fare le medesime cose che ora». Cosi scrivera Machiavelli nel prologo
della Clizia’, e questa affermazione pud forse dar ragione retrospettivam
anche dell’ onomastica della Mandragota.
Resta il nome di Timoteo. Per questa scelta & stato ipotizzato il possibile
riferimento al discepolo di san Paolo con questo nome“, destinatario di due
lettere dell’ apostolo. L’elemento che giustificherebbe l'associazione 2 il fatto
che la prima delle due lettere contiene degti insegnamenti pastorali sulla con-
dizione ¢ il ruolo delle vedove in seno alla chiesa. Poiché, come si sa, il frate
entra in scena proprio dialogando con una vedova, & parso che in Machiavelli
potesse agire una suggestione neotestamentaria. Tommasini”, volgendosi
alla cronaca, aveva in precedenza richiamato lattenzione sugli estratti di let-
tere della Cancelleria dell’ anno 1494 redatti da Machiavelli, nei quali si regi-
stra il divieto opposto a un frate scellerato di nome Timoteo di predicare a
Volterra, Ma Dionisotti® ricorda con umorismo il gran numero di frati fio:
rentini che nel Cinquecento portarono il nome di Timoteo, ¢ la singolarita del
‘ Marelli 1971, p. 891
“© Flaumenbaft 1978, p83.
Tommasini Vita, I p. 388 n,
® «Ordinossi che uno fra Timothco non predicassi ad Volterra come homo scandolo-
so» (N. Machiavelli, Legazioni, Commissarie, Sertt di govemo, a cura di F. Chiappelli, |
Bari, Laterza, 1971, p. 549). Parronchi 1995, pp. 81-83, avrebbe sucvessivamente identifi
ccato questo personaggio con Timoteo di Filippo Buonaccorsidell’ordine dei Serv
* Dionisott 1984, p. 629,
fatto che i
bilita eccl
dell’autor
nella cone
mologia. J
piano dell
viamo pid
di quest’
Damo
ut sic
det me
enim
Lepi
Alessandi
intempera
condottier
principe t
dedica un
femine si
Aristotle,
ingiuriato
rompere i
causa dell
ali stati “y
sua preser
Dario, & i
Lal
Niccold, €0
Timoteo
* Tim,
= Phi
> Lib,
* Dis
vas il Nicia di
monimo della
ta interpreta
ja politica che
enze (Lucre-
la repubblica
ntini del 1512
eccanica, con-
fragola ha un
sun personag.
pfiligrana die-
shé gli uomini
polto. «Se nel
a volta insie-
li nel prolos
spe
vamente
ato il possibile
atario di due
gione @ il fatto
ali sulla con-
fe si sa, il frate
in Machiavelli
volgendosi
-estratti di let-
i quali si regi
di predicare a
0 di frati fio-
singolarita del
domo scandolo:
FF. Chiappelli |
jamente identi
nomi dei personage
fatto che il personaggio della Mandragola non influi «sulla dignita e appeti
bilita ecclesiastica del nome» neanche in una famiglia collaterale a quella
dell'autore’®. Certo la cronaca pud aver esercitato qualche suggestione, ma
nella concezione machiavelliana non basta certo a spiegare le scelte. Intanto,
come si @ gid detto, il nome di Timoteo si giustifica anzitutto con la sua eti-
mologia. Abbandonando poi il terreno della contingenza per trasferirci sul
piano delle storie, tornando a consultare onomastikon plutarchiano, tro
viamo pitt personaggi che portano il nome di Timoteo: uno stratega atenie-
se‘!, un poeta (Timoteo di Mileto)®, un soldato dell’esercito di Parmenione
generale di Alessandro, Leggiamo cosa racconta lo storico greco a proposito
di quest uhm:
Damonem et Thimotheum Macedonas quorundam stipendia sub Parmenione
mmerentium temerisse mulieres [Alexander] audiens, ad eum scribens, mandat
‘ut, si convicti sint, eos tamquam perniciosas humano generi beluas saevis truci-
det modis. In ea epistola hoc pacto de se verbum ex verbo scripsisse liquet. E
enim Danii uxorem nedum aspexisse aut aspicere decrevisse, sed eorum qui eXi
iam eius vel illus formam praedicant, ne verba quidem admisisse comperiar®
Leepisodio riportato da Plutarco mette in evidenza Vinflessibilita di
Alessandro nel punire chi mette in pericolo la coesione dell’esercito con atti
intemperanti, ¢ nello stesso tempo la virtuosita dei comportamenti del grande
condottiero, Le sue sono virti politiche, non morali. E pericolosissimo per un
principe tollerare che si rechi ingiuria alle donne degli altri. Machiavelli
dedica un capitolo dei Discorsi a questo argomento: «Come per cagione di
femine si rovina uno stato». Cosi si legge, tra 'altro, in quel capitolo: «E
Aristotile, intra le prime cause che mette della rovina de" tiranni, @ lo avere
ingiuriato altrui per conto delle donne, con stuprarle © con violarle 0 con
rompere i matrimonii». L’aggressione di Sesto Tarquinio a Lucrezia romana,
causa della fine della monarchia, & l'esempio pia vistoso di come si perdano
gli stati “per cagione di femine”. Da questo punto di vista Alessandro, che in
sua presenza non permette neppure che si parli delle bellezze della moglie di
timodello di Sesto, che
Dario, @ il modelo virtuoso da contrapporr
© La famiglia dei Ricsi, con cui si era imparentata la Bartolomea, ultima figlia di
Niccold, conterebbe intorno alla meta del "S00 addirittura due frati domenicani di nome
Timoteo,
5! Tim, 36,1; Syl 6, Sete
© Phi, 11,3: Agi. 10,7 ete
Lib. hed
& Disearst TH 26. L
5
mento &toecato anche nel Pr
ine, capp. XVITe XIX
Storia eflologia della Mandragola
proprio da discorsi sulla bellezza delle donne si era acceso di insano amore
per Lucrezia. E cosi era ayvenuto anche per Callimaco nei confronti della
Lucrezia fiorentina,
Ma cosa c’entra il Timoteo della Mandragola con tutto questo? Nulla
C’ perd nel racconto di Plutarco un particolare, apparentemente trascurabile,
che potrebbe forse chiamare inaspettatamente in causa il frate. I! soldato
compagno di malefatte di Timoteo ha nome Damone, e Damone & anche il
nome del personaggio della Clizia che mette la sua casa a disposizione di
Nicomaco per il convegno amoroso con Clizia. Damone svolge la parte del
ruffiano, proprio come fa Timoteo nella Mandragola, seppure in altro modo,
E vero che “Damone”, che non & nome plautino né terenziano, era stato gid
usato da Ariosto nei Suppositi, ma questo aggiunge non sottrae spessore alla
scelta di Machiavelli, rendendo ancora pit fitta la rete dei richiami, Le coin-
cidenze sono certo sorprendenti, ma forse non ci sorprenderemmo pid di
tanto se conoscessimo pit in profondita i meccanismi dell’ onomaturgia let
raria, Che gli autori, nel dare il nome ai loro persona; ano percorsi
mentali imprevedibili non pare comunque dubbio. Questo & del resto cid che
rende nello stesso tempo difficili, incertie affascinanti gli studi di onomasti-
ca letteraria
Ing
nella tra
dibattuti
anche a
manosen
do cosi ¢
1. Laca
ua
14
lig
finta ign
stolidez
gioco di
to daun
Mac
abu
2B
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Il Viaggio in Italia Di Enrico IIIDocument382 pagesIl Viaggio in Italia Di Enrico IIIAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Prediche Quaresimali Del Padre EmmanueleDocument499 pagesPrediche Quaresimali Del Padre EmmanueleAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Programma Brochure MODDocument2 pagesProgramma Brochure MODAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Introduzionestorica RisorgimentoDocument61 pagesIntroduzionestorica RisorgimentoAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Machiavelli e La Politica: PremessaDocument4 pagesMachiavelli e La Politica: PremessaAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Materiali MarinoDocument5 pagesMateriali MarinoAngelo PagliardiniNo ratings yet