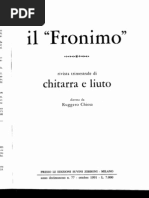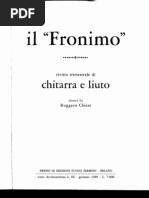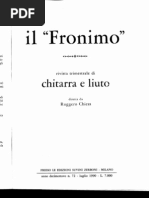Professional Documents
Culture Documents
Fronimo 001 PDF
Fronimo 001 PDF
Uploaded by
Jacopo Lazzaretti0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views37 pagesOriginal Title
Fronimo_001.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views37 pagesFronimo 001 PDF
Fronimo 001 PDF
Uploaded by
Jacopo LazzarettiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 37
° “ ° 9 res
il “Fronimo
tether ities
of
rivista trimestrale di ue
chitarra e liuto .
diretta da psi
Ruggero Chiesa a
PRESSO LE EDIZIONI SUVINI ZERBONI - MILANO
ottobre 1972 - L. 600
anno primo a.
SOMMARIO
Laugurio alla rivista Segovia
Premessa di Ruggero Chiesa
Incontri
Intervista a Goffredo Petrassi
La rinascita della chitarra
Angelo Gilardino
« L’arte di suonare la chitarra 0 cetra»
di Francesco Geminiani
di Bruno Tond
Storia della letteratura del liuto © della
chitarra di Ruggero Chiesa
I. II Ginquecento
La chitarra e gli strumenti a tastiera
di Mario Sicca
I. La chitarra in duo col fortepiano
TT, Laletteratura per chita
eclavicembalo
TEL. Le composizioni moderne per
€ pianoforte, chitarra e clavicer
chitarra e fortepiano
Cronache di concorsi internazionali
Rece
N
asioni
Dischi
10
21
Letter to the Review from Andrés
Segovia
Premise by Ruggero Chiesa
Encounters
Interview with G
o Petrassi
The Rediscovery of the Guitar
by Angelo Gilardino
Francesco Geminiani’s «The Art of
Playing the Guitar or Cittra»
by Brun
Tonazzi
History of the Literature of the Lute
and Guitar by Ruggero Chiesa
The Sixteen
The Guitar and Keyboa
by Mario Sicca
[Guitar i
struments
IL.
ILI. Modern Works for Guitar
forte, Guitar and Harpsichord, Gi
tar and Fortepiano
Reports of Interna
Reviews
Musi
Recordings
RUGGERO CHES)
REDATTORE CAPO; SILVIO CERUIT
DIREZIONE, AMMINISTRAZION!
20122 MILANO
UFTL 1 DIRITTL RISERVATT
AUTORIZZAZIONE
JUNALE BI
PUBBLICITA’; EDIZIONE St
CORSO FLIROPA.5
IGHTS RESERVED - PRINTED IN ITALY
MANOSCRITTI E FOTOGRAFIE
LANO N.
331 DEL 13 SETTEMBRE 1972
NON PUBBLICATI
NON VERRANNO RESTIT
UN NUMERO 1. 600 - ESTERO 1, 500
BBONAMENTO ANNUO: STALIA.L. 2000 - ESTERO L, 300
NUMERD Al TT DISPONIBILE 1. 1.00
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO NELLE EDICOLE PER LTFALIA A. & G. MARCO
‘VIA FORTEZZA 27 - 20126 MILANO - TEL. 2526
1s Olivos
5 de Aono de 1972
Celebro muy sinceramente el nacimient
la notable Casa Edi
tora SUVINI ZERBONI, de Milano, ba da
fecha. S
cioso elemento para la unit
a Guitarra, Estoy 5
ada inteligente de Ruggero Chiesa
rd: muy pronto prestigio y anche difu.
si me lo permitiesen él y los
rd nuevo
rsalizacion
do a luz en esta memorabl.
sion. Y
es, les aconsejaria que no dejaser
estrecha vigilancia sobre el
ritual y artistica de lo:
de que no se
debe volar muy alto y no apadrinar trabajos
flojo aliento que amenacen convertirla en
Gaceta de aficion. le
Hago votos porgue logre
y porgue practique, en be
longevidad sect
ficio de la
Guitarra, un magisterio severamente bigié
I7AUGURIO ALLA RIVISTA
DI ANDRES
SEGOVIA
Saluto con gioia sincera la nuova rivista
che Tillustre casa editrice Suvini Zerboni
di Milano ha dato alla luce in questo giorno
per noi memorabile, Sard un mezzo nuovo ¢
prezioso per luniversale affermazione della
nostra amata Chitarra. Sono sicuro che sotto
Vintelligente guida di Ruggero Chiesa incon.
tret’ presto grande prestigio ¢ larga diffusio:
ne, E se egli e gli editori me lo permettone
consiglierei loro di non smettere di esetcitare
una stretta vigilanza sul numero ¢ sulla qua:
lita spitituale e artistica dei futuri collabo
ratoti affinché non venga vanificato Pauspica
to risull uin sf nobile sforao. Questa
rivista volare molto in alto e non pa-
woti di scarso valore che minac-
una gazzetta di
trocinare
ero di trasformarla in
anti pseudomusicofil
Faccio voti perché essa raggiunga una lon.
svolga, a vantaggio
insegnamento rigor
gevita secolare ©
della Chitarra, un
mente salutare,
AnpREs SEGOVIA
PREMESSA
L messmo rapido fotnat della chi
4 tarra nel mondo musicale, verificatosi in
esti ultimi anni, 2 testimoniato dalle sempre
i frequenti apparizioni nelle sale da concerto
i esecutori, dal mol-
di artisti famosi e di gio
tiplicarsi delle incisioni discograjiche ¢ delle
pubblicazioni, dallinteresse dei compositori
iWentusiasmo degli allievi
che affollano le aule dei Conservator. Tutto
questo potrebbe far supporre che la chit.
4 ormai acquisito un posto di rilievo ac
canto agli altri strumenti dopo esserne rimasta
ai margini per lungo tempo, ma anche se essa
@ circondata da ua innegabile corrente di sim
non @ facile far dimenticare tutte le di
fidenze del lontano e recente passato, che
tornano puntualmente ad affiorare quando si
giunge a darle una precisa collocazione storica ¢
quindi una esatta funzione nell
stica atinale
Oggi forse nessuno mette pit in dubbic
sue qualita timbriche ¢ le sue possibilita tec-
niche, ma pochi credono che essa possegga una
letteratura originale ampia di valore,
spensabile per sostenere le sue ambizioni. Sen-
1a questa ossatura nessuno strumento, per quart
10 affascinante, pud sopravvivere a lnngo, ¢ co-
avverrebbe per la cbitarra il giorno in cui
corso questo periodo di felice entusiasmo
vita concerti-
e dovendo contare sulle proprie for
trovasse ancora a mantenere un pericol
oco che la condurrebbe inevitabilme
i quelle profonde crisi di cui ® costellata la sua
Liequivaco, lo sappiamo bene, & di non
loso equi
re add una
avere la consapevolezza di una piena autonomia
nel proprio repertorio, il che rappresenta una
pro 1a assolutamente ingiustificata,
poiché ben poco 2 stato fatto per riportare alla
luce la produzione del passato, Ci sembra quin:
tutte, si debba dare
1e troppe volte ci
di che ora, una volta p
una risposta alle domande
sono state poste, tracciando un quadro comple
to ed esauriente di ogni autore ¢ di ogni opera
esistenti dal Cinguecento ai nostri giorni,
Per raggiungere uno scopo cosi preciso non
bastano certamente le ricerche e le pubblicazio-
ni gid esistenti, particolarmente numerose e pre=
gevoli in quest'ultimo decennio, ed occorre pro
cedere ad un lavoro sistematico e razionale. Si
consideri poi che anche quando tutto sari sco
perto € catalogato esisteranno degli interroga
tivi a cui non sari facile dare wna risposta. Te
rnendo. presente che la chitarra ba sublto attra
verso i secoli delle trasformazioni radicali, che
si riflettono specialmente sul timbro ¢ sull’ac
cordatura, bisogneri accertare sino a qual pur
to potra essere valida Vesecuzione di opere con:
cepite per strumenti che portavano il nome d
«chitarra» ma con caratteristiche diverse di
quella attuale. Da tenipo poi existono opinion’
cordanti sull’opportunita di considerare co
‘me propria la letteratura originale per linto (si
intende il liuto rinascimentale, a sei corde, an
che se i chitarristi si rivolgono per ora con mag-
giore entusiasmo verso le composizioni barocebe,
ad esempio le suites di Bach), ¢ non bisogna
dimenticare Vesistensa di altri similtstrumenti
4 corde pizzicate, come 1a vibuela, la pandora,
la cetera, il colascione, per i quali sono state
‘crite pagine numerose ¢ di grande
ito ritenere la chitarra lo strum
per riassumere le loro caratteristiche, 0
vremo farli rivivere tutti per eseguire la loro
letteratura? Infine é@ assolutamente necessario
valutare a fondo il periodo classico, compreso
tra la fine del Settecento e la prima meta del
VOttocento, oggi ingiustamente mortificato, la
cui ampia produzione solistica e «
ancora quasi sconosciuta agli attuali esecutori
Per il liuto il discorso 2 in parte diverso. Qui
non vi sono dubbi circa il valore e l'ampiezza
della sua letteratura, gia accertati attraverso ap-
profondite ricerche che hanno rivelato wn patré
monio di insospettata bellezza. L'impegnativo
lavoro di trascrivere in notazione moderna
te le opere scritte dal Cinguecento alla fine del
Settecento ® gid stato iniziato, ma per vederne
la conclusione occorreranno ancora lunghi anni
E invece urgente che git da ora non si dimen-
tichi Vesecuzione delle composizioni pid rap
presentative, per non correre il rischio di con-
5
gelare tutti i risultati in una stretta cerchia di
musicologi e di iniziati. A questo proposito,
musi
cost come & avvenuto megli anni in cu
ca clavicembelistica era eseguita con il piano
forte, la cbitarra si 2 assunta il compito di dif
fondere quella per liuto in attesa di assistere
sla piena rinascita di questo grande strumento.
‘Benché tale interjerenza possa dare adito a
egabile che in questo
ido un processo volto a
vivaci polemiche, @ ix
modo si stia accelera
far conoscere opere di autori eccezionali, da
troppo tempo dimenticate. D'altronde anche i
pocki lintisti oggi esistenti sono ben lontani
dalleseguire tutte le composizioni con assoluta
fedeled, inipiegando spesso un solo tipo di stru
pagine rinascimentali €
‘mento per interpreta
barocche, € ponendosi anch'essi su un inevite
bile piano di compromesso.
Dovrebbero quindi cessare le diffidenze degli
uni verso gli altri, ricordando che il primo
lentrarsi in una
palorizzare con
so da compiere, prima di ad
intricata querelle, consiste nel
qualsiasi tipo di esecuzione, purché criticamen-
te consapevole, la letteratura esistente
Vie poi un punto di contatto ancora pit
preciso tra la chitarra e il liuto, La loro tec-
nica, intendendo esclusivamente cid che é vi-
olto alla impostazione della mano sinistra sulla
tastiera e il modo di pizzicare le corde con la
mano destra, @ identica. La scuola del liuto,
totalmente scomparsa quando esso cade in di
suso alla fine del Settecento, dipende oggi da
quella della chitarra, dove purtroppo esistono
ancora delle gravi perplessita. Benché molti in
segnanti si considerino i depositari della ve-
rita didattica, non sono stati nemmeno codifi
cati i principi basilari, che poi sono i pitt ine
portant venica strumentale, da cui di
ei due strumenti.
ppo futuro
mo solo ricordare che gran parte della
loro letteratura, forse la migliore, & ancora ine
seguita per mancanza di interpreti (ad eccezio
ne di alcuni che non sempre perd sentono esi
genza di arricch
terminate difficolta
ivi, ¢ ve ne sarebbero
re il loro repertorio) idonei a
Tutti questi interrog.
altri, sono stati posti per dimostrare che esi:
stono le premesse per creare una rivista che
poglia assumersi Vimpegno di dare loro una
periodico dedicato in
risposta, Ecco quindi
teramente alla cbitarra ¢ al liuto, «I! Fronimo»,
1 nome dellimmaginario liutista che diede il
fo al celebre libro di Vincenzo Galilei, edito
tit
nel 1568 e nel 1584: Fronimo / dialogo di Vin-
centio Galilei / nobile fiorentino / sopra l'arte
del bene intavolare / et rettamente sonare la
one). Un dia.
chitar
musica (titolo della seconda edi
logo anche per noi, a cui parteciperann
€ musicologi, con opinion
inti e anche contr
‘ma solo attraverso un conjronto ampio si po-
iranno finalmente dissipare i dubbi e chiarire
foere alt
visti, lint
tranno essere diver
gli equivoci, certi di fare
Vinconjondibile personalita di questi strumenti
opere di grande vatore
RucoeRo CHtEss
INC
Inrervista 4 Gorrrepo Prrrasst
[ Mocessions di un suo breve soggiomo a Mi
lano, Goffredo Petrassi & stato intervistato
da Ruggero Chiesa. Ecco il testo della loro
conversazione:
RC. In questi giorni Lei ha consegnato al
Suo editore una nuova composizione per chi-
tarra sola, intitolata Nunc.' Quali sono stati i
motivi che L'hanno spinta a serivere ancora
per questo strumento, dopo averlo impiegato
1 settembre 1972 al Festival di musica contempo
Venezia questa comporisione &steta eseguita
nssluta dal chitacrsta Mario: Gang
Goffredo Petrassi © Ruggero Chiesa durante Mntervsta
nella Seconda SerenataTrio per arpa, chitarra e
mandolino, nel Concert
¢ dopo i Suomi notturni?
per flauto ¢ orchestra
G.P.: Non vi sono motivi particolari, ma so-
lamente affettivi. La chitarra mi ha sempre af
fascinato, non soltanto per il timbro, ma per-
ché la ritengo uno strumento misterioso, da cui
emana un mistero che & comunicabile a po
chissime persone. Escludendo assolutamente
quella elettrica, che @ fuori dai miei gusti e
quindi dalla sia pratica, con un timbro inol
tre che ritengo detestabile, considero la chi-
tarra « naturale » uno strumento intimo,
la suona mi sembra debba avere la sensazio
di colloquiare con una persona. La sua intimita
ils suo timbro rappresentano
Je tre componenti che mi hanno attratto € mi
10 mistero &
hanno fatto ritornare spesso sulla chitarra. Non
per niente, come Lei ha ricordato, ho scritto
quella Seconda Serenate-Trio per tte strumenti
‘omogenei, non soltanto perché essi sono a cor-
de pizzicate, ma anche perché sia l'arpa che il
mandolino partecipano in parte a cid che ho
detto prima della chitarra, Dei tre strumenti
perd preferisco la chitarra, ancora pitt dell’arpa
(& inutile che io analizzi Parpa e quali interessi
timbrici mi susciti) perché in essa vi & questo
senso misterioso del suono.
R.C.: Il linguaggio tecnico e musicale di Nene
ha subito modifiche rispetto ai precedenti brani?
G.P.: Non ci sono modifiche sostanziali. E mia
abitudine ticereare qualche cosa in ogni pezzo
che sctivo. Se non proprio Vinedito, cerco di
fare una nuova esperienza, che pud essere rivol-
ta anche ad un minimo effetto o ad un agglome
rato di suoni ai quali prima non ayevo pen:
sato, Quest'ultimo brano, Nur, che & pitt bre-
ve dei Soni notturni, non mi pare abbia delle
particolarita tecniche evidenti o troppo eviden-
ti. Ce n’é perd una che ho adoperato, quella che
si chiama percussione 0 tambora, non solo co-
me effetto, ma in senso funzionale, come se fos
se incorporata ai suoni della chitarra. Vi quio-
di una specie di contrappunto tra la percus-
sione e il suono dello strumento. Ho cercato
di adoperare 1a tambora non soltanto con il
palmo della mano, ma anche con delle singole
dita, per dare una varietA di ritmo e di peso.
RC: A proposito della scrittura per chitar
1a, sappiamo tutti che & piuttosto ardua ¢ che
richiede una particolare conoscenza dello stru:
mento. Le Sue composizioni si sono avvalse
dell'esperienza di qualche esecutore, ¢ in tal
caso in quale misura?
G.P.: Lei Iba gia detto, Ia chitarra @ uno stru:
mento difiicilissimo, dir’ terribilmente difficile,
e Ia sua conoscenza & un pozzo senza fondo,
poiché ogni esecutore pud trovarvi dei parti-
colati che non si possono insegnare. Sono pro:
prio delle scoperte singole, come avviene per
altri strumenti, ma in special modo per la chi
tarra. Ho letto evidentemente quello che scrive
Berlioz nel suo trattato di strumentazione a
proposito della chitarra, che egli sapeva suo:
are molto bene, mentte non sapeva suonare
il pianoforte; quando ho cominciato ad occu
parmene mi sono trovato in imbarazzo, per:
8
ché Ja sua tecnica ® alPapparenza clementare,
ma soltanto un’apparenza pet chi si contenta
di qualche suono, mentre in realta & complica
tissima. Ho cercato allora di studiarla per mio
conto, immaginando la sua tecnica, come un
compositore deve fare. Potenzialmente il com
positore dovrebbe suonare mentalmente tutti
er Ja chitarra.
Jevo scritto
ali strumenti, € cost ho fatto
Ho fatto poi vedere quello che
(solo perd i due brani solistici Swoni notturni e
Nunc) ad un chitarrista, il prof. Gangi, il qua-
Je mi ha dato ottimi consigli, sulla base dei qua
iho anche modificato qualche cosa, Ci sono in:
fatti degli effetti che noi possiamo soltanto
immaginate, ma questo credo che succeda a
tutti i compositori, soprattutto trattandost di
uno strumento difficile come Ia chitarra
RC. La ricerca delle possibilita timbriche de-
gli strumenti @ stata portata oggi alle estreme
conseguenze. Nella chitarra invece poco & stato
fatto in tal senso. Ritiene Lei che questo stru
mento possa interessare piti di ogni altro i com-
positori odierni?
GP. Il compositore si interessa di tutto il
materiale sonoro ¢ sfrutta tutte Je possibilita
haturali, artficiali e virtuali esistenti, anche se
qualche volta con scarso risultato, ma qui siamo
nel campo dellastrazione. Per la chitarra non
so se vi sono altre possibilita oltre a quelle ado-
perate sino adesso. E difficile che il compositore
possa artivare al di 1a di certe combinazioni,
mentre questo pud avvenire da parte dell’ese
cutore, il quale pud scoprire cose diverse. Che
esse siano poi sempre di buon effetto © quindi
utilizzabili dal composi vun’altra faccen
da. Lo non dico di aver scoperto nuilla, perd ho
cercato di usare quelle che sono le possibilita
4 mio avviso praticabili, ossia il ponticello, la
tastieta, i suoni armonici, la percussione ¢ qual
che altro ritrovato. Ce ne saranno probabilmen:
te altre, ma allora & compito proprio dell’esecu-
tore trovarle, esibirle ¢ renderne conto in mo-
do che noj le possiamo adoperate. Per esempio
nel caso della percussione, che si pud eseguire
sul legno o sulle corde, io sono caduto in un
errore. Usando la tambora sugli accordi, non
hho tenuto conto che battendo sulla cordiers
vibrano evidentemente anche le corde a yuoto.
Questo era un piccolo particolare, ¢ quando
Tho scoperto mi sono detto che era infantile
non averci pensato prima. Quindi aspettiamo
dai bravissimi esecutori qualche suggerimento.
R.C:: Non tutti i chitarristi hanno ancora rag:
giunto le condizioni tecniche € musicali comu-
ni agli altri strumentisti, e quindi il loro inte
esse verso Ia musica contemporanea pud sem.
rare minore di quello che & in realti. I com:
positori che scrivono per il nostro strumento
possono forse avere l'impressione di non essere
tanza seguiti, ma Le assicuto che l'esigen-
za di conoscere nuove opere & da noi particolar
mente sentita
G.P.: Si, questo lo so, ma vorrei dire che ho
notato molto interesse per la letteratura mo-
derma. Ho visto con sorpresa che quel pezzo
seritto anni fa, i Soni notturni, & conosciuto
da quasi tutti i chitarristi, e ultimamente ho
ricevuto un disco con la sua incisione* Ora a
mia volta vorrei farLe una domanda, se mi per-
mette. Non ho mai capito, ossia I"ho capito ma
vorrei averne una conferma, perché si chiami
« chitarra classica ». Questo credo che dipen:
da da una stortura mentale, Ad esempio noi
abbiamo nella musica di consumo una termi-
nologia che ci fa orrore: le canzoni, il jazz,
sono chiamati musica moderna. Evidentemente
& un termine improprio, ¢ cost vorrei sapere
da Lei il perché della « chitarra classica »
Exvesto Birertt: Cuatro siglas de musice itliona
a, Hispavor. HITS. 10-400,
RC. Questa definizione @ veramente assurda,
€ per questo motivo & stata ufficialmente abo:
lita nei programmi per i Conservatori, realiz-
zati qualche anno fa. Non esiste il termine di
classico per il pianoforte o il violino, non ve-
do perché si debba usare nei nostri confronti
La ragione di questa abitudine penso che ti:
salga al petiodo in cui la chitarra era conside
rata uno strumento destinato generalmente al-
Taccompagnamento della voce o allimpiego nel
Te orchestre di musica da ballo, e quindi si era
forse sentita l'esigenza di una definizione da
parte dei pochi che eseguivano la letteratura
classica. Oggi cid non & pit necessario, ¢ sta
gradatamente scomparendo.
G.P.: Questo mi fa molto piacere perché sa
18 di afuto per elevare i livello della chitarra
Tl termine di classico mi dava fastidio, come
se Ia gente dovesse essere messa in guardia
badate che non si tratta di chitarra elettrica
ma si tratta di chitarra classica, quindi di quel
classico che voi dovete avere pazienza per stu
diare, lo dovete prendere con molta buona vo
lonta, eccetera, insomma, tutte queste precau:
zioni. Adesso quello che mi dice mi riconforta
c ho piacere che sia caduto il termine « chitarra
classica » che era veramente un nonsenso.
R.C: Grazie, Maestro, delle gentili parole che
Lei ha usato nei confronti della chitarra; ci
auguriamo che presto voglia scrivere ancora per
il nostro strumento.
corrneno rereasst: Nunc
dal manossritto dll prima. pagine
LA RINASCITA
DELLA
CHITARRA
Aninascr della chitarra, che ha preso av
vio agli inizi del secolo XX, @ un feno-
‘meno le cui origini ed i cui sviluppi richiedono
individuazione e studio da molteplici punti
i vista
Finora, il fenomeno & stato genericamente €
superficialmente attribuito alla comparsa di un
grande virtuoso della chitarra, qual & stato An-
drés Segovia. Tale attribuzione & un tipico e-
sempio di capovolgimento dei rapporti di cau-
sa ed effetto, per cui un fenomeno riflesso viene
indicato come un fenomeno iflettente. Se le
sorti della chitarra fossero dipese dalla presenza
di un virtuoso, la rinascita dello strumento non
sarebbe incominciata con Segovia, ma molto
tempo prima, Giuliani, ad esempio, fu un vir-
tuoso eapace di attrarre su di sé tanto Vammi:
razjone del pubblico come Vattenzione dei mu:
sicisti, e, nella sua felice esistenza, egli rag.
sgiunse una celebrit’ paragonabile a quella di
‘qualsiasi grande concertista contemporaneo.
Tattavia, nonostante questa importantissima
presenza (c se ne potrebbero citare altre non
meno significative), la chitarra, fino a quasi
tutto il secolo XTX, continud a vivere ai margit
del mondo musicale, benché moltissimi music
sti ne avessero da tempo individuate le possi-
biliti polifoniche e le caratteristiche espressive
Tl confinamento della chitarra in tale posizio-
ne di « esilio » non fu dungue un fatto colle
gato all'assenza di esecutori che sapessero rive-
lamne i pregi, ma fu piuttosto uno dei fenomeni
egativi causati dallindirizeo generale dell'atti
vith dei compositori, del gusto € del costume
musicale, All’epoca di Sor e di Giuliani, i com-
positori erano impegnati in una ricerca ed uno
sfruttamento delle possibilita orchestrali_ ten-
denti alla gigantofonia, alla dilatazione delle
sonorita, all'esaltazione drammatica del suono:
10
situazioni che costituivano Vopposto pid violen-
to € schiacciante dei climi sonori in eui la chi
tatra avrebbe potuto esprimersi. Nel campo
stesso della musica da camera e del solismo, do-
minava la tendenza, di estrazione tipicamente
romantica, a proiettare gli strumenti in una
sorta di impegno eroico € trascendentale, in cui
le grandi sonorita avevano necessariamente una
parte insostituibile. Verosimilmente, non si pud
far torto a Beethoven di aver trascurato di in-
cludere Ja chitarra nei suoi quartetti, 0 a Liszt
di non essersi distolto, per un momento, dal
Vadorato pianoforte, per regalare alla chitarra
uno dei suoi momenti creativi; né & lecito pen:
sare che essi (come pure Schumann, Schubert ©
Chopin) non abbiano mai scritto per chitatra
perché non sapessero di che cosa poteva essere
capace lo strumento: sappiamo che tutti questi
musicisti apprezzavano la chitarra, e le ragioni
per cui non venne loro idea di comporte per
Jo strumento, erano evidentemente connesse a
scelte di fondo riguardanti V'estetica, lo stile €
la concezione formale € strumentale propria
della loro arte ¢ del loro tempo. Sbagliano an-
che coloro i quali accusano Berlioz, sostenitore
accanito della chitarra, di essersi contraddetto,
perché, agli elogi che egli espresse all'indirizzo
dello strumento ¢ dei suoi maestri, non fece
‘mai seguite il proprio impegno di compositore,
scrivendo qualche brano per chitarra, Tn realti,
le citcostanze in cui egli si trovava ad agire,
Jo costringevano a considerare Ia chitarra come
uno dei suoi affetti privati, mentre, al momento
della creazione, precise citcostanze storiche ed
ambientali, lo inducevano a mobilitare eserciti
di orchestrali ¢ di coristi, per poter esprimere
pienamente i propri intendimenti creativi
Occorte peraltro rilevare che, ove
particolari e momentanee della composi
avessero richiesto, i compositori di quell’epoca
sarebbero stati capacissimi di ricorrere con pro-
prieti alla chitarra, ¢, a tale proposito, basteri
ricordate l'impiego che ne fecero saltuariamen:
te gli autori di opere liriche, o anche i compo-
sitori di musica strumentale, quando, in specia
lissime circostanze, avvertivano Vesigenza di
creare delle sonorita pit: raccolte e meno fra-
gorose di quelle della grande sinfonia o del
concerto: alcuni momenti di Rossini, cette pa
gine «familiari » di Weber, la frequente pre
senza (implicita nel testo pianistico) di formule
chitarristiche nei Lieder di Schubert... Mentre,
nel caso del genio paganiniano, legato, per aff
ita naturali, allo strumento a corda, noi pos:
siamo assiste nzione completa delle
caratteristiche della chitarra, sia nellattivita
strumentistica, sia nella composizione: il che
dimostra essere senza fondamento la test se-
condo cui la chitarra sarebbe stata « ignorata »,
in attesa di uno strumentista che la rivelasse, ¢
pone invece, definitivamente, la situazione in
altra prospettiva storica. La chitarra era sulli
cientemente conosciuta ed apprezzata, le sue
connivenze con la musica popolare o con il di
Jettantismo da strapazzo non impedivano af
fatto ai musicisti di prendere atto della vera
natuta dello strumento; cid che impedi, allora,
il verificarsi di una riassunaione della chitarra
nel mondo musicale e nella pratica concettistica,
fu inves a storia della musica, le
cui vicende chiamavano allora i compositor ad
un tipo di impegno nel quale la chitarra poteva
avere soltanto una parte marginale ed un'im-
portanza irrilevante.
il corso de
Ne consegui la necessit’
per i virtuosi del-
Vepoca, di eseguire quasi esclusivamente le pro-
prie composizioni, ¢ sfortuna volle che, nella
pur dignitosissima, spesso ingegnosa, opera dei
chitarristi-compositori, non apparisse mai
traccia del genio, cosi come essa apparve invece
nel’opera dei pianisti-compositori (Schumann,
Chopin, Liszt); la musica dei vari chitartisti
compositori fu contraddistinta da una tendenza
allepigonismo od allimitazione scolastica dei
grandi maestri; se, da un lato, questa tendenza
fu producente agli effetti della quantita del re
pertorio dello strumento, dall'altro lato essa fu
negativa, perché diede luogo alla formazione di
hi comuni strumentali, di formule stereo:
tipate, e concorse alla nascita di una sorta di
artigianato compositive che tuttora appiatti-
nella prospettiva storiografica, fe figure di
parecchi autori, rendendole spesso impersonali
ed insufficientemente caratterizzate.
Con 'opera dei « giganti della decadenza » ¢
dei post-wagneriani, Riccardo Strauss, Bruck-
net, Mabler, la grande orchestra c
fine del secolo XIX ¢ V'inizio del secolo XX, il
proprio splendido declino. Nell’aria vi erano
con parvenze allora esoteriche o scandalose
le atmosfere rarefatte dell'arte di Debussy; i
limi sonoti derivati dalla scoperta della picco-
la orchestra, l’interesse per certi preziosismi ar-
caici, apritono, nel mondo della musica, uno
spiraglio nuovo. Con i maestri della scuola di
Vienna, assertori di un linguaggio polifonico
depurato, il quale portava necessariamente alla
selezione timbrica, con i raffinati esperimenti
coloristici di Ravel, con lo stesso avvento del
balletto, scopritore di arguzie folcloristiche, si
andava producendo, nel gusto musicale, un’at-
titudine nuova, in cui la quantita, la massa, ce-
devano gradatamente il passo al dettaglio, al
particolarismo fonico, alla ricerca di nuove di-
mensioni del colore strumentale.
‘Attraverso questo spiraglio, la chitarra acqui-
sta, nel volgere di alcuni decenni, la possibilita
di riproporsi al mondo della musica. Le caratte-
iche della sua voce, evocatrice di antiche
suggestioni, capace di aderire alle esigenze del
classicismo ¢, nel contempo, di creare impasti
timbrici e coloristici assai invitanti per 'imma
ginazione dei compositori (liberatisi dal_giogo
esclusivo della grande orchestra), costituiscono
una delle pitt significative rivelazioni. strumen-
tali della musica moderna.
Nel contempo, la chitarra si era, per cosi di
re, preparata agli eventi nuovi, attraverso l'ope-
ta di Francisco Térrega che, sul fi
colo XIX, aveva abbandonato lo stile della « sin
fonia chitarristica » in cui s’erano stemperate
le fatiche dei suoi predecessori, offrendo una
del se-
visione nuova della chitarra, piti incline a vo
calizzate le linee, ed a ricercare, sfoltendo la
selva dei virtuosismi calligeafici, una dimensio:
ne timbrica dello strumento. La solitudine ar
tistica in cui egli visse, gli impedf di corrobo-
rare la sua istintiva vivacita mentale con soli
di acquisti di cultura; ma, nonostante il limite
nazionalistico, Térrega fu capace di porre un’im:
portante premessa alla rinascita della chitarra,
che doveva incominciare dopo di lui
La contraddittoria figura di Miguel Llobet
agisce proprio nel momento cruciale; da una
parte, questo catalano ipersensibile ¢ medita
bondo, di prova di aver capito qual & Ia via
ssiusta per il futuro dello strumento, ed armo
nizza alcune melodie catalane con gusto squi
sitamente moderno, influenzato dai suggerimen-
ti di ur’arte che viene — impropriamente
u
definita « impressionismo »; dall’altra_ parte,
gli reagisce, con spagnolesco settarismo, alle
proposte di Debussy, che vuole comporre per
chitarra, dimostrando di non capire che soltan-
to attraverso la sensibilizzazione dei composi-
tori si potra giungere alla riassunzione della
chitarra nel ruolo che le compete. Certo, il
giorno in cui un compositore come Debussy si
sente attratto dall'idea di comporre un pezzo
per chitarra, anche se non incontra la collabo:
razione da parte di uno strumentista, allora ve-
ramente si compie quel processo di evoluzione
del gusto musicale, dal quale ha inizio la sic
nascita della chitarra. E, pochi anni dopo, pro-
prio in memoria di Debussy, Manuel de Falla
sanziona V'ingresso della chitarra nel mondo de-
ali strumenti provvisti di dignita solistica, scri-
vendo quell’ Omaggio che & la prima importante
composizione della letteratura moderna per chi
tara,
‘A questo punto, sono mature le circostanze
attraverso le quali un grande strumentista co:
me Andrés Segovia pud fare il suo ingresso, nel
mondo della musica ¢ nelle sale da concerto,
forte di un’autorita che era sempre mancata ai
suoi predecessori; i musicisti che ora lo ascol-
tano non sono pi mobilitati, come i grandi
romantici, su un altro fronte, ¢ possono colla-
borare con ui alla creazione di un repertorio
originale di musiche per chitarra; il pubblico
delle sale da concerto pud ora stabilire, tra le
rusiche per chitarra ¢ altre musiche che gli
vengono proposte, un rapporto di relazione e di
continuita (laddove il pubblico ottocentesco po:
teva ascoltare un concerto di chitarra al mas
simo come esibizione di bravura a sé stante,
quando non come una curiositi o una strava.
ganza), poiché ode, assieme al concerto di chi
tarra, orchestra da camera, Porchestea antica,
il clavicembalo, il liuto, Parpa, persino il vio-
lino ed il violoncello soli (che eseguono le sui
tes ¢ le partite di Bach); poiché gli viene rive
lata la polifonia rinascimentale, c, attraverso
Vascolto dei madrigalisti e dei mottettisti, li 2
dato di rintracciare certi elementi discorsivi che
Vaiutano anche a comprendere la natura di stru-
menti come il liuto e Ia chitarra.
Segovia non ha dunque prodotto la rinascita
della chitarra, ma vi si & inserito, da protagoni.
sta, in un momento in cui effettivamente V'atti-
2
viti di un virtuoso della sua statura era stata
resa matura e possibile da un processo di evo:
luzione storica durato per due secoli e pi
Successivamente, la rinascita della chitarra,
‘ormai giunta ad uno spiegamento completo ed
articolato di tutte le sue componenti, si & mos
sa sviluppandosi nelle seguenti direzioni:
1. Vintensificazione dellativied concertistica
prodotta con Papporto di altri validi con:
certisti, che si sono aggiunti a Segovia;
2. Ia nascita di un‘attivita didattica a livello
di conservatori e di scuole musicali qualifi-
cate;
3. la creazione di un sempre piti vasto ed in-
teressante repertorio di musiche originali,
dovute alla collaborazione tra compositori
fe chitarristi;
4. la proliferazione di una trattatistica didat
tica sulla tecnica della chitarra;
5. la riscoperta dell’immenso patrimonio di
musiche rinascimentali e barocche per liuto
e per chitarra, la loro trascrizione in nota
zione moderna, con conseguente risveglio
dell’attivita filologica, anche se talvolta se-
utisti ¢ chi-
gnata da inutili polemiche tra
arrist
6. la revisione critica del costume della tra
scrizione per chitarra di brani composti per
altri strumenti, anch’essa condotta attra-
verso polemiche non sempre serene e do-
cumentate;
7. la revisione delle opere didattiche © delle
composizioni originali per chitarra dei se
coli XVIIT ¢ XIX, aggiornate secondo cri
teri di lettura ¢ di condotta strumentistica
moderni;
8, Ia nascita di alcuni tentativi di fondare una
storiografia chitarristica di avviare una
saggistica sulla letteratura e sulla tecnica
della chitarra;
9. 1a nascita di un'attivita editoriale legata
al mondo della chitarra;
10. il sifiorire della liuteria, sollecitato dal gran
de numero di chitarristi, studenti ed ap:
passionati
Chi scrive si ripromette di trattare, nel tem
po, aleuni degli argomenti sopra elencati, con
particolare riguardo al settore della musica con-
temporanea per chitarra
ANGELO GILARDINO
LARTE DI SUONARE LA CHITARRA
O CETRA
DI FRANCESCO GEMINIANI
LA rin & sompostore del violinista luc-
4 chese Francesco Geminiani (nato nel 1678
© 1680, ma battezzato nel 1687 — morto nel
1762) legata soprattutto ai suoi Concerti gros
sie alle Sonate per violino, mentte quella di
trattatista ¢ dovuta ad una nutrita serie di opere
didattiche tra cui, senza dubbio, primeggia la
fondamentale The Art of Playing on the Violin.
L'importanza di questo trattato & dovuta al fat
to che, quale allievo diretto di Corelli, Gemi
niani per la prima volta ha esposto minuziosa
mente i principi basilari della scuola del suo
grande maestro! contribuendo decisamente a
diffonderne la tradizione in Inghilterra
Tra le altre sue opere didattiche, qui inte-
ressa principalmente presentare The Art of
Playing the Guitar or Cittra (1760), oltre che
per tracciame un’analisi, anche per cercare di
precisare a quale tipo di strumento Popera stes
sa sia stata indirizzata, Infatti, pet quanto ne
<0, in diverse pubblicazioni questo lavoro vie
ricordato come un metodo pet chitarra* ¢
per di piti — in un unico caso, se non erro
‘| suo autore viene citato, sic et simpliciter,
tra i chitarristi italiani, Va subito detto, pero,
che molto probabilmente la parte iniziale del
titolo del frontespizio dell’opera, parte dame
citata, ossia Larte di suonare la chitarra o ce
Cie, Mane Prscmeate, Les violonistes, He
rens Eaiteur, Pati 1922, pp. 3861
Cle, ad egy Puttar J. Bove, The Geitor and
olin (Second Edition, enlarged), Seht & Co,
dra 1954, p- 136, dove, citando'cestualmente, The 2h
playing the Guitar, ete. di Geminiani (quind om
tra, deve aver tratto in inganno coloto che non
hanno tenuto conto di quanto Geminiani espo-
ne nella parte introduttiva, contenuta nella
gina 1 del libro. Qui il maestro hucche
ti, informa di aver inteso « to
Lessons adapted to the compass and stile of that
Instrument », cioé per « the lesser Guitar
nfat-
jompose some
Citera ». Egli, quindi, ha voluto « comporte al
cune lezioni adattate all’estensione ¢ allo stile di
guello strumento », ossia per « la chitatra mi:
nore o cetra ». Geminiani, dunque, fa un pre-
ciso riferimento ad un unico strumento ¢ cio?
alla cetra che, come meglio vedremo pit avan
in Inghilterta nella seconda meta del_secolo
XVIII venne generalmente chiamata English
guitar (ed ® appunto per m chiarezza che
Geminiani usa il termine lesser Guitar),
Strumento appartenente alla
chitarra, la cetra ebbe un ruolo
famiglia della
asi, modesto
‘ma non sempre trascurabile. In un primo perio
do di notevole diffusione, per essa si stamparo-
no diversi libri di intavolature (dovuti a G.
Motlaye, A. Le Roy, F. Viaera, S. Vreedman, P.
Phalése, A. Holborne, R. Allison, Th. Ro
J. Playford, ecc., ¢, per cetra e altri strumen
a Th, Morley e P. Rosseter) apparsi, in Francia
Fiandre ed Inghilterta, tra Ja meta del Cinque
cento e la meth del Sei
precisizione “or Citta"),
‘which is of no valve at present, was published in no le
Tanguages, E Traian, French, "Germs
ci Sto layoro che sttvalmente
cata. in non mene i cingy
'e olandese.»
B
La cetra, ormai in disuso (eecetto in Portogal
lo dove & chiamata guitarra portuguesa), era mu-
nita di corde doppie (cori) normalmente di ac-
ciaio 0 di ottone’e, vista di fronte, il contorno
della sua poco voluminosa cassa armonica appa-
iva alquanto circolare mentre il fondo era
piatto. Un foro di risonanza, finemente in-
tagliato, stava al centro del piano atmonico.
Le corde, partendo dal cavigliere, dopo esset
passate sopra un ponticello posto sul piano ar-
monico (pit sotto rispetto al foro), mediante
dei bottoncini venivano fissate all'incontro infe-
riote delle fasce. Da quanto si pud constatare
da due delle raffigurazioni del Praetorius, late
ralmente le altezze delle fasce diminuivano pro-
ressivamente dalle estremitd superiori a quelle
inferiori. Dopo esser stata suonata col plettro
sino alla fine del sec. XVI, per merito dei com:
positoti inglesi, da quel periodo Ia tecnica ese-
cativa della cetra ebbe maggior impulso avv:
lendosi delle dita della destra. Sempre dalle ci-
tate raffigurazioni del Praetorius e da una di
Adrian Le Roy,’ i tasti, che erano disposti per
semitono ed erano di metallo, vatiavano da 14
a 20 (il 12° di norma coineideva con Pinizio del
la parte superiore della cassa armonica), ma non
sempre (A, Le Roy) tutti i tasti attraversavano
Ja tastiera in tutta Ia sua larghezza, alcuni ~
dopo il 4° — sottostavano solo ai primi cori. Nel
Cinquecento ¢ Seicento il numero dei cori vari
da 4.a 12 con accordatute instabili (Con 4 coti,
ad es., A. Holborne ~ The Cittharn-Schoole,
1597 -— usd le acco ure si-si sol-sol re'-re!
mimi? oppure mismi do-do solsol la-la)
Accanto a questi tipi di cetra vi furono anche
gli altri tipi con foggia ¢ caratteristiche diver
3, Manny Meesenne (Harmonie uniersele (Parigi
1636], red. in facsimile, Editions du Centre. national de
ln recherche scientifique, Parigi 1963, vol, IML, Lirre Se.
des Instruments a chordes, p. 97 [bis}) et informa
in Francia, dove ‘si usevano cetre con 4 cot, eta
pppio solo il 3° coro mentre alt alti tre com
Storde ciascuso, Per la cetra, eft. loc, cit,
P'Che" Micnaee Prarrortus, Syntagme musicum, Wol
fenbauel 16151620, parte seconda De Orgenograph
tay. VIE. Alt pi divcetre vi sono ralfigurati alle tiv
fet Pesce Vita, Les
ides, nella Collection "Que
fe", Presses universtaites de France, Parigi 1970, p.
Bet acta, oh cpp, 124126
6. Der le cetre con fopge ¢ caratctstiche diverse ase
‘onda dei periodi e det pacsi, che, RIEMAWN, Musik Le
5. Chr, Hue Cane
instruments 2 corder
4
see, tra questi, va ticordata Varcicetra (ted. Erz
Cister, Theorben-Cister; fr. archicistre; ing].
biiuda cither, syron, Sirene), specie di cetta tio
bata usata attorno al Seicento, ma nel Settecen-
to particolarmente in Francia e Germania, Ol
tre ai cori sulla tastieca era pure munita di
bordoni (di solito semplici) sostenuti da un se-
condo cavigliere posto sul sopraclevamento del
manico, (Th, Robinson ~ New Citharen Lessons,
1609 = ad ¢s., ne usd una con 7 bordoni sem-
plici e 7 cori)
Dopo un periodo di crisi pit o meno accen-
tuata, la cetra torna in voga specie in Inghilter
ra nella seconda meta del sec. XVIII, e questo
ce lo conferma lo stesso Geminiani’ come me-
slio vedremo pitt avanti, La foggia dello str
mento ora presenta linee piti fantasiose. Con
manico pitt corto, che termina con una specie
di riccio in cui un sistema di viti ha soppian-
tato i tradizionalj bischeri, in Inghilterra passa
sotto il nome di English guitar (fr. guitare an
glaise, occasionalmente pandore)* In prevalen
za comprende 10 corde distribuite in 6 cori cost
accordati: sol'-sol' mil-mi! do!-do! sol-sol mi-mi
do-do’ F, raddoppi a parte, si tratta della stessa
accordatura che viene usata da Geminiani nella
sua opera per Guitar or Citra,
Tl nome italiano, oltre che cetra, anticamen-
te poteva essere cefers, cister, citara, citera, ©
pure nelle altre lingue poteva presentarsi con
grafic diverse: fr. cistre, citbre, citole; ingl.
cithern, cittern, citthary, cither, citharen, ck
thren, sittron; ted. Cister, Cither, Zitter, Zitber,
questultimo termine designa pure Ja cetra da
tavolo — della famiglia del salterio ~ origina
ria della Germania meridionale e del Tirolo: sp.
cedra, guiterna; port. guitarra portuguesa
ikon, B, Schott Sdhne, Magonza 1967, Sachtel, w
Gister, pp. V74105,
7, Che in quel ps
odo a cetra avesse larga diffus
in Gran Bretazna ce lo conferma anche la. pubblicezione
fawenuta a Londra i 6 Teil per eetza, violino
f basso, del violinista © compositore torinese Felice de
Giardini (1716-1796). Di quest, il "Trio 1V, in fa mag
lore, & stato pute riedito a cura di EJ. Giesbert, Veslag
Adolt Nagel, Hannover.
‘8. Cir ROMANS, Too. il, p. 174; HL Chuganass ot F
Ventttan, op of, py 136; Hue’ Oxroan ComPaxton’ 70
Mustc, Ninrb edition, Oxford University Press, Londra
1956 ¢ 1960 voce Citerm p. 187. Inolite, per’ la ceva
in Inghilterra, cfr, THORSON R. Datty The Cittern and
lis Englob Marie, in ""The Galpin. Society Journal” T
1548, ‘The Shenval’ Press Ltd, Londia e Herford
9. Cie. RIeMaNn, Hid
Peserontus, Syntagma
zrapbia, Wolfenbartel
wm, pate seconda D.
re.
Qui di seguito riporto integralmente tutto
quanto & contenuto dal frontespizio dell’opera
di Geminiani
The ART of / Playing the GUITAR or CITT
Containing / Several Compositions with a BA
for the / YVIOLONCELLO or HARPSICHORD /
Most Humbly Dedicated to the / Countess of Char
leville / by / F. Geminiani, /N:B:
Solos / for the V
Graces requisite to play in a good
These Compo:
very proper
the Shifts and
taste are dis
tinetly mark'd, it must be of great use to those
that Instrument. / EDIN-
BURGH MDCCLX / Printed for the Author by R
the Harp & Hautboy and sold at all
in Great Britain and Jreland
Music shops
Eccone
la traduzione:
te diverse com
we di suonare Ia chitarra 0
a, comprenden-
osizioni con un basso per il violon-
cello 0 clavicembalo, Molto umilmente dedicate al:
la Contessa di Charleville da F. Geminiani. NB.
Queste composizioni sono congegnate in modo da
ire degli assoli molto adaeti per il violino;
cost tutti i virtuosismi ed abbellimenti, necessar
pet suonare con buon gusto, sono chiaramente se
nati, Ce] cid deve essere di grande vantagaio per
Coloro che aspirano a suonare quello strumento,
Edimburgo MDCCLX. Stampato per lautore da R
Bremner, presso {coi tipi di] Harp & Hautboy, e
venduto in eutti i negozi di musica in Gran Breta
gna e Trlanda
Come si pud constatare dal lungo titolo, si
hanno due versioni, luna e Paltza autonome, del-
Un alto
Jettaglio editriale lo troviamo in alee
1 EDINB: os
(o di) Edimbur
mentari, Mla, olte
fe sulle viola da gumba o sul cel:
he per tagion! di forza
il Contino semplicem:
le stesse composizioni che, quindi, si possono
eseguire sia con cetta e basso oppure con vio-
lino e basso.
er quanto concerne la realizzazione del bas-
so, petd, l'indicazione “per violoncello oppure
cembalo” non va presa alla lettera perché, in
pratica “oppure” poteva significare anche “e”
E noto, infatti, che nell"epoca era piuttosto d
fusa la consuetudine di far figurare “oppure” "
nel titolo ed “e” nelle parti: come appunto si ve-
rifica in questo caso in cui sia il violoncello che
il cembalo contribuiscono ambedue alla realiz
zazione del basso continuo.
Per economia di spazio, riporto soltanto la
traduzione italiana del testo della pagina 1 del-
Vopera, comprendente una nota introduttiva,
gia in parte citata, ¢ le delucidazioni sul sistema
Gintavolatura che Geminiani ha usato per Ia
parte della cetra, (La traduzione, al pari di quella
del contenuto del frontespizio, ® redatta lette
ralmente, Prego quindi il Jettore di perdonarne
Ja forma, dato che la mia unica preoccupazione
B stata quella di rimanere strettamente fedele
al testo originale), Questa la traduzione del
testo di Gemini
Essendo d ato tra noi Luso della chi
tarra minore 0 cetra [lesser Guitar or Citera,
originale}, pensai che avrebbe potuto essere di
xi comporre al
e allo stile di
juello strumento, E mi sono sforzato di perfezio-
vantaggio per tutti i suoi ammiral
cane lezioni adattate allestension
narlo aggiungendo pid armonia ¢ modulazione al
solito modo di suonatlo
La doleezza e Ia brillantez
della chitarra [Guitar, nelWotig
sua comoda forma © misura, none
della peculiare so
me a alla
facilita di suonarla, Phanno gid resa di gran moda
finato: ma essa & anche pitt degna di
che da parte dei buoni cultori di
di quanto generalmente si cre
considerazio
disposizione ed il numero delle sue corde la ten:
dono suscettibile di un'armonia molto piena e com
pleta, come si pud osservare dalle composizioni
fguenti. [Ossia dopo le istruzioni che
to, Inolte, per il contenimento. dell
nunica, fasta si stampavano sia
i del cembalo, claseuaa
Beer Doxincton, the Interpret
ber and. Faber, Londea 1963, p. 295). Comungue ~ @
Cart “Philipp: Emanvel Bach ‘a! confermarcelo. il
pagnamento diun "Solo" yeniva conse
R
“of Barly Maric, Te
Oh » Arr Of
¥:
Playing the
G C TAWTRhE
tUVTAR or CVE TRA
: Containing
Sor C omyposttions nih a BASS jer the
VIOLONCELLO or HARPSICHORD
Se > *
a Uost Mently Dedicated to the
DEAS SBI 1 Oe
(GSountels “ASharlaille
ee ee
S fe ve 8 -
© fe MUM «
or
hese, Compositions are ¢ ad. 30,05 to make Soles
ise, Copies gue gaia ees
ic mucat bef broat use t those nhe aspibe 2
EDINBURON. MDCCLX
on the Author by R:Bremner.st the Harp d Hautby.and fold ot all the Matic ropa
in Grey Britain aad Ireland,
SPIEGAZIONI DEI DIVERSE SEGNI
Consistendo di se line, il rigo intermedio rappre
senta le sei corde della chitarca (Guitar, nell origi
nal
Dove 0 ® posto sopra una qualsiasi linea Cinf-
lacovi, esattarne nella cord a
© Gli altri simboli [cifre] rappresentano i tasti che
ateraversano Ia tasticra ed anche le dita adatte pet
mate {premere] que tast (vedi es. A)
In ira I posta
so. indica
2° linea, significa che il primo
dito deve essere posto sul primo tasto della
da, corda che & rappresentata da quella linea, Anco-
1a, la cifta 2 sta ad indicare il 2° dito sul 2° tasto
3° corda e cosi per le altre cifre. Ma se una
second setie di cifte & posta sopra le 6 linee [in al:
to risp (vedi es. B),allora le ci
fre sul ndicano soltanto i tasti ¢ quelle al di
sopra indicano le dita adatte per formare quei
Lrispettivi] tasti.
Dove '@ un qualsiasi numero di cifre sovrappo-
ste I'una sullalera (vedi es. C), esse rappresentano
Te note che costituiscano un accordo, e devono ve.
ni suonate tutte insieme. Questa linea obbliqua
0 (vedi es, D),
Dove una linea ~ & posta sopra due o pi cifre,
bisogna pizzicare solo Ja prima [nota] perché le
dita {della sinistta] nel passare sopra le altte pro-
ducono il suono (vedi es.
Per quanto concerne il tempo ¢ il valore delle
note, 1a parte del violino la sola cui bisogna at
Non stard
diversi abbellimenti, cio? tillo, mordente, appog-
giatura, e¢c., ma affiderd quelli alle istruzioni di un
buon maestro o al talento dell’esecutore
Ho soltanto da osservare che i tasti verrebbero
individuati pitt prontamente se fossero numerati co:
me in questo abbozzo della tastiera.
19 all’esagramma
ha lo stesso signifi
ui a tediare il lettore colVillustrare i
Ecco, in facsimile, la tastiera e gli esempi pre-
senti nell’opera
Lecce
Geminiani, dunque, pet la parte della Guitar
si serve dell'intavolatura in cui una portata esa
12, Pet i vari gistemi diotavolatura. di cetra, confton:
tare:) Jonnotes Wout, Handbuch der Nosaionsiunde
Brsithopt & Hire, Wiesbaden 1963, wolume I, pagine
123.146
gtammata rappresenta i cori dello stramento™
Egli perd, pur dimostrandosi abbastanza chiaro
nella propria esposizione, non elenca tutti i se
gni da lui usati nel testo intavolato. Da tale
testo, perd, non 2 difficile desumerli per cui,
per comodit’ del lettore e per maggior chi
rezza, oltre a riportarli, riassumo_sistematica
ente, pure nel suo insieme, il sistema grafico
di Geminiani
La linea superiore dell’esagramma indica il
coro pitt acuto. I suoni da ricavare dai cori a
vuoto, sul 1°, 2°, 3° tasto, ecc., sono rispet
tivamente indicati con le cifre 0, 1. 2, 3, 4, 5
6, 7, 8 e 9; quelli dal 10° al 14° tasto, invece,
coi numeri ordinali X, XT, XT, XII e XTV. Tut
ti questi numeri, cardinali ed ordinali, sono
Tati sulle varie lin
Queste, come gid accennato, erano le
ze dei suoni relativi ai cori a vuoto, dal 1° al
§
Pertanto, ad esempio, dei suoni sul 3° coro so-
no cost intavolati
© cortispondono a
Da questo esempio, quindi, non ® difficile
constatare che, poiché i tasti dello strumento
sono disposti per semitono, le cifte dall’l in poi
corrispondono rispettivamente al m
mitoni cui deve venir elevata l’altezza del suono
del coro a vuoto rel
tivo.
Come nella scrittura tecnica della chitarra &
del liuto, anche in quelle della cet
2,3e4i
a le cifre 1,
ano tispettivamente Pindice, il me
13, Per comoditi di scritura uso la chiave di sot con
una 8 sottopostav, la cost detta chiave di tenore, [a questa
imovo & sficiente adop
Son cortispondono un
dio, Yanulare ¢ il mignolo della sinistra. Ge-
miniani, a sua volta, ci avverte che se tali dita
devono premere i primi quattro rispettivi tasti,
le cifre dellintavolatura ne sottintendono i re-
lativi diteggi. Ad es, 1 3 2 4 indicano il
1°, 3%, 2" © 4° tasto, ma allo stesso. tempo,
anche il 1°, 3°,2° e 4” dito, Nei casi di non
coincidenza numerica di tasti e dita (e, ovvia-
mente, nelle diverse posizioni della tastiera
ra), i diteggi della sinistra sono segnati sopra
Yesagramma, Inoltre, per evitare di segnare pitt
volte la stessa cifra sopra la portata, Geminiani,
dopo averla scrita, la sottintende sostituendola
con delle trattine. Nei casi del genere si tratta
di un dettaglio tecnico piuttosto particolare in
cui il diteggio, oltre ad essere costituito dallin.
dice sinistro che preme piti cori (il consueto ca
potasto, ossia il barré nella terminologia chitar
ristica), sitha che anche il medio © Panulare
adempiono alla stessa funzione
Egli non segna alcun diteggio per la destra,
ma, da un accurato esame dell’intavolatura, ri:
sulta evidente che Pesecuzione pud avvenite
soltanto con I'uso delle dita e non col plettro,
dato che in alcuni casi i cori da pizzicare non
sono consecutiv
Gli accordi, naturalmente, sono notati con
cifre sovrapposte, oppure (es. D — & Gemi-
niani che Io dice — con cifre consecutive
contrassegnate con un tratto oblique (ma in
certe intavolature barocche di liuto questo se-
gno indica un accordo arpeggiato
Una finea curva che na legatura di
portamento, abbraccia piti cifre, indica che i
rispettivi suoni vanno eseguiti legati (es. E).
Si tratta del cosi detto legato tecnico che, ben
hitarristi, va realizeato pizzicando la
prima nota con la destra mentre le rimanenti
vanno ricavate con la sinistra
Geminiani non segna i valori ritmici relativi
alle varie cifre dell'intavolatura ed avverte che
essi vanno desunti dalla parte del violino che
~ come gia detto e come vedremo meglio pit
avanti ~ & pure compresa nel testo, Lo stesso
avyertimento vale sia per le indicazioni di tem-
po e, a me sembra sicuramente, anche per
ali abbellimenti, appunto non riferiti allesa
gramma
Dalle istruzioni sopra riportate, risulta che
il musicista non ha precisato le altezze dei suo-
8
ni relative all'accordatura della cetra ma sol-
tanto-i nomi delle rispettive note dal grave al-
Vacuto (CE G C EG, ciot DO MI SOL DO
MI SOL).
Particolare interessante: lo schema della ta,
stiera dello strumento — gid riprodotto ~ ci
permette di desumere che i primi 3 cori com:
prendevano ciascuno 2 corde e che gli ultimi 3
erano costituiti da corde semplici. Quindi, Pac
cordatura, a partire dall'acuto, era: sol'-sol!
mitmi' do'-do! sol mi do. Inoltze, i tasti erano
16 per cui Pestensione dello strumento com:
prendeva due ottave pitt una settima maggiore
(do-si).
The Art of Playing the Guitar or Cittra, col
frontespizio comprende 51 pagine, di cui 49 di
sto musicale. Questo, a sua volta, si suddi-
vide in 11 composizioni, che Geminiani indi-
ca come Examples, ma si tratta di Sonate nel
significato formale dell’epoca; ognuna di esse
si compone di piti movimenti, in numero varia
bile
TI testo musicale, per le consuete ragioni di
economia editoriale, ® presentato in partitura
in tre portate
la prima (con Vindicazione Violino) con
la versione per violino e le relative precisazioni
di tempo, dinamica ed abbellimenti (le scrit
tura ® tipicamente violinistica e concepita, qua
12, con tecnica alquanto avanzata);
- Ja seconda (con Vindicazione Chitara 0
Cetra) con Ia versione intavolata per cetra, con
parziali indicazioni dinamiche, senza valori rit
mici, senza indicazioni di tempo, né di abbell
menti; le indicazioni sottintese vanno desunte
dalla parte del violino (eccetto che nell’esecu
vioni di certi abbellimenti, presenta limitate dif-
ficolt’ tecniche);
Ta terza (con Vindicazione Violoncello ¢
Cembalo) senza indicazioni di tempo, ma con
dinamica ed abbellimenti.segnati; prevalente
mente in chiave di basso, ma in alcuni: momen:
ti in chiave di tenore, e corredata dalla nume.
rica per Ja realizzazione armonica. Da come si
presenta questa parte, @ chiaro che, per la sua
esecuzione integrale, essa deve venir alfidata sia
al cello che al cembalo perché in diversi punti
lo strumento ad arco esegue disegni diversi da
quelli del cembalo e per di pid in alcuni passi
sostiene da solo il basso fondamentale, pur es-
sendo segnata la numerica inintetrottamente
dal principio alla fine. In pratica, all'iniziare di
ogni composizione, Geminiani sottintende il con-
corso dei due strumenti; quando in certi passi
vuole precisare che il cello resta solo (cioe il
cembalo « tacet »), usa l'indicazione Viol.; in:
quando i due strumenti devono riprende
re uniti Vesecuzione, pone l'avvertimento fut:
Comunque, poiché molto era lasciato alla ve
lonta degli esecutori ¢ dato che il basso @ inin:
chiaro che Geminiani,
terrottamente cifrato, @
almeno in via subordinata, ammette l'uso del
solo cembalo se non, addirittura, forse del solo
violoncello,
Tl trattato di Geminiani non comprende al-
cun indice ma, frontespizio a parte, la materia
& cosi impaginata:
Parte iNrropurriva
p. 1 Succinta premessa con delucidazioni
agli scopi della pubblicazione. Spie
gavione dei diversi segni,
PARTE MUSICALE
PLE I (do maggiore): Allegro
pp. 2-3 EX
‘Moderato
pp. 4-5 Allegro
p35 Adagio
pp. 6-8 Giga (Allegro)
pp. 810 EXAMPLE LI (do minore): Andante
Allegro-Andante
pou r0 Cantabile
MPLE III (re maggiote): An.
Infinito alla 12°
Allegro Moderato
Grave
gro Moderato
E IV (re minore): Andante:
25 EXAMPLE V (mi ore): Andan
te-Allegro Moderato
14, A Giovanni Battista Marella si deve ona serie di
fet doc chitarre, del 1762. Tooltre, a quanto chin
forma Hl Buck, Marella sarebbevissuto in. Inghilerca tra
11755 © dl 162 (ctr. Batre Bure, Die Gitarre und ibn
Meister (3, Auflagel, Robert Lichaa/Vormals_ Schlesi
get) Berllno say py 11). Quin a chitara'a 3 cori era
pp. 26-27 Giga (Allegro Moderato)
p. 28. EXAMPLE VI(mi minore): Andante
p. 29 Canone Infinito (Spiritaso)
pp. 30-31 EXAMPLE VII (fa maggiore): Alle
gro Moderato
pp. 32:33 Allegro Moderato
pp. 3435 Allegro
P. Allegro
P. EXAMPLE VIII (fa minore): Alle
Allegro Moderato
Afettuoso
p. 42. EXAMPLE 1X (sol maggiore): Alle
ro
p. 43 Alllegr
pp. 44-45 Allegro
p. 46 EXAMPLE X (sol minore): Allegro
>. 47 Alfettuoso
pp. 48-49 EXAMPLE XT (Ia maggiore): Alle
Moderato
3iga (All
pp. 50-51
Poiché Ge allinizio dei suoi compo
rnimenti (p. 2), pone lindicazione Chitara 0 Ce
tra, qualcuno potrebbe forse chiedersi se, con
uso di termini italiani, egli avesse voluto ti
chiamarsi al preciso significato che essi hannc
nella nostra lingua, Ma si tratterebbe di una
perplessita che va senz’altro fugata, sia perché
la chitarra dell’epoca era munita di 5 cori * (e
Vintavolatura per cetra ne indica esattamente
6) e sia perché, di norma, il numero dei suoi
tasti non arrivava a 17 ¢ quindi era nell’impos:
sibilita di emettere il La? (nel registro acuto)
che risulta intavolato pitt volte.
Sia nella
violino,
strumentale particolare, Inoltre, per 1a loro va
lidita musicale, meritano la stessa considerazio-
ne della migliore produzione sonatistica di Ge
miniani. A mio avviso, vanno segnalate le So-
nate I, II, I, IV, Vie X
Nel presentare il lavoro di Geminiani, ho do-
‘one per cetra che in quella pet
11 Sonate denotano un interesse
verosamente illustrato il fatto che si tratta di
composizioni scritte pet cetra, oltre che per vio-
fino, ma altrettanto doverosamente, ho pure
sottolineato il loro intrinseco valore musicale,
pratcata_ in_Inghiltersa al
Popera dt Geminiani. La T
comenute in: BRUNS HEeNz
VEB Eredrich Hofmeister, L
pure elaborate da”
Devo ora conchidere che, proprio per a loro
validita artistica ed anche per il prestigio del
foro autore, sarebbe estremamente inopportuno
seguite solo perché la
cetra & otmai scompatsa 0 praticamente igno-
rata nella pratica musicale, Ma la chitarra,
cui famiglia la cetsa appartiene, vanta oggigi
no diffusione ¢ prestigio e, proptio nelle sue
caratteristiche moderne, & 'unico strumento che
pud far rivivete con sostanziale appropriatezza
15. Nel pit completo rispesto dell'oiginale, Tedizione
Jella Suvial Zecbont comprenderd sig Ia versione pet chi
mera (cetra) che quella per violino, Ognona delle due ver
Sint pots avvalersi dello steso. basso continuo realiza:
sonora i preziosi lavori di Geminiani. E di cid
non possiamo che rallegrarci, specie. se tenia.
mo presente che, eccetto qualche rarissimo det
taglio musicalmente trascurabile, la versione in:
tavolata & eseguibile sulla chitarra
Sono quindi lieto di poter comunicare che,
pet lodevole iniziativa delle Edizioni Suvini
Zerboni, quanto prima satanno pubblicate sei
delle Sonate di Francesco Geminiani.”*
Bruno Tonazzt
wicembalo (oppare
‘paso continuo pole ven
asso 08 qualsiast altro strumento
to per violoncello ¢
Ferise, Teseeusione
al solo clavicembalo
Francesco Genmiast: Example I (Allegro moderato) da « The Art of Playing the Guitar or Citta », Edinburgh 1
STORIA DELLA LETTERATURA
DEL LIUTO
E DELLA CHITARRA
IL CINQUECENTO
1
Iyrropuzione
y imprcNo di presentare tutti gli autori di
4 opere per liuto e chitarra,' a partire da:
ali inizi del Cinquecento sino ai nostti giori, ¢
intraprendere di conseguenza l'analisi cla critica
di una letteratura tra le pid ampie della storia
della musica strumentale, costituisce un'impre
sa vastissima ed estremamente ardua. Le cause
di qu
a difficolta dipendono dal fatto che le
attuali ricerche musicologiche compiute in que-
sto settore, pur essendo in costante sviluppo, so:
no affidate a pochi studiosi che non hanno anco-
ra totalmente esaminato e trascritta il patrimo-
rio musicale esistente. Si ® giunti perd ad una
sua completa catalogazione (salvo qualche impre
vista eccezionale scoperta) che ci consente di
¢ una visione generale di quella che fu la
meravigliosa fioritura di autori e di interpreti le-
zgati al destino di questi strumenti, Tale risultato
stato un passo ind
rensabile per metterci in
condizione di affrontare un primo studio razio-
nale di questa letteratura, consentendoci di at
tingere direttamente alle fonti originali quando
non ayremo la possibilita di avvalerci di auto-
revoli edizioni ctitiche moderne.
on queste due denomin:
ere tot li
cla, la cetera, Torphari
Un argomento cosi complesso richiederebbe
tuna Iunga introduzione di carattere storico, ma
considerando pitt urgente addentrarci immedia
tamente nella viva materia, eluderemo di propo-
sito cette premesse che in sede diversa sareb:
ero state necessaric. Non si tratreti quindi
accenno implicito dovra essere dato
in alcuni casi) dell’origi
Ie loro trasformazioni, ¢
(benché u
1¢ degli strumenti, del
io delle inta
volature, lasciando al lettore impegno di do-
cumentarsi personalmente. Dobbiamo invece
puntualizzare subito il tipo di scrittura adotta:
ta nei nostri esempi musicali. Noi considerere-
mo il liuto rinascimentale (un termine un po’
vago, che vuole per ora definire lo strumento
sato nel periodo cl
c va dai primi anni del
uecento alla meta circa del Seicento,
ando la
sua accordatura ¢ il numero delle corde subi
ranno numerose modifiche, per poi giungere al
cost detto liuto barocco accordato in re minore)
accordato in mi, con le not
pra i suoni reali
SS
Daremo volta a volta le indicazioni nevessa
sui bassi aggiunti ¢ la loro intonazione, cost co-
me parleremo al momento opportuno dellac
cordatura della chitarra ¢ degli altri strumenti
La nostra scrittura sara
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- Bicinia Sui 12 Modi Zarlino3Document27 pagesBicinia Sui 12 Modi Zarlino3fabyguitar6660No ratings yet
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- TANSMAN-Pieces Faciles PDFDocument12 pagesTANSMAN-Pieces Faciles PDFfabyguitar666080% (10)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- BACH Cello Suites For ViolinDocument45 pagesBACH Cello Suites For Violinfabyguitar6660100% (1)
- Liuto Gentile GarganoDocument2 pagesLiuto Gentile Garganofabyguitar6660No ratings yet
- Durighello PesachDocument3 pagesDurighello Pesachfabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Sehnsucht Nach OscarDocument1 pageAA. VV. Sehnsucht Nach Oscarfabyguitar6660No ratings yet
- SDL - ITA - Il Liuto - Numero18 - WebDocument48 pagesSDL - ITA - Il Liuto - Numero18 - Webfabyguitar6660No ratings yet
- Bottesini-Carulli Cavatina Dall'op. Andronico Di MercadanteDocument4 pagesBottesini-Carulli Cavatina Dall'op. Andronico Di Mercadantefabyguitar6660No ratings yet
- Calegari Sonata Op8Document7 pagesCalegari Sonata Op8fabyguitar6660No ratings yet
- De Selma, Fantasia Sobre El Canto Del CaballeroDocument3 pagesDe Selma, Fantasia Sobre El Canto Del Caballerofabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Journal Fur Gesange Und GuitarreDocument4 pagesAA. VV. Journal Fur Gesange Und Guitarrefabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. RomanceDocument2 pagesAA. VV. Romancefabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Tiroler Alpenlieder n.2Document3 pagesAA. VV. Tiroler Alpenlieder n.2fabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Lied Des TrostesDocument1 pageAA. VV. Lied Des Trostesfabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 077Document56 pagesFronimo 077fabyguitar6660No ratings yet
- Gragnani, Duo Per 2 Chit Dedicati e CarulliDocument35 pagesGragnani, Duo Per 2 Chit Dedicati e Carullifabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Schweiz HeimwDocument3 pagesAA. VV. Schweiz Heimwfabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Aria FavoritaDocument3 pagesAA. VV. Aria Favoritafabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 071Document71 pagesFronimo 071fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 076Document64 pagesFronimo 076fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 073Document66 pagesFronimo 073fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 074Document67 pagesFronimo 074fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 064Document73 pagesFronimo 064fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 067Document64 pagesFronimo 067fabyguitar6660100% (1)
- Fronimo 070Document62 pagesFronimo 070fabyguitar6660100% (1)
- Fronimo 065Document60 pagesFronimo 065fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 066Document70 pagesFronimo 066fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 072Document68 pagesFronimo 072fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 063Document69 pagesFronimo 063fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 060Document59 pagesFronimo 060fabyguitar6660No ratings yet