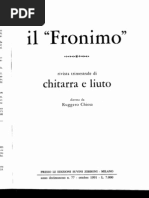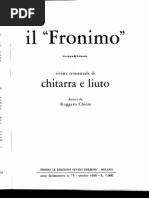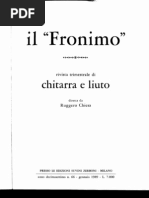Professional Documents
Culture Documents
Fronimo 002 PDF
Fronimo 002 PDF
Uploaded by
Jacopo Lazzaretti0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views31 pagesOriginal Title
Fronimo_002.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views31 pagesFronimo 002 PDF
Fronimo 002 PDF
Uploaded by
Jacopo LazzarettiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 31
fi
il “Fronimo’”
rivista trimestrale di
chitarra e liuto
diretta da
Ruggero Chiesa
PRESSO LE EDIZIONI SUVINI ZERBONI - MILANO
‘anno primo n. 2 - gennaio 1973 - L. 600
SOMMARIO 1
Incontri 3 Encounters
Intervista ad Andrés Segovia 3 Interview with Andrés Segovia
Aspetti della musica per chitarra Aspects of Guitar music of the Twentieth
del secolo XX di Angelo Gilardino 7 Century by Angelo Gilardino
Storia della letteratura del liuto History of the Literature of the Lute
e della chitarra di Ruggero Chiesa and Guitar by Ruggero Chiesa
II. II Cinquecento 11 II. The Sixteenth Century
Cenni sulle ricerche delle origini etniche Notes om research into the ethnic origins
della chitarra e del liuto of the Guitar and the Lute
di E, Fausto Ciurlo 16 by E. Fausto Ciurlo \
Stabilita morfologica 18 Invariant morphology
Principio della irreversibilita del meccanismo Principle of progressive complication, leading
di compliczione, che conduce gli strumenti the original instruments to increasingly com
originari a forme sempre pit complesse 18 plex forms y
Metodi di ricerca 18 Research methods
Deduzioni 22 Conclusions
Cronache di concorsi internazionali 25 Reports of International Competitions ‘
Recensioni 26 Reviews i
: Musica 26 Musie |
i Dischi 28 Recordings i
§
DIRETTORE RESPONSABILE: RUGGERO CHIESA
REDATTORE CAPO: SILVIO CERUTTL
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITA’: EDIZIONI SUVINI ZERBONI
: 20122 MILANO - CORSO EUROPA 5/7 - TEL, 794.841
i
IRITTE RISERVATE . ALL RIGHTS RESERVED - PRINTED IN ITALY
ZAZIONE: TRIBUNALE. DI_MILANO N. 331 DEL 13 SETTEMBRE 1972
ANOSCRITIT E FOTOGRAFIE ANCHE SE NON PUBBLICATI
NON VERRANNO RESTITUITI
UN NUMERO: ITALIA L. 609 - ESTERO 1. 800
BEONAMENTO ANNUO: ITALIA TL. 2000. ESTERO 1. 3.500
"TE VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE CCP 3/43859
NUMERT ARRETRATI DISPONIBILE L. 1.000
TORE ESCLUSIVO NELLE EDICOLE PER LITALIA A. & G. MARCO
VIA FORTEZZA 77 - 20126 MILANO - TEL. 2526
"0 DI STAMPARE NEL MESE DI GENNAIO 1973 CON I TIPI
DELL'ARCHETIPOGRAFIA DI MILANO
40
t
|
[
INCONTRI
Inrervista ap ANDRES SecoviA
N occasrone della sua recente tournée ita-
Tiana Andrés Segovia ha concesso un’inter-
vista a Silvio Cerut
S.C. Caro Maestro, grazie anzitutto della Sua
lettera, augurale per la nostra rivista. Essa co-
stituisce un'indicazione stimolante di cui tenia-
mo conto e che era all’origine della nascita del
la rivista stessa. Ora, noi, € soprattutto i no-
stri lettori, vorremmo conoscere le Sue idee
fondamentali sui problemi della chitarra. Ma
la prima domanda, che sorge spontanea, 2 la se
guente: qual 2 il segreto di questa vitalita, di
questa eterna giovinezza d’uomo e di music:
sta, che si manifesta nelle Sue esecuzioni?
AS.: Ebbene, credo Vorigine della mia vitalita
risieda nei miei antenati piuttosto che in me
stesso, In seguito ho constatato Ja validita del
principio che Pacqua tranquilla e quieta & mar-
cia, mentre l'acqua che corre e si muove @ sem
pre giovane, Guardate il mare: & sempre in
movimento eppure sulla sua superficie non
compete una sola ruga. II lavoro & naturalmen-
te inseparabile dai doni ricevuti dal cielo. Se
tuna semente non viene concimata & sterile, bi
sogna coltivarla perché possa sbocciare, cresce
te © conseguire il suo destino, divenire ciot
fore e poi frutto. Essendo il lavoro inseparabi-
le dalla tecnica, bisogna essere anche dotati di
una forza di volonta che porti alla vittoria sulle
difficoltA che comporta lo strumento. Anche
avendo, come me, una lunga esperienza — que-
3
sto @ il sessantatreesimo anno della mia attivi
tA concertistica! — bisogna tener presente la
parabola di Giacobbe: gli angeli salivano e
scendevano per la celebre scala, gradino per
gradino, benché avessero Ie ali!
S.C.: Oggi, molti giovani chitarristi dimostra-
no alte qualita tecniche e d’interpretazione, ma
quelli che si accostano alla Sua meravigliosa
trasparenza di suono sono pochi ¢ rimangono
ancora lontani dalla qualita di quel suono, Mae-
stro. Questo dipende da una dote personale 0
da un lavoro tecnico affatto particolare, oppu-
re da un apprendistato d’eccezione?
A.S.: Dipende da tre cose. Anzitutto dalla sen-
sibilita con cui si ascolta il proprio suono, sen-
sibilita ch’e essenziale affinché il lavoro di ti-
cerca passa essere realizzato appieno. Se non
si possiede questa sensibilita, che costituisce,
per cos{ dire, la fisionomia dell’artista, quel
lavoro 2 perd inutile. Poi @ importante la qua-
lita delle unghie, che non dovrebbero essere né
troppo molli, perché non si rompano, né trop-
po dure, affinché i suoni non risultino sgrade
voli. Infine credo occorra tener conto del-
la qualita oggettiva dello strumento. Bisogna
saperlo scegliere.
$.C.: Lei ha lasciato dietro di sé una celebre
scuola d’interprelazione che conta nomi ormai
celebri. Lei ba lasciato un'impronta di gusto e
di stile, ma noi abbiamo Vimpressione cbe cid
che manca effettivamente sia un testo, delle in.
dicazioni precise, universali, che garantiscano
una veritd didattica unica, che consentano di
evitare gli equivoci tecnici che sono presenti
anche in scuole magari avanzate dal punto di
vista musicale. Non pensa anche Lei che cid
che manca sia un lavoro teorico, una specie di
decalogo di cui non si possa piti fare a meno do-
po la sua apparizione?
AS.: Si, perd quello che voglio dire & questo:
ig non ho avuto molti compiti da svolgere, per-
ché sono stato, per tutta la vita, « il mio pro-
fessore e il mio allievo ad un tempo ». Ecco
perché non ci sono stati troppi bisticci tra i
due! Comunque credo si tratti di un problema
affatto personale. Quel che V'insegnante deve
4
fare & abbreviate il cammino dell’apprendista
10; quello che non pud fare & fornire il combu:
stibile per il fuoco sacro dellallievo. Tuttavia
il maestro impara dal discepolo almeno quanto
il discepolo dal maestro. Ecco un concetto che
bisognerebbe diffondere in tutte le classi, non
solo di chitarra, ma di ogni strumento musi-
cale, anzi pti in generale nel campo della didat-
tica cotrente. Bernard Shaw ricorreva ad una
boutade che contiene insieme un po’ di menzo:
gna ma anche una grande veriti: colui che sa
fa, colui che non sa insegna.
S.C: Lei ha fatto come Bach, @ stato professo
re e allievo di se stesso, si tratta perd di una si-
tuazione eccezionale, consentita ad una perso-
nalitd eccezionale come Lei. Ma tutti gli altri,
tutti gli allievi che si trovano in condizioni
mali di tirocinio?
AS.: Tutti hanno avuto professori. E se io
non li ho avuti direttamente, ho perd guardato,
tutto cid che avveniva intorno a me, ho cercato,
per la chitarra, i maestri del passato, Ho osser-
vato come facevano per ottenere lo sviluppo
elastico delle dita della mano destra e della ma-
no sinistra. Mi sono anche servito di metodi,
benché purtroppo i metodi per chitarra non
siano né troppo numerosi né troppo buoni. Mi
sono aiutato allora con metodi scritti per altri
strumenti, perché lo scopo era lo stesso: svi-
luppare Ia forza, la celeritt e Vindipendenza
delle dita. Cosf a volte prendevo studi per pia-
noforte e li trasportavo per la chitarra e questo
mi serviva egregiamente.
S.C.: La cbitarra offre molte possibilita come
strumento d’insieme nella musica da camera.
E d'accordo con noi su questo punto, oppure
pensa che la natura dello strumento sia essen:
zialmente solista?
AS. Da un punto di vista “spagnolo”, credo
che la chitarra sia per sua natura profonds
mente “solista”. Uno dei miei migliori amici -
% anche uno dei pid grandi scrittori d’oggi
~ Salvador de Madariaga, ha detto una volta
che lo spagnolo ha un’individualita talmente ric.
ca che possiede in se stesso tutta una societa
Ecco perché ha scelto la chitarra che offre la pos-
sibilita della polifonia ed @ quindi un’orchestra
in se stessa. Se ne pud dedurre — e questo
molto utile per la domanda che Lei mi pone —
quanto segue: la chitarra & polifonica ¢ nello
stesso tempo & molto ricca di colore, di timbri;
se la si accosta ad un’orchestra, anche piccola,
alla presenza reale dell’oboe, del auto, degli al-
tri strumenti ai quali la ricchezza di timbri del-
Ia chitarra fa allusione, essa si trova comple-
tamente disarmata. Perché la chitarra solamen-
te allude a questi timbri, se li avesse in sé, sa-
rebbe affatio perduta, Deve quindi rifugiarsi
nella omogeneitd sonora.
S.C: Maestro, Lei ba rivalutato la chitarra,
rendendole la sua dignita di strumento solista,
grazie alla sua eccezionale personalita d’artista e
Ginterprete, cioe ba scoperto delle possibilita
che lo strumento aveva in se stesso. Secondo
Lei, in che consiste il segreto fascino, lo charme
della chitarra?
AS.: Potrei spiegarmi con una specie di leg.
genda. Apollo inseguiva una ninfa, naturalmen-
te molto bella; siccome era galante, le disse:
ti prego, non affannarti a correre, perché ti
prometto di non superarti >. Riuscf allora a
prenderla fra le braccia e a stringerla a sé. La
ninfa invocd suo padre, ch’era un demiurgo, ¢
questi Ia converti in una pianta di alloro. Eeco
perché il lauro @ divenuto da allora in poi il sim
bolo della ricompensa del talento, della poesia
della musica, ece. ece. Si pretende anche che
Apollo abbia tratto da quell’albero mitico la
prima chitarra, 0 il primo strumento con una
forma simile a quella della chitarra. Ma prima
di tutto quellalbero era una ninfa, era una fem
mina. La chitarra ne ha conservato la forma,
ecco perché 2 tanto tenera, tanto dolce, ma an
che un po’ isterica
SC: Grazie alle Sue esecuzioni, molti compo
sitori sono stati indotti a scrivere per la chitar
ra. Fra questi numerosi musicisti, quali, se-
condo Lei, sono arrivati a cogliere meglio Io
spirito pit vero e profondo dello strumento?
E perché?
AS. Se Le rispondessi sinceramente sarebbe
una mancanza di educazione verso tutti i com:
positori che non potrei nominare! Dird quindi
che tutti hanno capito molto bene e di conse-
guenza hanno scritto molto bene. Quando un
compositore sente per la prima volta una delle
sue opere eseguite sulla chitarra non sa piti fer-
marsi, non sa pitt tralasciare il comporre per
questo strumento. La prova l'ha offerta Castel-
nuovo-Tedesco che, dopo il primo, ha sctitto
non so piti se centocinquanta 0 duecento pezzi
per chitarra, Ponce, un compositore ammirevo-
le, anche se non 2 ancora abbastanza conosciuto
nelle sue opere sinfoniche, ha fatto la stessa co-
sa e ha lasciato, ripeto, opere miabili, Torro-
ba, de Falla, Turina, eee. ecc., Tansman, che
ha scritto molto anche per me. Infine, lo char-
me della chitarra consiste nella sua natura, &
cio& uno strumento che Stravinsky definiva in
questo senso dicendomi: «la Sua chitarra
non suona forte, ma lontano ». Il che & esatto:
tun piccolo accordo armonico tiempie una sala
di quattromila persone e questa esperienza I’ho
fatta a Londra, alla Royal Festival Hall, dove
suono sempre, la cui capienza 2 quattromila
persone, Ma anche in America del Notd, in
tanti centri artistici, purché intorno alla chi
tarra ci sia il silenzio. La sua sonorita penetra
grandi lontananze.
S.C: Oggi assistiamo alla rivatutazione della
antica musica scritta per la chitarra, la vibuela,
il liuto. A proposito di quest’ultimo stramen:
to, i lintisti attuali torcon la bocca quando si
parla della possibilita di suonare la musica an-
tica sulla chitarra. Si tratta di un falso proble
ma, 0 no?
AS.: Mio caro, Le dird che hanno completa-
mente torto, perché i] liuto & uno strumento
che ad un certo momento 2 scomparso dalla
scena musicale, mentre la chitarra & stata sem-
pre ed & uno strumento vivo. Da un canto la
duplicazione delle corde nel liuto rende la tec-
nica un po’ piti maldestra che sulla chitarra, la
quale ha una corda sola, e questo 2 evidente di
per sé. L’aggiunta della seconda corda al liuto
& stata fatta a causa della povera sonorita che
Jo strumento possedeva. A tale proposito vo-
slio ricordare quanto dicevo a Wanda Landow-
ska, per farla arrabbiare: « il clavicembalo, mia
cara, & come una chitarra raffreddata! » E cost
5
aggiungo che la musica per liuto trasportata
sulla chitarra riprende tutta la sua vitalita, Pre-
ferisco, ad esempio, brani di Couperin, di Ales-
sandro 0 Domenico Scarlatti eseguiti da un
grande pianista su un magnifico Steinway, piut.
tosto che su un piccolo clavicembalo con la sua
sonorita nasale e affatto metallica. E evidente,
nevvero? Che differenza!
S.C: Qual é il consiglio. principale che Lei da
ai giovani interpreti?
AS.: Ai giovani allievi consiglio sempre di al-
Jontanarsi dalla chitarra piuttosto che dalla mu
sica, La musica 2 come POceano, gli strumenti
sono come isole, di diversa grandezza, piti bel
Je, men belle, pti ricche di alberi e fiori, oppu-
re pit aride, ma pur sempre isole: 1a cosa im-
portante & la musica. Ne consegue che i chitar:
risti devono assolutamente evitare di sentirsi in
condizioni Pinferioriti di fronte agli altri stru
mentisti, Ad esempio, gli orchestrali hanno la-
votato seriamente col loro strumento, hanno
studiato, hanno aspirato a diventare grandi so-
listi, grandi musicisti, ecc. Se non hanno po-
tuto, il loro lavoro & perd molto nobile © quasi
mai un chitarrista si trova ad essere inferiore
aun qualsiasi altro musicista d'orchestra.
S.C: Quali sono i pericoli che i giovani debbo-
no soprattutto evitare?
AS.: 1 cattivi professori
S.C. Qual 2 Videale, se vuole, che i giovani
debbono considerare come fine supremo dell’in
lerpretazione?
AS. B molto difficile, molto complicato ri
spondere a questa domanda, perché linterpre-
tazione non deve essere una cosa rigida. Per
esempio, tempo addietro, Vinterpretazione tc-
desca di Bach era concentrata in questa frase,
che mi ha fatto sempre estremamente artabbia-
re: una buona interpretazione di Bach & quella
in cui il pubblico, gli ascoltatori insomma, s
annoiano. Allora interpretare Vopera di un
grande, che & Himalaya della musica, ma che
nello stesso tempo aveva ventitré bambini, co-
me una marcia militare, mi pare sia completa-
6
mente idiota! Bisogna non cadere nella stan-
chezza, nella mollezza, ¢ nel contempo vitaliz-
vate Pinterpretazione. E il solo modo di atti
varci pienamente, da parte dello strumentista,
% quello di avere una nobile sensibiliti morale
€ conoscenze superior.
S.C: Maestro, non bo piti domande da porLe,
anche se il mio desiderio sarebbe quello di ri-
‘manere qui a parlare con lei sino a domattina,
perché questo colloquio 2 inebriante, & come
bere del vin di Spagna! Ma vorrei che dicesse
ora lei qualcosa spontaneamente, ad esempio
sugli interpreti, sui compositori, sui musico-
logi
AS.: Si, purché i musicologi non siano sol-
tanto musicologi, ma anche musicisti!
S.C.: Infatti, « per essere buoni musicologi non
2 necessario essere cattivi musicisti »!
AS. No, credo che la musica, meglio, la mu:
sa della musica, possa largire i suoi favori anche
ai musicologi. Assai meno ai ctitici! Ecco vor-
rei dire qualche parola a proposito dei miei al:
lievi, Ne ho avati alcuni che hanno fatto una
splendida carriera, per esempio John Williams;
in seguito un ragazzo californiano che si chiama
Christopher Parkening, e poi naturalmente Ali
tio Diaz, che si & imposto come magnifico con-
cettista. Debbo poi menzionare un allievo che
hha studiato con me a Siena € che ha scelto la
storia della musica, pur essendo un brillante in-
terprete © strumentista, cio& Ruggero Chiesa.
C8 anche un altro grande allievo, Oscar Ghi
glia, ¢ poi un giovane, che si chiama Guglielmo
Fierens ¢ che mi ha telefonato poco fa. E ve
rnuto alla mia investitura a Oxford, quando mi
han dato la laurea honoris causa in quella ce-
lebre universita. Era 1a, mi ha fatto piacere
vederlo. C’ infine Alvaro Company, musicista
di gtande talento ¢ di probita artistica straor-
dinaria. E debbo dire qualcosa anche di un al
tro allievo, José Tomés, al quale ho lasciato
Ja mia classe di Santiago de Compostela duran-
te le mie assenze. Lavora If, in modo mirabile,
e anche ad Alicante, ove si & stabilito con la
famiglia, presso il Conservatorio Oscar Espla
— ORO
scommpntonns tee
ASPETTI DELLA MUSICA
PER CHITARRA
DEL SECOLO XX
Us remmanmerace ference, ditngue
Ja musica contemporanea per chitarra da
quella composta nei secoli precedenti; fino
a Manuel de Falla, infatti, furono i chitarristi
(in misura quasi esclusiva) a sctivere per il lo-
0 strumento, entre, da de Falla in poi, la
chitarra @ divenuta un mezzo comune di espres-
sione per tutti i compositori — indipendente-
mente dal loro grado di conoscenza diretta del
lo strumento. Le pagine di piti alto valore mu-
sicale composte per chitarra dal 1930 in poi,
sono dovute a compositori che non hanno mai
imbracciato lo strumento, eccettuato, forse, i
solo Villa-Lobos.
Con il verificarsi di questo fenomeno, la chi-
tarra @ entrata a far parte diretta della vicenda
musicale contemporanea, laddove, nei secoli
precedenti, questo strumento esprimeva musi-
ca di seconda mano (nessuno, infatti, tra i chi-
tatristi-compositori, ebbe personalit creativa
autenticamente propria, ¢ tutti si limitarono ad
esprimere, in brillanti realizzazioni strumenti-
stiche, il risultato della loro assimilazione del
linguaggio di maestri come Mozart, Haydn,
Beethoven e finanche Rossini, il cui influsso sul-
la musica per chitarra di Giuliani ® evidenti
simo); Vorizzonte della letteratura per chitarra
si 2 cosi positivamente ampliato ed approfon-
dito, arricchendosi di quei requisiti di autenti
cit di cui, prima, aveva beneficiato soltanto
incidentalmente. In un certo senso, il nostro
secolo ha conferito alla chitarra un carattere
non dissimile da quello che il liuto ebbe a ri
stire nel rinascimento ¢ nel primo periodo del:
Petd barocca, quando esso divideva con altri
strumenti il favore e l'attenzione continua dei
compositor
E tuttavia singolare il fatto che la chitarra,
emergendo rapidamente dall’anonimato del di
lettantismo e della sottocultura musicale, ab-
bia potuto di colpo interessare categorie’ cosi
diverse disparate di compositori: dal neo:
classicismo alle avanguardie (ci sia concesso
Fuso di questi termini solamente per comoditi
di discorso), tutte le posizioni linguistiche ed
estetiche dei compositori del nostro tempo han-
no trovato nella chitarra qualeosa che faceva al
caso loro. Ecco dungue delinearsi le angola-
ioni differenziate dalle quali la chitarra & sta-
ta scoperta, studiata ed adoperata, molto spes-
so con originalitd ¢ padronanza.
Frank Martin se ne servito per rievocare,
nei termini della sua pensosa spiritualita e
delle sue scelte stilistiche, un clima preziosa
mente arcaico; Castelnuovo-Tedesco ¢ Tansman
hanno sviluppato, dai rispettivi punti di vista,
alcune “qualita” di composizione chitarristica
gid trattate dai chitazristi-compositori (la me
Jodia accompagnata, varie forme contrappunti
stiche, le sequenze di accordi, il pedale, ecc.
tuttavia, mentre i chitarristi-compositori del
passato adoperavano quegli elementi sulla base
della loro limitata esperienza compositiva, Ca.
stelnuovo-Tedesco e Tansman hanno tentato,
con successo, di portare sulla chitarra Ia loro
esperienza di costruttori e di orchestratori, sin-
tetizzando entro un limite monostrumentale la
loro provenienza da esercitazioni pitt analitica-
7
mente complesse, come Vorchestra, il pianofor-
te, le formazioni da camera); anche se, tutto
sommato, nella loro musica per chitarra non
¢® nulla di particolarmente nuovo nel modo
i impiegare le risorse dello strumento, il gra
do di responsabilita con il quale essi scrivono
per chitarra @ infinitamente superiore a quel:
To dei chitarristicompositori, i quali appaiono
coggi come dei semplici calligrafi, cio dei for-
ti di modelli di scrittura chitarristica, sui
quali i compositori hanno poi innestato i carat-
teri autentici della loro personalita
Castelnuovo-Tedesco e Tansman sono i com
positori che pitt efficacemente hanno contrib
to a fare della chitarra uno strumento “classi
co”: la limitatezza dei mezzi loro offerti dallo
strumento li ha indotti ad una ricerca formale
in cui Pessenzialita e 1a stringata incisiviti del
materiale tematico, cost come {a calcolata di
stribuzione degli sviluppi e Tuso del colore
strumentale, hanno dato luogo ad un risultato
complessivo che s'iscrive nel solco del pid puro
dlassicismo, Con loro, molti altri musicisti han-
no lavorato con gli stessi intenti ¢ nella stessa
direzione, tuttavia la loro scelta neoclassica ap.
pare spesso pit un atto di complicit scoperta
con le fonti della musica popolare che il risul
tato di un processo di maturazione stilistica;
pet molti di questi maestri, sarebbe pit esatto
parlare di un neofolclorismo decisamente in
ritardo rispetto agli esempi di de Falla, Bartdk
€ dello stesso Villa-Lobos.
Tl caso di Villa-Lobos pud essere preso co-
me un esempio anomalo (ed eccezionalmente
interessante) della combinazione tra elementi
geniali di invenzione e limitatissime capacit’
nella tecnica compositiva — combinazione risol-
tasi in un fortunato acquisto per Ia letteratura
chitarristica. Villa-Lobos, come & stato sottoli-
neato da alcuni suoi critici, si @ quasi sempre
petduto nel Tussureggiante guazzabuglio dei
suoi poemi sinfonici, nascondendo, sotto il rim.
bombo di apocalittiche sonorita, la sua incapa-
cita di sottomettere il materiale al controllo
della volonta ed al dominio della forma (che
egli abbia scelto di assomigliare « ai fiumi del
Brasile », 2 un poco inverosimile: c’é chi sostie-
ne che, nonostante le sue Bachianas brasileiras,
a Villa-Lobos sia mancato proprio l’elemento
bachiano, e che egli, in realta, abbia pensato a
8
Bach senza mai potersi districare dalla giun-
gla); la sua passione per la chitarra, per con.
tro, lo sollecitava ad un tipo di scelte affatto
opposto, ciot verso la necessita di forgiare te-
mi chiari, brevi, di facile impressione, e di svi
Jupparli con coerente pulizia ~ senza peraltro
soffocare le prepotenti esigenze della sua inven-
tiva, In questa sorta di conflitto sta il segreto
della forte produzione chitarristica del maestro
brasiliano: i limiti della chitarra gli impedirono
di perdersi negli oceani in cui egli amava avven
turarsi scrivendo per grandi formazioni, ma
non gli impedirono di dire quanto egli poteva
dire, senza cessare di essere se stesso: Villa
Lobos, osserva Bream, « ha fatto grande il suo:
no della chitarra »; si potrebbe aggiungere che
la chitarra ha costretto Villa-Lobos a farsi pic
colo, e questa @ stata la fortuna di entrambi ~
fortuna in parte gid compromessa quando,
uscendo dalla forma breve del Preludio ¢ dello
Studio, Villa-Lobos tenta d’immergere a. chi
tarra nel dialogo con Vorchestea: i riferiamo
allinfelice Concerto.
Mente atticchisce il suo repertorio nell’ap
porto di questi compositori (e ad essi si po
trebbero naturalmente aggiungere molti altri
nomi, da quelli decisamente legati alla tradi-
ionale elaborazione di elementi_ folcloristici,
come Rodrigo, Torroba, Turina, Bacarisse, Pe-
deell, a quelli di maestri che equilibrarono i det
tami delle forme derivate dai classici con i ca
ratteri di un linguaggio pid altamente meditato
¢ personale, come Ponce, Santérsola, Berkeley),
la chitarra riceve V'attenzione di musicisti at-
tenti sia all’influenza del passato sia alle solle-
citazioni del presente — e tra tutti spicca il no-
me di Britten, il cui Nocturnal rappresenta cet
to uno dei cardini della moderna letteratura per
chitarra; non solo, essa solleva V'interesse di
musicisti la cui posizione e Ia cui opera sono in
aperta polemica con il neo-classicismo. E ovvio
che Pangolazione dalla quale questi composito-
ri scoprono ed impiegano Ia chitarra sia del
tutto diversa, Si direbbe, a questo riguardo,
che le risorse dello strumento siano pressoché
inesauribili, poiché, da Hans Werner Henze a
Sylvano Bussotti, da Ernst Krenek a Karlheinz
Stockhausen, da Goffredo Petrassi a Peter Max-
well-Davies, ognuno conferisce alla chitarra un
ruolo diverso © particolare: chi si afida allo
strumento prevalentemente in funzione della
sua timbrica, chi lo sfrutta per raffinati sottin
tesi polifonici dissimulati in apparenti forme
monodiche, chi tratta la vibrazione nella sua
incerta durata come un elemento aleatorio cui
affidare aggregazioni sonore restituibili, di volta
in volta, con quel margine di casualita che co-
stituisce uno dei chiodi fissi di molta musica
i ogg
Sotto questo aspetto, occorre sottolinear
come la chitarra ed i chitarristi (al livello pitt
progredito, sjintende) si siano avvantaggiati
della polemica in atto tra le diverse “tenden
ze” musicali, e come anzi questa polemica sia
risultata stimolante nei confronti della maturith
di una generazione di interpreti (almeno dal
1960 in poi): Ja figura del chitarrista sorda-
mente legato ad un limite linguistico — o mage-
ri impegnato in anacronistiche ed intolleranti
cavalcate contro i compositori che operano al
di fuori di un certo “sistema” — appare oggi
pateticamente superata dallefficiente imparzia
lita di chi sa eseguire, nell’ambito dello stesso
programma, una Invocazione e danza di Ro-
drigo (Ia quale potrebbe benissimo essere stata
scritta nel 1910) e i Drei Tentos di Hans Wer
net Henze: alla fine, le responsabilitd dellin
texprete sono principalmente quelle di propor:
re la musica esistente, cosi come essa esiste, €
non di scrivere Ia storia della. musica
Ma, con il diffondersi delVinteresse per a
chitarza tra i compositori, l'interprete moderno
@ stato chiamato anche ad un altro tipo di la
voro, che ha contribuito notevolmente all’evo-
luzione della sua personaliti musicale: quello
della collaborazione con il compositore, prima
dell'esecuzione vera ¢ propria del brano; que.
sto lavoro si colloca nel momento in cui il com-
positore (normalmente poco istruito sul labirin-
to chitarristico, anche se in possesso di una
“proporzione” assorbita nell’ascolto dei concer.
ti di chitarra, delle esecuzioni discografiche
auspicabilmente non fuorviato dalle superficia-
li istruzioni contenute sulla chitarra nei ma-
nuali di stramentazione in genere) realizza i
primi abbozei del suo brano per chitarra. A
questo punto (e non dopo, come molti riten-
gono) il chitarrista & chiamato ad assolvere al
compito di guidare il compositore, non soltan:
to spiegandogli come e fin dove quanto egli ha
abbozzato sia praticamente realizzabile, ma so-
prattutto fornendogli idee, alternative, sugge:
rimenti, in modo da indirizzarlo positivamente
verso la concretizzazione di quegli elementi che
vivono sempre — spesso in forma latente — nei
progeiti di un autore (condizionati perd dal
dubbio ¢ dalle titubanze). Superato questo pun-
to, si verifica spesso un’inversione di rapporti;
il compositore, entrato in possesso della chiave
che regola le vicende del gioco chitarristico (al-
meno, nell’accezione che a lui interessa), ¢ ri-
‘manendo nel contempo immune dal condiziona-
mento cui & inevitabilmente sottoposto lo stru-
mentista, riesce spesso a creare situazioni chi-
tarristiche nuove ed efficaci, soxprendenti per
lo stesso chitarrista: il fatto di poter osservare
e comandare il gioco, per cosi dire, dall’ester-
no, pone il compositore, una volta ambientatosi
nell’uso della terminologia chitarristica, in gra-
do di scoprire possibilita che il chitarrista tal-
volta non immagina.
Questa situazione si 2 verificata cosi larga
mente, nel nostro secolo, da obbligare i chi
tartisti pit capaci e sensibili ad operare una
vera e propria rivoluzione della loro tecnica, in
funzione della possibiliti di eseguire tutto il
repertorio contemporaneo, il quale richiede pre-
stazioni assolutamente inaccessibili allo. stru-
mentista formatosi secondo gli schemi della tec
nica scolastica ¢ sull'unica base della trattatisti-
cae della letteratura didattica dei chitarristi-
compositori. In questo senso, 2 necessario sot-
tolineare come la didattica chitarristica — nei
suoi valori medi ~ sia tuttora in forte ritardo
rispetto alle esigenze poste dalla pratica pro-
fessionale, la quale, correttamente intesa, deve
necessariamente porte in primo piano la musica
contemporanea. La situazione & talmente evi
dente che, non solo i chitarristi pid preparati,
ma gli stessi compositori se ne sono resi conto:
Stephen Dodgson, uno def musicisti inglesi pit
versati nella composizione per chitarra, ha rea-
lizzato, a monte delle sue musiche, una raccolta
di studi intesa a colmare il “gap” esistente tra
la letteratura didattica tradizionale ed ill mini-
mo di conoscenza necessatio per abbordare una
parte del repertorio contemporaneo; Dodgson
si 2 servito, naturalmente, della collaborazio-
ne di un chitarrista (Hector Quine), ed insieme
essi hanno creato una serie di studi i quali si
9
pongono il problema di normalizzare tutte quel-
Ie situazioni che il chitarrista “vecchio stam-
po” & portato a considerare anomale, irregolari,
antichitarristiche, quando non addirittura im-
possibili. Per compiere questo lavoro, Dodgson
ha scelto una quantita di situazioni problema:
tiche, dal punto di vista strumentale, prenden-
do come elemento di base della composizione
un “punto critico”: egli ha costruito Ia sostan
za musicale dei suoi studi (che, sia detto per
inciso, sono densi d'immaginazione e di ri
chezza frascologica) proprio 1a dove il chitarri-
sta medio cercherebbe la semplificazione di co-
modo e, non ttovandola, abbandonerebbe la
partita. Con questa raccolta di studi, Dodgson
ha iniziato la codificazione del passaggio. tra
due epoche: quella del chitarrismo ovvio, faci
lone, che chiudeva gli orizzonti della compo-
sizione e dellesecuzione entro una serie di
clichés preordinati, quella del chitarrismo pro-
fessionale, responsabile, proteso alla ricerca di
nuovi elementi linguistici ¢ cosciente del fatto
che questi gli possono pervenire soltanto dal
contatto sistematico con il mondo musicale e
con l’eliminazione dei limiti settari entro cui
chitacra ¢ chitarristi hanno vissuto per molto,
troppo tempo.
ANGELO GILARDINO
8 EIR
Po Pe RE Ee
eestor PR Ee
pr
Fuancesco Semiscino: Intabulatura de Lauto, Libro secondo, Recereare X, Fol. 55%, Pasis, Bibliotheque Nationale
10
STORIA DELLA LETTERATURA
DEL LIUTO
E DELLA CHITARRA
IL CINQUECENTO
I
A @REGOLA PER QUELLI CHE NON SANNO
CANTARE », contenuta all’inizio dei due li-
bri, rappresenta il primo documento pervenu-
toci sul sistema dell’intavolatura. Sappiamo co-
si che i dodici tasti del liuto di Spinacino erano
indicati da numeri (ma per eyitate confusione
gli ultimi tre erano scritti X, X e X) mentre lo
zero simboleggiava la corda a vuoto. Le figura-
zioni ritmiche, poste sopra Vesagramma raffi
gurante le sei corde dello strumento, con il can-
tino rivolto in basso, crano rappresentate dai
seguenti segni, che si ritroveranno in numero-
se edizioni italiane di musiche liutistiche fin
quasi allo scadere del secolo:
LORRF
Volendo assegnare loro un valore espresso
in notazione moderna, bastera stabilire una du-
rata convenzionale del primo segno e dimezza-
re gli altri, ad esempio:
od JD Hoppe wo d IS
Spinacino introduce poi delle figurezioni ir-
regolati dove, rifacendosi alla nostra prima i
terpretazione dei valori ritmici, si avra
[= PPP Cond e9) teens P= BP
V1 co TTD) out 141
Nella « Regola », infine, si avverte che i pun-
ti posti sotto i numeri si riferiscono al modo
di pizzicare le corde, cio® dal basso in alto. La
tecnica liutistica dell’epoca si avvaleva infatti,
nei passaggi monodici, dell’alternanza del pol
lice con V'indice, Le « botte in su» potevano
essere date anche con il medio ¢ Vanulare, ma &
probabile che in pratica T'esecutore adopetasse
soltanto Vindice, pit congeniale a questo tipo
di tecnica, mentre il pollice agiva sempre dal
alto in basso. Le corde del liuto (basso 0 con-
trabasso, bordone, tenore, mezzana o mezza-
nella, sottana o sottanella, canto}! non sono mai
nominate, forse perché erano talmente cono-
sciute da ritenere inutile elencarle. Non per
nulla Spinacino prevede in due occasioni (Lom
¢ bani ¢ La Mignonne) il « bordon descordato »
(commettendo una evidente distrazione, in
quanto si tratta della sesta, e non della quinta
corda) ma dimostrando cost di ritenere git ac-
quisita questa terminologia da parte del lettore.
Per la stessa ragione non vi 2 nessun accenno al-
Paltezza dei suoni e agli intervali esistenti tra le
corde, Ma se su questi ultimi non potevano esi-
stere dubbi, I'altezza doveva essere estrema-
mente variabile, sia a causa delle diverse di-
mensioni degli strumenti, sia per la difficolta
di poter disporre di una precisa fonte di into-
nazione. Tale problema rimarri insoluto per
lunghissimo tempo, e solo nel Seicento, quan-
do il liuto si troverd a confronto con altri stru-
1. Come & noto, i tre ordini pit grav erano raddoppiatt
alVortaya superior, il secondo el ter29 allunisono, raentze
canting era scempo,
uw
menti, si potra stabilire con maggior precisione
Ja sua accordatura,
Le opere di Spinacino, che costituiscono la
pietea di paragone per tutti i successivi sviluppi
della musica strumentale, comprendono compo-
sizioni originali e trascrizioni di brani polifo-
nici, vocali € strumentali.
Le composizioni originali portano tutte il ti
tolo di Recercare, un termine quanto mai ap.
propriato per definire V'intenzione dell’autore,
che aveva intuito perfettamente le reali possi-
bilita del liuto. Questo strumento, dove era
abbastanza facile produrre suoni simultanei,
non poteva sostenere in continuita intrecci com-
plicati di voci, sarebbe stato assurdo fargli
assumere un compito superiore alle proprie
forze. Spinacino, sfuggendo alla tentazione di
cedere a tutti i costi alla densita polifonica, co-
sf insita nella sensibilita del tempo, vide nel
liuto il mezzo ideale per conciliare ed alternare
passaggi melodici, armonici ¢ contrappuntistici,
Compiendo una indagine approfondita sulle sue
possibilita tecniche ¢ timbriche (da qui il signi-
ficato di “‘ricercare”) e svincolandosi dai mod
i formali delle opere vocali, egli riuset ad ad-
dentrarsi in un mondo sonoro con la pitt am-
pia liberta e a concepire la creazione musicale
in funzione esclusivamente strumentale. Questo
concetto si ritrovera in tutte le opere dei liutisti
italiani dei primi decenni del secolo, Dalza,
Bossinensis, Capirola, fino a giungere a France.
sco da Milano, nel quale gid si avverte la tra.
sformazione del ricercare in una severa impo-
stazione imitativa, articolata in episodi come
nel motetto vocale. La natura toccatistica in-
trodotta da Spinacino sari poi quasi comple-
tamente abbandonata verso la meta del Cinque-
cento (anche in Spagna, nonostante I’esempio
di Luys Milan) per rifugiarsi in pit rigid sche-
mi formali. La stessa varieta di figurazioni rit.
miche verra presto sostituita da un criterio di
semplice linearita
T ricercari di Spinacino si presentano come
composizioni completamente autonome, ma
non & escluso che in alcuni casi possano asso
vere una funzione preludiante. Ad esempio, il
Recercare de tous biens © il Recercare a Juli
amours sembrano destinati a precedere gli omo-
nimi brani vocali. Pochi anni pit: tardi Bossi:
nensis consacrd questo principio per i ricercar:
che intzoducevano le sue trascrizioni di frottole
per canto e liuto, ma dopo di lui tale formula
venne del tutto abbandonata, L’inizio delle
composizioni di Spinacino & spesso improntate
ad una libera esposizione monodica, come nel
Ricercare IV (I libro) dove la frase si evolve
dapprima senza alcun sostegno (il la della pri
ma battuta @ solo un breve rinforzo), poi con
Paggiunta di alcuni bassi, per tornare infine
alla semplice monodia ¢ ricadere sul mi. La ri
presa si svolge, in efficace contrasto, con un
andamento imitativo:
eaten
r
Un altro bellissimo esempio di melodia ini-
ziale, con una maggiore varieta negli intervalli
e che si conclude su ampi e solenni accordi, si
ritrova nel Ricercare XV? (I libro). Anche qui
a 20
F
re FTP re
la ripresa accenna a delle brevi imitazioni, al-
ternando passaggi di decime, intervallo che ri
cotte frequentemente nell’opera di Spinacino,
simultaneo 0 spezzato,
Cosi come avviene spesso all'inizio delle
composizioni, anche nelle parti finali le frasi
melodiche ritornano con insistenza e con ca-
rattere pit deciso, Il Ricercare II (I libro), ad
esempio, termina con una lunga cadenza in
cui, dopo un’ascesa per grado congiunto, av-
viene if ritorno verso il registro grave dappri-
2.11 primo volume dell'Antolosia di musice antice per
lito, vibuela €-cbitarra (te. R. Chiesa), Edizion! Suvini
* originale
ma attraverso una progressione che provoca
uno spostamento di accenti dal ritmo binario
a quello ternario. Poi un incalzare di terze spez-
zate conduce agli intervalli di nona e di setti-
‘ma, ¢ alla improvvisa conclusione su un ina:
spettato fulcro tonale:
Zesboni, Mileno 1969, contiene, oltre a questa composi.
ione, il Ricercare XITE (libro) e il Ricercare X (IT libro}.
B
Il Ricercare XV (I libro) contiene un finale 98, su un accordo che fa acquistare alla frase
Gi grande suggestione, dove un ininterrotto una vibrante intensit, mantenuta sino al trion-
melisma della voce supetiore sfocia, alla battuta _fante appoggio conclusivo sul modo maggiore:
#?
F
Le imitazioni non sono numerose, e appaio- _cellula sincopata, i vari registri del liuto, men-
no solo in alcuni episodi. Nel Ricercare XIII tre nel Ricercare VI (IT libro) si susseguono in
(L libro) esse interessano, sotto V'aspetto di una _progressione:
tid a i i
=@—
ame
4
Le successioni armoniche procedono sovente
a tre voci, e le modulazioni, quando si atten-
gono a schemi essenviali, rivelano gid un gusto
decisamente tonale:
Ricercare XI (I libro)
-
Anche quando Pandamento & limitato a due
voci, Spinacino riesce di frequente a creare un
z
perfetto equilibrio sonoro. L'inizio del Ricer-
care VII (I libro) ne & un bellissimo esempio:
Come si pud notare, i Ricercari non presen-
tano particolari complessita di costruzione ar
monica (I'epoca stessa lo eschideva) né con-
trappuntistica, ma si reggono tutti su un anda-
mento melodico, appoggiato discretamente da
bassi e da accordi, su semplici modulazioni, sul-
Vincisivité ritmica ¢ sul timbro strumentale.
Solo tenendo conto di tutto cid si potranno
evitare analisi semplicistiche, e afferrare la loro
vera sostanza. Una lettura affrettata di queste
composizioni’, come del resto di tutta l’opera
di Spinacino, potrebbe infatti condurre a dei
giudizi imprecisi sul loro contenuto artistico.
Nulla di pitt difficile 2 ricreare dentro di noi
Parmonia di un mondo cost lontano, dove gli
echi del Quattrocento si fondevano con la na-
scente sensibilita rinascimentale. Tuttavia, a
nostro parere, non tutti i Ricercari riescono a
mantenersi su un livello costante. Cette inge-
nuitd delautore (daltronde facilmente giusti-
ficabili) che dilatava oltre misura alcune ide
insignificanti, compiendo poi degli sbalzi espres-
sivi di una certa durezza, spezzano a volte Puni
1 psicologica dei brani, Ma dove tale unita 2
presente il valore & autentico e sincero: sari
compito dell'esecutore renderlo oggi evidente
attraverso una interpretazione estremamente
approfondita
Ruccero Cuigsa
(continua sul n, 3 della rivista nell’aprile 1973)
3. I Rese VII (I), amp, obisewna
ert e postiva tsformasione ie provociano uno
amento' delle barute: Tnisindo in Tevare atta la CO:
srrgine simica acaista up spent ben giveno di
‘Quello‘confuso € impreciso che st ha mantenendo la posi-
lone originale delle stanghette
ro
JON & LONTANO 11, TEMPO — il lettore non
N giovanissimo lo ricordera certamente — in
cui si riteneva conveniente far precedete i con.
certi di chitarra di qualche pretesa, da alcune
informazioni, recitate o diffuse con un volanti-
no, sulle antiche origini dello strumento, quasi
a restituire un po’ di prestigio e a richiamare
un po’ di attenzione in favore dello strumento
di Figaro, del sor Capanna ¢ del Barbapedana.
Queste iniziative non devono essere dimenti-
cate ed hanno un posto nell’evoluzione della
cultura musicale del nostro Paese, per cui, se
2 git un sollievo non ascoltare o non leggere
pid tali erratici e sbrigativi saggi di superficia-
lita, essi rimangono, tuttavia, argomento di ri-
flessione sul poco rigore dell’indagine storica e
morfologica di questo antichissimo strumento,
pure al lume della pid recente letteratura. F,
‘ovvio che ricerche di tal genere richiedono lar:
ga disponibilita di mezzi e di tempo per intra-
prendere’ viaggi nei paesi che furono culla delle
civilta piti antiche, per cercare, reperire, studia
re, interpretare, nelle sculture, raccolte nei mu-
sei, nei documenti, presso le biblioteche, i se
gni, le tracce delle origini che si ricercano, per
poi legarli insieme in successive ipotesi di un
tracciato e avvalorarle o respingerle, al ume
delle testimonianze parallele dei reperti di altti
paesi, sul filo della storia comune, fino a trac
ciate, o credere di poter tracciare con sulfficiente
attendibilita, un racconto logico e continuo che,
dai nostri giorni, ci riporti a 2000 ¢ pit anni
a.C. sul filo conduttore della chitarra
E, dunque, necessariamente, lontana dalla
mente di chi scrive questi appunti, 1a pretesa
di poter dire qualcosa di definitive nel campo
di queste ricerche, né il direttore del « Fro-
imo » ha presunto niente del genere nel ricki
16
CENNI SULLE RICERCHE DELLE
ORIGINI ETNICHE
DELLA CHITARRA E DEL LIUTO
detli. 1 saggi che leggiamo, nella letteratura no-
strana ¢ straniera, appartengono piti al campo
delle ipotesi che a quello storico ¢ rispecchiano,
‘quasi sempre, una sintesi personale delle poche
informazi e dei molti luoghi comuni che si
trovano in scritti precedenti. Per cui 2 piutto-
sto da affermarsi che ill campo delle indagini
sia ancora aperto e aspetti chi si senta animo
di esploraclo.
Nel novembre del ’68, venne annunciata, dal-
la rivista « Violo e Mestres » di $, Paolo, la
imminente pubblicazione di un lavoro di Isaias
Savio col titolo Origem e aspectos evolutivos
do violao. Non ebbi notizia del seguito. Nel-
Paprile del ’69, ebbi occasione di recensire, per
« Strumenti e Musica », uno degli studi piti re-
conti, firmato dai Prof. Michael Kasha ¢ E-F.
Watson dell’Universita di Stato in Florida, i
quale mi aveva colpito per Voriginalita della
impostazione e l'onesti delle ricerche e della
documentazione. Non mi & occorso di leggere,
dopo quello, nulla di altrettanto organico, per
cui a quel lavoro mi riferisco per offrire ai let-
tori del « Fronimo » il quadro, a mio parere,
pid aggiornato sulle origini della chitarra
del liuto, sulle loro migrazioni ed evoluzioni
morfologiche.
Ai due studiosi citati, il mondo dei cultori
della chitarra ¢ del liuto @ debitore, oltre che
di molti lavori sull’acustica applicata alla lute
ria e di interventi e suggerimenti sulla tecnica
costruttiva dei due strumenti, anche di una gal-
leria del suono, realizzata ed operante con uti-
lissimi risultati nell’esame della portanza delle
diverse “qualita” di onde sonore, sulla perdita
degli armonici alla distanza, etc. E doveroso ri-
conoscere che questo impianto, insieme con i
laboratori per l’analisi spettroscopica dei suoni,
i
\
{
}
5
we
costituiscono gli apporti principali che segnano
il progresso della tecnica liutaria del nostro se-
colo.
M. Kasha ed EF, Watson hanno preso le
mosse dalla definizione della chitarra, come
costante morfologica di stramento musicale: 1
A CORDE PIZZICATE; 2. A FONDO PIATTO; 3.
CON MANICO A TASTI; 4. A FORMA DI OTTO.
Una tale definizione sgombra subito il terre:
no da tutta la confusione creata dalla ricerca
di una relazione della chitarra con Ia lira e
con Ia cetra, greche e romane e, molti secoli
dopo, con la famiglia dei uti
Essi hanno, parallelamente alla definizione,
impiantato uno schema inteso a promuovere il
confronto razionale per la correlazione dei re-
petti e la critica delle ipotesi che scaturiscono,
via via, col progresso delle indagini. Tale sche-
ma risulta dall’incrocio dei sistemi di ricerca
inguistico, delle culture dei popoli, della con-
tiguita delle regioni, degli avvenimenti storici,
delle migrazioni) con taluni “principi guida”,
basati su verita acquisite, quali la stabilita dei
rapporti di accordatura, la lentezza delle modi-
ficazioni morfologiche, la tendenza, irreversibi
Ie, alla complicazione degli strumenti.
Non si pud fare a meno di riconoscere € am:
mirare la forza di questo impianto il quale, &
bene dirlo subito, prende le mosse dalla straor-
dinaria semplicita della chitarra moderna, per
non perderla mai di vista nel controllo dei ri-
sultai
Penso che possa tornare utile al lettore Pos.
servazione della rappresentazione grafica del
procedimento, come guida nella lettura del se
guito di queste note
RICERCHE
LINGUISTICHE
CONTIGUITA GEOGRAFICA
AVVENIMENTI STORICI
| conrronro cuLTuRE
STABILITA NEI
RAPPORTI DI
ACCORDATURA
Diamo un rapido sguardo critico ai
guida assunti dai nostzi studiosi.
‘pi
PRINCIPIO DELLA STABILITA DELL’ACCORDA.
‘TuRA
Non & una novi
|. Tl noto liutologo Curt
Sachs basd interamente su questo principio i
suoi studi sulla classificazione degli strumenti,
nella assegnazione alle diverse famiglie. Perso-
nalmente trovo razionale questo principio il
quale trae Ia sua origine dall’anatomia della ma-
no dell’uomo, in relazione con la dimensione
degli strumenti e quindi della lunghezza delle
corde. L’apertura della mano sinistra corrispon.
de, infatti, a un intervallo di quarta nei suoni di
una corda lunga circa 60 ./. 65 centimetri. Ne
segue una caratteristica fondamentale in tutti
ali strumenti a corda con manico a tasti, di po:
Co peso ¢ facile trasporto.
Troviamo infatti gli stessi rapporti di accor:
datura nel liuto rinascimentale e nella vihuela
spagnola della stessa epoca. I due strumenti
appartengono a due famiglie diverse e di di
versa origine storica. Essi sono tuttavia classi-
ficabili nel ramo degli strumenti con manico a
tasti, con corde pizzicate e ovviamente traspor-
tabili. Entrambi, infatti, sono montati con 6
ordini di corde, accordate per quarte, con una
terza maggiore interposta:
Sol Do Fa La Re Sol
IV IVm wv Iv
La chitarra spagnola, al principio del 1500,
ha quattro ordini di corde, che cortispondono
alle 4 corde intermedie della vihuela:
Do Fa La Re
IV It Iv
STABILITA IRREVERSIBIUITA
MORFOLOGICA DEL PRINCIPIO
DI COMPLICAZIONE
v7
Pit tardi le 4 corde verranno alzate di un
tono
Re Sol Si Mi
¢ tali rimarranno e sono rimaste dopo l’ag-
giunta della quinta , poi, della sesta corda,
La costante dei rapporti di accordatura tro-
va dunque conferma in cinque secoli di docu-
mentazione sicura,
STABILITA MORFOLOGICA
‘Come accennato in principio, questa “idea
guida” porta ad escludere qualsiasi parentela
della lira ¢ della cetra, romane e greche, con la
chitarra e con il liuto, Buna responsabilitA pe-
sante, perché viene a contrapporsi a posizioni
acquisite e largamente condivise, soprattutto
per la discendenza del liuto dalla cetra romana.
La posizione 2, tuttavia, ragionevole € trova
conferma nell’attenta considetazione dei reper-
ti archeologici. La lira e la cetra sono infatti
caratterizzate dalla loro cassa armonica, di for-
ma schematicamente quadrangolare, avvolgen
te, per tre lati, il corso delle corde e vente fun-
zione di struttura portante per resistere al tito
delle corde stesse, Il quadrilatero & chiuso dalla
barra trasversale per laccordatura. (Vale la pe-
na di osservare che Paccordatura con cosiffatto
sistema, postula l'uniformit’ della estensione
delle corde intonate. E questo un criterio che
troviamo conservato nella calibratura delle cor-
de degli strumenti moderni, nei quali, all'uni-
formita dell’estensione, corrisponde pure l'uni-
formita delle tensioni delle singole corde.) Non
ud, ragionevolmente, ammettersi che strumen-
ti di cosf caratteristica concezione evolvano,
nella loro struttura, altrimenti che con laggiun-
ta di altre corde al numero di quelle originarie e
con vatianti di forma, spessori e rapporti fra
le parti del quadrilatero della c.a. Appare quin-
di da escludersi Ja comparsa di un manico a
tasti, che si associa a tutt’altra concezione co-
struttiva e funzionale. Ed ecco che i reperti gr
fici ele sculture dell’eta romana certificano T'esi-
stenza di strumenti contemporanei e anche piti
antichi, della cetra € della lira, di morfologia
diversa e chiaramente assimilabile alla chitarra,
come definita al principio (strumenti a corde
pizzicate, con manico a tasti, tavola armonica di
legno, fondo piatto ¢ forma a otto).
18
Pure V'idea guida della stabilita morfologica
hha dunque trovato conferma e sposta decisa-
mente verso quest’ultima famiglia di strumen-
ti popolari, un ramo maestro, se non il ceppo,
dell’albero’genealogico del nostro strumento.
PRINCIPIO DELLA IRREVERSIBILITA DEL MEC-
CANISMO DI COMPLICAZIONE, CHE CONDUCE
GLI STRUMENTI ORIGINARI A FORME SEMPRE
PIG COMPLESSE
E questo il terzo dei principi guida adottati
da Kasha e Watson e si basa sull’osservazione
del costante susseguirsi delle iniziative dei co-
struttori, sollecitati dai suonatori, alla ricerca
dell’arricchimento dello strumento di nuove
possibilita espressive, tanto nell’estensione,
quanto nel yolume della voce, con l'aggiunta
di bassi potenti. II principio trova conferma
nelle rappresentazioni grafiche dei vari stru-
menti particolarmente in quelle numerosis-
sime della cetra, che si vede, alle origini, mon-
tata su 4 corde, per modificarsi, nell’epoca clas-
sica, in forme pit elaborate, a sostegno di 7 cor
de, e complicarsi sempre pid con Vaggiunta
progressiva di altre corde, in esemplari di un.
dici corde e fino a 20 corde, in tempi posteriori,
prima di avviarsi all'abbandono e alla scompar-
sa. (Non possiamo, infatti, configurare come
derivazioni della cetta le varie arpe che trova-
no documentazione storiografica in civilta pid
remote ¢ in paesi lontani, le quali corrispondo-
‘no, fino dalla loro concezione primitiva, a im-
postazione diversa.)
II principio della “irreversibilita” trova ap-
plicazione nella critica delPipotesi di una paren-
tela fra la cetra ¢ Ja chitarra e il liuto, ipotesi
alla quale si oppone negando Ia possibilita che
forme tanto elaborate e complesse abbiano po-
tuto sboccare nella linearita della chitarra, che
troviamo di modeste dimensioni ¢ montata su
sole 4 corde, al principio del medio evo.
‘METODI DI RICERCA
Ora faremo una corsa attraverso i metodi di
ricerca, nei quali si inquadra la funzione criti-
ca del principio guida testé accennato.
a) Indagine linguistica, Si tratta di un terreno
molto battuto, a motivo della facilita di appro-
I
i
t
ENS
fondire gli studi relativi consultando i testi di
cui dispone qualunque biblioteca di una certa
importanza. Prima dei nostri ricercatori, han-
no pubblicato memorie, su questo tipo di ri-
cerche, altri musicologi e particolarmente Curt
Sachs ¢ ne accenneremo in seguito, Il Kasha
orienta le sue ricerche in due direzioni: una
orientata sulle derivazioni della parola “Tar”
dellantico persiano e Paltra sulla parola “Ud”
dellarabo antico. La parola “tar” significa in-
variabilmente “corda” nel sanscrito e nelle an-
tiche lingue medio-orientali e ancora si conser-
idiom moderni persiani, bengali, urdi
indi, Col prefisso dei numeri cardinali, si for:
mano, nei medesimi idiomi, nomi di diversi
strumenti ancora in uso in quelle regioni. Cost
il “Do-Tar” 2 lo strumento con due corde del-
Lantica Persia e si pud ancora trovarne nel Tur-
estan e paesi limitrofi
Il Se-Tar @ Io strumento con 3 corde, pure
dell’antica Persia, dalla quale passa in India do-
ve si complicheri enormemente, fino ai giorni
nostri, conservando Vantico nome. In Indocina,
in Giappone e in Cina, ha conservato invece
le 3 corde originarie, insieme col nome “Se-
Tar”, che vediamo sopravvivere pure nel Pa
kistan, dove le corde sono 5. Ecco Pesempio di
un bell’incrocio del sistema della ricerca Tingui
stica col principio guida della costante morfo-
Togica
Sembra che, fra gli strumenti originari del-
Vantico mondo medio-orientale, sia esistito pu-
re un “Char-Tar”, a 4 corde, ma, a quanto
sctive il Kasha, non risulterebbe presente fra i
reperti storiografici dell’epoca. E qui vediamo
inclinare gli autori verso una teoria che punta
decisamente verso il Caucaso e i paesi dell’an-
tica storia del suo altipiano.
Tutti questi. strumenti, Do-Tar, Se-Tar,
Char-Tar, erano composti da una cassa di ri-
sonanza di modeste dimensioni (un teschio, un
guscio di tartaruga, una zucca segata a meta)
con un lungo manico applicato a sostegno del:
Te corde, fissate allaltro capo, al disotto della
cassa di risonanza. Su questa veniva tesa ¢ le-
gata una pelle di animale, disseccata, con fun-
zione di tavola armonica. L’applicazione del
manico risponde all’esigenza di potcr mettere
in vibrazione corde di lunghezza sufficiente a
produrre un volume di suono soddisfacente.
=
Tl complesso ‘‘cassa-manico” costituisce, co-
‘munque, una caratteristica fondamentale di
questi strumenti, che sono i piti antichi di cui
ci pervengano le immagini da epoche larga-
mente anteriori alla lira e alla cetra. Dalla Me-
sopotamia, dalla Persia e, poi, via via dalle al-
tre regioni del medio oriente e dell’oriente, le
innumerevoli raffigurazioni dei Se-tar ci perven-
gono accompagnate col nome generico di “Tam-
bur” (che vuol dite zucca). Da Tambur deriva
Tambura e poi Pandur e Pandura. Alcune di
queste Tambur vengono rappresentate come ri-
cavate da zucche della classica forma detta “del
pellegrino”, che presenta due espansioni, di cui,
quella inferiore, alquanto pit sviluppata del.
Paltra. Sono queste le rappresentazioni pid an-
tiche di strumenti che dichiarano apertamente
la forma a otto della chitarra,
Ancora in campo linguistico, sembra interes-
sante trovare il nome di “Kithara” nei mano-
scritti dell’antica Grecia, riferito a una primi
tiva lira a 4 corde, nel cui nome il permanere
della radice “Tar” porta a pensare ad una im-
portazione dello strumento dalla Persia 0 da
paesi vicini. Pare che gli Arabi si siano impa-
droniti dello strumento ¢ della parola greca,
che trasformarono in “Pithara” — parola in
cui @ immediato il rilievo della presenza della
radice “Tar” quanto del Teta greco (Th). Non
ci addentriamo in altri argomenti, perché ci
pare che quanto esposto basti per dare un’idea
del cammino seguito dai nostri ricercatori
per affermate la presenza della radice “Tar”
nel nome di “quitarra” che si trova nel latino
dei primi secoli dell’era volgare, ed & segno si-
curo della derivazione persiana-medio orienta-
Te dello strumento indicato con quel nome
Troppo facile e immediata, poi, Ia discendenza
dal nome di “quitarra” dei sostantivi moderni
che, in tutte le lingue neolatine e sassoni, si as-
segna al nostro strumento.
Veniamo, ora, alle detivazioni dall’arabo
“Ud”. Il vocabolo significa “ramo”. L’articolo
2 “AP” e cost “ALUd” vuol dire “il ramo”.
(Anche nellarabo modern). Non mancano
rappresentazioni grafiche, provenienti dall’an-
tica Arabia, di rami piegati ad arco dalla ten-
sione di una o pitt corde, imbracciati da uomi-
ni, accovacciati al suolo, in attitudine di accom-
pagnarsi nel canto. I significato di “ALUd” e
»
a considerazione di queste immagini hanno in-
dotto il Sachs a proclamare questo “‘tamo” co:
me precursore di tutti gli strumenti a corda
Quale sistema pit semplice pud immaginarsi
per mettere in tensione una corda allo scopo di
estrarne dei suoni? La metatesi, poi, operatasi
in Spagna di ALUd in La-Ud, ha aumentato la
confusione, fino a indurre taluni esegeti a di-
menticare che il Laud compare in Spagna come
strumento piuttosto tardivo, mentre si trova
nell’area mediterranea medio orientale soltan
to col sorgere dell’Islam, vale a dire molto tem-
po dopo le civilta dell’antico mondo Mesopo-
tamico-Caucasico. Per cui, la teoria, che lo
stesso Curt Sachs condivide, e secondo la quale
non solo dal “ramo” primitive, ma addirittura
dal liuto islamico sarebbero derivati tutti gli
strumenti a corda, a cominciare dalla chitarra
per finite al contrabbasso, risulta definitiva-
mente contraddetta dalla storia proprio di
quelle region nelle quali il liuto ebbe origine
sviluppo.
Liindagine linguistica sembra dunque con-
durte a due diverse sorgenti degli strumenti a
corda: Yuna Persiana, V'altra Araba, Sard com-
pito dell’indagine storica seguire, nel susseguir-
si dei secoli, le migrazioni dei popoli di quelle
due regioni, attraverso gli avvenimenti e lo svi-
Tuppo delle relazioni con i popoli vicini e lon
tani, per ritrovare le matrici degli strumenti
delle due diverse origini, nei diversi paesi del
VEuropa, al principio del medio evo.
b) Indagine archeologica-storica. Ci siamo trat-
tenuti alquanto nel capitolo dellindagine lin
guistica per date un’idea del sistema del con-
fronto — in questo caso — col principio guida
della costante morfologica. Tale confronto ha
consentito di definire la famiglia dei “Tar” ¢
quella degli “AI-Ud”, nelle rispettive sedi ori
ginarie. Abbiamo pure incontrato uno strumen-
to di forma a otto, come variante dei “Tar”
Non ci siamo tuttavia ancora incontrati con
alcuno strumento a fondo piatto, con il risulta-
to, fino a questo punto, di un’evidente Tacuna
nei confronti della matrice di quella che, col
E ovvio che Ia sostituzione della cupola con
un fondo piano ¢ della membrana che chiude
Ia cassa di risonanza, con una tavola di legno,
nonché il collegamento del fondo con la tavola
20
mediante fasce sottili di andamento curvilineo,
debba considerarsi come un gradino nella evo:
luzione dello strumento con manico, Infatt,
nei confronti dei “tambur”, fin qui considerati
si tichiede una tecnica costeuttiva alquanto pit
avanzata, anche se, al principio, il corpo della
c.a. risulta scavato in un solo blocco di legno.
Questo gradino definisce la “Gui-Tar” come un
“Tar”, con piano armonico di legno, cassa ar
monica sviluppata, fondo piatto e fasce di col
legamento del piano col fondo. La tecnica pit
avanzata risponde, a sua volta, a un grado di
csigenza musicale pit avanzato, per il quale ri
sultava insoddisfacente Vemissione sonora pte
cedente. Il tentative, poi, di riprodurre nel
legno la figura ingrandita della classica 2ucca
del pellegrino, pud far suppotre una preferen-
za verso questa forma, in confronto a quella
ovale e pud trovarsi, in parallelo con detta esi-
senza, all’origine della forma a 8 di questi stru
menti. Gli strumenti piti antichi, che rispon-
dono a questa nuova definizione, si trovano
nell'archeologia Ittita. Parallelamente, nell’ar-
cheologia Egizia e in quella Greca, Etrusca ¢
Romana, i ‘“Tar” evolvono seguendo la defini-
ione del “Tambur”, al quale si applica Ia tec-
nica, via via pit avanzata, fino a raggiungere —
dopo secoli — le forme elaborate e orate dei
liuti di Arabia.
La chitarra ittita @ il pid antico reperto ar-
cheologico e il piti notevole per la certezza della
sua indicazione e della conseguente interpreta-
zione. Si tratta di un grande bassorilievo in pie-
tra, che raffigura un ittita che suona Ia chitarra
La forma dello strumento, la sua posizione,
Vimpostazione delle mani del suonatore, tutto
2 sorprendentemente vicino alla rappresenta-
zione attuale di un suonatore di chitarra, Il re
perto ® conservato nel museo di Ankara, fu
tolto dalla porta della citta di Alaja-Huitk del-
Tantica Anatolia e risale all’anno 1.300
aC. circa,
Gli Ittiti appartenevano al gruppo linguist
co Indo-Europeo, che si trova alla base del
Sanscrito ¢ dell’Indo-Iraniano. Si pud, quindi,
legittimamente supporre che questo strumento
si chiamasse “Tar” se non Do-Tar o Char-Tar.
Non appare infatti del tutto chiaro dalla scul:
tura consunta, se le corde fossero quattro, co-
me tuttavia sembra doversi desumere dall's-
pertura della mano destra del suonatore. Lo
strumento corrisponde a tutti i canoni che de-
finiscono la morfologia della chitarra; lungo
manico, spianato ¢ con evidenti tracce dei ta
sti in rilievo, cassa armonica sviluppata, tavola
armonica collegata al fondo piatto da fasce di
andamento curvilineo, seguenti la forma a otto,
¢ fori armonici sulla tavola. La presenza di que-
sti fori sulla tavola e dei tasti sul manico, in-
sieme con lo sviluppo della cassa armonica, av-
icinano in modo sorprendente questo stru.
mento ittita, del secolo XTIT a.C., alla chitarra
che troviamo, nei paesi europei, al principio
del medio evo e, posteriormente, in Spagna,
raffigurata nelle Cantigas de Sancta Maria di
Alfonso el Sabio, come strumento di uso comu-
ne, in parallelo con Ja chitarra moresca, nel
secolo XIII dell’era volgare. La chitarra ittita
ba scavalcato, dunque, ventisei secoli di sto.
ria, mantenendo integre le proprie caratter
stiche; esempio mirabile dei valori umani rac
chiusi nella semplicita della sua struttura.
Pare che gli Ittiti provenissero dal di la del
Caueaso, E noto che conquistarono la Capa:
docia (Anatolia) nel secondo millennio a.C. Nel:
Parco di duemila anni con le innumerevoli gues
re fra i popoli del medio oriente, seguite da oc-
cupazioni militari e da infiltrazioni pacifiche,
si consolidd il terreno pitt fertile per la propa-
gazione della cultura dei singoli gruppi etni
di pari passo con gli scambi dei prodotti del
suolo e delle botteghe artigiane, Particolarmen:
te, fra gli Ititi e gli Egizi, si contano almeno
tre lunghe occupazioni Egiziane del territorio
ittita e altrettante degli Ittiti del territorio sulle
coste del mare, al seguito delle vittorie degli
uni e degli altri. Nei periodi di pace, i due po-
poli a contatto confondevano le reciproche co
noscenze, mentre 'espansione ittita raggiungeva
il Mediterraneo e quella di altri popoli si spin:
geva fino all’Eufrate e alla Giudea.
Lroceupazione romana d’Isracle, al tempo
dell”imperatore Tito, pud essere considerata co:
me il termine di questo ciclo, al quale suc:
detd quello dell’espansione romana in oriente
e in occidente, estendendo all’Asia e all’Euro-
pa il meccanismo di penetrazione dei costumi.
E in questo quadro storico che si deve con-
siderare con il maggior interesse la. presenza,
proprio all’inizio dell’era volgare, di una chitar-
ra a quattro corde in Roma, e cosi pure la dif-
fusione successiva in Europa di questo stru-
‘mento tanto simile alla chitarra ittita del secolo
XII a.
Diamo, ora, un rapido sguardo all’archeolo-
gia Egizia, Greca, Etrusca e Romana,
Ricchissima @ l’iconografia dell’antico Egit-
to: dipinti murali, graffiti, bassorilievi, statue
in pietra e in legno, ci tramandano forme e di
mensioni ed anche la struttura di strumenti
musicali da epoche anteriori al 2000 a.C., fino
al sorgere dell’Tslam, Questri strumenti hanno
tutti in comune un corpo ovaliforme di piccole
dimensioni, talvolta molto allungato, con fon-
do a cupola chiuso quasi sempre da una pelle
disseccata tesa e fissata intorno al bordo. Ne-
gli esemplari piti antichi, il manico & solamen
te introdotto nella pelle, attraverso due asole
€ fissato, al fondo, in una tasca ricavata da
tun risvolto della pelle stessa raddoppiata al
bordo inferiore. La tensione delle corde, dal
sommo del manico alla sua base, che & pure la
base dello strumento, & interamente soppor-
tata dal manico, mentre Ja cassa armonica risul-
ta in stato di riposo. In epoche posteriori, la
tecnica costruttiva si evolve progressivamen-
te quanto alla struttura, ma le caratteristiche
dello strumento simangono invariate rispetto
al paradigma primitivo. Molto tardi, intorno al
settimo secolo d.C., comparivano in Egitto i
nuovi clementi introdotti dagli Arabi con i
Tiuti, con la grande cassa armonica, il largo ma-
nico e Je altre caratteristiche che li differenzia-
no dalla linea degli strumenti egizi. Essi non
possono, dunque, considerarsi, in aleun modo,
derivati dalla Pandura, né in generale dai Tam-
bur che Pantico Egitto ha in comune con la
Persia e la Mesopotamia e che persistono, quasi
inalterati, negli stramenti popolari slavi e bal
canici (Tamburitza), indiani (Se-tar), turchi
(Sar) e greci (Butzuki), Il principio-guida della
costante morfologica riceve da questa persisten-
za una conferma indiscutibile, mentre induce a
considerare come una linea a sé stante e carat-
teristica questa dei Tambur. Come la famiglia
dei liuti, cost pure quella della chitarra & estra-
nea a questa genealogia, anche se compare nel-
Viconografia egizia, come prodotto d’importa-
zione ittita, al tempo della promiscuita dei due
popoli.
a
Ul materiale archeologico greco abbonda nel-
la rappresentazione delle arpe da grembo tanto
nella versione popolare della lira, quanto in
quella della cetra, riservata ai musicisti di pro-
fessione, E da rilevarsi, tuttavia, la contempo-
raneita della rappresentazione di queste arpe da
grembo con quella della Pandora, gi presente
nell’antica Grecia.
Tale contemporancit’, nelle rappresentazio-
ni e, quindi, nel costume, rende evidente, an-
cora una volta, Vindipendenza della linea dei
Tar, con manico, originari del Mediterraneo
sudorientale, da quella della lira e della cetra,
propria dei paesi del Mediterraneo settentrio-
nale e, nello stesso tempy, la forza di penetra-
zione dei Tar durante Ja civilizzazione precti-
stiana e i primi tempi del cristianesimo.
L’esemplare pid notevole di Pandura si tro-
va nel museo di Atene e porta la data del 300
aC. Il manico termina, in alto, in un ventaglio,
che fa pensare a una paletta destinata ad acco
licre i pioli per Paccordatura, anche se tali
pioli non si ravvisano. Le corde sono 3, piti pro-
babilmente 4. Il corpo é di piccola dimensione,
con spalle cuspidate, cui fa riscontro la base
triangolare. Tavola armonica lignea ¢ fori ar-
monic, fondo a cupola ribassata, completano la
fisionomia di questo strumento che assomiglia,
in modo sorprendente, alla tamburitza balcani-
ca dei nostri giorni
Il materiale archeologico efrusco-romano di-
mostra anch’esso Ja predominanza della lira
€ della cetra da grembo in forme sempre pit
elaborate ¢ complesse. Tuttavia, piti frequen-
temente che nei reperti greci, si trova rappre-
sentata la Tambura, esponente della serie dei
Tar, soprattutto dopo il 300 d.C. Numerosi
bassorilievi sono conservati nel British Museum
€ al Louvre e in altre numerose raccolte, raffi-
guranti Tambure scolpite spesso come elemen-
to decorativo di sarcofaghi. A volte vi si di-
stinguono 4 corde e, in alcuni casi, anche 4 pioli
per l’accordatura, Il fondo @ sempre leggermen-
te a volta, mentze il manico, spianato nella fac-
cia superiore, si allarga, dal sommo verso Ja
base, fino a raggiungere lintera larghezza della
piccola cassa armonica nel punto del suo inne-
sto alla stessa. Tutti questi strumenti possono,
essere collegati con levoluzione del Tar che,
pit tardi, raggiunger’, proprio per questa via,
2
Ja Spagna; in ogni caso prima delVintroduzione
del liuto, ad opera degli Arabi, all’inizio dell’ot-
tavo secolo.
Rimane, tuttavia, una lacuna nella documen.
tazione iconografica, che va dal III secolo fino
allinvasione Moresca della Spagna e, poi, della
Sicilia. Bisanzio potrebbe essere il ponte che
collega, anche in questo campo, la cultura del
mondo classico, greco-romano, col sorgere di
quella Islamica ed Araba in Italia e nella Spa-
gna, Ma l'eredita Bizantina, nonostante il suo
splendore, s'identifica con la sua religione, dal-
Ja quale gli stramenti musicali sono esclusi.
Nessun contributo reca, in questo periodo,
esame dell'iconografia tramandata da altri pae-
si, che non partecipano al grande ciclo storico
nel quale cerchiamo di seguire le migrazioni e le
evoluzioni somatiche degli strumenti a corda.
Nemmeno per i periodi precedenti ci vengono
lumi dai reperti Assiri, Babilonesi, Mesopota:
mici, Istaeliti etc., che ci segnalano strumenti
Ja cui struttura non offre apporti interessanti
Vindagine.
Depuziont
Cerchiamo ora di mettere un po’ d’ordine
nelle deduzioni accennate, via via che i reperti
delle diverse archeologie sono stati messi a
confronto con la ricerca linguistica e con i prin-
cipi-guida.
Sono state, innanzitutto, individuate due
matrici degli strumenti a corda, in due
menti diversi. La matrice dei Tar, dell’antica
Persia e quella degli Ud dell’antica Arabia.
Entrambe evolvono nelle proprie sedi, entram-
be si propagano attraverso i contatti dei popoli
originari con altre popolazioni, nel succedersi
degli avvenimenti, nel corso di 40 secoli di sto-
ria, per arsivare ai giorni nostri. La matrice dei
Tar evolve nella linea dei Tambur e della Pan-
dura fino alla Tamburitza, che troviamo, nella
integrita dei catatteri primari, fino ai nostri
giorni nei Paesi Slavi e Balcanici. La matrice
degli Ud evolve in Arabia nei liuti, che gli Ara-
bi diffonderanno nell'Egitto prima e, poi, in
Europa,
Mori e Arabi costituiscono, con I'Islam,
un‘unica civilta. Nel medio evo, gli Arabi de-
rivarono la loro cultura musicale direttamente
dalla Persia. Non bisogna confondere, ovvia-
mente, questo rapporto culturale con i rap-
porti fra gli stessi popoli di quindici, venti se-
coli aC., quando si costituivano, del tutto in-
dipendenti Puna dallaltra, le linee genealogi-
che dei Tar e degli Ud. I maggior teorico del
mondo musicale Islamico fu AFFarabi, che vi
se in Persia dall’875 al 950 dell'era volgare,
ossia circa due secoli dopo Vinvasione moresca
della Spagna, La presenza dei suoi trattati nella
Biblioteca dell’Escorial (se ne contano dodici
traduzioni successive in lingua spagnola) dimo-
stra la permeabilita del tessuto culturale ispa
no-moresco dell’epoca, quanto la sua derivazio.
ne dalla cultura musicale persiana
Vale la pena di mettere in rilievo che pro-
ptio ad Al-Farabi, viene attribuita Daggiunta
della quinta corda al liuto moresco in Spa-
gna. Ripetute sono infatti le rappresentazioni
grafiche nei documenti spagnoli del IX e X
secolo, del liuto a 5 corde,
La chitarra, al Iume dellindagine archeolo-
sico-linguistica, confortata dal confronto con
i principi-guida, viene individuata come pro-
dotto caratteristico degli antichi Ittiti, in deri
vazione e variante del Tambur persiano. Le
innovazioni ¢ le modificazioni strutturali di
questo strumento lo portano fuori della linea,
quanto sono fuori della sede evolutiva del Pan-
dut. Esso si insedia, con gli Tetiti, sulla sponda
sud-orientale del Mediterraneo, in Egitto e dal-
TEgitto si trasferisce e si radica nelle coste ita-
liche ea Roma, al tempo di Cesare e di Augu-
sto. Con la colonizzazione romana della Pro-
venza e dell’Tberia, si trasferira definitiva
mente nel costume europeo, dove rimarta inal-
terato fino al cessare dell’influenza Islamica.
Si gid accennato, infatti, alla presenza della
chiterra in Italia al principio del medio evo,
come lascito del basso-Impero. E questo il me:
desimo strumento che ritroviamo illustrate
nelle Cantigas de Sancta Maria dell’anno 1270
€ che resiste, senza alterazioni, fino alla caduta
del potere politico degli Arabi in Spagna (1492),
Esaminiamo sommariamente le sue caratteri-
stiche come ce le presenta la Cantiga,
La dimensione della cassa armonica sta fra
quella della tamburitea e quella della chitarra
del secolo XVIII. Il fondo & piatto e le fasce
sono chiaramente curvate nella carattetistica
sagomatura 4 otto. Il manico & largo € corto €
non ¢’é ancora la bocca, né i fori armonici sono
ancota raggruppati nella caratteristica roseola,
nella zona centrale della tavola, come gia si rile
a nel liuto contemporaneo moresco, ma si tr0-
vano disttibuiti, quattro per parte, rispetto al-
Trasse dello strumento, nell'identica disposizio-
ne di quelli della chitarra Ittita del museo di
Ankara di cui si & parlato. Merita attenzione
il fatto che la vibuela, che ritroveremo, sempre
in Spagna, nel 1500, presenta le stesse dimen-
sioni, lo stesso numero di corde, gli stessi fori
armonici di questo strumento, non solo, ma gli
stessi intervalli nellaccordatura delle 4 corde.
L'unica differenza consiste nella forma delle
spalle, che nella chitarra latina del 1200 erano
cuspidate, riproducendo fedelmente il modello
della Tambura Greca del 300 d.C. di cui si
fatto cenno. Qui soccorre, ancora una volta, il
ricorso alla derivazione linguistica del nome
stesso di Vibuela, di certa derivazione dal
basso latino “‘Vitula”, da “Fidula” o “Fidicu-
la” del periodo imperiale. L’indagine storiogra-
fica concorda, dunque, con quella linguistica
€ trova conferma nei principi-guida della sta-
bilita morfologica e dei rapporti di accordatura,
nell’affermare la diretta derivazione della Vi-
ucla de mano dalla chitarra latina, gia presen:
te in Spagna al tempo dell’occupazione moresca,
in linea discendente dalla “Fidula” romana,
C’® un punto importante, che deve essere
messo in rilievo. La Fidula romana, come la
chitatra latina dellalto medio evo, quanto quel-
Ja del secolo XIII, illustrata dalle Cantigas,
non meno della contemporanea vihuela, sono
strumenti d’estrazione popolare, destinati, so
prattutto, al facile accompagnamento delle can-
zoni della gente incolta. Ebbene, proprio in
questa caratteristica popolare tisiede la forza
della sua penetrazione e la sua resistenza al lo-
goramento dei secoli, la continuiti inalterata
della sua morfologia. L’originalita e la lineati-
t8 della concezione ne hanno favorito la diffu-
sione ¢ V'attecchimento nei paesi raggiunti. Sa-
14 compito dei musicisti del Rinascimento quel-
Jo di aggiungere una quinta e poi una sesta
corda alla vihuela de mano, prima che venga
superata, sul finire del secolo XVI, dalla chi-
tatra. E qui si vede, ancora una volta, che il
meccanismo dell’evoluzione degli strumenti
2B
procede sempre verso le forme piti complicate
¢ non ritorna mai indietro.
La vihuela de mano del Rinascimento spa
gnolo nel secolo XVI aveva infatti sei ordini
di corde raddoppiate all’unisono, mentre la chi
tarra, nello stesso periodo, ne aveva ancora
quattro (come la fidula del basso Impero), di
cui solo la pitt grave raddoppiata all’ottava su-
periore, e apparteneva al folclore spagnolo. Co-
si semplice e popolare, ricevette tuttavia le
attenzioni del Fuenllana, che scrisse musiche
per questo strumento. Si visto precedentemen-
te che la sua accordatura corrispondeva a quel-
la delle 4 corde di mezzo della vihuela a 6
corde (che era Ia medesima del liuto a 6 corde).
Sarebbe un errore il pensare alla chitarra a 4
corde come a una versione popolare, semplifi
cata, della contemporanea vihuela (e a maggior
ragione del liuto). Lasciando in disparte il liv
to, che segue una linea evolutiva a sé, come si
@ visto, nella cultura persiana dei secoli IX ¢
X, quanto ai rapporti di dipendenza fra la
vihuela ¢ la chitarra, dobbiamo piuttosto pen-
sare a uno sviluppo della accordatura originaria
della chitarra in quella, pid estesa, della vihue
Ia. B cosi che questa diviene Pevoluto strumento
della societa educata ed & per questo strumento
che furono scritte le composizioni numerose
della nota schiera dei vihuelisti spagnoli del
1500 (Luys Milan, Luys de Narvéez, Alonso
Mudarra, Enriquez de Valderrabano, Diego Pi
sador, Miguel de Fuenllana, Esteban Daza) e,
in Italia Melchiorre de Barberis, in Francia
Adrien Le Roy etc. Sul finire del secolo, tutta
via, la vihuela, come accertato, verra superata
¢ poi sostituita dalla chitarra, che a sua volta
compare con 5 ordini di corde. E a questo ci
clo evolutivo che partecipa Vicente de Espinel:
per quanto Ia chitarra a 5 corde esistesse gid
prima della sua nascita, come fa fede la Decla-
racion de Instrumentos di Juan Bermudo pub-
blicata nell’anno 1555 (Espinel nacque nel
1551).
Giunti a questo punto, mi pare potersi rite-
nete esaurita la relazione critica delle ricerche
€ degli studi dei prof. Kasha e Watson che,
come detto al principio, ritengo i pid recenti
approfonditi in materia.
Le ricerche sulle origini del liuto ¢ della chi-
tarra hanno portato a individuarne Je matrici
4
distinte ed entrambe in epoche remotissime
Lungo la via si sono individuate altre due ma-
trici parallele: quella dei Pandur 0 Tambur ¢
quella delle arpe da grembo, le lire le cette
Sarebbe infatti ingenuo e troppo semplicisti-
co pensate a un’origine unica di tutti gli stru-
menti a corda ed & per I'appunto in questa
molteplice individuazione che risiede limpor-
tanza di questi studi che si spingono fino al
secondo millennio a.C.
Altri strumenti, assimilabili, pi o meno, a
quelli definiti (arpe da grembo, Tar, Ud) sono.
esistiti e in parte sono stati messi in luce €
raccolti nei musei dell’archeologia cinese, mes
sicana e di altri insediamenti delle civilta pit
remote. E owvio che, a un certo punto della
storia e dell’evoluzione culturale dei vari popo-
i, Yuomo deve aver sentito il desiderio di
esprimere nei suoni i propri sentimenti ¢ che
la vibratilita delle corde tese, rivelata in forme
sonore dai primi rudimenti delle casse armo-
niche, abbia trovato manifestazioni parallele ed
evoluzioni ansloghe.
Nel campo organologico, al quale, chi scrive,
ha dedicato molti anni di applicazione, pare
doversi dedurre una legge molto importante.
Si 2 visto infatti che la tecnologia sempre
piti avanzata dei vari insediamenti non ha scal
fito, nella costruzione degli strumenti, il dise
gno otiginario del tambur ed ha rispettato la
Tinearita della sua struttura, Tutte le compli-
cazioni e le aggiunte, affacciatesi nelle varianti
diverse, in diversi paesi e in diverse epoche,
sono tutte cadute, provocando la caduta e Vab-
bandono degli strumenti derivati. Per cui la
perfezione di quelli che, fedeli al disegno ori-
ginario, sopravvivono, ¢ oggi vengon costruiti
(liuti, chitarre © archi), deve ricercarsi in pro-
fondita ¢ non in superficie. Intendo nella sa
piente scelta dei legni e soprattutto nella sa-
piente “lettura e interpretazione” dei legni
scelti, non importa se empirica 0 scientifica, a
seconda della formazione del liutaio,
Ma diffidiamo dei “messaggi” degli ispirati
€ delle alchimie di supposte scoperte di co-
struttoti piti entusiasti che preparati,
E. Fausto Crurto
Be
RecoLAMENTO
1) Ta ea eivice Berben, ine
Neinconealeco, inde cd
Siguniass pao concono
Gteamotce intial a
some. delllutce compare
Mau CASTELNUOVO.
TEDESCO(Fienee 1895
Beverly His 1968), nel po
pool al onsale I sens
pe ‘chordare* Hmporapes
cctinig che El holes
Sore, alla" letteratuta della
ia“ tn posts
fconcettista maestro Andrés Se
ovis!
2) D eanetto & speto 4 tj
epeson op melon
re wus linked ob
3)
Le composizioni debbono ave
re le seguenti caratteristiche
2) ese composte per chiar
5) avere una durata tra i 5 ed
425 minuti di esecuzione
e) essere scritte per chitarra
‘esacorde,
Le composizioni debbono per-
venite alla segreteria del con
corso di composizione chitart.
stica « Mario Castelnuovo-Te
desco », c/o Edizioni Bérben,
Via Redipuglia 65, 60100 An:
cona (Italia), entro Je ore 24
del 30 giugno 1973. Esse deb:
‘bono essere inviate a mezzo
4
pico portale raccomandato
Non_ sono ammesse alte for
me di inolto.
5) Le composiziont debbono por
tare, sal frontespizio, un mot
to, enon dedbono ‘contener=
nssuna indicazione atta a fat
Heonoscere Fidentia dellauto-
eA parte, in busta chiuss
Silla, il composivore dove’
includete un fogio. indicate
Ie proprie generalits, Vert €
Tinditizz. $9. tale_ busts, do-
val stere inst mot
esto tl frontespio della oom
odzione, Verranno aperte so
Tanto le. buste corispondenti
alle’ composizioni premiate 0
segoalate
6) B presrtto che le composizio-
ni invite sano inedte msi
eseguite.pubblicamente, Bin
facolel, ma non in obblig, in
dlcare sulle note le ditggiats
fe 0 le descriviont degli effet
Hrumentaly destderat dal com
positore. Ove ial diteggatu-
fe vengano Tealizzate da. per.
ona divers dal_compositore,
anche Pidentith del ditegeato
re deve essere sconosciuta in
flcun' modo indicate ello
sina
Oltze alforginale manoserito
I componitore, deve allegare
cingue copie conform’ della
composizione, Si contiglia dt
Flcorrere a procedimentt di t=
produsone che gsreniscano la
penfette decfabili
CRONACHE DI CONCORSI
INTERNAZIONALI
Primo Concorso INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE CHITARRISTICA
“Manto Castetsvovo-Tepesco”
8) Le composizioni,pervenute en:
to i limiti del Bando, verran:
no inviate per il giudizio ai
componenti la commissione e-
saminatrice, nelle persone dei
— Alexandre Tansman (Fran.
‘ial,
= John W. Duarte (Inghil:
terra).
— Riuggéro Chiesa (Italia
= Alvaro’ Company (Italia.
‘Angelo Gilardino (Italia),
Dopo aver esaminato le opere
pervenute, la commissione
faminatice sf siunist — in un
ogo 1 suo tempo stabilito —
ed emetter) il giudiio nel se
fuent termini
2) secglies tuna composizione
ails quale. vert confer
lun. primo. premio indivi
bile;
b) stabilcd una graduatoria toa
Je altze composizion! ite
ute meritevol,
©) indichera,.eventoalmente
foori graduatoria, il titolo
di composizioni "che, pur
fon estendo state itenute
metitevoli div un premio,
presentano tuttavia cratic
Fistiche tali da meritare una
10) Il giudizio della _commissione
entro i 31 ottobre 1973. T
Vineitori ed i compositor se
gnalatverranno informati con
fettera raccomandsta
11) Alla composizione gud
9
1. Riportiame la letters omsegio
she’ il grande chiterista Andrés Se
feria ba indrzeato ala memoria di
Mirio Castelnuovo Tedesco
Chicago 11 de febrero de 1972
PARA MARIO CASTELNUOVO-
TEDESCO
Homenaje de
ANDRES SEGOVIA
Una de las mas dilatadas y esplén-
dias ‘Provineiat de In Historia de la
Goiarea sera siempre la misica que
Mario Castelnuovo Tedesco ha ese
to para ella. Su fecunda y viva ime
finacion plasms en paginas inolvide
bles piesa de melbdico y harmonica
Tirismo, ‘trasuntos de estados deal:
‘ma, retratos musicales, paiseges de
Su'Tualla yen todo elo, fo mas raro
9, dificil, Poesia, ‘sin le cual, ninguna
bra de Arte ha subsistide jamie,
Los, gitarsstas acrusles y furazoe de
Benin estar orglloos de tal Tesoro
Y ahondar noblemente en
Gaando se havan ‘isipado Jos na
btrones con que a Smpotencia crea
dora de Soy cubre lar pellas formas
Ge'ls Verdad Aristicn, el nombre de
Mario Castelntove Tedesco resplan
deze con mayor bilo. Ya om
fefsjr thuminasin pata siempre a Ta
Gost. meee
Avon Seoovia
2
vincitrice del concorso, verri
conferito il premio « Mario
Castelnuovo-Tedesco », cons!
stente in una somma’di dol-
lari 600, in un diploma (nel
quale verranno expreste le mo-
ivazion della” commissione)
in un contratto per la pub-
blicazione dell’opera nella col
levione di musica contempo-
anea per chitarra diretta da
Angelo Gilardino. Alla com
posizione, verranno assicurate
almeno cingue esecuzioni in
prima contemporanea nel mon-
do, per mano di noti concer.
MUSICA
Le OPERE COMPLETE PER LiUTO di
Francesco da Milano trascritte
in notazione moderna da Rugge-
0 Chiesa
Raggero Chiesa 2 gid noto, in
Iulia ft, pet i So vasto I
oro di ricerca dl svalutarione
Gi importandopere_ per listo, vi
fuels chitara,opere che eli a
ttasrtto in, notarione moderna
alle intavolature originate che
pet ha ne & ora
Chitrtstt che ne cosiuscono Ia
parte pid vitae © preponderate -
E deg studio! in gener B quind
col rspetto che ti deve alle nobil
Snivative che mi accingo «pre
tna fatica che © conituta dalla pub
Blcsion in die wa dee 0.
pore complete per listo (Edisiont
Suvini Terboni, Milano) di France.
seo da Milano (1497-198).
Git la mole dei due tom! 2 di
pete steseneloguente ove #1 con-
iden che, nelPinseme ed scsi
ali indie hanno “complesiva
Inente ben 737 pagine cost suddiv.
se: Volume 1, pp. CLVE pid pp.
31; Volume il, pp. LXI pit pp
269, Nal primo "sono. contenute
tis, La graduatoria compile
te dal “Commissions, cor
prendetd_un secondo "premio
Edun terzo premio, consisten
in una medagia con dipo
ina, ai ent vinciton & in fx
cai ala at isk Be
fen di propore il contratio
pet In. pebbliaione dll ope
fe Le menzioni onorevoli ver
renno conferee con un diplo
La tassa di isrixione al. con-
corso t fssata in line 5000,
Ga inviare, t mexs0.asiegno,
alla casa editrie. Berben
RECENSION
tutte le composisioni orginali¢
fe secondo cute fe tasrizion lise
tistche di opere vocal
Come si pud constatare da quan
to Chiesa illostea com ciate
hella volutamente sueints prea
Hone! “del primo volume, France
So. Canova’ da Milano, det
Diving”, fa celebre sie come Titi
sea che’ come compositor, Dela
Son fama cf testimoniano ben 39
Gpere a stampa ¢ 19 manosert
Ghiziont pervenute fino” i_noste
font che contengono sue" com
kion Ber fer ale oe
faccolte stampate, dird che quest
fono wscite in Talia, Germania
Belgio, Francia e Spagna, echo
«qind! sono state redatie coi sate
Si dintavolatura di Tio alano,
tedesco e frances (in Spagna con
Fintayolatrnspagnols per stn
tment a tasters) Nella stesa pre
fesione Chiesa offre delle spiega
dloni soi tre citat sistem df graia
Hii
cori in tiferimento_ primo
volume (che contiene 60" Riccres
Hh, 4l Fantasie, una Toceata per
Tiuto solo, tn Canone e una Spa
gna pet due liu), per avere on
es ella complessia. del lavoro
svolto. da Chiesa, t necesaio
pete che
Pepecie Le racolte stampate din
Zavolanize.possoao.contenere ero
Fille volte anche grosslan
12
13) Le opere non _premiate non
14) Il giudizio espresso dalla com-
missione 2 insindacabile, ¢ la
semplice iscrizione al concorso
ne implica Paccettazione da
parte dei concorrenti
15) B in facolta dell'organizzazione
del concorso.procedere, in cx
£0 di forza maggiore, alla so.
stituzione di uno o pit giudic.
Per ulteriori informazioni, rivol
gersi alla segreteria del concorso.
= data Veccetionale fama goduta
Ga‘Franceco, cea i due teal del
Suol Ricerati e Pantase sono 7
perbil ole che nelle napettive
Ffesure’appese nelle varie prime
ftizioni, ‘anche in quelle delle vs
fle redision! a sampa ©. mano
Scitte (acl sistem dinavolataes
ita); ne conseque che, «causa
Gi error o di arte, le prime ver
Sioni spo non concordano con le
er Pedizione del pers omnia
di Francesco, dunque, oltre = re-
pest tute i ein 4 ape ©
Hi del Htista milanese, Chiesa ha
Aloyuto tasrivere tutte Ie compo
suceessvo confronto di esse, ha po
tuto rcosrize quelle che’ seu
biente devono esser sate fe versio.
Bi volute da Ersncesco, Ma Pesem
plare. scrupolostta dello tudiono
hon sit fermata qui. Infst, la
derna (che presenta cronologics
tmente | lavor cot rpettvi tol
Ge relative prime ediioni) ® pre
ceduta da unsppendic (i 1d pa
gine) dove sono tiportate minuzio
Stmente sia Te version orginal i
Get particle da Tui corretti-e
ft gue parca op
nelle varie rediion, non collins
fo con la tspetiva prima stesura®
1. Sia Ja prefazione che le note eon:
tenuite nel dae volumi sono redate in
Italiano, inglese e tedesco,
2 Per dare un‘dea della comples
sith dello. studio sulle concordanze,
volendo citare soltanto alcuni esempi,
2%
ticordo che dei Ricereai J, VII, Ve
IIT esistono rispettivamente, 10, 11,
13 e 14 stesure, Bisogea inolte sape
re che, per Pindivideazione delle va
He stesure di una stessa composi
4 titolo relative, dato che § termini
Fantasia ¢ Ricerete erano i fato a
imi Aoaighe ico san. do
Waments alle compossion! senza th
tol
on tle appendice, pertanto, li
Studios! hanno la possiblth dt con
tollre le cortesionispporate ed
Sno’ ‘dponone ‘to ie
reed esamitare non solo le prime
tua anche tite Te successive fed
Zonta tutte Te opere del lamoto
fits
Per quanto ls vasta mole di le
vero alll concordance el tetimo
sulla serupolosaserieth dl Chie
Sk seme che vada parole
mente sttlineato iI fatto che ea
4 prove di ese serito dt que
So lavoro sopratutio quale meee
tia premesea pet poter model
te delle version! che, snterpretate
on mature arisen e con igore
Sls, rappresentabo it frat di
ia sensbilh d una prepara
ne musical dt prim’ordine
Velirione del. secondo’ volume
che, come’ gi accennato, compren-
de oper plifooiche vocal intav-
lite pet Hoto da Francesco da Mi
tino'st presents con ln stessa ac
€ pertante, per evtare dt ipeter
ftom né tracer Ia desctiione
Mi limite solo. ad oxservate che
Gjicsio, sspetto al primo’ volume
fin 8 certamente meno interessant
din inieamente che strumental
mente. Dal Tato strumentale, an,
tpprezenta sh presoxo.documen
come Tre dell tasrisione abla
indowo ! liste) a siluppare ule
tlotmente Te isore del foro Hr
to nelio tteso campo, ¢ parallels
Bente, anche tet gl organist
Te terscrvont del Hata ila
ese ‘Hguandano soltaato aot
francofiamminghi, comportr! ch
to la soa eensibith, Chiesa da
mre sua, ha voluto evidensiare i
fore compiuto da Francesco
per questo motivo alle vie tr
Tcristni ha acooata, igo per 1
fo, | Hspete test polifonic of
final afinché i lettoe poses glum
ere apevalmente ad un obietivo
ual ie consatzioni che si pos
sono fate? A mio avelso at pd a
fermate che Francesco da Milano
ha in pratica cresto delle belle
nove €, con soluzionl ed attcaai
tment! precpusmente Lust, a
rusia degli orignal che quanto
pub appari da tna pura ¢ sem
plice analisi della loro scrittura
tipicamente vocae.
Per concludere isd che, per
metito del lavoro di Chiesa, Fran.
cesco da Milano riacquista final
‘mente a sua teale dimensione ar
tistica, cio quella di uno dei mas-
simi tappresentanti della musica
strumentale del Cinquecento. E,
per un giudizio sulla sua persona
Fita di compositore, riporto’ quanto,
con cognizione di causa, scrive lo
stesso Chiesa: « Sono evident nel
Ja personalita dell’Autore la sa
pienza contrappuntistica e la gran-
de austerita tipiche di una cultura
‘musicale fiamminga, con una ricer
ca dello sviluppo pitt che dellidea
tematica, ma il suo spirito latino Io
conduce spetso verso una naturale
inclinazione melodica, che epli tx
duce in una intensa ¢ purissima
cantabilith. »
Bruno Tonazzt
Maxcoust ARnony, Fantasy for solo
guitar, Edited by Julian Bream
Faber’ Masie Ltd, London.
‘Tea compositor britanaict a.
aqisit alla causa della citar dal
Tarva’preseuss di Jollan Bresn,
Matcoln Arnold occipa senza dub:
bio un’ ruolo importante ¢ bene
sero: la quail, Guntth
camentate Bnora nella musien per
hikers © ofchesta, #!completano
ona con Ia pubblicrsione di questa
“Fancany™ per chitara sola, una
composiione tr Ie pid significa
See dal panorama chitaastico mo
demo
Te perionaish di Malealm At
old. ¢"segoaia. da un labosioso
edletismo e da na dinemica in
teaprendenca; le sue esperienze di
Compositore e di diretore dorche
Stra sono sempre state improntate
ad amiacadeisna ea spregiud.
Gateira ~ non per questo Arnold
mal contaibunebboe tale colloc
Hone ia *Faatasy® in argomento,
Tioto del termine “Fantasia” &
cost soggetto variant eda tra
formation, dallepca.snaschnen
tale ad ogg, per eal ® asad dif
ima’ musicale ben definita;_sappin
oper certo ch gusto igh fon
signa pi dal tempo dl Sch
‘nan, un solo brano, ma che pub
anche titers, in seouo leteaeio
9 come programma silistic, a pid
composzioni, tra di loro legate ©
imerelae da ness tematic, chia
mis somigliane, ce, Sembra. que
So Fuso che Arnold ha inteso fi
re della *Fantasy®, dividendole in
fette moment, stan soluone di
Contin, ma con iol distin ¢
con sion propos. Lerche
ture complesiva pealzo. sai
ten disegnate, proporionsta e, in
tin certo sens, ‘ersino rgotoss
ie tl mini dll oh
a,"e ne repo Fespessione ed i
‘peo vena ali fea,
T'brano al apee con un rela
dio: sil basso tlternato as
petto ostingamente ma con” dé
ere. Spuravion! vitmiche, in fu
Hone di pedale, scorrono’declame.
oni di acon profond! e vigor
dal quatro ed. ociiona
niente te par etna quind! una
sorta di dversimento daegnato con
tin gruppo di quattro. semicrome
tin Gui’ deinen m_accordo di
Settina di volta in volts divers),
ie" quali vengono tresporate svc
Cestvamente nelle te diferent ot
tave delfestenione. citar. —
tale modelo presets. ben poche
snomalic nella soe. applceeione a
dio. per Pesecttore — dopodiché
stoma alt element db apertura
(cio al tematien), riratara con
Tl “secondo episodio. (« Scher
zo») & da un ponto di visa sma.
tural, capovotgimento del « Pre
Iudios: ta Funzione di pedale vie
ne attibuitaalla_parte superiore
te alle corde’ moto), mente li
accord totant_giocano sulle corde
ddato ia concomitanea alla prima
delle ce note sibatute di ogni mo
wimento, la mano detra score dsp.
prima col police (secondo Fefficn
€e ditegpiatara di Bret) si. quat.
fto cone, mente Te sbatiture di
po hanno ‘un senso di prokungs
Mento. vibrate deltaccondo ates
fount ung perenne a,
ts fonica che lemiea; questa
Inosfera slonata‘erisonante © com
trata da un breve disegno bao.
tccondo da ctogute in sco pis
cato (il carattere di “scherzo” de-
tia propio da quest contrast ef
fei ara Ineone vac
E contituita (pag. 5) da tin disegno
polfnico {a de vod!) stmfeamen.
fe simmetico, ma non identeo ne
Ta pronuncia, a cause dell'ntrod
dione delle legture.chitarrsiche
27
rela parte superiore (alera raf
fata csogitaione di Bream); da
Dag. 6, ha inisio un lungo inter
mneizo” che, schematicamentey po-
trebbe define! come “melodia se
compagnste": ma Is linea ping:
pale dapprims nel basso, po! nella
Soce.superiore, indi nugvamente
hel basso, pur avendo un, certo
predominio, non impedisce alle al
fre part di svelgere una fanzione
di commento assai superiore a
gquella dt un comune. actompagna
mento;.strada facendo, episodio
incorpora im piacevole gioco su
accord, part late (due conde a
vest on quae eters) un
segno ad arpegal gas! (che si
presented pot sl finite dell com
Posizione), ‘ona breve ripresa del
Fepisodio's due voc, prima del i
tomo dello scheme sctord-ote 1
pete,
UnAviett dal sapore patio ed
ingcene Gt et poi)
chiamna Ia prema cord alle sue pi
serch fuzont nig, So
furimene, anche fl amon fn
oii canto sh addenta elle cade
Sonor della guara e della quin-
ta cords; un tintorra ad ottave aon
deve ere fit coe eft
Bile, sol fatto}. poiché st rapgan
Gia, senza cambiament di cima a
disegno inisale dell Aceta, molto
“paleotia” un fo! villalobosiaa,
ie Robatas (gar pi
ma intenlonalmente ambiguo: c's
Teosteritainevitabile dll architer
tua eutinsons Fema &
Sdémodée” — salvo forse il punto
in ui pliaccordi tematic del
«Preludio» sappsiono severamen
te (per a basso fermo); Tepisodia
tale del «Preludio», con Te sue
he ot ripresentato tale e guale,
in fungione dt “divertimento™ del
Ja faghetea: il che ei dimosta con
aqaleaccorta premeditazione’ Ar
told ha dato campo libero alla pro
Pra “fantasia”: Ta fughett si con
Glade alla svelta, ma T'« aceleran
do feroce» dellltma battuta non
esplode in modo drammatico, sf
fia, al contrario, in ‘ona. seconda
‘chviett », meno canteting © pa
insteriosa della presedente, con ‘un
tficace ed atmonrco impego del
Je vibration’ protungote sull pep.
28
_armonici, tambora erage
46 colorano diseretamente {a pare
centrale
Tl ses episodio & una_« Max
cia». “La seansione del ritmo.
aida al ‘oto edetto delle due
Corde inerociate (ses ¢ quinta),
he sprigiona un'atmosters da an
biltasione generale; Arnold se n°
servito com molto buon Bust, co
the raremente. prima di‘ lui era
fatto (tut { nuolt inferior! delle
sercito, dal tamburino al soldsio
innamorato sis fino ai caporall,
rey da qualche composiione chi
tatrstca, com questo effet), #9.
veapponendo allo « snare drum ef
feet > un prottesco disegno melod
©, sontenato anche dalle tipetzio
ne indiferente i un pedale (si
Bemolle); sulleffettacio” viene pol
innesato un gioco pid’ gonfor il
pedale isi ‘bemolle viene. 10d
oppiato alfortava,superioe, cost
she il dicgpo melodico, prima seo
perto, viene ora.a. trovars alin
temo delfotava (sempre com il
more, ostante) uh el ao
per Tesccutore, ma. Teffeto do.
‘rebbe essere eecesionslmente inte
ressante. La melodia che, alfinizio
di pag. 6 avevn costiuito In ve
fiante™ di” rilfevo “nella strattura
Gell Scherzo, ritorna ora, sere
pre nel basso, con un ritmo alla
ato'e adattto allandamento. del
{it marca: ma, invece del disegno
limpido che Taccompagnava: prec
senteneate, got funn, ee
aeados” Ta sommergono, pi che
Fite da eco (Gi comanda se i
«ff» ichiesto per gli accordi‘non
Sia caagrato: Teffetto rlamico pod
benisimo essere reo anche da un
mero forte», ¢ coloristicamente
ia'cosa sta bene assai, ma.con il
vantepaio di permettere una. mi
glior rivelszione » dellimporante
profilo melodico del aso} tutto
A svecessivo episodio della marche
3 In ripetizione integele della par
te dello « Schcr2o» git cata (pag,
6) e anche il disegno ad. arpep
plist & identico tna non en
Exmente stampato: qualche errore,
anche in editioni eccelenti come
aqesta,sfugge sempre). i che non
tol dire che Te die cose, in due
punti cost diversi ed. espressiva
mente dierenviai della compost
ione, abbiano identico signifato
Ia Topica contestuate di ® che pre
cedeve di co che segue ® capace
Gi proittae sillo steso episodio,
in “ve articolazioni, due’ rifles
di colore asal contraitato
Al setimo ed ultimo posto,
< Poatadion: “nettelmente, e380
Buna sipress del « Preludio», ma
solo fing adn certo punto, ed
csatamente. fino alla dodeesima
tattta pot, Ht « Podado am
Biche aplira_al « diversinento')
prolunghlricamente, tascinandola
rerio Facuto, ia socceone. deg
fecondi sostenutl dal pedal; ind
Bprende il quarutino accords
dis seri, ne fail petno di ana
Hg nn pa is a
doppia otave sul fa ona ipo
Portione delMntervallo di quara
milan, che potrebbe anche ese
ye" considerato comme celal tema
tea tutta Ta composizione sem
Brerchbe vole chindere movinen
tel « Fantay » ma, alla foe, sor
aecordo di a magaore, non ft.
Conchiso: al bao. C2 unm
came dite che st posebhe ano
feglangers.. un’ allro In,
Ta echciea di idee © la solidi
state dquo ia By sc
Comandano come uno de pit so
jn questi lt anol; Ta vareth
clement stm, dinar, epics
Siv, Pabbondanca spess straripan
te del colore chitarstico ne fanno,
Incline, un effcace mewo di come
lexsone con ilpubblico: si
gamer eld gueio ano
fo'ripngher sbbondantemente, sen
za export al recto a incompren
ony anche da parte di un udtorio
dP india cultuce musicale
AG.
DISCHI
Jou Winutams pays. Spanisi
Music, CBS Stereo 72680.
Liincisione di un disco dedicato
interamente alla musica spagnola &
coggi un'impresa delle pis diffcli,
tra quante ne pub intaprendere
un chitarrista; il repertorio spagno-
Jo & ben. lungi dall’essere stato e-
splorato in tutti i suoi aspetti (la
maggior parte della _Tetteratura
vihuclistica & ructora ineseguita),
ma la parte di esso che va dalla se-
conda meti delf'ottocento fino ai
nostri giorni ® stata oggetto di una
celebrazione concertistica € disco
grafica cost qualifcata, da parte di
Segovia e di altri chicarvisti spa-
fol, che insistere poubbe sen.
rare inutile e ripetitive. John
Williams, nello scegliere il “pro-
JOHN WILLIAMS
gramma di questo suo disco, si &
Inyece diretto proprio alla tradizio
tne segoviana di cui egli, del resto,
= uo deg ered pid rian, car
cando di aggiungervi il proprio
contributo interpretative © la pto
ria opera di ascrittore.
La parte antica ¢ classica del re
Pettorio spagnolo figura in questo
disco solo marginalmente, con Ga
spar Sanz e Mateo Albeniz, entram:
bi trascriti da Williams, La dan
za nota con il nome di Canarios
ebbe varie trascrizioni strumentali
chitatristiche; quella datane da
Gaspar Sanz (non molto diversa
dalla versione di Ruiz de Ribayaz)
hha avuto, a sua volta, varie ampli
Ficazioni ‘concertistiche (da quella
di Narciso Yepes a quella di Joa
uin Rodrigo, che ae ha fatto la
base_delPaltimo movimento della
sua Fantasia para un gentilbombre
per chitarra € orchestra, articchen
do Ia ritmica vivace e' gioiose di
questa danza con varie cadenze di
indubbio gradimento concertist-
co); Ia trascrizione di John Wil
liams @ pid sobria di quella di Ye
pes, © Pesecuzione, per contro, &
tun po’ anacronistica: T'uso di tina
accentazione molto “caricata” con:
twibuisce certo a rendere eccitante
Yascolto del brano, ma ne distorce
indubbiamente Ia semplicith essen
Ziale, Mateo. Albeniz pud essere
considerato uno scarlattigno un po-
co in ritardo; questa sua Sonata
ricorda, chiaramente Scarlatti, sia
nel taglio formale, sia nella limpi
dezzagiocosa dei?ispitazione; la
trasctizione di Williams ® splendi-
dda, e T'esecuzione capace di testi
tuire il brio scintillante e la gioia
di vivere proprie della composi
Di Albeniz in Albeni2, si passa
al pid noto Tsaac, di cui john Wil
liams. presenta ‘tre pezzi: Varcino.
ta Asturias, i! Tango (entzambi nel
Ja “ormai_ ‘lassicn trasctizione “di
Andrés Seyovia) e Cordoba (da
Cantos de Espara), un brano fino
ra trascrito soltanto per due
tarte (se vogliamo restate nel ci
po della credibilita: una trascrizio
fhe per chitarra sola pubblieata in
Spagna alcuni anni of sono avevs
ill pregio di dimostrare come si pos
sano realizzare sulla earta cette’ co
se che, nella realth della pratica
chitarristica, non hanno alcun sen
$0), che John Williams si 2 ince
ricato di ‘ricreare, piti che di
stivere, in termini chitarvstic
Asturias & eseguita con la veemen:
za di cui Willams 2 capace, men
{ee pet contro, nel Tango, il gran
de" Giarrista"britanaico”adopera
tna dione molto exprssiva e om
tenuis, che non gli € fore abitua
Je, ma che risus asst convincen
te, sia sul plano dlfequlbsio mu
sicale, sia uf piano delle sonorta
proprumente.chiteestich. “Quan
to 4 Cordoba, cccorre sotillneare
ome la tasrsione di. Willams
Sia veramente genale; pur sempli
fiend notevolmente ‘Porgingle
eal viesce a creare in modo pester
&© ttt t plant sonot, conferendo
alla pare del brano scita in for
mma di-corale una stopenda reali
Zarione ‘el registto acu (e Teor
Fendo, per rspettare le distanze vo.
Tate di Albenis, ad una temeraria
dell stessa fase al momento del
Ja petitions), la quale evoca, in
modo effeacstimo ‘quel!'stmosfeta
dicui In Gitta andalusa & inbevu
i, ent nlapate dana pet,
cost die), Ie tactzione at 2eege
su eccellesi scam della Linea ie
fodica tra Tottava acuta (cantina)
e'Youava centrale (quarta cords),
gon Tinserimento. di un possente
‘Hpieno™ ottemsto per mes del
“rasgucados” nel punto clisnan
te Ussecgone dW da
‘ero travlgente, pare che eal vo.
alia superare i Umit test della
fhitara, entando”nellambleo di
sonoritl compose "violent, git
rope dal pianoforte, Non rsa
hela tractsone: di Willams sia
pubblicata, ma probable che e=
$2 sia sala effetcuata pli in fon.
ae personile che in vista di una
dlestinarione al mercato chicas
in questo quadro i neoroman-
sco fate nan. pe
mancare qualche pagina di Enrique
Granados} Ia not lca per canto
« pianoforte, che, nelPacezione Te
slonale spagnola, chia tna
ila”, farparte di una delle caceol
te che Granados scrisse sotto la
suagestione dl quad i Francisco
Goya y Lucientes (ma non si tat
ta, in queso cao, delle Goyescas),
Si'initola La Moje de’ Goya, che,
come il eelebre dipinto cf prove,
era una gran bella signora, [spire
tissimo, Granados st immerse’ nel
veriko del fatto che, sucess
Inents, Llobet aveebbe fatto di
quel. pez, rispettandone tutto lo
sltncio. meiodio e.simbolizand.
be appena Laccompagnamento, un
fate brano pet chiara, Wil
29
Yiams gui non si serve della ers
sctzione di Llobet, simeno. non
alla letra, calca tn poco a ma
to’ slla delicata poesia della cu
zone, con sonoridl ecessive © Bi
ent Lo slancio travolgente
Giteists sh trove alle rete con
fin tereno’ pid adatto nella tr
Sctiziong, sempre. operata dally
seg Willams re eit
te Valserpocticos. per pianoforte
(pit dione ae os
diseadentismo stlotiero,e pet gis
te priva di quelle freshers, nat
te [propria del Granados, ten
do, quest ‘sispira alla musica. po
poate dla roi tu Wile
R proigi, eabiace fa sun tecnica
ttascendentale ed il sto bel fresep
fo, ma il risltoto rests egvelmen
fe mediocre
Anche Manuel de Falla ® degna-
mente rapteenio con re dans
ttatte dal suo balleto Il cappelio
1 te punte: quell del Corregidor
quella del Molinero ¢ il Canto det
Bercatore, Tutte ¢ me troppo not
petché se ne debba discorrere qui
Williams neha fata una tres
zione 4 proprio us9, e si rcomette
fvidentemente alle express. inter
dloni chitaisiche di de Falla ce
fete: nelforchestrarone del. baller
to: rsultaro grandioro, con pieno
Spero. di quell are’ di mistero
di malinconia che trspare. dal
Canto’ del Pescatore
“Torroba, if fortunato zarzuelisa
che tante’belle pagine he serio
pet chitars, ha if seo posto aan
{o ai grand! padri della masica sp
anole, © Toctupa con la sua som
flnte! © maliiosa musielta, Wit
Jiams ne" propone due pagine tra
Je pi felch ed ipitate: Madrofos,
che & una danza leggera © graioss
dela regione castiliena, e@ it pid
ddenso"e meditato. Nocturno, na
pagina in en le sonoith doviebbe
fovcreare quellatmosfers di ombra
edi mistro pit evocata mopstal:
mente da. Mane! de Falla con le
sue Noches en los jardines de Et
pata; mentie nel Madroios ‘Wi
fitms controll assai bene Velegan
za ttmica e fraseologica, nel Noe
turno si abbandona a sfoghi vir-
tnosisticl sem motivaione expres
sivs, e sommerge il brano in una
fraporosaesibizione di vittuoismo,
“Joaquin Rodrigo & presente con
il primo del sect Tre pera spagno.
fi senz'attro il migllore, cot i
Fandango: la lepgcra e ‘cavalere
sce nobfea di questa danza © stata
Stlizzata dal maestro madrileno con
30
fli clementisrmonici che carate-
Bmano la sua arte, coe Tso
foso e sapiente delle. dissonance
ineme alt accord, agglustate con
gatbeta tronia so profil, melodit
del tutto conventionali: questo
Fandango ne ¢ uno degli eiempi
pi riseiti Linteicata complessita
tecnica del brano.& superata da
Williams ‘con’ spavalda facilita,
aleuni toechi. di disereta elegans
{come Vinizio del secondo tema) so
no resi con magistale eftcaia,
‘Completano il programma due
delle mumerose canzoni cateane ti:
create sulla chitara da Miguel Llo
bets La Nit de Nadal e El noy de
la mare, sulle cui esili ¢ doled me
odie il'maestro eatalano seppe in
nestare, con Tatfinatissima scelta di
gusto, quel procedimentiarmonici
he, allora,arivavano in terra ibe-
vey per ie dimporasion, du
vari de Falla, Tuzing, ce, in visita
2 Parigi: Llobet si inser! com mo-
Sessia'¢ con inteligenss in questo
cireuito culturale, fu dungue. i
primo vero grande chitarrista della
hostra epoct. Benché le note del
dic ai Wiliams eda da Kay
ee, neghino Llobet di essere
Bato un compositore, non ve dub:
bio che queste melodie avzebbero
ben poco valore, se non fosse per
I realizzazione’ che ne ha. dato
iI chitarristatrascrittore. Williams
propone una versione vivacssima
Se Eri de Nadal no spice
‘gsi, il suo. vigore), mentre” am:
Bienea molto poetiamente il “pa
thos” del EP noy de ta mere,
‘Un disco, questo, che solamen-
te un grandisino Srumentsta ed
tua interprete di primo. 1ango.co-
ime Willams poteva realizar, sen-
4a correre il pericolo di cadere nel
Ja noia della ripetsione. La ‘sua
ante & git ai livelli pit alti, © an
he questo suo contributo ala tra
dlzione del binomio Spagoa-chitar-
4 2 altamente significative.
AG.
Aunerto Poxce, Récital de gui
tare, sion 30 A 062. steteo-
Alberto Ponce ® uno ii quegl:
artist, spagnoli (@ nato a Madrid
‘nel 1935) che, dopo essersi forma
ti nella Toro terra dorigine, hanno
scelto Parigi, sia come logo di
residenza che come terreno dazio-
ne culturale; Ja storia della mo-
sica, dalla seconda meta dellotto-
cento ® cost ricea di esempi come
quello di Ponce (ota i compas
fori, tutti i maggiori spagnolt han
no bubito it fascno dt Pargi e La
ua attrativa)y che si pad ommsl
patlare d'una ttadizione ispano- pie
Figina, in cui sidentfica una sce
{2 spisitale ©. professionle
Ia formarione di Ponce, natu
ralmenteinfluenzata dallate di Se
govia (main modo indiretto), ha
Ficereato un dificlle equilibrio tra
sii clement istiativi ela culeurs
Serumentistia © musicale concep!
ta. prewoché.scientificamente; la
figura del didatta ¢ mosicologo E-
milio. “Pujol, eminentissima tra
ante hanno ago oe nosto
colo a favore della chicarra, &
cio sata la fonie zeta dllap-
prendimento Ponce, che ha la
Yorato a fondo, sotto Fiaflusso del
uo maestro, la vihuela edi su
repertorio, oltre ‘ad -acguistare la
muestra di cui oggi dispone come
chitarist: una figura completa ed
interesante, dungue, ta le pid va
lide ¢ pid generosamente’ impe-
gna
i prima parte de disco 8 un’an
tologis dedicate + Manuel. Ponce;
Toronimia tra compositore ed in
terprete ® per casuale, ¢ cid che
Jega Alberto @ Manuel non @ un)
parcel ma oat ati
Le copiosa produxione chitarristica
Gel maestro’ messicano dovelsen-
alo, nel tempo, esere inguadea
ta da ‘un'indagine sera, ed atten,
Ia quale s'incarcher’ di seleziona
re, ta tante opere, quelle che pid
atenticamente e-fluidamente "1
velano valori dimmaginarione, d
Ireschezsa ¢ di spontancita, ©” che
meno rsentono del tavaglio crex
tivo, soprattutto per quanto si
ce al problema delle forme ¢
delle scelte.stilisiche: “Ponce fu
ten artista sincero ed ispizatissimo,
moa certo condizionato dalla Tita
tezza del suo bagiglio tecnico di
compositore «© questo, se 0M ap-
pare nelle. sue composizioni pid
Brevi e semplici (come i Prelud,
pesa talvolta negativamente, crean-
do discontinuith e squllibrio, nel
Je composizion! pid artcolatc. Le
seelte di Alberto Ponce sono gia,
fd ogni modo, selettive, perché Fin.
texprete presenta quanto di me-
lio sia uscito dalla penna det suo
omonimo: clot la Sonatina meri
dional « il Thome vari ot finale,
‘con le Tre camoni popolari messi
‘ane come intermerzo, La Sonatina
meridional 8 il lavoro dove meglio
Ponce ha spot salare un equ
Tibsio ta la riechezza.staripante
del_materiale di base, sanamente
ispirato al folelore, ma’ con dignith
propria, e gli schemi formali euro-
pei, mantenendosi nel limite di
un'asciutta ed essenziale architettu
1 eleganza briosa del primo tem-
po ctea quel particolare clima da
u- cui, pid ea oon ridotto Ct
= seule del bitemausme “e
‘Sent fomnai dwcende to
fi 41 diminutive; la Sonatina aon
inst una “pica ood oe
_ tn modo specie dl adoperate Time
la pianto del tempo di sonata. Il The.
E- me varié et finale & senz’altro il
: Golavoro di Ponce, alrove emer
: Sb act bitin dela vesaaone;
: in echez inventive np
> tel tems off nat un tereao
_ ferlissimo, nel volgte di un pe-
el iodo relativamente breve, denso €
: Sngato; i compostore ba dure
la ue poto crea effect con.
od non in senso puramentc ritmico,
* Bae dan aa pao
41 game ts Vartista e la amusioh
> popaare ai t qu fat sepa
: tote o meglio Ponee he bloat
to cert suggenimenttfollorstie in
una visione altamente individual
‘at, pet cul non appare eccestivo
Hcoidite Fesempio dr Béla Barth
Le Tre cancon! popolai messiane
t000 ‘avece, al contro, sempl-
fe grsiose armonizeziont di mo-
Se Dopo she, i compostore
realizw) in un primo tempo per
Pianoforte, utofizando pol. hn
Ere Segovia a lane una Versione
per chitsra
Ta tuto i programma. poncia
to, il ehitarsta elle pet'la ta
fertile musialita¢ per a proprieta
con ei dinoaa per ope
Mumatuts, anche Ta" pit sot
della musica! il suo modo di man:
tener lo stacco del templ veloc ea
sndament ass Tschios! non on
odo sl esbite vanaments il pro.
foavincente dmostasione diene
tusasno per la vill fasta nella
musi, mente, daltzo canto, ne!
moment di pli distess ef aperta
camtbilid, il chitarrit non Ie
‘ea incsplorata aemmeno Ta. piG
Pitla vibrnone Liber
tancataa di slgore in aleuot punt,
oso entusiastico dl mibsto, han
no sempre una loro givstfiizione
interpetativa e una’ pena cre
be
1 second faci del dio 2
catia spagnols, salvo Vaiso, dedi
cato_a Villa-Lobos, con lo studio
nr fy al cal Alberto Ponce rst
Bitisce (dopo ‘mole esecusion di
scognaliche altars pi ine
cai alla ome di comodo) )) la A
pastagio con | trl, che Ponce a:
fronts secondo i detato dll ato.
sg nom setuenol on pil
AP Joaquin Rodsigo En lor trigaes
(enamored un preludio debut
ne), in eat Ponce ci una leone di
stile sulla masea spagnoa, alot
tando ‘un sitmo asa elastic, che
iB peace debi tae we
fanle potenca dei past con note
bata, scale, eee, lletando
dove lo’ sdopplamento ‘delle voc!
Impedizebbe “ai tenere lo se300
staceo: il ehe Bon & solo un modo
pe cwversela dalfimpicco, ma an.
She e soprattutio una scelia ds
Ie plenameate legit, almeno si
gutito particle tercea0, Il noto
Hommage 2 Debussy di Manuel
de Falla & pore teondotto da Pon
ce alle sue oniginichitaristiche
icine al peniero del'aitore: Pus
%o ce Ponce fa della versione di
Tibet i inatdi pregio dt exe
re'un spprofondimente. del plant
Sonor (con laniseim! fumat nel
nulla © con. uso espessivo del le
tito della sinista) che plova mo
ining ala veaane el ean,
VHlomensje « Térrega di Joageln
Turina sono oxmal dt tempo acu
site nel numero delle cove pid
Svalidel"reperorio.chitaristca;
tees acne Gh sua sea
Tomeno private i ana parte’ dell
loro. suena, proprio. ascoltan
do Tesecuzione di Ponce, il quale
2 capace di far copliere un sotto
fondo’ di ingulets e-pensota del
cate anche dove il rime. sem
ba etteiormente celebraze i gu.
sto della danza Tra i compositor
spool pit povan, Antone Rue
cio del cule dia su ets
personal: tra la gloiosn cme
Aloevalegiante Cantion 'y ‘dents
ne (erite quando Rule-Pip8 ave
wa at anni) la Cation 9
Udansa 2, ropostaci dal progr
saa di ‘Allerto Ponce, e8 to lo
Sato di tutta unevolixone di
enslero ¢ i ale (un'evolizione
fhe, manco a dito, pasa per Par
{B. Alberto Ponce &, com Narciso
Yepes, i chitansta’ pilin tono
com It personal crestva di Rate:
Pips, € non. occore.sottolnesre
quanto pocticae brillant sia que:
Mesecuione. Ul sécital st conclite
con il Tionto ai Mauricio Obans,
Sere sng ach
toc sl dei ia
one, classics pee il tall ¢ per le
Seale ‘mewiche, sprofondata nelle
wene. pitt emote del cente jondo
er quanto rgoarda Ia spinels
Ghana tata i lato espresions
co del suono, affidando alla vibra
shone ed alfato delle dissonanze i
Compito di esphimere una, tensio.
ne continua, sottlmente sopgeta al
Fpensamento ossenivo. dalle stesse
Celle: una pagina di grande i:
foresee dl atentica mattce ibe:
Questo disco di Alberto Ponce
ha arateische altameate perso
nal, sia per Timpegno del” pro
gramma. che per il valore_ dell
securion: si fratta di un'arte ps
fa, che alronta il compito dell.
tezpetasione ifacendon, con stu
polosa uml, alt ineni det om:
oslion, servendosi di meczi tec
idl primordine e ai na dspo
ibid saono .vasiailisina,
sos per quant ig
partcalaze‘lcune pape, pol una
Keclone “di autendcth oterprete
diva, Le ‘ote ‘astrative sono
imate da Robert Vial
AG,
SB
ERRATA CORRIGE: Nel'articalo
di Matio Sicea, La cbitara e git tru.
‘ment a tasters, apparso sal mitnero 1
ella vista, a pag. 29, righe 31-32,
fnvece di « opere per chitara © pia
noforte citate dal Biedermeier », leg
‘asi: « opere per chitarra e pianoforte
del Bledermeersei »
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- TANSMAN-Pieces Faciles PDFDocument12 pagesTANSMAN-Pieces Faciles PDFfabyguitar666080% (10)
- BACH Cello Suites For ViolinDocument45 pagesBACH Cello Suites For Violinfabyguitar6660100% (1)
- Fronimo 071Document71 pagesFronimo 071fabyguitar6660No ratings yet
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Fronimo 065Document60 pagesFronimo 065fabyguitar6660No ratings yet
- Liuto Gentile GarganoDocument2 pagesLiuto Gentile Garganofabyguitar6660No ratings yet
- Durighello PesachDocument3 pagesDurighello Pesachfabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Sehnsucht Nach OscarDocument1 pageAA. VV. Sehnsucht Nach Oscarfabyguitar6660No ratings yet
- SDL - ITA - Il Liuto - Numero18 - WebDocument48 pagesSDL - ITA - Il Liuto - Numero18 - Webfabyguitar6660No ratings yet
- Bottesini-Carulli Cavatina Dall'op. Andronico Di MercadanteDocument4 pagesBottesini-Carulli Cavatina Dall'op. Andronico Di Mercadantefabyguitar6660No ratings yet
- Calegari Sonata Op8Document7 pagesCalegari Sonata Op8fabyguitar6660No ratings yet
- De Selma, Fantasia Sobre El Canto Del CaballeroDocument3 pagesDe Selma, Fantasia Sobre El Canto Del Caballerofabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Journal Fur Gesange Und GuitarreDocument4 pagesAA. VV. Journal Fur Gesange Und Guitarrefabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. RomanceDocument2 pagesAA. VV. Romancefabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Tiroler Alpenlieder n.2Document3 pagesAA. VV. Tiroler Alpenlieder n.2fabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Lied Des TrostesDocument1 pageAA. VV. Lied Des Trostesfabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 077Document56 pagesFronimo 077fabyguitar6660No ratings yet
- Bicinia Sui 12 Modi Zarlino3Document27 pagesBicinia Sui 12 Modi Zarlino3fabyguitar6660No ratings yet
- Gragnani, Duo Per 2 Chit Dedicati e CarulliDocument35 pagesGragnani, Duo Per 2 Chit Dedicati e Carullifabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Schweiz HeimwDocument3 pagesAA. VV. Schweiz Heimwfabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Aria FavoritaDocument3 pagesAA. VV. Aria Favoritafabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 076Document64 pagesFronimo 076fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 073Document66 pagesFronimo 073fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 074Document67 pagesFronimo 074fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 064Document73 pagesFronimo 064fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 067Document64 pagesFronimo 067fabyguitar6660100% (1)
- Fronimo 070Document62 pagesFronimo 070fabyguitar6660100% (1)
- Fronimo 066Document70 pagesFronimo 066fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 072Document68 pagesFronimo 072fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 063Document69 pagesFronimo 063fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 060Document59 pagesFronimo 060fabyguitar6660No ratings yet