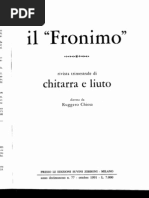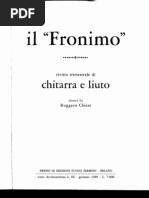Professional Documents
Culture Documents
Fronimo 013 PDF
Fronimo 013 PDF
Uploaded by
Jacopo Lazzaretti0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views28 pagesOriginal Title
Fronimo_013.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views28 pagesFronimo 013 PDF
Fronimo 013 PDF
Uploaded by
Jacopo LazzarettiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 28
il “Fronimo”
rivista trimestrale di
chitarra e liuto
diretta da
Ruggero Chiesa
PRESSO LE EDIZIONI SUVINI ZERBONI - MILANO.
; anno terzo n. 13 - ottobre 1975 - L. 800
SOMMARIO
Incontri
Colloquio con Ernesto Bitetti
Gli interessi chitarristici di Paganini di
Bruno Tonazzi
11 problema della diteggiatura nelle musi-
he per chitarra di Angelo Gilardino
Parte TL
Storia della letteratura del liuto ¢ della
chitarra di Ruggero Chiesa
XIII. Il Cinquecento
Hans Judenkiinig
Appunti di tecnica dalle lezioni di Narci-
so Yepes di Francesco Gorio
Idee a confronto
I concerti in Italia
Corsi € concorsi internazionali
Recensioni
Musica
Libri
Dischi
iL
15
19
22
23
24
24
24
25
27
Encounters
Interview with Ernesto Bitetti
Paganini’s Interest in the Guitar by Bro
no Tonazzi
Problems of Fingering in Guitar Music
by Angelo Gilardino
Part IL
History of the Literature of the Lute and
Guitar by Ruggero Chiesa
XIII. The Sixteenth Century
Hans Judenkiinig
Notes on Technique from the Teaching of
‘Narciso Yepes by Francesco Gorio
Exchange of Ideas and Opinions
Concerts in Italy
International Courses and Competitions
Reviews
Music
Books
Recordings
DIRETTORE RESPONSABILE: RUGGERO CHIESA
REDATTORE CAPO: SILVIO CPRUTTL
DDIREZIONE, AMMINISTRAZIONE FE PUBBLICITA': EDIZIONI SUVINT ZERBONT
10138 MILANO ~ VIA MF. QUINTILTANO 40 - Tel. 5084
‘TUPTI_ 1 DIRITTI RISERVATI
TAUTORIZZAZIONE: TRIBUNALE DI MILANO N. 331 DEL
MANOSCRITTL E FOTOGRAFIE. ANCHE SE NON PUBBLICAT!
NON VERRANNO RESTITUITT
UN NUMERO: ITALIA L. 800 - ESTERO L. 1.000
ABBONAMENTO ANNUO; ITALIA L. 3000 - ESTERO L. 4200
MEDIANTE VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE CCP
NUMERT ARRETRATI DISPONIBILI 1. 1.000
FINITO Dr STAMPARE NEL MESE DI OTTOBRE 1
[DELL’ARCHETIPOGRAFIA DI MILANO
ALL RIGHTS RESERVED - PRINTED IN ITALY
13 SETTEMBRE 1972
3/3859
CON 1 TIP
of
INCONTRI
Nite ortonne 1974 Emesto Biteti & sta-
to intervistato a Vercelli da Ruggero Chie
sa.
RC: Quale importanza ha avuto per la tua
formazione la scuola chitarristica sudamericana?
EBB. Non credo che esista una scuola sudame-
ricana con una identita ben precisa. Vi sono
consuetudini per suonare la chitarra folclorist-
ca, per ricavarne certi effetti, ma sempre in fun-
zione dell'accompagnamento. Ti dird inoltre che,
personalmente, non credo alle scuole. 1 mae
stro ha il compito di seguire le qualita natura-
Ji dell’alunno i quale, dopo una base iniziale,
deve ptocedere da autodidatia. Cid per quanto
conceme l'impostazione chitarristica; la forma-
zione musicale & un’altra cosa, ed ha bisogno di
cute pitt assidue.
RC: Gli elementi del folclore sudamericano
ossono ancora essere inseriti nella musica com
lemporanea, 0 pensi che occorra cercare altri
modelli?
B: Alcuni musicisti, come Villa Lobos ¢ Cha:
vez, hanno usato molti motivi del patrimonio
popolare. Ancor oggi un giovane autore, Leo
Brouwer, inserisce nella sua musica clementi
ritmici ed espressivi cubani, Ma con tutto cid
credo che pochi abbiano saputo approfittare di
questa ricchezza, In Argentina, per esempio,
‘on esistono tuttora opere per chitarra di gran:
de valore che abbiano origine dal folclore, ¢ un
celebre compositore come Ginastera non si &
mai valso di tale possibilita
RC.: Qui in Europa, dopo le esperienze di Bar
16k ¢ di Kody, sembra che la musica popolare
abbia ormai esaurito Vinfluenza sulla musica
colta, Credi che in Argentina la situazione sia
EB Se si crede ancora alla validita di un cer
to tipo di musica, quella tonale per intenderci
Tutilizzazione div questi spunti pud rivelarsi
fondamentale. Vi sono infinite possibilita da
sfruttare, € non soltanto nel folclore argentino.
Un nostro compositore, Valdo de los Rios, fi
lio di una cantante di musica popolare e dota
to di un’ottima preparazione tecnica, pur limi-
tandosi semplicemente ad orchestrare diversi
‘motivi tradizionali, ha fornito dei bellissimi sag
gi in questo settore,
RC: Quali sono le opere moderne che attua
‘mente interpreti, € quali sono le ragioni delle
tue preferenze?
E.B.: Io suono poche composizioni contempo:
ance. Tra di esse la Sonata di Buenagu, wn au:
tore che conosco personalmente, ¢ con’ cui c’®
stata Ia collaborazione attiva che dovrebbe sem:
pre unire interprete © compositore. Egli ha
sctitto per tre volte il terzo tempo della Sonata,
€ cid non sarebbe stato possibile se non avessi-
mo potuto lavorare insieme. In caso contrario
bisogna accettare da un autore il risultato com-
piuto, non sempre questo pud giovare in fase
esecutiva. Un’altra opera importante per me &
Suoni notturni di Petrassi, dove ho incontrato
un’atmosfera affascinante @ un messaggi che
mi ha colpito immediatamente. Per lincisivita
ritmica apprezzo molto Leo Brouwer, del quale
interpreto alcune composizioni. In futuro pen-
so di affrontare altzi lavori contemporanei, tra
cui Tenebrae factae sunt di Gilardino, un bra-
Emesto Bitett
no che ho avuto occasione di ascoltare in que:
sti giorni dal suo allievo Marco De Santi. Per
quanto riguarda i criteri delle mie scelte posso
dirti che esse mi portano sempre verso quella
musica in cui io possa identificarmi, ¢ che nello
stesso tempo sia comprensibile a un pubblico
abbastanza vasto.
RC: Tw suoni con unghie molto Innghe. Po-
tresti dirci qualcosa sui motivi che t hanno
spinto a scegliere questa particolare forma?
E.B.; Le mie unghie, pur essendo cost lunghe,
sono natutali, e non artificiali come si potrebbe
credere. Siccome sono molto deboli, pongo su
di esse diversi strati di uno smalto (il Pro life)
che consente di creare una grande solidita. Inol-
tre, siccome le mie unghie sono totalmente se-
parate dalla carne, hanno bisogno di una mag
giore lunghezza, in modo che Ia loro superficie
adetisca totalmente alle corde. Ottengo cosi un
suono pitt potente, che mi avvantaggia special-
mente quando suono con l’orchestra
R.C.: La chitarra su cui suoni & una Fleta, alla
quale sei fedele gid da molti anni. Quali sono le
Caratteristiche di questo strumento?
EB: La migliore qualita della Fleta & il tipo
del suono: pastoso ¢ profondo, che si addice
perfettamente al mio tipo di unghie. In ogni
cotda vi 2 un grande equilibrio, e ciascuna di
esse possiede una propria personalit), Natural
mente la Fleta ha anche potenza, ma unita ad
uno straordinario prolungamento del suono,
RC: Tu hai eseguito alcune opere del reperto-
rio ottocentesco, nia poche se si tiene conto del-
Ja letteratura esistente. Hai intenzione di inseri.
re altre composizioni dell’epoca nei tuoi futuri
programmi?
E.B.: Si, € non soltanto penso di interpretare
pezzi a solo di Giuliani, Legnani ed altri autori,
ma anche musica da camera dello stesso perio-
do. Vorrei incidere al pidi presto un disco in cui
la chitarra faccia parte di un trio, insieme al
violino, alla viola o al violoncello. Occotte riva-
Tutare questo repertorio, ancota troppo poco
conosciuto.
—a@IBIo—
R.C.: In occasione di concerti con orchestra, tu
tsi spesso il microfono, ma non tutti i chitarvi-
sti si sono decisi a compiere questo passo. Cre
di che questo accorgimento sia a volte necessa
rio anche quando si suona come solisti?
E.B.: Non si dovrebbe mai impiegare il micro-
fono in quest’ultimo caso, poiché ne risentiteb-
be 1a qualita timbrica. Con l’orchestra la que-
stione & diversa, poiché Ia quantita del suono
® molto importante, e se Ia sala non possiede
tuna buona acustica l’amplificazione diventa ad:
dirittura necessaria. Oggi possiamo giovarci di
ottimi apparecchi, ma bisogna che il suono giun-
ga con eguale intensita a tutti gli ascoltatori e
hon, come purtroppo avviene con frequenza, in
maniera incostante. La chitarra non. richiede
perd un’amplificazione enorme, ma soltanto un
piccolo aiuto: cid & sufficiente per risolvere il
problema. Quando si ha la fortuna di disporre
di un’orchestra di grande pregio, come la En-
glish Chamber Orchestra con la quale ho suo-
ato di recente, 'inconveniente del. rapport
sonoro sparisce quasi completamente, ma se in-
vece gli strumentisti non sono eccellenti o il di
retrore ha poca esperienza nei confronti, della
chitarra, allora nascono parecchie complicazio-
ni, Ad esempio, Porchestra mediocre si trova in
dilficolta nei “pianissimi”, che sono invece co-
si necessari per l’equilibrio con la chitarra!
RC: Come tutti i grandi concertisti tu sei un
po’ un cittadino det mondo. Quali sono le con
dizioni della chitarra nei paesi che hai visitato?
E.B.: La nuova vita della chitarra si manifesta
ovungue, € questo risveglio & il pitt importante
di tutta Ja sua storia, Naturalmente non esiste
solo la chitarra classica, ma anche la chitarra folk
¢ la chitatra jazz. Ho osservato perd che anche
gli esecutori di pop music ascoltano volentieti
i recitals di chitarra classica, e si sentono invo-
sliati a studiatla, Generalmente queste persone
non ascoltano altri concerti, ma sono attratt
dallo strumento, che compie cost un ruolo di
divulgazione musicale, Sono convinto che il fu
turo sari sempre pid favorevole alla chitarra,
gid oggi amata da un numero enorme di per
GLI INTERESSI CHITARRISTICI
DI PAGANINI
A BEN 239 anni dalla scomparsa di Nieold
Paganini tutta Ja sua opera attende ancora
tuna obiettiva rivalutazione che la inquadri nel
contesto della produzione strumentale del pri-
mo Ottocento e, per quanto riguarda la musica
cameristica con chitarra e specie quella molto
abbondante per chitarra sola, tutto 0 quasi ri-
mane addirittura inesplorato. Infatti, se da un
lato le composizioni chitarristiche possono ve
nin elencate con sufficiente approssimazione
dall'altro finora nessuno studioso competente
in materia ha avuto la possibilita di esaminarle
nella loro globalita per poter giungere a delle
valutazioni sufficientemente attendibil.
Questa dunque Pattuale scoraggiante situa-
ante si siano presentate almeno tre
approfondito esame del retaggio musicale pa
ganiniano. Ecco, in sintesi, i fatti:
— nel 1908 i nipoti del Maestro offrirono in
vendita al Ministero della pubblica istruzione
tutti i manoscritti ereditati; una commissione di
nomina ministeriale (composta da Ettore Pinel:
li, Enrico Polo e Luigi Torchi), valutata la con
sistenza artistica del ponderoso fondo, pur rite
nendo validi solo il 3°, 4° e 5° Concerto per vio
lino (poi vincolati a termini di legge) giudicd
tuto il resto di assai scarso pregio;* Pesame fu
portato a termine in soli cingue giorni e venne
raccomandato Pacquisto del blocco, ma il Mi
ristero non accolse la raccomandazione;
= nel 1910, eccetto i tre Concerti, il fondo fi
ni all’asta e, in tale occasione Arnaldo Bonaven-
tura, ne Gli autografi musicali di N. Paganini,
catalog, descrisse e valutd i manoscrittis
— nel 1971, dopo vari trasferimenti di pro-
prietd avvenuti in Germania, il fondo, acqui-
stato dallo Stato, rientrd in Italia e nel 1972
1. Gir. Owpnerra Macearznat, Catalogo delle opere per
lita di Nicolo: Paganint (in « Quaderi dell Tsteato dh
Sadi Papaninian » n. 2, setembre 1974, Genova, p. 47),
2. Cir Gran Caso Constante, Vita di Niccold Pega
ini, cova ed, con ageiunte e note di Fenrnico MompEt
1a, Sie erie Dante Alighieri, Milano Genova Roma
Napoli, 1936, pp. 4495,
venne affidato alla Biblioteca Casanatense di
Roma, dove, in occasione della Mostra di auto-
grafi € manoscritti di Paganini, allestita nello
stesso anno, venne stampato un catalogot (cu-
rato dalla dr. Orchidea Salvati) che purtrop-
po non reca alcun contributo critico apprez-
zabile; pur trovandosi in una biblioteca pub
blica, la collezione non @ accessibile a tutti gli
studiosi.
Va ora sottolineato che i componenti quel
la commissione ministeriale, come pure il Bona-
ventura, per quanto riguarda le composizioni
per chitarra non avevano alcuna specifica com-
petenza tecnico-strumentale per cui le loro va
lutazioni in proposito lasciano molto perpless
E la perplessita aumenta se si tien conto che
cinque giorni non possono esser stati sufficien-
tialla commissione per giungere a delle valuta-
vioni ben ponderate: gia la lettura di certi au-
tografi di Paganini, e specie di diversi per chi-
tarra, comporta perdite di tempo per !a decifra-
zione (spesso il Maestro vergd con scrittura
nervosa, veloce e in molti casi non chiara, qua
€ la depennando e correggendo). Ne Gli auto:
grafi musicali di N. Paganini, poi, il giudizio
del Bonaventura sullinsieme delle composizio.
ni per chitarra @ addirittura settario ¢ inficiato
sin dall’esordio dall’avversione preconcetta per
lo strumento, Ecco come mostrd di non condi:
videre gli interessi di Paganini per la chitarta
To non pretendo certamente di attribuire sover:
chia importanza artistica alle composizioni pet chi
tarra 0 colla chitarra, data V'indole di questo str
mento inferiore 0, per dit meglio, di questo stru
mento destinato per la natura sua’piuttosto ad ac
compagnare il canto popolatesco, circonfondendolo
di una special poesia, che a tradurre, come stra
mento di concerto, le manifestazioni dell’ arte pit
3. Anwaipo Bowavexruns, Gli autograft musical iN.
Paganini (in, « La Bibliofiia», anno XII, dispensa 1,
aprile. 1910, Leo Olschki, Firenze).
4, Brpuroveca CasanaTense, Mostra di autografi ema
noscrité di Niccolo Peganini, Roma 1972.
I
alta e pit: nobile. Dico peraltro che le composizio
ni del Paganini per chitarra suscitano un interesse
4h viva curiosita, appunto perché raro trovare,
specie nei tempi moderni, chi si sia dedicato a
scrivere con intendimenti artistici per quello stru-
mento: onde, sebbene non sieno mancati,. dal Car-
cassi all’Aguado, al Mertz, al Regondi, al Tarreya
[sic], compositori di musica per ‘chitarra, certo la
non ricca letteratura chitarristica viene ad accre-
teersi notevolmente e, quasi direi, a nobilitarsi, per
Te composizioni di Niccold Paganini.*
Una tale presa di posizione oggi non pud che
far sorridere persino coloro che hanno un’idea
appena sufficiente sulle reali possibilitA espres
five della chitarra’ ed ancor pitt coloro che san-
no che la letteratura chitarristica non si pud de~
finite “non ricea’” per l’apporto dovuto proprio
‘a quei chitarristi-compositoti che il Bonaventu-
ra stranamente non cita: stranamente perché
egli, come studioso paganiniano avrebbe, dove:
to quanto meno essere al corrente dell esistenza
degli italiani Carulli, Giuliani e Legnani i qua
Ji, appunto, ebbero contatti con Paganini. An-
che se al Bonaventura va riconosciuto il merito
i aver curato per primo la catalogazione ¢ la
descrizione degli inediti, V'effettivo pregio di
gquesta parte del suo saggio deve aver inopina-
tamente procurato credibilita pure alle sue va-
Jutazione critiche sulla produzione chitarristica,
come risulta evidente dal fatto che, sostanzial-
mente, hanno purtroppo fatto capolino in suc-
cessive monografie di argomento paganiniano.
1 catalogo edito dalla Biblioteca Casanaten-
se, a sua volta, ha il pregio di offrire una cata
Togazione completa del prezioso materiale ma,
specie nelle relative descrizioni, contiene un
jgran numero di inesattezze ed errori che sareb-
be inutile e troppo lungo elencare.
Nella stessa Biblioteca, oltre a pid di 125
pezzi per chitarra (tra cui 42 Ghiribizzi, quasi
40 Minuet? e composizioni varie) sono custo-
diti lavori per chitarra ¢ violino (Grande Sona-
ta a chitarra sola con accompagnamento di vio-
lino e Sonata concertata), per violino e chitarra
(Cantabile e Valtz, Duetto amoroso, 6 Duetti,
Centone di Sonate contenente 18 Sonate, 60
Variazioni sul Barucaba), gli accompagnamenti
per chitarra di Maria Luisa-Suonata con varia
5. A. Bonaventura, Git autograft mauscal (3 itp. 7.
2 th Neguno il Bonaventura, pur riportando”inteprl
meice quanto. avevaseitto sulla-« non_ricea, eteratura
mtralicn (Wi compreso il nome storpiato Tarreya io
Shits Gurcen) sit espreno meno negativamente ne Con
Pessailaele chitara (ele. Amwauno Bonaventura, Niccold
Togonint A. TF. ormiggini, Modena 1911, pp. 1819).
6
zioni ¢ della Sonata per la gran viola, Canzo
nnetta per voce chitarra, Serenata a viola, chi
tarra e violoncello, Terzetto per violino, violon
cello e chitarra, 2 Terzetti per due violini ¢ chi-
tarra e 9 Quartetti per violino, viola, chitarra
€ violoncello (il 2°, 7°, 8°, 9° 10°, 12°, 13°, 14"
© 15° di cui, come appare dal catalogo della Ca-
sanatense, ['8, i 10°, il 14° ¢ il 15° sono auto-
grali). Tnoltte, presso Biblioteche varie o colle-
Fionisti privati, vi sono ancora altre composizio
‘hi autografe 0 manoscritte, ma solo poche di
queste non sono comprese nel fondo della Ca-
Sanatense, cosi a S. Cecilia in Roma si trova
Pautografo della Serenata per due violini e chi
tatra, a Parma la Sonata per Revene per viol
no e chitarta, pure autografa al Conservatorio
Gi Parma PArietta per violino ¢ chitarra, nella
collezione Maia Bang Hohn di Washington 5
Quartetti per violino, viola, chitarra ¢ cello (il
TO, 11°, 12%, 13° e 14” autografi ¢ il 15°, in
cai ® protagonista la viola, in manoscritto) ¢,
presso P'Istituto di Studi Paganiniani, di Geno-
Ba le Variazioni su ‘La Carmagnola” pet vio
Tino e chitarra ed una copia della parte del vio
lino solista con Paccompagnamento di chitarra
del Grande concerto in mi minore (postumo ma
anteriore agli altri cingue, edito nel 1973 dallo
stesso Istituto in partitura con Vorchestrazione
Heostruita da Federico Mompellio). Sono poi
conservate copie di musiche con chitarra non
fnedite nel Conservatorio di Genova € presso
i marchesi Cartega.
"Tra le non molte composizioni fatte pubbli-
care da Paganini, quelle riguardanti la chitarra
sono le seguenti: Sei Sonate Op. 2 ¢ Sei Sonate
Op. 3 per violino e chitarra; Tre Quartetti Op
de Tre Quartetti Op. 5 per violino, viola, cel
Joe chitarra, Dopo la sua morte, il figlio Achil
le, suo erede universale, nel 1851 acconsent{
che venissero stampate importanti composizio
fni ma, se non andiamo ertati, solo una che com-
prendesse lo strumento a pizzico, ciot le citate
60 Variazioni sul Barucaba. Poi, nel periodo in
cui il cospicuo fondo si trovava in Germania,
Ja casa W. Zimmermann di Francoforte sul Me
rho ha dato alle stampe 26 Originalkomposiio
ren per chitatta, la Grande Sonata a chitarre
7, Par di taglio bipartito, di solito i Minuet di Papas
anivaon presentano le catateristiche di gueste dante ¢,
Nolte, sono ai concezione vitruosstca
Meche" Rowann Nett, I riforn! di Pepanini (in « Re
senna musicale’ Cure» anno XXVIL, a, 1, aprile 1974
GRE, Milano, p. 6). Linteressante studio contiene anche
Souse ben eentratigiudizt su Paganini compositore
sola con accompagnamento di violino, la Sona-
ta concertata per chitarra e violino, le prime sei
Sonate del Centone di Sonate per violino ¢ chi-
tarra, le Variazioni di bravura per violino ¢ chi-
tarra (sul 24° Capriccio, ma la parte di chitarra
aggiuntavi non @ sicuramente attribuibile a Pa-
ganini), il Cantabile in re maggiore per violino
e chitarra (la parte di chitarra & trascritta da
quella autografa per pianoforte), la Tarantella
per violino e chitarra (il cui accompagnamento
per chitarra & stato ricavato dalla partitura per
violino e piccola orchestra), il Terzetto in re
maggiore per violino, cello ¢ chitarra, il Ter-
zztto concertante per viola, chitarra e cello ¢ il
Quartetto 7° per violino, viola, chitarra e cello;
coi tipi della Casa Schott’s Séhne di Magonza
usciva un Quartetto in re maggiore per lo stes-
so organico; dalle Edizioni Bérben di Ancona
sono state pubblicate Tre compasizioni inedite
per chitarra e la Serenata per due violini e chi-
tarra (Pautografo di questa si trova perd a S.
Cecilia in Roma).
Quando Paganini comincid ad accostarsi alla
chitarra, questa, dopo un periodo di stasi, stava
allineandosi al movimento di profondo rinnova-
mento strumentale allora in atto. In quel te
po di fervida evoluzione Ja scrittura chitarri-
stica, nelPadeguarsi progressivamente alle nuo-
ve esigenze estetiche, attraversd una fase in
aiale ~ fase che ebbe pure qualche strascico —
in cui si presentd con caratteristiche stenografi-
che che non consentivano una costante indivi
duazione dei rispettivi valori relativi a ciascuna
parte del tessuto musicale, e cid in anal
quanto si verifica nella scrittura tecnico-violini-
stica. Non deve pertanto stupire se nelle com-
posizioni chitarristiche sia prevalso in Paganini
Vabito mentale derivatogli dalla sua formazio-
ne violinistica, abito che lo ha portato ad espri-
mersi con una scrittura sommaria e, per quanto
riguarda certi dettagli, a non curarsi delle effet-
tive possiblita dello stramento di cui tuttavia
aveva una conoscenza profonda. Avvenne infat-
ti che, limitatamente a quei dettagli, benché
consapevole che la prassi esecutiva non avrebbe
consentito il prolungamento di certi suoni (spes-
so i bassi), che per esigenze musicali si sarebbe-
10 dovuti mantenere, si accontentd che ne ve-
nisse accennato il solo stacco, proprio come, ad
esempio, avviene immancabilmente se al violi
no si debbano eseguire quattro suoni simulta
nei, E perd molto probabile che, prima di even:
tuali pubblicazioni ~ non si dimentichi che in
vita non fece in tempo a dare alle stampe alcu-
nna composizione per chitarra sola — egli avreb-
be opportunamente perfezionato quelle stesure
originarie e, a maggior ragione, avrebbe pure
sviluppato ogni suo lavoro da cui traspare con
evidenza la tipica provvisorieta che caratteriz-
za V’'abbozzo.
Nel rendere noto che nel presente articolo
ogni nostra considerazione pid che altro detiva
dall’esame delle musiche finora pubblicate, os
serveremo che Ja scrittura paganiniana, pur di
concezione personalissima, rispecchia tutti i ca
noni della scuola chitarristica italiana dell’Otto-
cento che, tra altro, ammetteva l'uso del polli-
ce sinistro sulla 6° corda e, in certi casi, anche
sulla 5*, Questa particolarita tecnica, purtrop:
po in Paganini non espressamente indicata, tal:
volta veniva praticata per ricavare degli effetti
sonori che, ovviamente, devono venir riprodot
ti anche con Ja tecnica attuale, sia pure a costo
di accrescere le difficolta di esecuzione. II Mi
nuetto in la maggiore (il n. 15 dell’Ed. Zimmer:
mann), alla 5* misura come alla 6* che 2 identi-
ca, ad esempio, presenta un caso del genere in.
cui Valternarsi nel basso del do diesis col la “a
vuoto” produce un bell’effetto di “legato” che
viene molto agevolato dall’uso del pollice sini-
stro che, data la sua impostazione ottocentesca,
non pud correre il rischio di intralciare le vi
brazioni della 5* corda. Ecco come, sia pure
meno agevolmente, si potrebbe ottenere leffer-
to voluto da Paganini seguendo i dettami della
tecnica moderna (facendo perd attenzione che
il 1° dito non intralci inavvertitamente le vi
brazioni della 5° corda):
Si @ gid visto che, a causa della sua sintetici
12, la scrittura chitarristica di Paganini compor-
ta dei problemi interpretativi, se poi si conside-
ra che essa di solito non é corredata dalle indi
cazioni di tempo, dinamiche ed agogiche, allo
1a appare chiaro che tali problemi non possono
che aumentare. Nel cercare di risolverli, ¢ per
una pid stretta aderenza allo stile paganiniano,
potri forse rivelarsi utile riflewtere sugli inten
dimenti espressivi insiti nelle svariate indicazio.
ni introdotte da Paganini stesso in molki suoi
lavori cameristici, come, ad esempio, con anima,
con passione, vivo e spiritoso, galantemente,
scherzoso, amorosamente, piangendo, innocen:
temente, calando, ecc., indicazioni che, di gu-
sto prettamente romantico, sono sottilmente
compenetrate nei piti diversi atteggiamenti emo-
tivi € psicologici?
‘Al fine di illustraze Ia reale portata degli in-
teressi di Paganini per la chitarra, ci riferiremo
spesso a quanto egli stesso ebbe a scrivere in
proposito e, per diverse documentazioni, cis
vviremo del suo epistolario pubblicato dal Codi
gnola in Paganini intimo.”
‘Che Paganini sia stato un abilissimo chitarri-
sta ce lo testimoniano inconfutabilmente le ar
ditezze tecniche presenti in certi suoi lavori, ma
non si sa invece né come né quando egli abbia
iniziato lo studio dello strumento. E perd certo
che il suo accostamento alla chitarra & avvenuto
sin da ragazzo dato che nel luglio del 1795,
quando cio® non aveva ancora compiuto tredi-
ci anni, al suo esordio violinistico ‘ufficiale al
Teatro Sant’Agostino di Genova esegui le Va
riazioni su “La Carmagnola” da lui composte
pet violino e chitarra. Inoltre, come risulta d
la sua breve autobiografia, “per qualche anno
gli prese « gusto a pizzicare Ia chitarra »:" si
tratta cio’, secondo i piti autorevoli studiosi
paganiniani, del periodo compreso tra il 1801
¢ il 1804, durante il quale non svolse attivita
concertistica. E perd pure noto che egli non ab
bandond mai la chitarra, sia perché se ne servi
per il suo ininterrotto lavoro di compositore, &
sia perché, anche se non in pubblico, la suond
solisticamente ed in esecuzioni di proprie mu-
siche da camera. E il suo attaccamento ad essa
2 confermato da lui stesso, ad esempio, in una
Jettera del 26.2.1824 inditizzata all'avv. Luigi
Guglielmo Germ, violinista dilettante, suo le-
gale e intimo amico (si noti anche il palese ti-
more di possibili plagi delle proprie opere)
Jo non suono quasi mai, ma accompagno spes-
sissime volte colla chitarra il Sig. Generale ([Dome-
nico Pino] qualche sonatina che gli ho composto,
¢ tale musica, se fossi Samo che il Sig. Botto non
Ja imprestasse a nessuno, gliela farei copiare pet
inoltrargliela, Che ne dici?”
Inoltte, dimostrando di avere a cuore i pro-
pri Quartetti con chitarra, ancora col Germi si
rammaricd che aveva dovuto rinunciare ad ese-
guirli a Palermo e a Napoli per non avervi tro
vato chitarristi preparati.” Ma, sempre nella
stessa letteta, quasi a voler fugare l'amara de
Iusione, incaricd 'amico’di salutare « il pitt bra
vo armonista, e professore di chitarra (Luigi)
Riva > rimarcando: « questi & Vunico pet i mi
Quartetti »." Petd stimd molto anche le capaci-
1h chitarristiche del fratello Carlo, egli pure vio-
linista, Cost infatti scrisse al Germi: « non sa
1 difficile ch’io lo facia venire qua [a Milano]
per suonate colla chitarra i miei Quartetti che
bramerebbero sentire. »" Nella stessa lettera
chiese Finvio dei « Ghiribizzi di Chitarra, che
‘amo rivederli prima di fame tirar copia »,” ¢,
successivamente, su tale raccolta espresse que-
sto indicativo giudizio:
Li Ghiibizai di chitarra dovettero servire ad una
bambina di Napoli, e non volli comporse ma sca-
raboechiare; ma petd non dispiaceranno eesti moti-
vii sentiti, e per passare il tempo non farai male
Ge ne hai copia) di farli vedere all'amabile figlia
del Sig. Botto.”
In diverse occasioni Paganini manifestd il
proposito di dare alle stampe tutte le sue com-
posizioni, ivi naturalmente comprese quelle pet
econ chitarra, ma non poté realizzare il suo as-
sunto solo perché impedito dalla morte soprav-
venuta troppo presto. Si sa, per esempio, che
egli progeitd di pubblicare ‘suoi lavori presso
Teditore Pacini di Parigi e che, in seguito, di
proprio pugno compild un Elenco dei pezi di
rusica da stamparsi.* Ed anche su questi pro-
positi & ancora il suo carteggio a venisei in 90c-
corso:
‘Tutta 1a professione, nonché i Maestri di Cap-
pella, mi pregano di dare alle stampe la ria musica,
ed attendono pure con impazienza il metodo pet
9, Nella letter
soo amico Germ: « Come trattl i
‘Sdetmo sida una idea del suonaze parlante,» (ARTURO
Choicnows, Pagenint fatima, edito a €ura del Municipio
F Geneve, Genova, 1925, p- 316). La locuzione “suonare
Slatante” di per he stessa ct offre Tidea di quanto sia pre
Preate il rwolo dellespressvith nelle esecuzioni di mu
‘che paganiniane
Tope amor’ di precsione confronteremo costante
mente le correioni che, previo control degli autogafi,
Rego tate apportate da Pietro Berri e Zdenek Vyboeny
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- Bicinia Sui 12 Modi Zarlino3Document27 pagesBicinia Sui 12 Modi Zarlino3fabyguitar6660No ratings yet
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- TANSMAN-Pieces Faciles PDFDocument12 pagesTANSMAN-Pieces Faciles PDFfabyguitar666080% (10)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- BACH Cello Suites For ViolinDocument45 pagesBACH Cello Suites For Violinfabyguitar6660100% (1)
- Liuto Gentile GarganoDocument2 pagesLiuto Gentile Garganofabyguitar6660No ratings yet
- Durighello PesachDocument3 pagesDurighello Pesachfabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Sehnsucht Nach OscarDocument1 pageAA. VV. Sehnsucht Nach Oscarfabyguitar6660No ratings yet
- SDL - ITA - Il Liuto - Numero18 - WebDocument48 pagesSDL - ITA - Il Liuto - Numero18 - Webfabyguitar6660No ratings yet
- Bottesini-Carulli Cavatina Dall'op. Andronico Di MercadanteDocument4 pagesBottesini-Carulli Cavatina Dall'op. Andronico Di Mercadantefabyguitar6660No ratings yet
- Calegari Sonata Op8Document7 pagesCalegari Sonata Op8fabyguitar6660No ratings yet
- De Selma, Fantasia Sobre El Canto Del CaballeroDocument3 pagesDe Selma, Fantasia Sobre El Canto Del Caballerofabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Journal Fur Gesange Und GuitarreDocument4 pagesAA. VV. Journal Fur Gesange Und Guitarrefabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. RomanceDocument2 pagesAA. VV. Romancefabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Tiroler Alpenlieder n.2Document3 pagesAA. VV. Tiroler Alpenlieder n.2fabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Lied Des TrostesDocument1 pageAA. VV. Lied Des Trostesfabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 077Document56 pagesFronimo 077fabyguitar6660No ratings yet
- Gragnani, Duo Per 2 Chit Dedicati e CarulliDocument35 pagesGragnani, Duo Per 2 Chit Dedicati e Carullifabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Schweiz HeimwDocument3 pagesAA. VV. Schweiz Heimwfabyguitar6660No ratings yet
- AA. VV. Aria FavoritaDocument3 pagesAA. VV. Aria Favoritafabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 071Document71 pagesFronimo 071fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 076Document64 pagesFronimo 076fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 073Document66 pagesFronimo 073fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 074Document67 pagesFronimo 074fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 064Document73 pagesFronimo 064fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 067Document64 pagesFronimo 067fabyguitar6660100% (1)
- Fronimo 070Document62 pagesFronimo 070fabyguitar6660100% (1)
- Fronimo 065Document60 pagesFronimo 065fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 066Document70 pagesFronimo 066fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 072Document68 pagesFronimo 072fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 063Document69 pagesFronimo 063fabyguitar6660No ratings yet
- Fronimo 060Document59 pagesFronimo 060fabyguitar6660No ratings yet