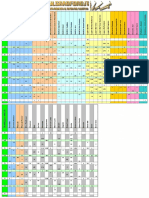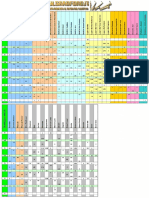Professional Documents
Culture Documents
Armonia Complementare - 2 PDF
Armonia Complementare - 2 PDF
Uploaded by
Marco0 ratings0% found this document useful (0 votes)
38 views39 pagesOriginal Title
Armonia complementare_2.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
38 views39 pagesArmonia Complementare - 2 PDF
Armonia Complementare - 2 PDF
Uploaded by
MarcoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 39
40
ACCORDI DI CINQUE SUONI
Come quelli di settima, anche quelli di nona si raggruppano in specie, a se-
conda della diversa costituzione dei loro intervalli.
Sono accordi assai importanti, ma, per le esigenze dell’armonia complementare
bisognerd limitarsi allo studio dei pit usati, fra i quali la nona di prima specie e
cio’ di dominante.
L’accordo in parola si realizza in due «forme»:
1) Nona maggiore - data sulla dominante del modo maggiore.
2) Nona minore - data sulla dominante del modo minore (0 maggiore armonico).
Come la settima, cosi anche la nona di dominante non si prepara ma rimane,
invece, Pobbligo della risoluzione delle dissonanze (nona e settima) che risolvono nor-
malmente sull’accordo di tonica.
Ha quattro rivolti, ognuno dei quali presenta un particolare e interessantissimo
aspetto (benché Vultimo sia scolasticamente vietato).
In ogni modo Taccordo deve essere sempre disposto in maniera da avere la nona
a distanza di nona dalla fondamentale e di settima dalla sensibile.
Data a quattro parti si omette la quinta (fatta eccezione necessaria per il se-
condo rivolto).
Ecco gli esempi relativi:
J ==
f
d_|o ad
e (Pir [tr
= i
Vere er vg ot ve 16 v§ 16
Tra le altre pit notevoli: quella data al II grado del modo maggiore (0 al IV
del modo minore) :
119 di Do mage.
Opp 1V® di La min.
eal IV del modo maggiore stesso:
La pia fervida e smagliante vita degli accordi di nona si manifesta nella lette-
ratura romantica e particolarmente nelle opere di Franck, Wagner, Fauré, Puccini e
Debussy.
B. 5856 ©.
41
ACCORDI DI UNDICESIMA E TREDICESIMA
Rappresentano le ultime possibilitd di accordi costruiti a sovrapposizioni di
terze: si usano spesso incompleti :
e hanno spessissimo carattere di appoggiature o di ritardi anzich® di reali accordi.
LA MODULAZIONE
Modulare significa passare da una tonalita all’altra. La tonalita ha due «rap-
presentazioni»: quella melodica, data dalla «serie» dei suoni della relativa scala
(maggiore o minore) nessun suono escluso. —
Essere in Do maggiore significa «melodicamente» sentire tutti i suoni della scala
stessa (in qualsiasi ordine) ma senza omissioni
GH ss,+-]
(8 26 5 4 7 4)
I si mancante p. es. lascia il dubbio di un possibile sib; il fa mancante quello
del fa, il mi mancante quello del mi b, ecc.
La rappresentazione armonica della tonalita si ha, invece - come gid dimostra-
to - con la «presenza» e la «sommay delle armonie (accordi) che rappresentano tufti
i gruppi armonici - senza omissioni - e precisamente (per la logica «onale» stessa)
nell’ordine: sottodominante, dominante ¢ tonica.
Cosi p. es. la tonalita di Do maggiore ha la sua pid chiara e completa rappresen-
tazione armonica nelle successioni:
IVvot
Nei riguardi del processo modulativo si distinguono :
Tonalita in primo grado di vicinanza (vicine).
Tonalita in secondo grado di vicinanza.
Tonalita lontane.
BE. 6856 ©.
42
MODULAZIONE AL PRIMO GRADO DI VICINANZA
(TONL VICINT)
I toni in primo grado di vicinanza sono quelli che portano in chiave una sola
alterazione differenziale (in pit o in meno) rispetto a quella data (oltre al relativo
tono maggiore o minore che non ha differenze nell’«armatura» della chiave).
P. es. Sol maggiore (1 # in chiave) ha come toni vicini :
1) Mi minore (lo stesso # in chiave).
2) Re maggiore e Si minore (con 2 # in chiave).
3) Do maggiore © La minore (nulla in chiave).
Si pud modulare ai toni vicini mediante vari sistemi, Tra i pit importanti
To - Modulazione diatoni
a) Per mezzo di un accordo comune.
Il processo modulante si divide in tre momenti:
1) Tono di partenza.
2) Accordo comune - consonante o dissonante - che appartiene - sotto due aspetti
diversi (cio& come grado diverso) - sia al tono di partenza che a quello di arrivo
e che stabilisce i] epunto di entratay nel nuovo tono.
3) Tono di arrivo stabilito e confermato definitivamente dagli accordi che rap-
presentano in sintesi la nuova tonalita.
Si voglia modulare da Do maggiore a Mi minore: posto l’accordo di Do come
punto di partenza si fara seguire la triade di Sol:
1 V di Do Maggiore
III di Mi minore
la quale, mentre & Paccordo di dominante del tono di partenza, rappresenta Va
cordo del {17 grado del tono di Mi minore stabilendo cosi il legame pitt ovvio
fra le due tonalita.
Si faranno seguire i gradi IV-V e I del tono raggiunto ¢ la modulazione (per
quanto brevissima e sintetica) sara completa:
I VdiDoIv V I
Idi Mi
Evidentemente la modulazione potra essere ampliata (e resa quindi pit evidente
e gradevole) mediante I'uso di un maggior numero di accordi (consonanti, disso-
EB. 5856 C.
43
nanti, fondamentali o rivoltati) concorrenti alla maggiore chiarificazione del pro-
cesso di «eambiamento di tono», p. es.
es
1 VaiDo Iv ‘vie 16 v6 If v7 1
Midi Mi
L'accordo comune pud perd, in molti casi, appartenere gid al gruppo armonico di
sottodominante; in tal caso si pud passare subito al gruppo armonico di dominante
e confermare poi il tono raggiunto mediante adatte cadenze conclusive.
Nel caso di modulazione da Do maggiore a Mi minore:
I VidiDo v 16 m6 Vv Tv
IV di Mi
Ancora: (gruppo di SD)
Laccordo comune pud, invece, appartenere al gruppo armonico di dominante. Se
si tratta dell’accordo di dominante vero e proprio sara bene passare subito in ca-
denza evitata oppure risolvere in tonica rivoltata (per non conchudere) e poi proce-
dere alla stabilizzazione del tono con gli accorgimenti armonici gid studiati.
Modulando da La minore a Fa maggiore si avra:
I Wldilavir ug 1 v7 T
V di Fa
Se si tratta, invece, di una triade di sensibile (evidentemente allo stato di § bi-
sognera per forza risolvere subito in tonica (rivoltata perd, per il motivo gia det-
to) e fissare poi il nuovo tono con le cadenze necessarie:
Modulando da La minore a Do maggiore si avra:
I USdita 1® Iv 1g v7 I
VIISdi Do
B, 5856 Cc.
44
Fra i toni vicini, perd, Vaccordo di tonica del tono di partenza & gid quasi sem-
pre accordo comune, appartenendo sotto due aspetti diversi alle due tonalita.
La modulazione, in tal modo, @ pitt facile e si sviluppa ancor pit semplicemente :
Passando da Do maggiore a Mi minore si otterra :
=
Idi Do Iv VIIé 16 116 v7 I
‘Vidi Mi
Data la strettissima parentela esistente fra i toni vicini si pud anche «attaccare» imme-
diatamente (cio subito dopo quello di toniea del tono di partenza) V’accordo di
tonica del tono di arrivo (che poi 8 quasi sempre comune) facendolo seguire (anzi-
ché precedere) dagli elementi armonici necessari alla conferma del tono stesso
Passando da Fa maggiore a La minore si avra:
I WidiFa Wé v mous i v7 1
Tdi La(e gia - quindi - accordo comune)
Un caso particolare ¢ interessante si presenta quando l'accordo comune fra i due
toni @ il III grado del tono maggiore di arrivo (comunque si parta da un tono
maggiore 0 minore).
Si_pud usare (come spesso fanno i grandi autori, come p. es. Beethoven) un pro-
cedimento spiccio che si vale di un movimento «per linea» del basso che porta
subito - dopo il TIT grado attraverso un V3 - alla tonica voluta, senza toccare al-
cun accordo del gruppo di sottodominante. .
Comunque V'armonia di sottodominante potrd «seguires in forma di cadenza pla-
gale aggiunta.
Ecco un caso: passando da Fa maggiore a Si b maggiore:
=
I VidiFa V8 1 I6 IV I
Til di Sib (Cadenza plagale)
b) Per mezzo del suono caratteristico.
Lielemento essenziale per la modulazione @ certamente il suono caratteristico che
differenzia le due tonalita. Si pud quindi tralasciare il «ponte» dell’accordo com
ne per passare a un tono vicino, ricorrendo invece a un accordo che contiene il
BE. 5856 Cc.
45
suono caratteristico (e che - percié - appartiene subito ed esclusivamente al tono
@arrivo).
Tale sono caratteristico sara inquadrato (a seconda dei casi) in un’armonia del
gruppo di sottodominante 0 di dominante.
Passando da Do maggiore a Sol maggiore il suono differenziale caratteristico
fa # sara inquadrato in un’armonia del gruppo armonico di dominante del
nuovo tono:
TdiDovM®diSolI® 116 1 V7 I
Passando da Do maggiore a Fa maggiore il suono differenziale caratteristico
stb sari inquadrato in un’armonia del gruppo di sottodominante del. nuovo tono:
Idi DoIV6diFa VE 1 ug v T
I casi ora trattati riguardano solo modulazioni verso toni maggiori. Nel caso di
modulazioni verso toni minori bisogna tener presente che il modo minore ha due
suoni caratteristici (nei confronti dei suoi toni vicini) e precisamente il suono
caratteristico fissato dall’armatura della chiave ¢ la sensibile (cioe il VII grado
alzato).
La sensibile basta gid da sola a indicare con assoluta chiarezza il tono da rag-
giungere, ma V’altro suono differenziale (stabilito «in chiaves) rende, naturalmente,
completo il senso della modulazione.
I due suoni caratteristici - nella modulazione - possono servire successivamente o
simultaneamente.
Nel primo caso sara il suono differenziale in chiave che avra la precedenza, men-
tre la sensibile alterata apparirA per ultima, (Passando infatti p. es. da Do mag-
giore a Mi minore, il fa $ indica evidentemente «allontanamento» da Do, col dub-
bio iniziale fra il tono di Sol maggiore o di Mi minore.
L'intervento successive del re #f chiarisce decisamente il tono da raggiungere.
Modulando da Do maggiore a Mi minore si avra dunque:
Tee yillg een ova eee,
suono differenziale _sensibile alterata
“in,,chiave
5858 Cc.
46
Nel secondo caso i due suoni caratteristici dati insieme nella stessa armonia sta-
piliscono subito senza dubbio il tono verso il quale si modula,
Ecco Vesempio, sempre da Do maggiore a Mi minore:
1 'v@ 1 6 vg v7 1
Ile - Modulazione cromatica.
B una cvariante» della modulazione precedente e si realizza in modo che il
suono caratteristico (nel minore - come si @ visto - il suono caratteristico «decisivo»
la sensibile alterata mentre quello stabilito dall’armatura della chiave non @ stret-
tamente necessario — ma comunque utile — all'«ntelligenza» della modulazione) «ar-
rivio per semitono cromatico.
Percid nel tono di partenza bisogna cercare un accordo che contenga un suono
che alterato cromaticamente (in senso ascendente o discendente) diventi il suono
caratteristico del tono d’arrivo.
Il processo cromatico deve avvenire naturalmente nell’ambito della stessa «parte»
per evitare la falsa relazione di unisono o di ottava.
Con tale sistema la modulazione da Do maggiore a Mi minore si pud eseguire
nel modo seguente
I Wu viz 1 me v I
I vari tipi di modulazione visti possono condurre sia alla modulazione stabile
© a quella transitoria.
Nel primo caso il tono raggiunto @ confermato definitivamente’dalle formole ca-
denzali che stabiliscono fortemente il nuovo ambito tonale.
Nel secondo, la modulazione porta a un tono che - mancando le necessarie con-
ferme armoniche - 2 ancora (per chi ascolta) grado del tono precedente al quale si
ritorna, oppure 2 un elemento che trovera «posizione» in un prossimo tono «stabile».
Ecco due esempi:
Tovu7 1 v7 1 W§ t
u
Modulazione transitoria
a Re minore che rémane
I grado di Do
E. 5856 C.
47
Iwo? «x ug 1% v7 I
VI
Modulazione transitoria
a Re minore che diventa
VI grado di Fa
MODULAZIONE AL SECONDO GRADO DI VICINANZA
Modulazione diatonica.
a) Per mezzo dell'accordo comune.
& basata sul principio gid notato per la modulazione ai toni vicini
«polivalenza» di un accordo. Dato che i toni in secondo grado di
no avere almeno un, accordo in comune (consonante o dissonante) bisogna appunto
rieorrere al procedimento gid studiato per condurre In modulazione. Bisogna perd
tener presente che V’accordo in comune @ talvolta insolito perché ricercato. sui
gradi melodici delle scale minori o sui gradi armonici di quelle maggiori.
Volendo modulare da Do maggiore a Si b minore, 'accordo comune sara sempli-
cemente: fa la do.
Tale accordo @ sottodominante del tono di partenza e dominante di quello di
arrivo.
Ma modulando da La minore a Mib minore l'accordo comune potra essere sib
re fa allo stato di primo rivolto. Reppresenta Ia sesta napoletana di La minore
€ nello stesso tempo la dominante (rivoltata) del nuovo tono.
Ecco la realizzazione:
I U6Nap. I 16 1 vw I
ve
Cosi, modulando da Sol maggiore a La minore la triade di dominante di Sol
corrisponde alla triade del IV grado melodico del tono di arrivo:
rov vue © Iv Vv 1
IVmelodico
B.
48
b) Per mezzo dei suoni caratteristici.
Mentre i toni in primo grado di vicinanza si differenziano per un solo suono ca-
ratteristico i toni in secondo grado di vicinanzn hanno varie e spesso molte alte-
razioni differenziali. L’accordo modulante dovra quindi contenere in sé, non tutti,
ma quei suoni che caratterizzano senza tema di confusione il tons da raggiungere.
E si tratta quasi sempre della sensibile - specie per i toni minori - e della con-
trosensibile, spesso, anche, riunite nella stessa armonia.
Modulando da Do maggiore a Mib maggiore le alterazioni differenziali sono da-
te dai tre bemolli: si, mi. la. L’accordo modulante non potrd contenerli tutti ¢
tre. Bastera, in esso, la presenza del la b per indicare con chiarezza la direzione
della «marcia» modulante e le armonie successive stabiliranno definitivamente il
senso del nuovo tono:
1 vue 1 16 1g v7 1
Modulando da Sol maggiore a Re minore l’accordo comune avra in sé il do#, suf-
ficente da solo a indicare il tono da raggiungere :
1 ove iw we if v7 I
Modulazione cromatica.
Essendo una variante della modulazione per mezzo dei suoni caratteristici sara
necessario che il cromatismo faccia «entrare» nell’accordo modulante i suoni che
maggiormente delineano il senso del tono da raggiungere.
Cosi passando da Fa maggiore a Mi b minore si potranno alterare contempora-
neamente il la e il do che, insieme alla sensibile, saranno inquadrati in un accordo
di nona di dominante del nuovo tono:
BE, 5856 0:
49
E passando da Sol minore a Mi minore Vaccordo modulante conterra sia il re #
che il si per indicare il percorso nella direzione del nuovo tono:
eeeele. vi oVI ug v I
Modulazione per mezzo del cambiamento di modo.
E una particolarita della modulazione cromatica e consiste nel mutare modo -
appunto cromaticamente - all’accordo di tonica del tono di partenza (trasformando-
lo da maggiore a minore o viceversa) in maniera da renderlo cosi «partecipante» -
in qualita di grado del nuovo tono - alla modulazione.
Passando da Do maggiore a Sib maggiore si avra:
dy_@y vg mg v 1
aD 8 id
Da Re minore a Sol maggiore:
1 Witty lee I
Modulazione per mezzo della transizione.
Sistema rapido di modulazione che unisce direttamente la tonica di partenza
con quella d’arrivo legando un suono comune fra i due accordi, sia che si tratti di
un suono naturale che enarmonico.
La modulazione sara confermata poi dalle formole cadenzali necessarie.
Modulando da La b maggiore a Mi maggiore il suono comune & enarmonico
(la b = sol #): .
E. 5856 Cc.
50
Invece da Fa maggiore a Re b maggiore, il suono comune é il fa stesso:
rot ugm7 = v7 I
Modulazione enarmonica.
Come si vedra nel capitolo che li riguarda, esistono accordi aventi la possibi-
lita - attraverso la trasformazione enarmonica - di vari significati per cui han-
no una «polivalenza» che li rende partecipi di varie tonalita.
Cosi: passando da Sib maggiore a La minore la trasformazione dell’accordo di
settima di dominante dell’accordo di partenza in accordo di sesta eccedente di quel-
lo di arrivo permette di raggiungere rapidamente il tono voluto:
Modulazione per mezzo di cadenze d’inganno.
Tutte le cadenze d’inganno (vedi capitolo relativo) hanno in sé il germe della
modulazione e servono appunto a «ingannare» il senso della tonalita data per porta-
re subito al tono nuovo.
Ecco un esempio da Do maggiore a La maggiore :
MODULAZIONE AI TONI LONTANI
Mancando fra i toni lontani qualsiasi accordo comune (naturale) la modulazio-
ne diatonica diretta @ impossibile e bisognera semmai raggiungere diatonicamente un
tono «ntermediario» che sia in primo o secondo grado di vicinanza rispettivamen-
te col tono di partenza e di arrivo. Cosi da Sol minore a Fa # maggiore si potri
scomporre la modulazione in due momenti: modulazione (transitoria) da Sol minore
E. 5856 c,
51
a Re maggiore (2° grado di vicinanza) e poi dallo stesso Re maggiore a Fa # mag-
giore (2° grado di vicinanza):
Iv © vile 1 v7 I
da Sol minore da Re maggiore a Fag maggiore
a Re maggiore
Evidentemente perd le modulazioni cromatiche, per transizione, enarmoniche, ect
sono assai pit adatte, e i procedimenti relativi sono esattamente eguali a quelli gia
visti per i toni in secondo grado di vicinanza (tanto pid, quando si consideri che
molti didatti distinguono solo i toni in vicini e lontani).
Nella pratica degli autori le modulazioni trovano molte altre e originali sinter
pretazioni» che appunto distinguono l’arte dalla scuola.
Solo l'analisi delle opere dei grandi musicisti pud svelare veramente iJ mondo
poetico della modulazione, che non é mai puro elemento tecnico, ma viva ed espres-
siva «parolay del linguaggio musicale.
Come si & gid accennato, tutti gli esempi di modulazioni proposti non sono che
schemi sintetici e - quindi -'«modelli, che si possono, in ogni caso, ampliare con
qualsiasi_ mezzo armonico che serva a meglio «spiegare» i procedimenti modulanti e
confermare con appropriate successioni cadenzali_ il tono raggiunto.
I programmi d’esame (oltre alla prova «praticay di modulazione) richiedono la co-
noscenza delle modulazioni (ai toni vicini) nell’armonizzazione del basso d’armonia.
assai difficile spiegare in sintesi come si debba interpretare un basso nei ri-
guardi della modulazione. Solo l’insegnamento diretto pud chiarire tutti i dubbi del-
Vallievo. Tuttavia alcuni principi generali possono aiutare a ben comprendere i vari
casi dubbi:
Anzitutto la modulazione - nel basso - pud essere espressa o sottintesa.
Nel primo caso la presenza del suono o dei suoni caratteristici svela subito il
tono da raggiungere e il tipo di modulazione (diatonica 0 cromatica).
Nel secondo caso aleuni «procedimenti» del basso possono indicare i «momenti»
nei quali si produce la modulazione.
Di solito i suoni lunghi (pedali) indicano toniche oppure dominanti.
Nel seguente basso in Do maggiore:
il re lungo indica «modulazione» a Sol, in quanto il re non pud essere tonica perch®
preceduto dal do bequadro, ed essendo seguito dal sol rappresenta senza dubbio la
sua dominante.
Nel caso seguente invece (sempre in Do maggiore):
indica modulazione a La. Il la & quindi in funzione di tohica; e il re e mi prec
denti il la lungo ne preparano il raggiungimento in qualité di sottodominante e do-
minante.
Ancora: molti procedimenti per linea (tetracordi) indicano con chiarezza certe
modulazioni.
EB. 5856 C.
52
Ecco infatti un caso in tono di Do maggiore:
S———y
La linea - sol ja mi re - indica senz’altro la modulazione a Re minore.
Comunque Vattento studio del basso deve indicare, a chi possiede una suf-
ficente musicalita, i punti nei quali la modulazione @ obbligatoria, dato che in
certi casi la modulazione pud non essere necessaria e la realizzazione pud essere
egualmente «musicales anche senza cambiamento di tono.
Analizzando il breve passo seguente (in Do maggiore):
Fy a So 3 3
Si vedra che:
1) Il tetracordo discendente sol ja mi re indica modulazione a Re minore.
2) Il si b (seguito da do) indica modulazione a Fa maggiore.
3) Il fa (controsensibile) che «risolve» a mi e do indica ritorno al tono base.
4) Il re mi la - chiara formola cadenzale - significa modulazione a La minore.
5) Il si, lungo, seguito da mi, indica modulazione a Mi minore.
6) Il fa naturale (e quindi non pit # ) riporta a Do maggiore, tono nel quale conclu-
de il basso.
Realizzando si avra:
oe
del basso _prestabilito) :
7 #S 7 #S 7 S 7 SF
NB. - La progressione modulante pud diventare —
B. 5856 ©.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Abba Gold PDFDocument77 pagesAbba Gold PDFMarco100% (2)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Arnold Malcolm - Saxophone Concerto For Alto Saxophone & Strin Orchestra PDFDocument34 pagesArnold Malcolm - Saxophone Concerto For Alto Saxophone & Strin Orchestra PDFMarco50% (4)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Roberto Solci - Testo Di Armonia-Completo PDFDocument176 pagesRoberto Solci - Testo Di Armonia-Completo PDFMarcoNo ratings yet
- Catalogo Letteratura Per SaxDocument220 pagesCatalogo Letteratura Per SaxMarco0% (2)
- Inno Di Mameli Sax QuartetDocument3 pagesInno Di Mameli Sax QuartetMarcoNo ratings yet
- Catalogo Letteratura Per SaxDocument220 pagesCatalogo Letteratura Per SaxMarco0% (2)
- LeggimiDocument1 pageLeggimiMarcoNo ratings yet
- Brass Ensemble Score Woodwind Ensemble Score Free Sheet MusicDocument267 pagesBrass Ensemble Score Woodwind Ensemble Score Free Sheet MusicMarco100% (2)
- Barton FanfareDocument3 pagesBarton FanfareMarcoNo ratings yet
- Manuale Di DirezioneDocument74 pagesManuale Di DirezioneAndrea Landriscina83% (6)
- Modulo ADocument1 pageModulo AMarcoNo ratings yet
- Sovracuti Tenore PDFDocument7 pagesSovracuti Tenore PDFMarcoNo ratings yet
- Comparazione ANCE PDFDocument1 pageComparazione ANCE PDFMarcoNo ratings yet
- Tenor PartDocument1 pageTenor PartMarcoNo ratings yet
- Comparazione ANCE PDFDocument1 pageComparazione ANCE PDFMarcoNo ratings yet
- Surfing UsaDocument7 pagesSurfing UsaMarcoNo ratings yet
- Mozart - Aria Regina Della Notte (Piano Solo)Document3 pagesMozart - Aria Regina Della Notte (Piano Solo)MarcoNo ratings yet
- Manuale Di DirezioneDocument151 pagesManuale Di DirezioneMarcoNo ratings yet
- Bach - Concerto en La MineurDocument14 pagesBach - Concerto en La MineurMarco100% (1)
- Manuale Di DirezioneDocument74 pagesManuale Di DirezioneAndrea Landriscina83% (6)