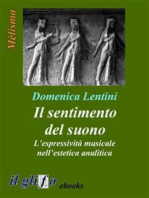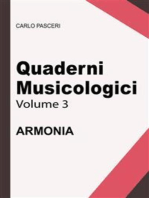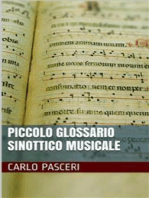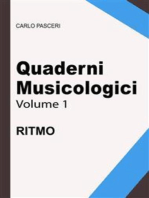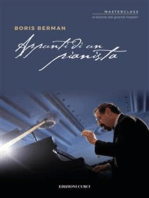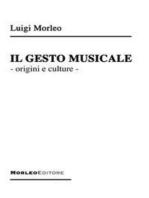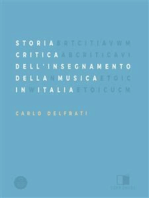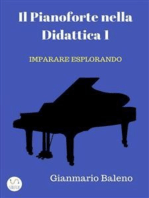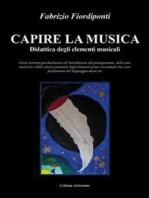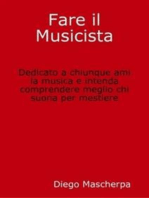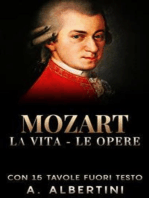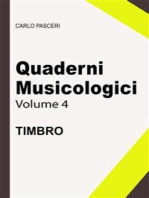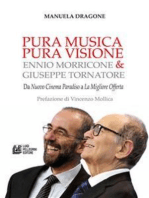Professional Documents
Culture Documents
Goitre Cantar Leggendo 56817b8452735
Goitre Cantar Leggendo 56817b8452735
Uploaded by
Centro Bachelet0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views263 pagesOriginal Title
Vdocuments.site Goitre Cantar Leggendo 56817b8452735
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views263 pagesGoitre Cantar Leggendo 56817b8452735
Goitre Cantar Leggendo 56817b8452735
Uploaded by
Centro BacheletCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 263
PREFAZIONE
In Italia, oltre le varie ragioni storiche, sociali, ambientali che hanno influito © tuttora influiscono negati-
vamente sulla diffusione del canto @ livello di massa, e che sarebbe troppo lungo esporre, si tramandarono tali errori
malintesi nelfinsegnamento della musica da ridurre il nostro Paese, un tempo culla della polifonia vocale, alla
retroguardia della civltd musicale nel mondo. Errori che continuano a ripetersi con Yavallo dei programmi mini-
steriali nelle scuole di ogni livello e, per indolenza o inadeguata preparazione dei maestri ¢ per mancanza di me-
todi, in gran parte dei cori amatoriali italiani,
Tl primo errore & T'insegnamento del canto per imitazione che impigrisce la mente, non educa il gusto, non
rende partecipe il discente, non migliora lo spirito, limita il repertorio, rende approssimativa Iesecuzione (1).
Il secondo & stato ed & gabellare per esecuzione a due voci il canto per 3e e per 6e, dannoso per l'intona-
ione, cosh poco artistico e tanto banale; uso deprecato e sconsigliato a chiare lettere da Kodaly nella prefazione
ad una sua raccolta di « bicinia »(2).
A rendere pitt arido e poco attraente 10 studio della musica si aggiungono l'imposizione dell'nsegnamento
teorico, come ® inteso dai programmi ministeriali, avulso dalla pratica musicale, e quell'amena quanto” inutile
assurdita che & il solfeggio parlat.
Eppure dalla mia passata esperienza di insegnante (di scuola d'avviamento, di Istituto magistrale e, attual-
‘mente, di Conservatorio) e di direttore di coro (dalle voci bianche di scuola elementare al coro semiprofessionale come
la Corale Universitaria di Torino che tuttora dirigo, al coro professionale come quello di Radio Torino che diressi
(«he cova 2 melt Invite ncn net gale ih fre np ie ingle vos imine dando
sangu, oppure fare legge a priciaviste porre mano'subfo al lavoro oi lima? ln quate seconda mariera si arrive al pollo
‘om con pest ptt Ano alia‘nola‘guind presi in ugula dai Bambini, in aggiuna, quel che importa, svitppana Padi la
mbt muncee'e il gusto del pccol cantor» (2 Revaly = Palogatou Bicinamok * TankSnyvkinds = Budapest 1967 = pag, 3)
. Kodaly
2) Le doe voei si muovano piutosto indipendentemente, percht le terze parallele non svluppano Torcehio.
= op. cit» pag. 3)
Shells
ewan SA, We aig,
iis ad. a pat ace 8. 7410 Z.
per oltre un anno) trassi la convinzione che per T'individuo & importantissimo cantare, ma intendendo per canto
il CANTO CORALE, come formazione sociale ed edueazione psichica ¢ morale, il CANTO PER LETTURA,
come educazione scientifica della mente ¢ dellorecchio non solo a fini puramente musicali, il CANTO ESPRES-
SIVO, come educazione del gusto (2)
Ne ebbi numerose conferme durante Ia mia attivita didattica e artistica considerando quanto i fanciulli della
seuola elementare o i ragazzi dell'Istituto Magistrale fossero entusiasti di imparare a leggere Ia musica ¢ ad ese
guirla con proprietd stlistica ed espressiva, come fossero attenti alle indicazioni chironomiche anche nel semplice
canto per imitazione, quanta passione unisse i ragazzi delle magistrali o quelli della Corale Universitaria di Torino
per allrontare concerti o concorsi, tanto da meritare ai primi (Istituto Magistrale di Saluzzo) una menzione in un
concorso AGIMUS fra cori di Istituti Magistrali e ai secondi il premio speciale per coti italiani al concorso poli-
fonico internazionale di Arezzo del 1962.
Purtroppo mi trovai sempre di fronte alla diffcoltt di far apprendere rapidamente Ia lettura ¢ la teoria
musicale senza stancare la scolaresca prima di ottenere risultati soddisfacenti, dif colt che mi impediva di inte-
ressare alla musica la totaita degli allievi e raggiungere un dignitoso livello qualitative delle esecuzioni senza gran-
de sforzo.
Durante un giro artistico in Ungheria in oceasione det 111° Festival Corale Nazionale Magiaro cui fu invi-
tata Ia Corale Universitaria di Torino nel 1968 ebbi occasione non solo di constatare Ia larghissima diffusione della
musica corale (nella sola cittd di Pécs di 130,000 abitanti sono attivi 41 cori dilettanti ¢ 25 cori scolastici) ma
anche la sorprendente preparazione culturale generale pur in persone prive di alti titoli di studio, ¢ Ia straordinaria
facilita con cui tutti cantano la musica a prima vista
(2) Moltigrandi diettori orchestra usano sovente Tinto a ¢cantare + per incitare alfespressione, al fervore livia, al
fraseuso.
Se uno cercasse di esprimere Tessenea di questa educazione (musicale) in una sola parola, questa potrebbe essere: “Cantare!”.
La paroa pit frequeniemente sata da Toscanin! durante le sue prove dTorchesia era: "Caniarel” espfesa in mille sapet © sig
feat». (2. Kodsly ~ Prefazione a Musical education In Hungary - ed. Corvina, Budapest 1966, pag.)
cAmaie il vost trumento.. Pessate comungue che esse -eanto e che nulla v' di pi inebriante el coro in vunione con Vor
Ghestea >. (Re Schuman = Precelt a slovanl sudion! di masca ~ ed- cord, +d, pag. 9)
‘Non rifutaie maid cantare ei cor, © paticolarmente nelle parti medic. Quesia pratica contrbuird a rendervi buon musica»
GR'Schumaan «op. ct, pag. 1).
u
Tutte le persone da me interpellate per conoscere il segreto di una simile fioritura culturale © musicale
furono concordi neltaffermare che essa 2 da attribuirsi allo studio sistematico della musica con criteri didattici
scientitici secondo i principi psico-peaagogici del metodo proposto dal grande compositore magiaro Zoltin Kodaly.
Le premesse di questo studio sono poste durante i tre anni di scuola materna per mezzo dell’ insegnamento di
oltre duecento canti popolari infantili, da cui i bimbi trarranno il materiale > musicale per giungere alla letura.
Questo & possibile in Ungheria dove opera congiunta di Bartok e di Kodily nel campo della ricerca ¢
della trascrizione di canti popolari ha provveduto a fornire una raccolta sistematica e graduale di canti autent
tradizionali, didatticamente vali, e dove le insegnanti di scuola materna studiano la musica per sette ore setti-
‘manali (cinque di pratica e due di canto corale). Se consideriamo ancora che i canti infantili tradizionali ungheresi
sono sovente di struttura pentatonica, che il melos popolare magiaro ® generalmente modale e che i pid) antichi
‘anti popolari di que! paese sono spesso formati dalla ripetizione a distanza di quinta inferiore o superiore dell
stessa melodia, efficace mezzo naturale per la comprensione dei tetracordi ¢ dei pentacordi, risulta evidente Ia
impossibilita di applicare il metodo Kodaly nelle scuole italiane con la stessa impostazione datagli in Ungheri
Sollecitato da queste informazioni e da queste esperienze, nuovamente incuriosito alla pratica adozione della
lettura con il sistema del «DO » mobile che il metodo Kodaly eredita dal metodo Curwen, il quale a sua volta
Ficonduce ai criteri pedagogici di Guido <’Arezz0, ripresi lo studio «ab ovo» rileggendomi il metodo Curwen ¢
accostandomi alla fonte: il « Micrologus de disciplina artis musicae », le « Regulae de ignoto canta 2, e I's Epistola
Guidonis Michaeli Monacho de ignoto cantu »(3)
Interesse ed entusiasmo crebbero leggendo proprio nel prologo del « Micrologus » di Guido d’Arezz0 che
fanciulli, eserctati a leggere 1a musica secondo Tuso delle sue note, nel volgere di un mese cantavano senza esi=
tazione a prima vista canti mai visti né uditi, si da offrire a tutti un « maximum spectaculum »(4),
(2) Gerbert « Seriptores ecclesasict de musica ~ 1788, Typis Sun-Blasians
snuscam tradere poers. Tandem sdfuit mii divina gratia, & quidam eorum imitatione chord
4) « ce
rm var ‘ta Primo inulty ipdubitanter “cantabant, ut
Imuximum spectaculom plorimis pratberetur; quod. tamen qui fon potest facere. nescio qua front se musioum vel cantorem abdeat
Aicere. Maxime itagye oltre nosire cantor, uci centum sarin stodio perseverent, numquam tamen vel minimart at
Phonam per se valent efferr semper discenes, ut at Apostlus. et mumguam ad perfestam huius aris seieniam pervenientes»
Uiterotogus ~ Gerbert - op. cit, paz. 3)
nius menus spatium invisos & Inaulos
att
A conforto della mia convinzione di aver intrapreso 1a direzione esatta con Tadozione del « DO > mobile
sowenne Ia rilettura dell'opera fondamentale dei Curwen (5) che riafferma la validita della lettura con il «DO >
mobile e, per la ritmica, propone delle identiicazioni sillabiche.
Due aspetti posti in evidenza dalle due opere, nel tempo distanti fra loro ma vicine per comune intento, mi
fecero riffettere sul tempo e sulle occasioni perdute in Italia per la diffusione della pratica det canto corale €
della lettura della musica, Innanzi tutto gli stesi errori e le stesse manchevolezze nella preparazione musicale, per-
sino a livello professionale, erano gid lamentate allora (1030 ca. e 1837) (6) come oggi e, malgrado le soluzioni
proposte dall'uno e dall'altro riguardo al problema didattico dell'insegnamento musicale, ancora oggi, in Italia si
sta dibattendo la questione senza tentare e trovare il modo migliore per porvi rimedio (7). Forse perch? di Guido
Arezzo fu sempre conosciuta e considerata pitt Topera e la figura di teorico che quella di pedagogo. Figura di
(9, G. eS. Curwen, monosolfa pentagramms = Come fare a legere la musica ed a capirla ~ ed, Marcello Capra - 1528 =
SITEN. Totino, 1929" Trad. di M- Capra e Mons. L Rostagno.
{6 «dum cantandi scientiam, quam consequi_mumguam possunt. labore sssduo & stulissimo persequuntur. Mud quoque
quis non defizat quod tam gravis error est in Sancta Ecclesia, tamaue pericuoss discordia, vt quando divinum ofiium celebramus,
‘epe mon. Deum laudare, sed inter nos cerare vigeamor. Vix denique uns concordat alter, non magiiro dispar, nee discipulat
ne fact en am apm ge ue puch So am lai anipomai guar mu Me gt
; vulgoque lam dicitur-antiphonarium non Gregori, sed Leonis aut Alberti au culuscumgue alteriu (Reg. mus
{de Igmoto cant" Getbert ~ op. cl, be
‘eMisicorum & cantorum magna est distant
Ist dicunt, Mi seiunt, quae componit Music:
Nam qul fait, quod non sapi, diiitur bestia,
Cacterum tonants vooisw Inudent acomin
Superabit philomelam vel vocals asna >
eg. Rythm. - Gerbert ~ op. cit, pag. 25)
(7) eHaxdquaguam imirum bane novam avdiendi educationem, ata magisto propagatam, musicae discplina illico maximam
vim stile, Nosrt paedagos = ilos ico, qui universlion msicae education incumbunt ~ pracipue forstan methodum mireatur,
im enercent dscpolorum eosque ad ditatum musicum perducat, nibilomiaus opera prelis edita de ca Te fere
‘mina tacent >. os. Smite van Waesberghe = De musco-pacdagogico ef theorstico Culdone Aretino eiurgue vita ef moribut =
‘Olschi, Firenze, 1955, pag. 92).
Iv
ppedagogo che V'ampia monografia del van Waesberghe, vincitore del concorso bandito dal Comitato Nazionale per
le onoranze a G. d’Arezz0, finalmente pone in luce (8). Questi infatti tribute un largo riconoscimento al. valore
el metodo pedagosico seguito e consigiato da Guido monaco e m'siutd @ comprendere sotto questo aspetto i
ppunti salienti delPopera sua (9).
Infatti gid Guido d’Arezzo intuisce 1a necessitt. del collegamento orecchio-occhio-memoria-voce (10) e Putilita
i imparare molti canti che tornino a sussidio mnemonico per l'intonazione degli intervalli nonché, « mutatis mu-
tandis » Macquisizione del senso della toniea (11) come, per quanto riguarda la ritmica, gid consiglia di incomin-
ciare dal'unita. di tempo (12).
(®) eTonovationum Guidonis duo eerera astnguimus:
8) quae ad! paedagogiam musicum pertinent
') quae ad theoriam muslcam pertinent
‘an Waesberghe = op ety pag. #8).
@) . (van Waesberghe op. cit, page 135)
410) « Quods secundum ordinem sonorum ab pea litera vel eolorata. linea ubique impicias, et ad apete connotes, qin is
Smita ecunis cedinbeseaden Yocum ctneunarun es usta, Smiter Ge Toi vel quarto ordne et rein ile, sve
Siperores sive infetiores odins cernas >. (Garber = ep ek. Pag” 36).
‘Non ergo debemus semper pro ignoto canta vocem hominis vel aicuius strumenti querer, ut quasi caecivideamur mumquam
Sine ductor proseere; sed agulram, sonorum omafumgue depostionum et clvaionum diversiates propestatsgue alle me:
tmovio comimendare >. (Gerbert= op. ety pag 45).
‘tga vir in his noe profere, neceie et aliguantoscantus ita memoriter discs, ut per sogulas neumas modos vel sonos
‘amen, qu vel quaes sin memotier senna. (Get. 0p, cy Pog. 37).
(11) «Cum autem quiibet cantus omnibus voeibus fist, vox tamen quae cantum termina, obtinet principatum; ea enim &
iutius & morosis sonal »- (Gerb. op. cit, pag. 1).
(12) «Cumque formae sint maioresfctae de minoribut, non est dubium, quod si quis minimas cognoverit, de majoribus nequaguam
bare poterit ». (Gerbert~ Op. city PA. 3).
v
Tutti sappiamo che Guido d’Arezz0 proponeva di imparare l'inno di S. Giovanni (UT queant laxis REsonare
fibris, Mira gestorum famuli tuorum, SOLve polluti LAbiis reatum, Sancte Johannes) poich®, a partire dal do (UD,
‘ogni versetto inizia con la nota successiva dellesacordo e il ricordo della melodia facilitava percid i cantori nella
intonazione dei toni e del semitono mi-fa. Ma se inno di $. Giovanni, per la sua struttura, risult® utile per
ricordare Faltezza ¢ il rapporto dei suoni dellesacordo fra loro tanto da servire di identiicazione sillabica dei
suomi, non fu perd ['unica melodia proposta dall'insigne pedagogo per collegare In memoria doll'altezza dei suoni
con assonanze sillabiche, Fra le molte altre basti questo curioso esempio:
Sancte Johannes meritorum tuorum copias nequeo digne canere
Boo lo o> °
wt * = ©
Ree c name ter a
BOS Se to —— :
in cui le stesse vocali del testo si trovano sempre su identiche note.
Anche Miss Glover, una modesta insegnante di Norwich, piccola cittd della contea di Norfolk, in Inghiltera,
nel 1812, trovandosi in difficolt4 con Vinsegnamento della musica ai suoi piccoliallievi, pensd di iniziare adottando
le sillabe ut, re, ecc., di Guido d’Arezz0, che non sono in uso nei paesi anglosassoni, per far leggere le note
su un cartellone riproducente una scala a pioli, annettendo anch‘essa una grande importanza alla « visualizzazione »
delle altezze dei suoni, pitt facilmente rapportabili ¢ rammentabili attraverso la consuetudine della letura delle
sillabe guidoniane. Dal paese d'origine, dal nome delle note guidoniane relative alle due uniche modulazioni possi-
Dili con il sistema del «DO > mobile ¢ dal nome inglese della scala a pioli (ladder) trasse il primo nome il sistema
(Norwich Sol-Fa ladder) che, ideato da un’umile maestrina inglese, sarebbe stato poi adottato, perfezionato e di
fuso dai Curwen, padre e figlo, con il nome di « Tonic Sol-Fa System >
“Mediante 1 comparazione dei metodi suaccennati con il metodo di Kodaly mi resi conto che a questultimo
va il merito di aver seguito i principi informatori di entrambi, averli adattati al melos tradizionale ungherese ¢,
disponendo di un vasto repertorio popolare, aver fornito i modelli melodici costituenti Vinformazione « a priori >
P
vi
per lo sviluppo dellinsegnamento successivo, anche in cid attenendosi al gid citato consiglio di Guido: « necesse
est ut aliquantos cantus ita memoriter discas, ut pér singulis neumis modos vel sonos omnes, qui, quales sint,
‘memoriter sentias », Pur convinto della necessita di un’analoga ricerca in Italia, la trascurai temporaneamente per
orientarmi verso le direzioni comuni indicate dagli autori suddett, pensando soprattutto di educare divertendo ed
interessando i ragazzi alla scoperta del mondo sonoro che essi stessi possono ricreare con quello strumento che
‘ognuno di noi porta con sé fin dal primo vagito: Ja voce. Tanto pitt convinto come sono che Ia musica si legge
e si serive proprio come una lingua parlata,
Anche qui i libri ungheresi di pedagogia musicale fanno frequentisferiment alla « madrelingua musicale »,
intendendo con quel termine tuto il patrimonio di « vocaboli >» musicali (ntervali e moduli melodic’) che il bim-
tbo magiaro attinge fin dalla nescita dalla voce dei genitor’insieme con le prime parole ¢ formano il primo
‘ccorredo >» musicale che, insieme con quello lingisco, la scuola arricchirh e insegnerd a dectrare, a scrivere ©
ad analizare ¢ con eui imparera ad esprimersi, collimando anche in questo con i prinipi pedagogict guidoniani(3).
Non potendo far leva su questo « corredo », pensai di procedere all'insegnamento della musica ai bambini
come per Tapprendimento di una seconda lingua.
Appena abbozzata a prima stesura del mio metodo ne proposi la sperimentazione ad un‘insegnante di pri-
‘ma clementare (14) che riusel ad ottenere in breve tempo tall risultati dalla sua scolaresca da stimolare aleuni
suoi alunni alla ereazione ¢ alla stesura del testo musicale e.. poetico di brevi canzoncine nell'ambito delle note
fino allora conosciute. L'esito lusinghiero del primo esperimento mi indusse a compilare un breve metodo, corre-
dato di esercizi, che mi consentisse una pitt ampia ¢ valida sperimentazione.
(3) «Sed cardo questionis quem viri dosti nimis neglexerunt, hie esse videtur: Guido disipuls suis auditum ae sensum
musicale efformat per ipsam musieam ef in ipea musica; non igiur, ut flert sole intervallainculeando, neque dovendo directe ab
{pats lines notatis notas mosices dignosere. Allam ab als diversam methodum adhibet: docet-nempe’diseipulos canendo. bonos
‘Rcleon modulorum addiscendorun, terum cantando et cantata conjungendo cum initio el terminaione aliorum. modulorum aut
afum distincionum si dovel cos sun auribus aude, observare, seni simulque notitiam scqurere necestatiam, unde pet modum
Eonsequentse faculiem adipiscantur Tegendi cantush ignotum sut-notandi modulum auditum. Hoc est alpha et omega els me-
Thodis- (van Waesberghe - op. cit, pag. 134)
(14 La sigra Anna Eva Nanni Gosto della souola clementare ¢ AS. Novaro > di Torino al cui entusiasmo e alla cu abit
podagogicn desidero rendere pubblico omagglo © ringraziamento,
vil
Venni corsi © seminari informativi ¢ pratici a Torino (15), Settimo Torinese (16), a Piacenza (17) ¢ a
Vresaro (18) per suffragare maggiormente Ja validita del primo esperimento.
Ma le esperienze pitt interessanti furono quelle da me stesso condotte con un piccolo coro di alunni scelti
fra diverse classi e con scolaresche non selezionate di seconde classi in scuole elementari di Torino (19) con cui
potci collaudare direttamente Papplicazione integrale del metodo ottenendo soddisfazioni insperate: i fanciulli si
‘mostrarono assai interessati al « giuoco » di scoprire ¢ di leggere la musica, attentissimi alla lettura ritmica e can-
tata a pitt voci, si sentirono ¢ responsabili » dellesecuzione, presero gusto e piacere al movimento polifonico delle
voci e, dopo una ventina di lezioni, furono in grado di scrivere « currente calamo », un dettato ritmico con valori
i ottavi e di sedicesimi, cantando a prima vista a due voci nell’ambito di un‘ottava. Il piccolo coro, nell ultima
lezione, ¢lesse » il «coro a bocca chiusa > della «Madama Butterfly > in meno di mezzora!
Sperimentazioni effettuate in scuole materne e in istituti per subnormali da insegnanti che avevano seguito
i miei corsi hanno confermato Tefficacia del metodo non solo ai fini puramente musicali. Infatti anche per ta
diretta testimonianza di alcune madri dei miei piccoli cantori, posso affermare che Tinsegnamento della misica
con questo metodo, sveglia talmente Fintelletio e le facolta percettive ed accettive dell'alunno, sollecitando a tal
‘punto la Togica da esercitare una benefica influenza anche sull'apprendimento delle altre discipline; e proprio a
‘questo tendeva T'ideale di Kodaly che esortava gli insegnanti ad agire pedagogicamente su due direttrici principal
Ja musica come arte ¢ come scienza.
‘A questi principi, che Vesperienza diretta mi aveva ultetiormente confermato come fondamentali, mi sono
attenuto nella compilazione del metodo; ma spetterd all'insegnante saper ottenere i migliori risultati non accon-
tentandosi mai dell'approssimazione, non insistendo troppo, durante la stessa lezione, su difficolta particolarmente
4 Bacatione Mute ere
(1) Alla scusla elementare « A. Roncalli » per interesamento del dirttre didatico prof. Camera
(Alla Scuola e yeuola «1, Sinigaglin > di Torino; in questultima per iniiativa della diretice profes-
soressa'Grosso-Nicoli,
Vi
ardue, ma soprattutto rendendo la lezione varia quant’é possibile, come dettagliatamente consiglio nelle « Aver
tenze generali » traendo anche Io spunto da ogni occasione per Neducazione sociale e civile degli alunni per cut
il canto corale pud essere mentore insuperabile.
Soprattuto Tinsegnante dovrad trovare gli espedienti e cogliere ogni opportunitd per inculcare negli alunni il
senso musicale, abituandoli ad « ossevare » con Tito il mondo che li ciconda, per esempio ascoltendo il suono
prodotto dalla'percussione i dve bottigle, i suoni comparati di due claxon 0 queli prodotti dal cigolo d'una
porta sui cardini 0 Vintervallo del verso del cuculo (20), facendo riconoscere, in DO maggiore o in LA minore, le
rote di una facile composizione, accostando analogie melodiche di canti divers, fornendo, in una parola, una
cespetienza musicale »(21).
La lettura ritmica (@ non solfeggio!), cos} com'® presentata in questo metodo, risulta di immediata compren-
sione agli alunni e permette Yesecuzione poliritmics a due e a tre parti dopo i primi venti minuti della prima
lezione: questo risultato affascina il ragazzo e lo sprona al superamento delle successive dificolt.
La lettura cantata presentata dapprima su una o due Tince, che imitano Ia scala a pioli della macstrina di
Norwich, avvia con facilita alla lettura per distanze invece che per posizioni fisse conducendo a poco a poco al-
Tuso del DO mobile.
Quest'uso, che si ricollega alla solmisazione guidoniana, se pud rappresentare soprattutto all'inizio una diffi-
colta notevole per V'insegnante, non lo @ affatto per 'alunno ed offre notevoli vantaggi che non sara del tutto inu-
tile clencare.
Innanzi tutto leggendo qualsiasi tonalitA con il nome delle note della scala diatonica Vorecchio si abitua
ad identificare con il nome delle note una precisa, sebbene inconscia, funzione tonale, definendo con DO la tonica
‘di qualunque tonalita, con RE Ia sopratonica, ecc.
(0) Osservazioni spontance dei bambini delle scuole elementart durante le mie eperimentazioni,
Gh) ete nota C3),
Con T'uso costante della lettura nella scala di DO maggiore ¢ di LA minore, a lungo andare Vorecchio si
avvezza ad identificare i semitoni con le sillabe MI FA ¢ TI DO (2) ¢, viceversa, queste sillabe richiameranno
alla. memoria (memoriter sentias) Vintervallo di semitono. Al contratio, leggendo con Ia posizione fissa delle note,
capita di dover leggere ad esempio nella scala di MI bemolle maggiore, il MI FA a distanza di un tono e ill
SOL LA a distanza di un semitono, rendendo sempre approssimativa Vintonazione di chi non possiede una pra
‘ica strumentale.
Definendo, come ho detto, i gradi delle diverse scale sempre con gli stessi nomi dei gradi della scala di DO
maggiore, si facilita la comprensione delle funzioni armoniche dei gradi stessi ¢ della formazione degli aceordi
principali di tonica, sottodominante ¢ di dominante (solo identificabili rispettivamente con DO MI SOL, FA LA
DO, SOL TI RE) connettendo immediatamente la teoria con Ia pratica.
Inoltre viene eliminata, si fini della lettura a prima vista, tutta 1a teoria connesss alle tonalita
Tl metodo si basa essenzialmente sul collegamento orecchio-occhio-memoria-voce. Sari percid compito del-
Vinsegnante rammentare continuamente 1a relazione delle sillabe dei vari intervali, ricordare il « disegno » visivo
degli intervalli sul pentagramma, esercitare frequentemente gli alunni allidentificazione deg
dalla viva voce © da uno strumento, far intonare intervalli isolati a partire dai diversi gradi della scala, insi-
stendo molto sulla differente successione di semitono fra il MI ¢ il FA, il TI e il DO e quella fra DO e RE
e fra RE e MI.
Chiedo scusa ai lettori per essermi tanto dilungato sulle mic esperienze ¢ sui vantaggi della lettura con
DO mobile; ma non voglio che possano credere Ia presente pubblicazione frutto di pure elucubrazioni cervel-
lotiche di un'arida ricerca avulsa dalla pratica realtd, tanto promettenti sulla carta quanto deludenti nelPattua-
ione, come sono molte opere del genere oggi in circolazione.
(22) Per il sistema del do mobile, come si vedi, & necessario mutare il nome dlls nota Si in Ti poiché con Si si definisce
i Sol diese,
x
Poiché i testo ha da essere adatto tanto alla scuola materna come a quella elementare ¢ media, ma pud
risultare utile ancho alle societi corali per Vaddestramento delle... reclute, i canti vanno da quelli infantili a
quelli polifonici non potendo allestire, almeno per ora, edizioni differenziate. Si affida al buon senso del docente
la scelta dei canti pid opportuni
Per il futuro si penser a fornire quel « vocabolario > musicale cui accenno precedentemente traendolo dal
ricco ma dimenticato repertorio popolare infantile italiano, facendo tesoro dellesperienza di Barték ¢ di Kodély
nel campo della ricerca etnomusicale. E, infati, auspice la casa editrice musicale Suvini & Zerboni, gid posso
assicurare che questa pubblicazione non 2 altro che il primo passo verso una pid organica e sistematica imposta-
Zione della nuova pedag le. Seguiranno, di pari passo con la collezione di « autentici > canti popolari
rantili, una pubblicazione periodica che sia sussidio e guida agli insegnanti ¢ metodi differenziati secondo Ie
esigenze dei diversi tipi di scuola e le ett dei discenti
La pubblicazione dei canti, ordinati secondo una progressiva difficolta seguendo i temi degli argomenti, per:
sticchimento del repertorio di melodie popolari trascritte a 2 ¢ a 3 voc
mete.
Qualche insegnante o preside di scuola media pit fiscale che sollecito verso i problemi pedagogici ¢ didat-
tici potrebbe esitare all'adozione del presente metodo non trovandolo ossequiente ai programmi ministerial. Ma
Vimplicito riconoscimento da parte del Ministero della P.T. della necessiti di spetimentazione di nuovi metodi ©
rinnovati eriteri pedagogici (23) e Ia garanzia dei risultati conseguiti da quegli insegnanti di scuole elementari e
‘medie che sperimentarono questo metodo prima dell'attuale pubblicazione, sono argomenti suffcienti a giustifi-
care Madoaione, non’ essendo valida Tobiezione ch’esso si discosta sostanzialmente da quelli tradizionali
(23) Vedi Itracion! proprammaiche per Fanno scolasico 1971-72- Roma, settembre 1971; a cura del Ministero della Pub-
blica Istrurione - Segreteria tecnica dt coordinamenta - page, 21-22,
XI
You might also like
- Musica in Fiaba: Una fiaba da creare, vivere e trasformare attraverso le suggestioni del linguaggio musicaleFrom EverandMusica in Fiaba: Una fiaba da creare, vivere e trasformare attraverso le suggestioni del linguaggio musicaleNo ratings yet
- Manuale Catalogo SBN - Sebina OpenLibraryDocument127 pagesManuale Catalogo SBN - Sebina OpenLibraryPaolo GiorgiNo ratings yet
- Il sentimento del suono: L’espressività musicale nell’estetica analiticaFrom EverandIl sentimento del suono: L’espressività musicale nell’estetica analiticaNo ratings yet
- Yaoi911 - ArtificeDocument88 pagesYaoi911 - ArtificePaolo Giorgi100% (2)
- Teoria Musicale: Elementi e principi fondamentali per la comprensione delle basi di teoria della musicaFrom EverandTeoria Musicale: Elementi e principi fondamentali per la comprensione delle basi di teoria della musicaNo ratings yet
- A scuola di canto: Verso una corretta educazione della voce e dell'orecchioFrom EverandA scuola di canto: Verso una corretta educazione della voce e dell'orecchioRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- L' ansia da performance musicale: Esibirsi con più frequenza aiuta a ridurre il livello d'ansia?From EverandL' ansia da performance musicale: Esibirsi con più frequenza aiuta a ridurre il livello d'ansia?No ratings yet
- Capricci in note. Percorso musicale nella scuola primariaFrom EverandCapricci in note. Percorso musicale nella scuola primariaNo ratings yet
- Doremat, la Musica della Matematica - Il Testo: Insegnare e imparare la matematica con la musicaFrom EverandDoremat, la Musica della Matematica - Il Testo: Insegnare e imparare la matematica con la musicaNo ratings yet
- Come armonizzare una scala e trovare gli accordiFrom EverandCome armonizzare una scala e trovare gli accordiRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Suonare il pianoforte (Tradotto): Con domande e risposte sul pianoforteFrom EverandSuonare il pianoforte (Tradotto): Con domande e risposte sul pianoforteRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Storia Critica Dell'Insegnamento Della Musica In ItaliaFrom EverandStoria Critica Dell'Insegnamento Della Musica In ItaliaRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- Il Pianoforte nella Didattica 1 - Imparare EsplorandoFrom EverandIl Pianoforte nella Didattica 1 - Imparare EsplorandoRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- Capire la musica-Didattica degli elementi musicaliFrom EverandCapire la musica-Didattica degli elementi musicaliRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Mi sento meglio: Esperienze di applicazione di musica elettronica in musicoterapia per l'educazione dell'orecchio con Ic, dsa, sindrome di Down e autismoFrom EverandMi sento meglio: Esperienze di applicazione di musica elettronica in musicoterapia per l'educazione dell'orecchio con Ic, dsa, sindrome di Down e autismoNo ratings yet
- Le tecniche di microfonazione stereofonica: Un vademecum per il fonico in erbaFrom EverandLe tecniche di microfonazione stereofonica: Un vademecum per il fonico in erbaNo ratings yet
- Nel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo II. L’epopea della polifonia (dal Trecento al Seicento)From EverandNel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo II. L’epopea della polifonia (dal Trecento al Seicento)No ratings yet
- 100 Solfeggi nelle chiavi di violino, basso, endecalineo e propedeutica al setticlavio: Primo volumeFrom Everand100 Solfeggi nelle chiavi di violino, basso, endecalineo e propedeutica al setticlavio: Primo volumeNo ratings yet
- Come scrivere una canzone e capire il mondo discograficoFrom EverandCome scrivere una canzone e capire il mondo discograficoRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- PURA MUSICA PURA VIOSIONE. Ennio Morricone & Giuseppe Tornatore. Da Nuovo Cinema Paradiso a La Migliore OffertaFrom EverandPURA MUSICA PURA VIOSIONE. Ennio Morricone & Giuseppe Tornatore. Da Nuovo Cinema Paradiso a La Migliore OffertaRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2)
- Bes e attività motorie inclusive: Proposte didattiche operativeFrom EverandBes e attività motorie inclusive: Proposte didattiche operativeNo ratings yet
- Girsa Il Gioco Di Ruolo Del Signore Degli AnelliDocument176 pagesGirsa Il Gioco Di Ruolo Del Signore Degli AnelliPaolo GiorgiNo ratings yet
- Consigli Di StudioDocument3 pagesConsigli Di StudioPaolo GiorgiNo ratings yet
- Somewhere SATB Sheet MusicDocument3 pagesSomewhere SATB Sheet MusicPaolo GiorgiNo ratings yet
- Arcadelt - Ave Maria SATBDocument1 pageArcadelt - Ave Maria SATBPaolo GiorgiNo ratings yet
- Creature of HavocDocument165 pagesCreature of HavocPaolo Giorgi100% (1)
- Poesie Sandro PennaDocument4 pagesPoesie Sandro PennaPaolo GiorgiNo ratings yet
- Jesu Corona VirginumDocument3 pagesJesu Corona VirginumPaolo GiorgiNo ratings yet
- Victoria - O Magnum Mysterium PDFDocument5 pagesVictoria - O Magnum Mysterium PDFPaolo Giorgi100% (2)
- Arcadelt - Ave Maria SATBDocument1 pageArcadelt - Ave Maria SATBPaolo GiorgiNo ratings yet
- Games of Thrones - Trono Di Spade - Regolamento SOLITARIODocument4 pagesGames of Thrones - Trono Di Spade - Regolamento SOLITARIOPaolo GiorgiNo ratings yet
- .I.labirinti - Di.krarth. (By - Dirk06)Document308 pages.I.labirinti - Di.krarth. (By - Dirk06)DemocritNo ratings yet