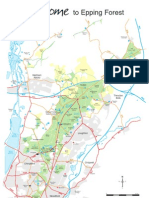Professional Documents
Culture Documents
PDF Fabbri Roberto Chitarrista Classico Autodidatta DL
PDF Fabbri Roberto Chitarrista Classico Autodidatta DL
Uploaded by
Matteo Android TV0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views115 pagesOriginal Title
Dlscrib.com PDF Fabbri Roberto Chitarrista Classico Autodidatta Dl 6a67f10a826d0d5a227310f6c3420758
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views115 pagesPDF Fabbri Roberto Chitarrista Classico Autodidatta DL
PDF Fabbri Roberto Chitarrista Classico Autodidatta DL
Uploaded by
Matteo Android TVCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 115
chitarrista
classicou
PRESENTAZIONE
di Carlo Carfagna
La didanica strumentale, pur continuando a iovaesi deglt important testi di autor’ class.
i (supratiutio ortocenteschi, appare in continua evcluzione. Per «questo, © ad ogni ilvello,
compaiono auovi lavori che si avvalgono dei mezzi pitt aggivinat
Si pub abletiace che, per quanto riguarda la chitarra slassica, tutto € git stato detio € cod
ficato, ma, se da un lato cid 2 vero, non altretiante si pul alfermare circa Fuso cet pi moder
ni mezzi al servizio ci chi vucle apprendre o insegnave.
Il presente metodo del giovane maestro ¢ concertista Roberta Fabbri vuole porsi per quel
lo che dichisra: “un manuale per imparare a suonaee attraverso iotopratie ed lire 50 tra stud
@ brani completi di teblatura da ascoftara su CD
Va iilevatn che questa metode @ tra i primi a proporre anche Viasegnaments con Tutile
auisitio deBa “tablatura” (un sistema riprase, come sappiamo. da quelle delle antiche “inti
volature”), che rappresenta non sole una guida semplificativa ma “esemplificative
I libra & pot completate dallurifissime compact-dise con ly registrazione di ust | dian!
Nessuno pud pieencere di segnare un purio ferme in una vicenda plurisccolare come la
proposta df support cidattici, ma ben vengano queste iniziative che, senza pretendere di
Avoluzionare IUto, farniscono quanto di positive pud offrire Is modlema tecnologia.
Roma, maggio 1998
Carles Carkagna
CONTENUTO DEL CD
Tracce AUDIO:
1 A Cano Studs
2 F Sor Studio
$4}, Sagreras Lezione
4 4, Sagroras tezione
5 ON. Conte studio
6 1. Sagreras lezione
7A Diabelti Studio
& 4. Saperas Lezione
9 N, Coste Studio
Ue |. Sagroras lezione
TE | Sagreres tezione
12 M.Carcassi_ Studio
13. Sagreras Leziane
14D. Aguado. Moderato
18 J, Sagreras Lezione
16. J, Sagreras Lezione
17M Carcassi Preludio
18 4, Sagreras Lezieine
19 F Sor studio
20 Sor Studio
21 f Sagreras Lezione
22 f. Sagreras Lezione
23 F Canali Preludio
24 |, Sagreras Lezione
25M, Giuliani Studio
26 A Diahell studio
27M, Giuliani Studio
28, Sagreras Lezione
29° E Tarape Studio
30 Sur Studio
"1
32
B
34
35
36
37
38
3
40
4
a2
B
a4
45
46
ar
48
Ey
R. Fahbri
R. Fabbri
R, Fabbrt
R, Fabbri
K. Fabbri
8, Fabbri
R. Fabbri
&. Fabbri
R. Fabbri
R. Fabbri
R, Fabbri
K. babbrt
R, Fabbri
R. Fabbri
R, Fabbri
R, Fabbri
©. Carfagna
Giannell
M. Gangi
Fi. Koedber
N. Puglalli
1S. Puglielli
F. Tortega
Anonima
4.8. Bach
G. Gershwin
Fink Floyd
Studlienn
Studio n
Studion
Studion,
Studio n,
Studio n. 6
Studio n, 7
Studio a. 8
Studio a. 9
Studion 10
Studion. 17
Studio m. 12
Studion 13
Studio a, 14
Studia a. 15
Studio n. 16
lanira
Perting
Ricovtia
Country Blues
Walking laze
Swing in Prima Posizionc
Lagrime
Giochi Proibiti
Bourrée
Summertime
ty there anybody out there?
INDICE
Le parti della chitarra
La scrittura musicale
Le corde a vuoto
Come si accorda la chitarra
Vimpostazione
Le note della chitarra in prima posizione
30 studi tratti dal repertorio didattico tradizionale
16 studi delfautore
6 brani di autari contemporanei
Scale
Arpeggi
It legato
5 brani dal classico al rock
27
39
71
87
99
104
103,
111
a cassa armonica o cassa di risonanza &
LE PARTI DELLA CHITARRA
La chitarra & formata da una cassa armonica, da un manico e da 6 corde.
costituita dla:
H
24
2
a
3
6
Piano armonice
Buca (6 rosa)
Fonticello (ponte |
Ose del ponte
Fasce
Fondo
U manico ® costituite da:
7) Cavigliere to paluitay
8) Meccaniche
9} Capotaste
10} Tastiera isueddlivisa ir XIX tastit
V1) Sbarretie dei tasti
12} Taceo
Le sei corde di nylon, di cui tue rivestite in metalio (Mi, LA, RE bassi), tese sulle strumento
vanno a formate un piano immaginario dette tele a cui distanza dalla tasticra ¢ dal piano
armonico viene chiamata altezza del telo,
La funghezza delle corde misurata dal capotasto al ponte viene definita diapason. Questa
lunghezza @ variabile; di solite oscilla fra 165 © 66,5 em.
LA SCRITTURA MUSICALE
Ul rigo musicale (pentagramma} @ conirassegnato, nella musica per chitarra, da un simbolo
denominato chiave di vieline io di Sel) che determina la posizione det SOL sulla seconda ti-
nea e di conseguenza if nome dei suoni e la relativa alierza (note masicall.
Hi nome ¢ l'altezza dipendono quindi dalla posizione che le note assumene sul rigo stesso.
Fsempio:
é
Mi 8 SOL tA st bo RE sa FA
Quando il pentagramma non @ sufficiente a rappresentare l'iniera estensione celle note mu-
i, queste si scrivono su linee supplement, di cui vengone tracciate soliante del fram-
menti tagti addizioneti) in alto ¢ in basso.
Esempio:
LE CORDE A VUOTO
Le corde della chilarea, partendo dalla pits sattite sono:
Prima corda
Mi (Cantino)
Seconda corda Si
Terza corda, Sol
Quarta corda = Re
Quinta Corda = ola
Sesta Corda Mi Basso}
Le corde vengono indicate con il numero consispondente alla corda inycritio in un cerchiet-
10. Cost ®) significhera che [a nota si trava sulla sesta corda (Mi Basso], @ sulla quinta cor
da (La), @ sulla quarta (Re), ete.
Per indicare graficamente le sei corde della chitarra useremo anche la tablatura
{Questo sistema (molto antico) & composto da sei lines, ciascuna corrispondente ad una cor
da delfa chitarra, sulle quali vengono scritti dei numeri che stanno ad indlicare i tasti da pi-
giare con le dita detla mano sinistra (G=corda a vuoto; 1=1 tasto; 2=11 rasta; etc.)
fo
COME SI ACCORDA
LA CHITARRA
Cost UACCORDATURA ¢
Vaceordatura dolla chitarra @ 'insieme dei suani prodotti dalle corde supnate a vuole ed &
data dai sei suomi corrspondenti a quelli cmessi da ciaseuna delle set corde. Per accordatu-
fa, poi, s‘intende anche Voperazione di accordare la chitarra,
COME SI ACCORDA LA CHITARRA
Per determinate il suone foreamentale su cui accordare la chitarra, ¢ cio 1A della ©} cor-
da vuota, siricorrera al diapason Feta 110 al carista [Foto 2).
Fow t rato 2
Una volta oltenuto if LA da uno di questi strumenti, si girerd la chiavetia relativa alla
Deorda verso destra per tiradla @ quindi innalzare il suona; o verso sinistra per allentar-
Ia, fing ad otteneee la coincidenza dei due suoni, depodiché si procedera nel soguente
modor
1 - Premere fa@carda af ¥ taste (LAY
caccordarla con laa vuoto.
Premere faG@dcorda al V tasto {RE} €
accordare sulla stessa la@corda a
yuoto,
3 Premeie la@corda al V taste (SOL!
caccordare laa vuato
4- fremere la@icarda al tasio (Sle
accordare lags yuvto.
5 - Premere laGheorda al V taste (ME) e
accordare la Deorda a yuote.
PROSPETTO DEI TASTI DA PIGIARE PER ACCORDARF £4 CHITARRA
Foichs Loperazione di accordatara & per
il principionte relativamente complossa,
si consiglia a quest ultima M'uso di uo
corista a sei note tuna per ogni corda
veota detla chitarra) ivedi Fote 3), opp
re ancora pil semplice accordatore
eletonicn che, con un indicatora a lan-
cetia na led, segnala se-uma corda & ins
tonata o se deve essere tirata uc allenta-
ta tvedi Foto 4).
Foto 4
Tiasio — Maasto. ib tasto. WW tasto. — Wansio VIrasto
® - - —
® *
® *
°
e
L’IMPOSTAZIONE
POSIZIONE DELLO STRUMENTO
Linsieme delle norme che indicano fa po-
sigione migliore per suonac la chiara de-
termina limpostuzione che rappresenta il
rapporio che intercorte fra if chitarrista e la
chitarra,
Premesso id, risutla evidente come im
postavione pid essere soggetta a variazioni
in relazione soprattutto alla steutiura lisica
dell'esecutore che suggerisce, di fato, le
regole generai piu opportune
Limpostazione tissa
a} - i punt di contatio fra strumento.
orl esecutore
bb} - Finctinazione dello stramento
©) atteggiamento dell’esecutore per
stabilizzare ¢ controllare lo
sirumento.
Essa determina, inoltre, 'esatia posizione
delle mani ¢ riveste grandissima importaa-
za —non solo pee fini estetici (piacevole im-
pressione per chi ascolta ed osserva) - per
poter ottenere if migfior sendimente acust-
co @ tecnico possibile.
E necessario quincl che it chitarrisia sia se-
duo su una sedia senza braccioli di allezza
proporzionata alla sua statura e che per-
metia al como una nonnale stabilita. 1! bu
slo’ @ la testa devono stare eretti, con que
stullima leggermente rivalea verso sinistra
{I piede sinisiro deve poggiare # uno sga-
ello posto ad una altezza di circa 15 cm,
rapportate alia lunghezza delia gamba,
Questa de
angolo vette, La chitarre pogaia senze pres:
sione al petto con la fascia inferiore sulla
gamba sinistra e la paletta all'altozza delta
spalla sinistra. I braceio destio poygia al-
Fincirea all’altezza del ponticelle, median-
te i] contatto dell'avambraccio appena sot-
to i gomito ¢ lo spigolo tra fascia ¢ tavola
della chitarra. Quest’ultimo contatio non
Serve a scaricare il pese del braccio sulto
¢ assumere una posizione ad
strumento, bend a controbilanciare la forza
che imprime la mano sinistra sulla tastiera
ia gamba desira, spostandos! verso Pester
no quanto basta, f posto aila parte inierio-
re ¢ pit ampia della forma ad etto dello
sirumento: si stabilisce cost un contatse fra
sttumenio ¢ parte interna della cascia, sen
za esercitare alcuna pressione. tl piede de
stro poggia Interamente a terra. I braccio
sinisiro deve consenlire appoggi¢: delta
mano rimanendo paralleto af corpo ¢ con
Vavambraccio sollevato verso Valto Foto n.
Fe 2).
MANO DESTRA
Vesatta impostazione della mano destra consente sta un conotto sviluppo della tecnica sia tl
superamento di important difficalta eseculive,
11 potso, leggermente airorondiio ¢ piegato verso il basso, deve portare la mann in posizione
vertical rispetto a quella dello sirumenta, Le dita devono aderire delic ‘alanente, non siretle
¢ lesgermente incurvate. 11 palmo delia mann deve distanziarsi dat telo delle corde di circa
3-4dcm. Foto nn. $e 4.
Fo Foto 4
Fotw 5
Le dita della mano desira, che percuoto-
no de corde, sono if pollice, l'indice, il
medio ¢ Panulare: esse vengono indicate
nelle diteggiature con fe loro iniziali
{p,i,m.a). H mignolo non si usa tse non
per particolari eifetti), ma normalmente
segue Fandamento det'anulare, evitande
perd ogni inutile istigidimento (Foto a. $1.
Un discorso a parte va dedicalo al police. Questo compie un movimento naturalmente tr
sversale rispetto alle carde (da sinistra verso destrai, cd & l'unico dito che, nonosiante sia
munito efi unghia, pud suonare anche solamente con il polpastrello. Il poilice, una volta pul
sata ia cordla, si va a posizionare sulla corda sottostante (Foto n. 6 @ 7] oppure, con un movi
monto circolate verso l"astemo, ritorna alla posizione iniziale (Foto n. 8 ¢ 9 1.
Foto & For 7.
Foto 8 Foe 9
Al contrario detla mano sinistra, te dita cella mano destra devono avere te unghie legger
mente sporgenté dal polpastrello. Iniatfi, suonare can il solo polpastrelle produrehbe una
quantita di suono insufficiente ed una varieta timbrica ricotta. IE polpastrello serve perd co-
me punto di contatte con la corda che poi viene percossa dall’unghia,
16
Vunghia non deve essere troppo funga
Tssa va limata a cupola e smussaia feg-
germente verso Vestemo (Foo n. 10 @
Wn
Foto 10
foto HL
Le dita delta mano destea possono pulsa-
re le corde usando fondamentalmene
due tecniche: quella dei tocco libero
idetlo anche volante} ¢ quella cel tocee
appoggiato
Ik taceo libera <\ oltiene quando il dito
indice, medio © anularet, percossa la
corda, utifizzando |estremo Fimite del-
Vultima falange, slitta suif’unghia dat
basso verso l'alte senza che il dite stesso
vada a torcare la cordla sotlostante. Le
falangi devono essere leggermente pie-
gate, evitando perd fa cosiddetta post
zione ad attiglio. Le dita, una voita per
cosse fe corde, si manterranna ad una
distanza minima dal tela delie slesse,
pronte ad una successive pulsione Foto
nite 13)
poi 12
Il toca libero produce un suon non inci-
sivo edi volume non particolarmente forte;
seve, petts - in contrasto con iI tocco aps
poggiate - ad eseguire arpeggi e passaggi
particolarmente veloci
I tocco appoggiato @ un modo ci attaccare
fa corda che cansente, appunto, cli “appos-
siare” it dito sulla corda sextostante. Tale
acco $i oitiene portando il dito della mano
destra a contatto con la corda; dopo aver
ialta pressione con il polpasivelfo, si fa sci-
volare quest ullimo versa lunghia in dire
zione della buca, dando it colpe necessario
afar vibrave la conda, It dito, finila ba corsa,
si andka cos a posare sulla corda sotostan-
‘¢, lascianelo la corda pizzicata Libera di vi-
brare; il dito cosi appoggiaic rimane fermo
fino a che un altro dite non ripeie ise neces
sario) la medesima oparazione. in tal modo.
le dita si aliernano ¢ si sallevane a vicenda
sulla corda (Foto n. 14-15 - Ye 17).
Fora 1
Fate 16
tI tocco appoggiate ha, rispetio a quelle i
beta, maxgior incisivitd @ potenze; serve ad
evidenziare 1a melodia e ad accentuate al-
cuae note quando fo si desideri,
La mane destra ha quindi il compito di pro-
durre 1 suoni deierminande due: caratteri: il
volume ed il limbea; aitre compito & quello
di interrompere i suoni, spegnendo fa vi-
brazione delle corde
Il volume dipende dall’ampiozza delta vi
brazione della corda in relacione alla force
esercitata dal dlito nel momento della pul-
sione,
I timbeo 2 dovuto invece al cosiddetto
transiente d’attacce ich, nel nesta ca-
50, & i] mamento in cui Punghia della
mano destra percuote la corda) ed atla
conseguente forma d’onda che if suono
viene a produrre.
Iltimbro, pud essere iondamentatmente
Foto 15
Foto 1?
18
dolce & morbide © chiara € metallica.
Rilasciare velocemente fa corda fa ten-
dere verso un suono piti duro; rilasciarla
invece con un movimento del dito tent
ad oblique fa ollenere un suono pill
morbido
Un‘unghia troppo dura o ivregolare pro-
dura gencraimente un suono dure © spi=
goloso.
Fist 18
Fete 20
E' interessante vedere, in relazione aile
possibitila limbriche della chitarra, come
Vazione della mano destra, nel posizionarsi
vicine af ponte o verso la tastier, porti
sensibifi modilicazioni timbriche. La chitar-
ra classica posstede Iniatti te registii: ano
aspro [al ponte), uno normale (in prossimita
detie bucal, ed une dolce {sulla tastieral
{Fota 0.18 « 19 © 20.
Fate 19
Passiamo ora ad eseguire afcuni eserc
bero e poi con quello agpoggiato
NA
MOML MEM at os 8 SI
SOLS, SOL SOL RE RE RR RE LA La
9
MOMUMIMI La LALA LA RE OHE RE RE
StS SES) ath sat
StS) MEME SOL SOL SI St RE WHE SOL SOL LA LA RE ORE MIME LAL
TA LA RE RE RE RE SOK SOL SOL SOL st SE SSE
N33
MESIMD SI) 31 SOL S91 SOL SOL RE SOL RE ORE LA RF OTA LA AM LA am
RE LA RE La SOL RE SOL RE St SCL SI Soko MTS} OW St
SIME SIMI SOL S1 SOL SL RE SOL RE SCL LA RE LA REO MEEA MILA,
LA.-RE LA SE ORE SOL RE SOL SOL SISOL SST
Sulla corca indice » media ncn appaggiana,
N.S
MEAT ML MMT LAC ME am MERE MALO SOL A sa MSI Mat
SOL MoM STE MPTP GA MME MEME MEM
eee Bont Qo Qe 8
MoOLA RE LA EA RE SOL RE RE SOL St SOL SOL MTT
RE 50, 81 SOL ka SO tA REL
MANO SINISTRA
La mano sinistra assolve fondamentalmente
a due compiti: il primo é di preparazione
della nota sulla lastiera ed il secondo, una
volta pulsata la corda con 1a mano dastra,
adi conscevazione del suono.
Posiziunande il dito medio, ossia il terze
della mano sinistra, sulla basliora, badancles
ad utilizzare osclusivamente [a punta estre-
ma del polpastrelle del dito, si potra avere
Fasalia impostazione della mano in rela.
zione alla tastiera stessa. Le dita dovearno:
essere sempre perpendicolari (a martellet-
10) af telo delle corde. La pressiong sulla
corda awverrd attraverso la punia dell'uli-
ma ialange, posta vicine alle sbarreite me-
talliche dei tasti (verso desiral. IE paso de-
ve essere lepgermente piegata verso l'ester-
no, con il pollice appasto ai medio. pol-
fice stesso si muove sia in senso orizzontar
le sia in senso verticate in mado che fra la
mano ed il manico esista sempre une spa-
zio di alcuni centimetri; esso deve essere
Ccomunaue posizionato net basso del retro-
manico # non deve possibilmente superare
{a linea che divide a meta i manico stesso,
Per non confondere la diteggiatura della
mano sinistra con quella delta destra, le di-
Fos 22
21
ta della sinistra verranno indicate con i nu
meti anziché con le leuere (1 =indice,
Jemedio, 3=anulare, dzmignolol. Le une
ghie della mano sinistra devano essere to-
nute cortissime.
Iniziamo ora a posizionare le dita sulla ta-
stieia partendo dai V tasto. C'e da dire che
quesia posizione reade inizialmente pitt
agevole mettere in pratica quanto fin ati
esposto, sia per fa minor larghezza dei lasti
sia perché la mano sinistra, una volla alza-
ta, sf irova naturalmente nella sua corri-
spondenza, senza che il hraccio e Favam-
braccio si spostino dall’asse del corpo.
Posizioniame quindi un dite per volla par
tendo dallindice in maniera che 1 polpa-
stralli abbiaro il maggior spazio possibile
di appoggio sulla corda; la naturale incti-
nazione che assumono le dita quando il
potlice si oppone al medio vede Vindice ed
il mignoto rispettivamente inclinati verso
sinistra ¢ verse destra; si deve quindi cerca-
fo, pee quanto passibile, di correggere que-
sta inclinazione facendo agire queste dita
pitt perpendicolarmente possibile alle cor
de, in maniera tale che anche [indice e i
mignolo come il modi¢ ¢ V'anularo) abbia-
no una sufficiente base d'appogyie (Foto n
24, 22, 23. 24),
Fete 22
2
Fore 25 voto 28
Esoguiamo ora una serie di esarcizi con diverse combinazioni.
Una volla che le note sono state suonate, si cerchard di mantenere il pit poscibile ta posi-
zione delle dita ferma sulla tastiera, con il duplice effetto di dare pik stabilita alla mano s
nistra e maggior continuita fra un suono e Haltio, Le dita dovranno essere solievate solo per
effettuare il cambio di cord
¥
oe
23
24
BREVI CENNI DI
TEORIA MUSICALE
Le note poste sul pentagramma, oltre a segnalare l'altezza dei suoni, ne indicane anche la
durata, questa viene clelerminata dai particolar’ segni, deiti figure, che le note assumono
1a durata dei momenti di silenzio viene indicata invece da altri segni, denominatt pause,
Vediamo ora una tabella con i segni pi usati:
FIGURA PAUSA NOME VALORE DURATA
° -_ INTERO 4 4 TEMPI
(seaigeevey 4
|
d —_ META 2 2 TEMP!
{MINIMA} 4
J 2 QUARTO 1 1 TEMPO.
{SEMIMINIMAP 4
d 4 OTTAVO 1 2 IN UN TEMPO
{croma) 8
J SEDICESIMO 1 4. 1N UN TEMPO
i {SEMICROMA) 16
‘tivalore dello dure e dole pause pud essere aumrentaio medignte Faggienig di ane 6 pil punt pasate
prose capo a nota F'auments dé meta del sua walore. bse = 324
La battuta lo misuraj & fo spazio che intetcore fra due sanghette ¢ solitamente viece divisa
in due, tre o quattro parti uguati chiamate tempi (o movimenti), per cui la battuta pud essere
adue, le 0 quaitro tempi. Le misure @ lore volta si dividono in: sermplicie composte
Nelle misure semplici la durata del movimento coincide {per ora) can [a figura di semimini=
ma (che viene definita anita di tempo). Come awiene per i suoni, ogni battuta deve avere
una precisa durata, che viene indicata da una frazione posta ali"inizio del brane subite dopo
{a chiave di violina.
2
tt numero che sta sopra (numeratore) indica il numero dei tempi; sotto di ess0 (denominato-
re) si trova invece il valore relative ad ogni singolo tempo.
Nelle misure compaste, invece, fa fazione sta act indicare il numero tnkale delle suddivisioni
Misure semplici
mavimenti
vine dhe Heme
“valle misure sero Ta sudktivisiune di og sngolo snavimnento & binara
Misure compaste
“nelle misure compose fafa sudivisione di ope! singoto movimerre & temaria,
6
PROSPETTO DEI SIMBOLI USATI
CHITARRISTICI
Diteggiatura mano desira Diteggiatura mano sinistra = prima corda
i= indice Fsindice @®z seconda coca
msmedio 2=media sz tera corda
a= anulare Jeanulare @- quana corda
p= police 4=mignolo ®zquints corda
®s sesta coda
O=lo zere posto vicine ad una nota indi
sinisira (corda a vuoto).
un suony prodotto senza I"intervento della mano
HILUT ecc.=l numeri comani in corrispondenza delia nota indicano il tasto da premere,
AzAccentare la nota utilizzando il tocco appoggiato.
8-Barré (edi pag. 53) - 1/2 B-Semiharré
DINAMici:
‘oppure crese. crescende, increment pradsale della somorits
p=piano Oppare dim. sciminuendo, diminurione graduale della sonora
mp=rne270 piano ral, =ralertande
nf =MezZ0 forte tariando.
Salone cceleraade
LF morissimo
sf=sforzato
#= diesis, innatza il suono di un semitono
b= bemolte, abbassa if suono di un semitone
he Dequacro, riporta if suono alle stato naturale
© alterazioni possona essere permanenti quando si trovano segnate dopo la chiave di viol
no {hanno effete per tutta la durata de! breno), momentanee se segnate vicino alla nota (la
foro validita viene timitata al corso di una sola misura).
LE NOTE DELLA CHITARRA
IN PRIMA POSIZIONE
28
Le Note MI-FA-SOL sulla! Cords
2 Mt MO MeN na Mit Mea Mi OMS noo
FA PR EA IA ERA BAA
be:
Si suona in prima posizione quand ke cita della man snisrafireice 1, medio 2. anuiare 3.@ migrola 4! suanane rispet-
\arnente sub Ht @ NV rasta,
29
36
Le Note SI - DO - RE sulla 2" Corda
RE ORF ORE RE REE REE
Le Note SOL - LA sulla 3 Corda
SOL SOL SOL SOL SO-0L SAL
31
32
Riepilogo sutle note dellottava SOL - SOL
La posizione lle stanghetie in ey ed in gid ron ha nessuna lafluenza sulla data delle note; Wb avans servira a diversi
care levee! ved pag 42)
Le Note RE-MI- FA sulla 4" Corda
35
5
a
4
a
3
z
4
vo
bo 60
po
36
Le Note ME- PA- SOB, sulla ¢* Corda
fac oME Ma
Perla spiznacione dle scale vedere & pag. 99
37
Scala Cromatiea in Prima Posizione
Ascendente
Discendente
LE NOTE SULLA TASTIERA DELLA CHITARRA
99
SCALE
to studio delle scale, nella tecnica chitarri-
stica, 2 Indispensabile sia per elaborare un
completo contrallo delle note sulla lastiera
nelle varie posiztoni possibifi, sia ner svi-
luppare una certa velocita nei movimenti
delle dita della mano sinistra. Altra peculia-
rita di tale siudio @ quella di facilitare fa-
zione sincrona della sinistra con la destra.
Inoltre, lo studio delle scale @ indispensabi-
le per prendere confidenza con i vari ambi-
ti tonali in cui ci si verra a Fovare
Deito questo, prima di iniziare fa trattazio-
ne del tema ticodiame che te scala & un
insieme ordinato di toni e semitoni che si
susseguano secondo regole precise. | toni e
i semitoni sono le unité di misura per iden-
tificare le distanze ira suoni diversi tl semi-
tono é le distanza pitt breve ed & facilmen-
te identificabite sulla chitarra: ogni tasto se~
ana la divisione di un sernitano.
long due lip: fondamentali ch scale: dia-
toniche © cromatiche. Le prime procedono
utllizzando sia i toni che i semitoni; le se
conde si ordinano solo attraverso l'utilizzo
dei semitoni
La chitarra ha un‘estensione che, partende
dal MI basso della corda a vuot @, artiva
al SI del XIX tasto della coda ME cantino,
Cid premessa, sulla chitarra si possono ese-
guire scale diatoniche e cromatiche di una
(0 due ottave in gai tonalita, montre per le
tonalita di MI, FA, FA#, SOL, LAb, LA, Sib &
Si 'estensione massima & di te ottave,
Vediamo, ner facilitare la memorizzazio-
ne, tre modelli base per le scale maggiori
quattro per Ie minoti melodiche che, tra-
sportaii sulla tastiera, censeatiranno di ese-
guire le scale in tutte le tonatita,
FONALITA BASE
Maggiori:
DO DO#/RED
SOl: SOL#AAD
Mi: FA
Minori
la fa
si: lat/sib
do: dotifreb
mi
TONALITA DERIVATE
RE REA/Mib
LA LA#SIb St
FAWSOLD
faitfsotb sal solitflab,
re settfmni
Consiglio di iniziare to studio ribattendo fe note prima quattro poi due volte ciascuna con il
tocco appoggiato.
La diteggiatura da seguire con fa mano destra @ la sepuonte: imim; iaiaymama
SOL Maggiore
103
‘MI Maggiore
102
103
104
ARPEGGI
Gili accord, ossia un insiame di nate rego-
late verticaimente, possano essere “ampes:
siati” con la mano destra. tn questo tipo di
ésecuzione, fa pulsazione della mano de-
stra nan é simultanea,
Larpeggio pud essere, nelle varie formule,
ascendente 0 discenciente, ¢ in ogni caso Fe
dila pulsano fe corde ovitando di appog-
giarsi sulle sottastanti e lesclando che vibri-
no tutte.
La naturale differenza tra le dita (in gran-
dezza ¢ in farza) spesso invaglia gli esceu-
tori ad adoperare ie dita pitt fort e 2 trascu-
rare quelle pit: daboti; ne consegue nen
soltanto un‘ineguaglianza notl‘espressione
delle varie note, ma anche Fimpossibilit&
di eseguire passagai nei quali non si posso-
no fare scelte di cita, Nel? arpeggio if dorse
della mano deve essere i! pid fermo possi-
bile e fe dita aon si posane sulle corde pri
ma dellistante in cui fe pizzicano (a meno
che non si voglia produrre un particolare ti-
po di staccate).
Al fine ot sveluppare quindi una efficace in-
dipendenza dette dita dolla mano destrs
negli arpeggi, veciamo une serie di combi-
nazioni tratte dai 120 Arpegal op. 1" di
Mauro Giutiani
los
peiominmipms pmipminminm i
ee ode ea ie ed Bed
Dimeimpimsim pimpimeimpim
sat
Pripmveminmt pmipminmi pms
106,
pam
ay
amie
1 Hsimbot & sestina sta ad inci are un gruppo cl se: node equivelente al valote i quae
107
108,
IL LEGATO
Sulla chitarra @ possibile, con le “legature”,
eseguire pill note con la mano destra suo
nando solamente la prima,
1 tipi di legatura realfzzabilt sulla chitarra
sono quattro:
Ascendente - Discendente - Combinale -
False (0 “ad eco"|
La lepatura ascendente (hammer on) @ Fu-
nione, senza interruzione del suono, di due
© pid note in ordine ascendente sulla stessa
corda. Viens eseguita con fa mano sinistra
dopo che #l dito della mano destra ha suo-
ato (possibilmente usando i tacco apnog-
giato, in maniera da essere faciitali dall'e-
nergia sprigionata dalla corda che ritoraa
alla posizione normale) fa prima delle due
© pid nole da legare, Successivamente, le
dita detla mano sinistra, pigiando con forza
i tasti corrispondenti alle note che seguono
(vieino alla sbarretta melaltical, producono
il suono senza che si debba far di nuove
uso della mano destra, Affinché la legatura
abbia maggior efficacia @ utile non solteva-
ro troppo il dito che deve offettuare fa toga.
tua,
La legatura discendente (pull off) & unio.
ne di due 0 pitl note in senso discendente
Viene eseguita anch’essa dalla mano sini-
stra dopo che questa ha preparato sulfa ta-
stiera le note da eseguire, Una voita suona-
ta con fa dastra la prima note - usando
sempre if tocco appogniate - il dito deli
mano sinisira tirer’ verso il basso la cosa
{in senso perpendicolare af telo delle com
de) consentencio casi alla stessa di entrare
auovamnente in vibrazione & producende
quindi il secondo dei suani preparati. Al fix
ne di una perfotta realizzazione & impor-
tante applicare fa foza_non solo al dito
che deve iegare ma anche a quello che
prepara, rimanendo fermo, la nota da lega-
te, La legatura discendente si pud oltenere
anche con un appoggiato della sinistra sul
la corda sovrastante.
4a legatura combinata ¢hammer on - pull off
é Funione i iegature ascendenti e discencent.
1a falsa legatura (0 “ad eco") & I'unione, sen
71a interruzione di sunno, i due o piu note se.
corde diverse, Per realizzarla, una volta suo-
nata con fa mano destra la prima delle note da
legate, le dita della sinista pigieranna con for-
za adeguata sullle corde ¢ sui rispetivi tasti,
30 STUDI
TRATTI DAL REPERTORIO
DIDATTICO TRADIZIONALE
|
|
|
|
i
|
Studio
A. Care (ISI - 1897)
S censigha di ascior i pia ounibie le dita della mano sinista ia aosizione sulla tstiera,alzandole saio quand ci si
‘ends nécessario. I simbaio al staal incicase il torneo, ossia la cipetzione delle batlute prccectere. Le grata musica
volummente semptficata in questo ed alt stl per renclome pid lacie fs romprensione,
41
Studio (ca “Studi” Op. 66
F Sor (1778 - 1839)
veil
li sretoio » (corona) protunga 2 piacere la durata della nota
a
A Levione (ds “Le prime levine ai chitsrra”)
Tiny J. Sagreras 1879 - #942)
$3 FS simite
a
Proparate aroventivamente con [a mana sinistra le poxizioné di gai singels bottta, I simBolo (terzina) sta ad indicare un
sBruppo of tre note equivaterte al valore di due. tn questo sucka compaione cue voci, individual date stangheete m gic
face inferior ed insu (voce superiors) della note.
Lezione ots “Le print tin deat
Aas
r
Studie (dal “Metodo Sor - Coste")
N. Coste {1806 - 1883)
43
ag
J. Sapreras
Studio (ae "Saxli" Op. 39)
A. Diabelli (1781-1858)
; :
45
46
i | Lezione le "Le prime lezioni di caitarsa")
i ice 8
*La dangheits cho unisce le note do e do diess sta ad indicare un cambio di pusizione oftenuts scivalanda il prime dito
della mano sinistia dal al aslo senza alzatlo dala rastera (portamento
1x
we [2] Séudio cu Sco
“ta legatura dl valore # una linea curva che unisce due rove delio sesso nome e altezza, formando up unico valore.
a7
J. Sagreran
Lerionne (d1"Le prime tvion i evar)
Lezione (aa Le prime tezioni di chitura")
49
con i 12 Studio (st "Metodo” Op. 59)
M_Carcasst (1792 » 1853)
50
Me (de "Le prieve Lezioni dk hata")
J. Sagreras
In questo studio troviarro per lz prima volta un segao dl akerazione ti] dono fa chiave di viola, Questa alterazione ha va.
lore per tla Is dorara del Erano.
Moderato (as "Metodo")
D. Aguado (3784 1849)
ay
$2
J. Sagreras
TE BARRE’
{| barré si ottiene quande un dito della ma-
no sinistia isolitamente if primo} preme
multaneamente pil corde sul medesimo ta-
sto. II cantatto con le corde & stabilito dalla
parte sinistra delltindive, cio® quasi lateral-
mente. tI dito non deve appialtirsi in una
posizione rigida in quanta, esponendo alle
corde il proprig profilo laterale, assicura
una pressione ed una aderenza uniformi
anche avantenendosi relativamente curve.
E alteest importante che il dito sia posizio-
nato vicino al‘estremo limite del tasio ver
so destra, facendo attenzione che aloune
corde non subiscano una pressione pits de-
simile
53
bole a causa della piegatura esistente fra fa-
lange e falange. La funzione del pollice
della mane sinistra & tondamentale in
quanto esso deve esercitare una pressione
pari a quetla dell'indice, Pud essere richie-
sto di non pigiare tutte e sei le corde delia
strumento: in questo caso si ha il semi-
barré, i barré o i] semibarré possono essere
realizzati eccezionalmente anche con Ie al-
tre dita della sinistra
Graficamente il barré viene indicato con
una B maiuscola, seguita da un numero 10-
mano che indica il tasto dove realizzario. II
semibaié, aivece, viene indicate con la
frazione 1/2 seguita daila B maiuscola e dal
nurnero romano.
Lenione (4a°"Le prime terion’ dich
1. Sagreras
2B
on
Preludio (daMetodo” Op. 39)
M, Carcassi
Moderato
5:
Lezione (aa"Le prime tsion i chiara")
Studio |as "Stwai" Op. 35)
oe [> | orn
57
Studio (1a “swat Op.44)
9
1. Sagreres
Letione (da "Le prime lecioy di chiterra")
*)
¢
Preludio (da "24 Preludi" Op. 114)
F. Canutli (1770 - 1841)
6
@ 24 Lezione tda "Le prime lesioni di chitarra")
Alegre be
Studio (aa "12 Pagilion® Op. 50)
M, Giuliani (1781 - 1820)
63
@
Studio tea “steal” Gp. 391
A. Diabet
Prime di studiare questo brane eseicitarsi rello studio sui legati pag. 108)
65,
Studio de Le Papition” Op. 50)
M. Ginfians
Andantino
J. Sagreras
67
Tarega (1852 - 1909)
Uarmonico al dedicesimo tasto dal ultima battuts si ottiene tiorando if suddette tasta con it quarto dite della
mano sinista
68
2p. 691
2
=
z
a
od
16 STUDI
DELL’AUTORE
(Roberto Fabbri)
72
a
Z
3
Z
z
Studio n,2
B
Studio n. 3
Studion, 4
76
Studion. 6
Studio n.7
8
|@ | 38 | Studio 2.8
79
Studio a, 9
Studion, 10
020
a
2
s
2
a
a2 Studio n. 12
+ ageignlato: le note delf accords. venyone suonate in rapida successione col police defladestra dal bazso versa it cant.
83
4
g
2
=
2
a
Studion. 14
S a5 Stadion. 15
86.
Gas, [as Studion, 16
87
:
6 BRANI DI AUTORI CONTEMPORANEL
DEDICATI A ROBERTO FABBRI i
4
Carlo Carfagna fanira
Nicola Giannelli Parting
Mario Gangi Ricordo
Francis H. Koerber Country Blues
Nicola Puglielli Walking Jazz
Nicola Puglielli Swing in prima posizione
110,
5 BRANI DAL CLASSICO AL ROCK
F. Tarrega Lagrima
Anonimo — Giochi Proibiti
J.S. Bach Bourrée
G. Gershwin Summertime
Pink Floyd Is there anybody out there?
Carto Carfagna (1940)
1 BT
vt mr
{ecmpo
39
90
_
@ em. xx ma
a
Sess
9
Parting
Nicota Gannelti 975)
92
Mario Gangt
Bae
Ty pene yyy
av NB
D
Hy
abate
a
93
Country Blues
en Francis H. Roerber (1964)
1e
“Tempo Swingato: tale indicazione significa che Vanefamenta del parza & da inteadersi “swinganta", come uno shuffle
crome scitc in 4/4 si stanerenne come se il pezat fusse i 12/8, alternando una semiminiina e una crema.
@&) Maing Sn
Nicola Paglielti (1962)
96,
Swing in prima posizione
Nicola Pagtielti
mi
a Lagrima
& 53 J Francisco Tarrega
, :
Acdane,"
Giochi proibiti
Anoniimo
Boe
3
14
1s
Summertime
‘oom “Porgy ant Bese")
ee
Teste di Ira Gershwin
Musica di George Gershwin
rr
=
Ee
F
7
Is there anybody out there?
@& [| Test e Musica di Roger Wates
‘odin apo vate ge a es akon pooh
no
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Forced Migration of Blacks/Negroes (Israelites) Across The Atlantic From 1595 To 1866Document15 pagesForced Migration of Blacks/Negroes (Israelites) Across The Atlantic From 1595 To 1866Viktor CasualNo ratings yet
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Detecting Sites UkDocument761 pagesDetecting Sites UkViktor CasualNo ratings yet
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- 2 07 15 BlackHistory Pt1 Color BWDocument13 pages2 07 15 BlackHistory Pt1 Color BWViktor CasualNo ratings yet
- Fairlop Fair HistoryDocument4 pagesFairlop Fair HistoryViktor CasualNo ratings yet
- Guitar Presentation - Journey Through The CenturiesDocument2 pagesGuitar Presentation - Journey Through The CenturiesViktor CasualNo ratings yet
- Diatomaceous Earth Fact SheetDocument2 pagesDiatomaceous Earth Fact SheetViktor Casual100% (1)
- Lords Bushes Knighton Wood Epping Forest LeafletDocument3 pagesLords Bushes Knighton Wood Epping Forest LeafletViktor CasualNo ratings yet
- 3 07 15 BlackHistory PT 5 TheAdoption BWDocument10 pages3 07 15 BlackHistory PT 5 TheAdoption BWViktor CasualNo ratings yet
- Epping Forest MapDocument1 pageEpping Forest MapViktor CasualNo ratings yet
- Spirit of God PT 1Document8 pagesSpirit of God PT 1Viktor CasualNo ratings yet
- Spirit of God PT 1Document8 pagesSpirit of God PT 1Viktor CasualNo ratings yet