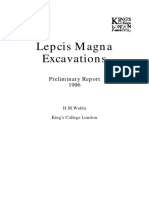Professional Documents
Culture Documents
BRECCIAROLI - Recenti Scoperte A Sabratha - La Necropoli Di Sidret El Balik, 1975
BRECCIAROLI - Recenti Scoperte A Sabratha - La Necropoli Di Sidret El Balik, 1975
Uploaded by
r monpean0 ratings0% found this document useful (0 votes)
34 views33 pagesOriginal Title
BRECCIAROLI - Recenti Scoperte a Sabratha - La Necropoli Di Sidret El Balik, 1975
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
34 views33 pagesBRECCIAROLI - Recenti Scoperte A Sabratha - La Necropoli Di Sidret El Balik, 1975
BRECCIAROLI - Recenti Scoperte A Sabratha - La Necropoli Di Sidret El Balik, 1975
Uploaded by
r monpeanCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 33
I
Anronino Dr Vira
LE NECROPOLI DI SABRATHA
NELLA STORIA URBANISTICA DELLA CITTA’
‘A mo’ di presentazione e d’inquadramento topografico del
lavoro che segue, opera della mia valente ¢ attenta collaboratrice
agli scavi di Sabratha, dott.ssa Luisa Brecciatoli Taborelli, ritengo
utile fornire qui le notizie essenziali concernenti l'ubicazione del-
le necropoli dell’antico Emporio, sperando cosi di conttibuire
a colmare una delle lacune di cui soffre ancora Ia nostra conoscen-
za della cittd. Il mosaico aerofotogrammetrico che presento alla
tav. I, ed al quale il lettore vorra rifarsi per la individuazione
delle aree ¢ dei monumenti di cui si parla & dovuto alla Soc. E.I.
R.A. di Firenze, che I’ha preparato sulla base di proprie riprese
della prima met& degli anni sessanta.
Le necropoli pitt antiche furono certamente fagocitate dallo
sviluppo del primitivo nucleo urbano, dato che possiamo conside-
rare una costante degli insediamenti punici il sistemare le necro-
poli ad immediato contatto con Pabitato. La progressiva e sem-
pre pitt accelerata crescita di Sabratha fra il wv ed il m sec. a. C.
comportd una cintura di latomie assai profonde, aperte nel banco
i arenaria sul quale 1a stessa citt® poggia, gia perlomeno all’altez-
za della via est-ovest lungo la quale si attestd Ia fronte meridionale
delle mura bizantine '. Queste latomie distrussero certamente le
1, Come hanno rivelato i saggi di scavo condotti da me stesso sot-
to il basolato della via a nord del mausoleo B, ¢ dal dott. B. Conticello
sotto la piazza fra gli isolati 11 ¢ 9 della regio VI. Resti di una tomba a fossa
scavata nella roccia sono stati rinvenuti poco a sud-est del mausoleo B sotto
e fondazioni del vano 32 («MEFR.», LXXX, 1968, p. 35, fig. 2).
12 Antonino Di Vita
pit antiche tombe della cittd punica, ma una volta abbandonate per
Ie nuove cave pitt meridionali (quelle a sud ¢ sud-est del teatro) €
prima di essere colmate per far posto ai nuovi quartieri dell’etA augu-
stea della regio vr, in esse si inseri una necropoli d’eta ellenistica con
sepoleri sia a fossa che a camera. Di tale necropoli i due monumenti
pitt significativi in assoluto furono certo i mausolei A ¢ B i quali, co-
me é stato rilevato , costituivano la nefesh, il segnacolo monumenta-
le, di tombe a camera scavate nella roccia ai margini di essi e trasfor-
‘mate poi in eta romana in cisterne (tre a ridosso dei lati est, sud ed
ovest del mausoleo B). Da una tomba della stessa necropoli pro-
viene poi, a mio parete, la piccola iscrizione ancora in caratteri
punici trovata nel 1965 nello scavo di uno dei vani sotterranei
dell’isolato 6 (sempre nella regio vt) e pubblicato dal Levi Della
Vida’. Tanto i mausolei quanto quest’iscrizione datano la necro-
poli cui appartengono, inserita negli spazi risparmiati dalle lato-
mie pit: antiche della citta, al 11 sec. a. C.
Pitt o meno coeve sono le poche tombe risparmiate dalla fascia
pid esterna delle latomie sabrathensi, tagliate a cielo aperto a sud-
est della citta, aperte forse gid nel 1 sec. a. C. ed utilizzate a lungo
fino almeno al mr secolo dell’Impero. In effetti, in uno stretto
« istmo » di roccia conservato fra la latomia grande alle spalle del
teatro © I'altra, gtandissima, pitt ad oriente, il Bartoccini trovd
fosse sia per inumati sia per incinerati ed una camera ipogeica, i
cui corredi hanno indotto lo scavatore a datare questo lembo di
necropoli nel corso del 111 sec. a. C.*. Una parte della suppellettile mi
pare perd pit tarda, almeno di 11 secolo, mentre pitt tarde, di 1 seco-
1, appaiono, ad un primo esame del materiale, le due fosse rinvenute-
nel 1967 dal lato opposto di queste tombe, a sud-ovest della cittd.
Si tratta di una scoperta isolata, ma Pubicazione di tali fosse, 250
metti a sud del fabbricato degli Ufici, al margine orientale della
via che porta alla tonnara gia Paternd, e quella delle camere pub-
2. Cir. « Quademni di Archeologia della Libia », 7 (1975), p. 179 ¢ n. 42.
3.G. Levi Detta Vins, Iscrizione punica di Sabratha, in «Libya An-
tiqua», V (1968), pp. 9-11 e tav. I
4. R. Barrocerst, La necropoli punica di Sabratha il culto delle divi-
itd egicie in Tripolitania, in « Annali dell eituto Orientale di Napoli >, 1.2,
TIT (1949), pp. 35 sgg., a p. 46,
Le necropoli nella storia della cittd B
blicate dal Bartoccini, mostrano l’estensione delle necropoli elle-
nistiche: dal mausoleo B a ridosso, o quasi, della cittd del 1 se-
colo, esse sembrano aver occupato, sia pure senza continuiti, una
Targa fascia in senso est-ovest alle spalle di quasi tutta quella che
sara la cittd romana. L’ubicazione dei mausolei A e B poi mostra
verosimile l'ipotesi che sepolcri monumentali fossero ubicati lungo
gli assi viari che si dipartivano dalla citta.
Liimpressionante espansione del 1 sec. a C. segue la distru-
zione dei mausolei A e B e segna la sparizione della nectopoli pit
vicina alla citta. Le nuove necropoli furono ubicate assai lontano
dall’abitato cui si riferiscono: ad oriente una setie di piccole ca-
mete ipogeiche fornite di pozzetto d’accesso poco profondo, con
nicchie pet incinerati ¢ decorate con pitture furono messe in luce,
nel 1942, dalla trincea scavata pet posate Ia fogna delle caserme
di Sabratha. La pitt settentrionale di queste tombe, la pitt ricca-
mente dipinta, & quella che ho chiamato « della Gorgone » (pet
via della testa di Gorgone raffigurata allesterno della sua fronte)
€ mi pare possa datarsi bene a cavallo dell’era cristiana ‘. Queste tom-
be restano ad 850-900 metri ad est del foro cittadino, ed anche
pid lontane (circa 1300 metri dal foro) sono quelle scoperte nel
1972 in localita Sidret el Balik e che costituiscono la seconda ed
anche pitt cetta testimonianza delle necropolisabrathensi del 1
sec. d. C. Si tratta di un piccolo gruppo di tombe presentato dalla
dott.ssa Brecciaroli nello scritto che segue e che hanno per noi
lo straordinario interesse d’essere tra le poche sepolture sabrathensi
a deposizione singola e con corredo cronologicamente omogenco.
La necropoli qui andd avanti perlomeno per tutto il 1 sec. d. C.
ed insieme a modesti cinerari deposti col corredo in superficiali poz-
zetti scavati nella roccia o in cassette di piccoli blocchi, si trovava-
no sepolture ben pid ricche ed importanti. Tale @ il caso della tom-
ba a camera segnalata da nefesh che ho chiamato convenzionalmen-
5. Nel settore pitt meridionale delV’area fra il muro di cinta del 1
secolo © queste camere ipogeiche il sig. M. Gemel mi assicura che furono tinve-
‘ute in passato, durante lavori agricoli, tombe a fossa che potrebbero aver fat-
to parte della stessa necropoli, ma potrebbero anche essere posteriori allerezione
del muro di cinta e raccordarsi quindi cronologicamente con Ie vicine cata-
combe
4 Antonino Di Vita
te mausoleo C, perché presenta, sia pure in scala assai ridotta, lo
stesso impianto dei mausolei A e B, dei quali 2 una evidente, roz-
za imitazione. La sua presenza sembra indicativa, poi, del fatto che
i'due vecchi mausolei, distrutti nella parte pitt alta, erano ancora
visibili, pur inseriti nelle nuove costruzioni d’etd augustea. Questa
nefesh ® costruita esattamente in corrispondenza di una ricca camera
scavata nella roccia, il cui corredo pitt antico (la tomba fu adope-
rata per lunghi decenni) la fa datare in eta claudio-neroniana, vale
adie la stessa cui vanno attribuite le tombe vicine, come ha mostra-
to lo studio fattone dalla dott.ssa Brecciaroli. Va tilevato che parte
di questa area a necropoli fu nei secoli successivi occupata da abi-
tazioni ed installazioni legate all’attivitd di una cava di tin esisten-
te sul posto. Questi edifici e la stessa cava andarono fuori uso
col terremoto del 306-310 ed allora nella vecchia cava fu ticavata
tuna tomba a camera con la quale fu connessa la pitt importante area
pet la celebrazione di refrigeria che sia mai stata trovata in Africa
tav. I.
Ritornando alle necropoli del r sec. d. C. & ancora da ricorda-
re che probabilmente gia in tale secolo, ma di sicuro in quelli suc-
cessivi, si inizid a seppellire su un modesto rilievo che restd quasi
ai margini dell'area urbanizzata nella fase di maggiore espansione
della citta ¢ che sincontra circa 500 metri in linea d’atia a sud-ovest
del foro. Quivi, in propriet di Amor el Aiuri, su un’estensione di
qualche ettaro a pattire dal rilievo e andando verso occidente, nel
1966 lavori agricoli di scasso misero in luce numerosi element che,
in un soptalluogo effettuato alcuni mesi dopo la lavorazione del ter-
reno con trattore, ebbi a riferire a tombe talora anche monumentali
costruite in atenaria; per la datazione di esse non ho perd elementi e
scarsamente indicativa resta, dato il tipo di manufatto, la pressoché
assoluta mancanza di marmo che, com’ noto, entrd nelle costruzioni
di Sabratha solo a partire dal pieno 11 sec. d. C.
Camere ipogeiche s'incontrano specie lungo il margine setten-
trionale di questa necropoli, mentre ancora pitt a nord, nei pressi
della tonnara, numerose sepolture a partire dal rit secolo in poi
furono inserite nell’area del fophet del 14 sec. a. C. - 1 sec. d. Cy
6. Cir, « Quaderni di Archeologia della Libia», 7 (1975), p. 183,
Le necropoli nella storia della citta 1s
rinvenuto ad un centinaio di metri dalla spiaggia’. A parte un
enchytrismos in una grande anfora del gruppo 1 delle « Tripolita-
ne» , si tratta di semplici tombe a cassa monosome, orientate est-
‘ovest ¢ con testa ad occidente, fate di pezzi di stele, di lastre e
blocchi riadoperati. Di esse alcune sono chiuse da larghi frammen-
ti di cocciopisto che le farebbero datare non prima degli ultimi de-
cenni del 1v secolo se, come mi pare, tali frammenti furono presi
da una vicina villa a grande peristilio, dove superfici di cocciopisto
simile sono state ritrovate in abbondanza.
Una menzione a parte meritano i mausolei che, insieme a se-
polture a fossa terragna, prima ed oltre Vanfiteatro, bordavano da
nord e da sud Ia strada per Oca. Ne sono individuabili facilmente
almeno otto, di cui due assai imponenti formano dei grossi mam-
melloni a nord-est dell’anfiteatro; erano tutti costruiti a grandi
blocchi squadrati e sono ridotti oggi al solo nucleo interno. La loro
esatta datazione mi testa incerta (11-111 secolo? ), mentre sul finire del
mt secolo, fra teatro ed anfiteatro, al margine meridionale della
necropoli del 1, i cristiani tagliarono la loro catacomba, che rag-
tiunse un'estensione assai ragguardevole e che ha dato materiale
databile durante tutto ’arco del secolo 1 *.
Dopo la distruzione del 365, poi, si seppelli dentro Ia stessa
area cittadina, sia nei pressi delle basiliche cristiane, sia sparsamen-
te, sia in aree ben delimitate, come avvenne nella regio 1v, subito
a nord-est del teatro. Qui gli scavi hanno rivelato una vera e pro-
pria nectopoli d’eta vandala © pit probabilmente bizantina, con
tombe a fossa profonda, segnalata, sul livello raggiunto dalla citta,
da cupulae del tipo ben noto dalla necropoli di Ain Zara nei pressi
di Tripoli’.
7. Si wats di scopes meen inci, Ame di guess tombe fone
tagline spezate vin, iseme parte del fopbet, pellinverno
Ai teat oman di uimpresa tule che peleveva sbi; ve fone
forest regolarmente dal Dipartimento nel 1974, alte cingue (wi mg. 43 di
Seperticie plata) sono venute alla hice neg svi condor nel 1975 dalla
MisioneArchcologics Teles.
Vedi A Neston, La catacombn di Seratba (Tripoltania). Tndagne
prlinivare in Libya Antigua TX (1972273), In coro at stampa,
Cle in acivene tne Guaderni dl Arctolgia della Lib >, 5 (1967),
p Been
16 Antonino Di Vita
Nessun elemento ho per segnalare sepolture databili nei due
secoli in {cui Sabratha fu araba, ma mi pare indubitabile che eli ul-
timi abitanti continuarono a seppellire nelle immediate vicinanze
dell'area ancora occupata, che si limitd probabilmente alla zona
del foro ¢ adiacenti, da dove provengono le poche iscrizioni arabe
pervenuteci ®,
10. Cf. Barroccrt, in « Libya Antiqua », I (1964), pp. 40-42, savy. XXIII.
XXV. Secondo il Bartoccrnt, ibidem, p. 38 sarchbero posteriori al secolo VIL
due. delle tombe inserite nel lastricato della piazzetta fra V'antica basilica ed. il
empio antoniniano,
1
Lursa Breccraroit TaBorELLI
REGENTI SCOPERTE A SABRATHA:
LA NECROPOLI DI SIDRET EL BALIK
Le tombe ad incinerazione qui prese in esame sono state rin-
venute negli anni 1972-74 in seguito a lavori edilizi in localita Si-
dret el Balik ' e sono situate nei pressi del viale che collega la citta
moderna di Sabratha all’area degli scavi, circa 700 metri a sud
dell'ingresso di questi: tavv. L-II.
Per diverse caratteristiche esse si possono distinguere in due
gtuppi. II primo comprende le tombe I-VI, situate ad ovest del
viale, costituite da pozzetti scavati in un banco roccioso_affio
ante € distribuiti su un’area ristretta di circa 20 mq.: & verosi-
mile che altre deposizioni si possano rinvenire ancora pitt a nord,
mentre verso sud Ja necropoli venne quasi certamente asportata
dal taglio della roccia effettuato nel 1v sec. d. C., onde ricavarvi
una monumentale area per la celebrazione di refrigeria?: tav. X, 1.
Avvertenza: i grafici sono opers del sig. Luigi Taboreli, Tecnico nellIsti-
tuto di Archeologia e Storia dell'arte greca e romana dell'Universiti di Mace-
rata; Ie fotografie della tav. X 1 ¢ 2 sono del sig. Antonio Solazsi, della So-
printendenza alle Antichitt del Lazio; quelle delle tavv. XII 2; XIII 1-4 sono
del prof. Antonino Di Vita; le restanti sono della scrivente. I disegai presentati
nelle tavw. IIFIX sono ridotti alla scala 1:3, mentre le lucerne sono ridotte
alla scala 1:2.
1. Le Tombe I-VI furono scavate dalla scrivente in due riprese, nel:
Trestate del 1972 © del 1973, poiché le ricerche non erano state estese dopo il
primo rinvenimento, esulando dal programma di attvita della Missione Archeo-
Jogica Ttaliana in quegli anni; le tombe VIX furono riportate alla luce nel 1974
4 cura del Dipartimento alle Antichit Iibico, cui sono grata per avermene con-
2350 lo studio © per Tampia collaborazione prestata
2, Per una noticia preliminare si veda A. Ds Vira, in « Quadetat di Archeo-
Togia della Libia », 7 (1975), p. 183,
18 Luisa Brecciaroli Taborelli
Il secondo gruppo, comprendente le tombe VIL-X situate ad
est del viale, presenta una differente tipologia, dovuta in parte alla
diversa natura del terreno — costituito qui da strati sovrapposti di
sabbia, roccia ed argilla — ma soprattutto alla monumentalita della
tomba VII a camera ipogeica, alla quale sono collegate le due tom-
bea fossa VIII ¢ IX ¢ la modestissima deposizione X, disposte tut-
te sulla fronte ovest dellipogeo. Ci troviamo dinnanzi, con ogni
probabilita, alla tomba di una ricca famiglia, con annesse all’ester-
no le deposizioni di suoi componenti di tango servile: tav. XII 2.
Una modesta condizione sociale denunciano poi anche le se-
polture del primo gruppo; se infatti una relativa ricchezza di cor-
redo si nota nei pozzetti II, IV e V, nei quali il cinerario @ accom-
pagnato da una lucerna, un vasetto a pareti sottili ed una lagoena
in ceramica comune, le tombe I III ospitavano soltanto il vaso
cinerario, al quale si aggiunge nella VI uno specchio.
E evidente dunque che I'interesse di queste tombe non con-
siste tanto nella varieta del corredo quanto nel fatto che, trattando-
si nella quasi totalita di deposizioni singole, abbiamo a disposizione
corredi cronologicamente omogenei che permettono una piti precisa
datazione, per mezzo delle classi ceramiche note, della ceramica
comune di produzione locale, come ad esempio ’anfora cineraria
ovoide delle tombe I, IT, III e VI
Le lucerne e 1a ceramica a pareti sottili indicano infatti, per
entrambi i gruppi di tombe, una datazione in periodo claudio-nero-
niano; fa eccezione Ia tomba VIT che, dovendo accogliere pit: depo-
sizioni, ebbe una prolungata utilizzazione, La durata del periodo re-
Iativo non si pud stabilize con certezza assokuta, dal momento che la
tomba venne violata ¢ quindi i pochi materiali conservatici si debbo-
no considerare orientativi. E probabile che l’oggetto pitt antico, os-
sia olla cineraria di vetro la cui diffusione & attestata dall’eta di
Claudio, testimoni la prima utilizzazione, in concomitanza con il
sorgere della necropoli, mentre la data piti bassa & indicata dalle
lucerne a becco tondo che non sembrano oltrepassare Ia met del
1 sec. d. C.
Lanalisi del materiale rinvenuto permette inoltre di fare al-
cune brevi considerazioni su alcune classi ceramiche in uso a Sa-
bratha nel 1 sec. d. C. e di distinguere cid che veniva importato e
Recenti scoperte a Sabratha 19
cid che invece veniva prodotto localmente *. Certamente importa-
te dall’Italia sono le lucerne di 1 secolo *, in questo caso i due esem-
plari con becco a volute e gli altti due con becco cuoriforme della
variet’ pit antica, che potrebbero testimoniare a favore di una pro-
venienza dalla Campania *; cid che non mi pare di poter affermare
per le lucerne della tomba VII.
Assai poco probabile mi sembra pure limportazione dall’Ttalia
della ceramica a pareti sottili presente nelle tombe; troppo poco
si conosce di questa produzione per azzardare delle ipotesi, anche
se escluderei, per le caratteristiche dell’argilla, una fabbricazione
locale, Questa & invece certa per la ceramica comune, contraddi-
stinta da un tipo di argilla friabilissima, ad alto contenuto di sab-
bia, che si riscontra fin dal periodo punico-ellenistico e che ora
possiamo identificare come propria di Sabratha®, Il repertotio for-
male mostra poi caratteri di attaccamento alla tradizione punica,
dal momento che gli antecedenti di alcuni tipi di contenitore, come
Vanfora ovoide e l’olla globulare, si possono rintracciare nella tipo-
ogia ceramica punica di eta ellenistica.
Una analoga persistenza delle tradizioni locali rispecchia d’al-
tronde l’architettura della tomba VII, che ad esse si rifa tanto nella
tipologia dell’interno quanto nel concetto di monumentalita del-
Testerno.
3. Il discorso potsd ampliarsi allorché verranno studiati i materiali di
altse tombe sabrathensi; per ora Io studio @ soltanto agli inizi, anche se un
notevolissimo contributo alla conoscenza della ceramica di Sabratha viene dalla
catalogezione, tuttora in atto, dei materiali dello scavo stratigrafico intomno al mau:
soleo B, i cui tisulteti preliminari sono esposti da A. Dr Vira, in « Monogratie
di Archeologia libica », XIT (1976), cap. 11, in corso di stampa,
4. Cle, anche E, Jovy, Lucerne del Museo di Sabratba, in « Monogratie di
Archeologia libica », XI (1974), p. 97.
5. La produzione delle lucerne a becco tondo della varietd pid antica po:
trebbe essere localizaata nei centri vesuvianis si veda a questo proposito: AA.
‘VV., Ostia TIL, in « Studi Miscellenei », 21 (1973), N. B. 3 a p, 402 € p. 662
Non @ forse ipotesi azzardata proporre una provenienza dalla Campania delle
nnostre lucerne, in considerezione del fatto che la qualita dellargilla e della ver
nice le avvicinano assai strettamente ad esemplari analoghi di Pompei, come
gentilmente mi ha comunicato il dott, Carlo Pavolini, curatore della schedatura.
6, Presentano costantemente questo stesso tipo i argilla anche i nume-
rosi vasetti rinvenuti nel ropbet dim sec. a. Cet sec. d, C., recentemente sev
perto a Sabratha ed in corso di studio da parte della scrivente
20 Laisa Brecciaroli Taborelti
Tompa I (tav. III 1)
Pozzetto di forma ovoidale bilobata (m. 0,30 X 0,36; prof.
0,28), era stato notevolmente danneggiato dal passaggio del ca.
terpillar, le cui lame avevano asportato la parte supetiore del va-
so cinerario, unico oggetto di corredo; questo era collocato vettical-
mente e poggiava su un leito di frammenti di parete di anfora da
trasporto,
Anfora cineraria
Ricomposta parzialmente da numerosissimi frammenti
Argilla matrone rossiccio, friabile, con numerosissimi granuli bianchi;
ingubbiatura_giallognola
Alt. cm. 31,2; @ max. em, 20,4; @ orlo cm. 12,7; © piede om. 8,7.
Presenta orlo inclinato e ripiegato su se stesso verso T'estetno, con se-
zione « a mandotla »; collo non nettamente distinto dalla spalla, legger-
mente svasato verso l'alto; anse a sezione arrotondata, con cingue scana-
lature ad andamento leggermente clicoidale, impostate poco al di sotto
del labbro e quasi verticalmente sulla spalla, dove presentano una dop-
pia strozzatura; corpo ovoide; fondo saliente ombelicato; piede ad
anello formante profilo continuo con la parete ¢ piano d'appoggio arto-
tondato.
E questo un tipo di anfora attestato fino ad ora soltanto nel
territorio compreso tra Tripoli ¢ Sabratha. Il maggior numero di
esemplati, conservati nel Museo di Tripoli, proviene dalla necto-
poli punico-romana sotto il « Forte della Vite »*; trattandosi per
Jo pitt di tombe con numerose deposizioni ed essendo i singoli cor-
edi mescolati, non & possibile trarne una indicazione di valore as-
soluto per il periodo d’uso di questo tipo di contenitore. Fanno
eccezione le tombe 8, 9 ¢ 10 (Aurigemma, tavv. X, a; XI, a; XII,
ab), poiché presentano non pid di quattro deposizioni distribuite in
7. Questo tipo di argilla & comune alla maggior parte dei vasi rinvenuti
nelle tombe, fatta eccezione per le lucerne ¢ la ceramica a pareti sottili; nelle
schede che seguiranno ci si limiterd percid a specificare soltanto il colore, va
Fiante a seconda dei diversi gradi di cottura
8.8. Aumicenas, Tn sepoloreto pusicoromano sotto il «Forte delle
Vite » 0 « Forte Nord-Ovest » in Tripoli (Libia), Tripoli 1958,
Recenti scoperte a Sabratha 24
un arco cronologico ristretto, compreso per le prime due in eta clau-
dio-neroniana e per la terza in periodo tiberiano-claudio. Interes-
sante notare, con la cautela richiesta da un argumentum ex absen-
tia, che Vanfora ovoide non compare in tombe databili anterior-
mente al regno di Claudio, ossia nelle nr. 6 ¢ 7 (Aurigemma, tavv.
VIII, ab e IX, ab).
Un cinerario analogo @ stato inoltre rinvenuto in una tomba
dipinta inedita di Zanzur?, databile intorno alla meta del 1 sec.
d.C. Un ultimo esemplare infine costituiva il vaso di consacré
ne deposto sotto il pavimento del vano 11, presso il mausoleo B
di Sabratha, ricostruito dopo il terremoto di eta primo-lavia: tav.
XIV 4; Panfora era chiusa all’imboccatura con un fondo di piatto
in Terra Sigillata italica, con bollo « in planta pedis » C. .M™,
T dati di rinvenimento finora acquisiti sembrano indicare, per
questo tipo di contenitore, una funzione esclusivamente tituale ¢
funeraria.
Cronologia. La presenza della sola anfora cineraria ovoi-
de offre un margine piuttosto ampio di datazione, compreso almeno
tra il regno di Claudio e quello di Vespasiano.
Tompa IT (tavv. IV; X 2)
Pozzetto di forma trilobata irregolare (m. 0,36 X 0,42; prof.
0,31), distava dal primo poco pid di m. 1,50 in direzione nord-
‘ovest. Anche in questo caso il mezzo meccanico ne aveva danneg-
giato la parte supetiore frantumando il cinerario e la brocchetta,
‘mentre la lucerna ¢ Ia coppetta, collocate sul fondo tra i vasi mag-
giori, sono state recuperate intatte.
9. Localiti a pochi chilometri da Tripoli in direzione di Sabratha, Per una
breve notizia su questa tomba cfr. Di Vira, in «Quaderni di Archeologia
della Libia », 7 (1975), p. 183.
10. Si tratta dello scavo stratigrafico di cui alla n, 3; tutte le notisie rela-
tive al rinvenimento mi sono state gentilmente comunicate dallo scavatore, A.
Di Vita. Per il bollo vedi: A. Ox - M, Comvoxr, Corpus Vasorum Arretinorum.
A Catalogue of the Signatures, Shapes and Chronology of Utalian Siggltata, Bou
1968, ne. 148,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- HALL, Jonathan M. - Ethnic Identity in Greek Antiquity 1997 PDFDocument242 pagesHALL, Jonathan M. - Ethnic Identity in Greek Antiquity 1997 PDFr monpean100% (2)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- BÉRMONT, C. - L'écriture À La Graufesenque - Les Vaisselles Sigillées Inscrites Comme Sources D'information Sur Les Structures ProfessionnellesDocument31 pagesBÉRMONT, C. - L'écriture À La Graufesenque - Les Vaisselles Sigillées Inscrites Comme Sources D'information Sur Les Structures Professionnellesr monpeanNo ratings yet
- GOODCHILD, R.G. - Roman Sites On The Tarhuna Plateau of TripolitaniaDocument42 pagesGOODCHILD, R.G. - Roman Sites On The Tarhuna Plateau of Tripolitaniar monpeanNo ratings yet
- LEPELLEY, C. - L'Afrique Et Sa Diversité Vues Par Saint Augustin - Ausonius ÉditionsDocument28 pagesLEPELLEY, C. - L'Afrique Et Sa Diversité Vues Par Saint Augustin - Ausonius Éditionsr monpean100% (1)
- LEPELLEY, C. - Évergetisme Et Épigraphie Dans L'antiquité TardiveDocument16 pagesLEPELLEY, C. - Évergetisme Et Épigraphie Dans L'antiquité Tardiver monpeanNo ratings yet
- LEPELLEY, C. - Iuvenes Et Circoncellions - Les Derniers Sacrifices Humains de L'afrique AntiqueDocument12 pagesLEPELLEY, C. - Iuvenes Et Circoncellions - Les Derniers Sacrifices Humains de L'afrique Antiquer monpeanNo ratings yet
- Matthews-1970-Olympiodorus of Thebes and TheDocument19 pagesMatthews-1970-Olympiodorus of Thebes and Ther monpeanNo ratings yet
- Erim-1970-The Copy of Diocletian's EdictDocument26 pagesErim-1970-The Copy of Diocletian's Edictr monpeanNo ratings yet
- Lepcis Magna - Preliminary Report 1996Document9 pagesLepcis Magna - Preliminary Report 1996r monpeanNo ratings yet
- Jones 1970 Sura and SenecioDocument7 pagesJones 1970 Sura and Senecior monpeanNo ratings yet
- Grafitos ColonialesDocument223 pagesGrafitos Colonialesr monpeanNo ratings yet
- GABRIELLI, Chantal - Violenza e Giustificazione Del Delitto PoliticoDocument52 pagesGABRIELLI, Chantal - Violenza e Giustificazione Del Delitto Politicor monpeanNo ratings yet
- CALLOUD, Irene - Per Una Storia Dei Restauri Italiani in LibiaDocument44 pagesCALLOUD, Irene - Per Una Storia Dei Restauri Italiani in Libiar monpeanNo ratings yet
- Lewis-1970-Roman Gold-Mining in North-West SpainDocument25 pagesLewis-1970-Roman Gold-Mining in North-West Spainr monpeanNo ratings yet
- ALFARO-GINER, C - La Mujer y El Trabajo en La Hispania Prerromana y Romana.Document24 pagesALFARO-GINER, C - La Mujer y El Trabajo en La Hispania Prerromana y Romana.r monpeanNo ratings yet
- Analysis of Raw Glass From Carthage HIMTDocument2 pagesAnalysis of Raw Glass From Carthage HIMTr monpeanNo ratings yet
- Fish Bones and AmphoraeDocument35 pagesFish Bones and Amphoraer monpeanNo ratings yet
- Éditions de La Sorbonne: Les Frontières Mouvantes Du Royaume VandaleDocument30 pagesÉditions de La Sorbonne: Les Frontières Mouvantes Du Royaume Vandaler monpeanNo ratings yet
- AMULREE - Hygienic Conditions in Ancient Rome and Modern London.Document12 pagesAMULREE - Hygienic Conditions in Ancient Rome and Modern London.r monpeanNo ratings yet
- Cedac-Carthage, 1Document20 pagesCedac-Carthage, 1r monpeanNo ratings yet