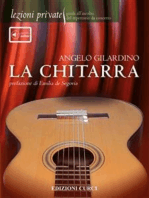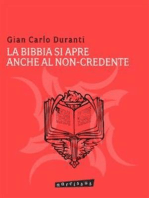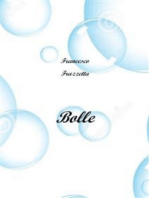Professional Documents
Culture Documents
Metodo
Metodo
Uploaded by
BalintGabor0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views38 pagesOriginal Title
Metodo_
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views38 pagesMetodo
Metodo
Uploaded by
BalintGaborCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 38
Gi Boise H.3°
GAVA fr,ing.C.0,BolJe afGenn
1924
per imparare a conosceré la musica e suonare
LA
CHITARRA
compasto colle masvima seiiphcita e chiareeza
LUIGL LEGNANI
OP.250
20208, Fr. Propriet
ott ett sipraelone trafonons sno rier
EDIZIONI & RICORDI
MILANO — warour ~ PALERMO ROMA
LONDRA
255 REC TREET. Wr
Luicl LEGNANI
Up.250
PRIMA LEZIONE
I principiante che ignora le Teorie della Musica sara tenuto d’imparare prima di tutto il numero delle
lineg, deg spazii, il sotto © sopra linee, e i luoghi su i quali posano Je note musicali.
Le lines sono einque e gli spazii sono quattro ineominciando a contare al disotto.
Tine spazié sopra linee @ spazit
‘WL
Sotto Tinee"e spaxit
DELLE NOTE DELLA MUSICA
Le note della musica sono sette ¢ si chiamano Do Re Mi Fa Sof La Si: la loro eostruzione @ di una te-
sting rofonda con una eodetta che si pud chinmare. anche gamba: —=—=—P=s— che ad ogni eam
biamento di loro situazione, preduce un differente suono. -
DeLta CHITARRA
La Chitarra tiene sei corde; tre delle-quali sono Bordoni,ossieno Bassi: Ie tre altre sono simili a quelle
del Violino. 11 primo bordone , si chiama in‘buona regoli sesta corda : Il secondo bordone
quinta corda: Tl terzo bordone. quarta cord:: La pit: grossa delle altre che rimangono, si chiama ter
nella che viene dopo si chiama seconda corda: ¢ Ia pit
cate ad un traverso di legno sopra alla tavola armonica che
in pari tempo vengono sostenute vicino alla testa del manico da un pezzettino di
sia bass
sottile, si chiama cantino,ossia pri-
corde stanno atta
si chiams Ponti
oso odi ebano portante il nome di Capotasto.
Vibrando le corde colla mano destra senza porre alcun dito della mano sini
pra { tasti, (2) cw risultano sei suoni Hiberi; i quali si pouno anche chiamare suoni a zero e a vnote.
I suoni liberi a zero 0 pure a vuoto sono Ii seg
Hl Medetla 8
tra nb sopra d'esse nf s0-
(ay Ltasti sono dedich pexzettint dt onso a di acento cotigenti a traverse del mamieo
Proprivte Rivord! yma
CoNFORMITA E LUOGHI DELLE SCDDETTE SEI NOTE 0 SCONI LIBERT
Tl Mf della sesta corda’sta posto sotto le linee con tre trattine in gamba.
Ti La della quinta eor-
z
a
12 posto sotto le linee con una trattina in gamba ed una in eapo. 11 Redella quarta corde
sta posto sotto le Tinee.
Ii Sol della terza corda sta posto in secottda linen. === Ml Si della
seconiti corda sta posto in terza Tinea
==
Tl Mi della prima corda sta posto in quarto spazio.
SECONDA LEZIONE
Nella prima lezione abbiamo detto che i tasti sono dodiei pezzetti di osso 0 di argento collocati sopra il ma-
co: i suddetti servono per formarvi le voci basse, medie ed acute ossieno mezzi tuoni e tuoni interi, che
si chiamano anche intervalli.
II passare con le dita della mano sinistra da un tasto all’ altro, 0 verso i] Ponticelio o verso il Capotasto,
produce un cambiamento di mezzo tuono pili basso o pid alto, owero pili grave o pill acuto come si ve~
dra in seguito.
hitanto parleremo del modo che si dovri praticure onde tefere: bene la Chitarra:120ecorreris un panchet-
tino non pit alto di un palmo, sul quale si porra il piede sinistro: 2°La parte media cho sta piegata den-
tro, ossia In parte inferiore dell'istrumento suddetto, fari d'uopo porla sulla coscia sinistra: 3°Sarh_ ne~
cessario tener la Chitarra pit alta dalla parte del eapotasto sostenendola hene colla mano sinistra,afli-
ne che la lurghezza superiare delle fiascie resti quesi per met naseosta fra la sinistra e destra. cose:
42.11 braccio destro dovrassi collocare sopra P angolo della tivola armonica e la fuscia,
sotto al gomnito, tenendo la, mano alquanto inarcata sopra le corde: 58Le dita della mano destra si do-
yranno chiamare coi nomi di Pollice, Indice, Medio, Anulare e Auricolare: 6°11 dito Auricolare si
porra sulla cima del Pontivello; " Anulare sopra la tavola armonica; ¢ intunto che il Pollice, Y Indi-
ce ed il Medio vibreranno le corde, !’ Anulare e I'Auricolare si dovranno alzare ed abbassare natural-
mente, a eeconda che se ne presentera il bisogno.
SEGNI pr CONVENZI0NF
Lsegni risguardanti alle dita della mano destra saranno li segnent
Medio +++ ¢ per I’ Anulare, se occorrerd «see I segni che si praticheranno per Ie ditt della
mano sinistra, saranno li seguenti: pel Pollice +, per I'Indice 1,pel Medio 2, per’ Anaiare 8 e per
Tl Auricolare 4.
ie] Pollice « per I Indice ee pel
Deis Scara
Siccome abbiamo di gid detto che le sette note della musica si chiamano Lo, Re, Mi, Fe, Sol, La. Si. &
necessario supere che Ia scala essendo molto estesa, sorte affutto dal limite di quelle summenzi
nate sete note; € che dovendone ripetere i] nome di tutte per pid volte attesa lu suz estensione.
non solamente si dovri fare attenzione ai cambiamenti di loro situazione, ma sari anche cox ben
fatta il porgere orecchio aj differenti
to incomineia sempre dalla nota Do
bay
a
TERZA LEZIONE
Prima d’incomineiare la scala, fa d’uopo supere che la besta corda, la quinta, 1a quarta‘e Ja seconda,
hanno tre note per ciascheduna: la terza ne ha due: ed i] cantino,ossia prima,ne tiene otto. Nel-
Feseguire le note della scala si deve fare attenzione ai loro nomi, come sono fatte, e dove stanno
poste; ai numeri e nomi delle corde; alla diteggidtura della mano destra: Police ¢,Indice + ,Medio
eo e6,€ Anulare se0,e della mano sinistra: Pollive +, Indice 1, Medio 2, Amulare se Auricolare 4:
ai dodici tasti che stanno collocati a traverso del munico, il primo de* quali sta posto vieino al ca-
potasto; che, partendosi dal detto primo tasto e progredendo verso il pontivello, si va sino al dodi-
cesimo. Per fare poi sortire una bella qualita di suono dalla Chitarra, fa d’'vopo che il Pollice del-
la mano destra, quando star per vibrare Je note della sesta, quinta, quarta e terza corda, vadi
i
ad appoggiare quasi sulla tavola armoniea: I’ Indice ed il Medio dovranno pizzicare la seconda e la
prima corda con maniera e destrezza tale, da non farle sferzare sulla tastiera. (a) Il primo, secon-
do, terzo e quarto dito della mano sinistr’ bisogna porli sulle corde alquanto inarcati,ossia a mar-
tello. ben vicini ai tasti e con forza sufficiente, affine di ottenere le voci chiare. Vi sono delle cir-
costanze in ei Indice della mano sinistra non potendo eseguire certe note che tante volte si
troveranno mareate, il Pollice della stessa mano sar obligato di rimpiazzarlo.
Scara NaTURALE
ot
- Corde
Mano sinistes,
Tasth
Mano destra
(a) V1 manico # uns parte della tavol
‘monica vccupata dal tasti
a wes
QUARTA LEZIONE
Det Drests
Tdi
is # ha il potere di alterare la nota che Jo precede dal suo luogo naturale e di renderla’ pitt aeuta
di mezzo tuna: per esempio se al Fa della sesta corda, che si trova sul primo tasto, si ponesse il
diesis, fa @uopo eseguirlo nel tasto secondo: I! Sof della sesta del terzo tasto col diesis, va eseguito
sopra i quart
Nl La della quinta corda, che si trova a zero o vuoto, se ha il di
is conviene eseguir
Jo sul primo tasto: II Do parimente della quinta sul terzo tasto, col diesis, va fatto nel quarto: Il Re
dey quarta corda, a zero 0 vuoto, col diesis, si eseguisce sul primo tasto: II Zr pure della quarta
uel terzo tasto, col diesis, si suona sul quarto: I] So/ della terza corda # zero o vuoto, col diesis, va
fatto nel primo tasto: Il _La pure della terza, che sta sul secondo tasto, eol diesis,si fa nel terzo:l1 Do
della seconda corda che si trova nel primo tasto, col diesis, si dovr’ fare nel secondo: Il Re della se-
conda pure,che sta nel terzo tasto, col diesis, si fa nel quarto; Il Fi del eantino o prima corda,che sta
nel primo tasto, col diesis, va eseguito nel secondo: Il Sol del terzo tasto, se ha il dis
to: Il La del quinto tasto, col diesis si
nel nono
ssi fi sul quar-
seguira nel sesto: I Vo dell’ ottavo tasto, col dies:
Il Re finalmente che sta nel decimo tasto, col dies
si fara
s, converri farlo sopra I’ undecimo.Dun-
que di sette note naturali che abbiamo nella musica se ne trovano per ora cinque alterate dal diesis #
e sono Fa, Sol, La, Do, Re; e se dalle suddette sete si é potuto ottenere una scala naturale di venti-
due note, comprese nel solo manico della Chitarra, per averne ripetuto alcune volte il nome, sembre-
rebbe che la seguente scala de’ diesis dovesse avere una maggiore estensione, ma non é vero; essa ha
la medesima quantita di note per la ragione che dovendo duplicare tutti i Fa, i Sot,i La,i Doe i Re po-
nendole un diesis a sinistra,.ne fa risultare un numero maggiore; a tale effetto se dovessimo levare
le cingue note duplicate ¢ altévate, avremmo una scala, eguale a quella che abbiamo veduto nella ter-
za lerione; e la seguente non si potrebbe chiamare Scala de’ Diesis.
Mano sinistra
Mano destra Si Do Do Re ke
22 :
Mano sinistra.
‘Mano dest
Note:
Corde
Tasti
Mano sinistra..
Mano destra.
q way
De. Bemorre
Se il Diesis $, come abbiumo detto, fa crescere, ossia rende pit acuta di mezzo tuono la nota che lo
precede, il Bemolle b invece la fa abba
nese la rende piti grave di altrettanto: per esempio il Mr
naturale del Cantino 0 prima cords che si trova sopra al {asto dodicesimo, se ha il bemolle b, si fa
riell' undecimo: Il Re del decimo tasto; col bemolle b, si fa nel nono: Il Si del settimo tasto,avendo
il bemolle b, si suoner’ sul sesto: I] La del quinto tasto. col bemolle b, converr’ eseguirlo nel quar-
to: I] So? che trov
{ nel tasto terzo, col bemolle, andra fatto nel secondo : tutte queste note sono
addette al
itino solamente; ¢ per le altre cinque corde che rimangono, sara sufficiente il con-
vare la medesima regola, ogni qualvolta si troveri un bemolle alla sinistra di quelle tali_ note
che lo esigono: se nella passata seala si sono tiovate cinque note alterate dal diesis$, altrettante
per ora ne troveremo nella veniente scala, ove vengono diminuite di mezzo tuono dal bemolle be
sono:
1) Mi, il Re, il Si, il La ed il Sol. Troveremo pure nella seguente scala de’ bemolli una si-
mile quantita di note duplicate, che vedute abbiamo in quella de’ diesis; ed invece @ incominci:
re dalla sesta
‘da, ci partiremo dal Mf della prima, posto sopra le linee con due trattine in gam-
ba ed una in capo sul dodicesimo tasto, affine di far conoscere l'effetto che fa il bemolle b nel-
Ja seguente scala.
zee "
nt : rem
Tat 1 vom
e 1 oe
*
—
F
‘Mano sinistra. ¥ = T + 3 T .
Mapetnin vase ae ane oe nee sea
Need Re Re Do 81 So! Fa Mi Mi Re
odes et rarer
Tastl | 43 201
43210
Mano sinistra
Mano sinistra..
Mano desta.
eoalll
Y zoos 4
QUINTA LEZIONE
Dewy’ Unissono
L unissono non @ altro che Punione di due note eguali, che vibrandole sopra-a due corde ri-
sultano un solo suono: questa cosa non si pud ottenere che per mezzo de’ trasporti del-
le note, sorpassando perd il limite delle scale precedenti: per esempio, incominciando la sca
la de’ diesis dalla sesta corda, abbiamo Mi, Fa, Fa diesis, Sol e Sol diesis:invece di continua-
re la detta scala passando sulla quinta corda onde eseguire il La, La diesis, Si, Do e Do die
sis,come per lo passato, bisogna sempre proseguire sulla sesta corda verso il Ponticello e tro-
vare le note della quinta corda suddetta, dove immancabilmente otterremo sul quinto tasto Pu
nissono del La; sul sesto quello del La diesis; sul settimo quello del Si; sull’ottavo quello del
Do; sul nono quello del Do diesi
; sopra il decimo il Re della quarta corda; su I’ undecimo il
Re diesis della quarta suddetta ; e-finalmente sul dodicesimo tasto, il Mi pure della quarta:e
seguendo cosi sempre la stessa regola sopra Ie altre corde, troveremo che colle note traspor
tate, un giusto unissono, sari inevitabile; tanto & vero che se ne vedra Veffetto dalle seguen-
ti scale de’ diesis: N.B. la mano sinistra in queste sei scale, scorrera i] manico della Chitar.
va colla stessa maniera @ sopra tutte le corde, come sié prativato sul cantino nella seal de?
di
s che veduto abbiamo nella quarta lezione: la mano destra pure seguird la stess: manie~
ra delle seale pasate: i segni che prenderanno sopra due e tre corde pi note progressive di
queste sei seale, faranno conoscere tutte Ie situazioni dove si pud ottenere V'unissono.
q 20203 q
Seata
della
quinta
Corda
gquarta
Corda
Seale
della
tersa
Conta
Seale
della
second
Corda
Seala
alli
prime
Curda
‘Tasti.
Mano sinistra.
Mano destra.
‘Tast
Tasti
‘Tasti
‘Mano sinistra
‘Mano destra.
Tasti
Mano sinistra
Mano sinistra.
Mano sinistea
Th siamo destra
ut
4
n a
‘
te —#
a 12
Mano deste.
q 20203
SESTA LEZIONE
L Cnissono si ottiene egualmente ne? trasporti che presentano le altre sei scale bemolizzate che
trovansi qui appresso. E necessario che lo scolaro conosca Ja quantita di scale che si posso-
no fare sulla Chitarra, prima di eseguire o 4’ incominciare a suonare qualche cosa: con que~
sto mezzo, il discepolo restera padrone della manicatura, di modo che per qualunque posi-
tione gli si’presentasse, impieghera poca fatica per eseguivla.La diteggiatura,tanto della ma-
no destra che della sinistra, sara sempre la stessa come per lo passato, vale x dire come ab-
biumo praticato’ nelle alfre sei scale de’ diesis; ad eccezione solamente che invece d’ incomin-
ciare dalla sesta corda a yuoto o zero alla mano sinistra e Pollice alla mano destra, per a-
scendere, si prineipiera dal’ ultima nota della prima corda che trovasi sul dodicesimo tasto
col quarto dito della mano sinistra” e Medio della mano destra, per discendere sino al zero 0
vuoto di ciascheduna corda, come si vedri dalle seguenti scale.
Tsegni pure che prenderanno da una nota all’altra, indicheranno V’unissono come le prece-
denti.
q msg
Tastl . ;
jane sinistra “4 sé
Mane sinist toe fop got oa °
£ o
Seata f+ obs
della ‘
prima
Corda Mano deste:
Testi once
Mano sinistra
Seal
della
seconda
Corda Mano
Tasth
Mano sinistr
Seal
della
tersa
Conta || Mano deste...
‘Testh
Mano sinistra
Seala
della
grarta
Corda
. Tasti
Mano sintstra
ast
Seala Mano sintstea.
delta |
esta
Corda Mano destra
g meg
SETTIMA LEZIONE
Vi sono delle circostanze in cui le seale di terza, quarta, quinta e sesta corda de’ diesis e de’ be-
molli, invece di doverle eseguire col solo Pollice della mano destra, come abbiamo veduto si-
no ad ora, sari nevessario servirsi dell'Indice e del Medio, come si é praticato colla seconda e
prima corda, Troveremo inoltre nelle scale de’ bemolli e de? diésis tanto nell’ ascendere quan-
to nel discendere un segno che si chiama Lequadro, fatto in questa maniera: $. Il bequadro ha
i potere di rimettere a suo posto naturale qualunque nota stata alterata dal diesis o diminui-
ta dal bemolle: per esempio se il Fit, Su’, Lu, Do e Re fossero stati alterati di mezzo tuono,po-
nendole il bequadro $.quelle note ritornano al loro Iuogo naturale: se il Sol, La, Si, Re e Mi
sero stati diminuiti di mezzo tuono, poneudole il bequadro § ritornano anche quelle «] posto na-
turale, Ora si vedranno due scale co'digsis, bemol!? © bequadri, ambe per ascendere e discen-
dere. In queste seale le note diesate duranno il medesimo suono delle bemolizzate.e nel tem-
po stesso le naturali saranno bequadrizzate . Queste scale sono molto utili, poiché da esse s'im-
para a conoscere la forza del diesis #, del bemolle b, ¢ del bequadro }. Letfetto che produce
imile a due suoni eguali o all’unissono: per
Ja nota col diesis unita a quella che ha il bemolle,
esempio se si trova un Fa diesis, quello diventa un So? bemolle: un Sof diesis diventa un La be-
Re diesi
Re bemoll
diventa Mi bemol-
molle: La diesis diventa Si bemolle: Do diesis dive
le. Rapporto poi alla diteggiatura della mano destra € sinistra non che a’ tasti, non é necessario
a porre i numeri, essendosene bastantemente presa cognizione dalle altre scale: solumente si
‘i i nomi delle note e delle corde.
troveranno segna
yg erg
ScaLe PER DISCENDERE
Mi_Fa -Fa_ Sot Sol Ia La Si Do Do Re Be Mi Fa Fa Sol Sol La Tu
Do ‘Do Re Re Mi
\ Bh .
} La ta Sol So! fu fu Mi fe Re Do Do Sl 1a Ia Sut Sol Fa Fa Mi
' ee
gms g
a2
Ti doppio diesis
per esempio il Fr naturale col dies
OTTAVA
LEZIONE
DEL DOPPIO DIESIS E DOPPIO BEMOLLE
is enarmonico
che si chiama anche Diesis Enarmonico, é fatto cosi ¢ cosi } ed ha la facolta di
rendere la note che lo precede, pitt acuta di due mezzi tuoni che corrispondono 4 un tuono inte!
diventa un So? naturale: il So? diesis enarmo-
nico diventa un La naturale: il La diesis enarmonico diventa un Si naturale: il Do diesis enarmoni-
co diventa un Re naturale: Il Re diesis enarmonico diventa un AV naturale.
ESEMPS
La
Si Nat.
Do
Hi doppio Bemolle viene composto di due Bemolli uno presso all’ altro bb; questi hanno la forza di rende-
ve la nota che li precede di due mezzi tuor
oppure di un tuono’piit bas
yer esempio il Mf col dop-
pio Bemolle bp diventa Re naturale: 11 Keb diventa Do naturale: 1 Si bp diventa La naturale: Lu)
diventa Sof naturale: Nl So? diventa Fa naturale.
ESEMPS
yey si La
bo ie =
He ar. ra at ~TSsor Nat
Di sette note che abbiamo nella musica, come si é detto, einque portano il diesis e il die
chiamano Fa, Sol, La, Do © Re: quelle che portano il bemolle € doppio bemolle, sono: Mi. Re
Sot. E perd necessario sapere che moltis
is enarmonicoe si
Si, Lae *
sime cireastanze obbligano di porre il diesis ¢ il doppio diesis,
sal Sie ul Miz nonche il bemolle e doppio bemolle al Do ¢ al Fa; poiché anche queste quattro note
n-
no soggette ad essere alterate 0 diminuite di un mezzo tuono o tuono intero piti acuto 0 pi grave,eo-
me si vedri in seguito.
II Si diesis diventa Do naturale; e il Mf diesis diventa Fi naturale.
Do Nat
’ ESEMPS
II Si diesis enarmonieo diventa Do diesis 0 Re bemolle; e il Midiesis enarmonico diventa Fi # 0 So? b.
ESEMPS
Do Re
a
II Do bemolle diventa Si naturale; e il Fa bemolle diventa Me naturale.
ESEMPS
ESEMPI
{sina
is
NONA LEZIONE
Deer’ INTERVALLI
jvamente si chiamano anche salti
GU’ Intervalli sono certe Wistanze che passano da una nota all‘altra, che abu
di terza, di quarta. di quinta, di sesta, di settima, di ottava, e di pit ane
formano Tutervallo di terza Do e Fa, quello di quarta; Do e Sol quello di quinta; Lo e La quello dis
Do e Si quello di settima; Do e Do quello di ottava Dag’ Intervalli si possono formare intanto sei
scale di alternate e ripetute note: La prima coi salti di terze: Do Mi,Re Fa, Mé Sol, Fe. La,Sol Si, La
Do,Si Re,Do; La seconde di quarte: Do Fa, Re Sol, Mi La,Fa Si, Sol Do, La Be,Si Mi,Do: La ter-
za di quinte: Do Sol, Re La, Mi Si, Fa Do, So? Re, La Mi,Si Fia,Do: La quarta di seste: Do La, Re Si
M) Do,Fia Re, Sol Mi,La Fa,S¥ Sol, Do: La quinta di settime: Do Si, Re Do, Mi Re,Fi Mi, Sol Fu,La
Sol, 8i La, Do: La sesta di ottave: Do Do, Re Re, Mi Mi,Fi Fa, So! Sol, La La, Si Si,Do Du. Dopo qu=
ste scale, si pud anche sortire dal limite dell’ottava e formare delle distanze per sino di diciasette note,
come si vedra nella scala deg!’ Intervalli in generale. *
ra volendo; per esempio Do ¢ Mi
ASCENDERE E DISCEXDERE
i
Intervalli di
‘Terze
Interval di
Quarte:
3t
Intervalli di
Quinte
Interv
Seste
Bt
Intervalli di
Settime
Otave
svreRvanEr
a yy bt let ue
in WB te 2 et
oo
terendere
1st et
mt lot
4 wos
AA
DECIMA LEZIONE
DELLE Frocre pexta Musics
Le figure della musica le pid usitate sono sette, ¢ si chiamano: Semibreve, Minima, Semiminima, Croma,
Semicroma, Biscroma e Semibiseroma.
Il valore corrispondente ad ognuna delle suddette figure musik
Quattro Quarti ossia una Battuta, vale la Semibreve.
‘Due Quarti ossia mezza Battuta, vale la Minima.
Un Quarto di Battuta, vale la Semiminima.
Un Ottavo ossia mezzo Quarto di Battuta, vale la Croma.
Un Sedicesimo di Battuta vale la Semicroma, ¢ un Trentaduesimo di Battuta, vale la Biscroma.
li, viene diviso come segue:
ESEMPSs
Semibreve Minima Semiminina —*_ Croma Semicroma
S. é ——— “ee
= i =}
1 Rattata Latins Laman Latatwe
z + A at Batata A ay astute
6 cr
La Minima vale due quarti ossia mezza battuta, per causa ddila codetta che tiene; ed @ per questo che vi vo-
gliono due Minime a formare la Semibreve.
La Semiminima, perché é tutta affutto chiusa nel capo, vale un quarto di battuta, ¢ ve ne vogliono due por
formare la Minima, e quattro ad eguagliare il yalore della Semibreve .
La croma, oltre essere chiusa nel capo, tiene la covletta rivoltata; una simile eostruzione le da il valore di
mezzo quarto, ossia di un ottavo di battuta, e ve ne yogliomo poi due per formare Ja Semiminima,quat-
tio per la Minima e otto per la Semibreve.
_ La Semicroma scema anch’ essa la met’ del valore, per causa di uma trattina che tiene a traverso della eo
-detta rivoltata; e non avendo che Ia valuta di mezz’ottavo ossia di un sedicesimo di battuta,ve ne vo~
gliono due per formare la croma, quattro per lu Semiminima, otto per la Minima « sediei per la Se-
mibreve. .
La Biscroma pure, avendo due trattin
a traverses della codetta rivoltata, non ha che i] valore di un tren-
tadnesimo di battuta; e per questo ve ne vogliono due a formare In Semieroma, quattro Ia Croma, otto
la Semiminima, sedici ls Minima e trentadue la Semibreve.
Si vedranno Ie due, le quattro, Ie otto, le sedi
. fante volte le tre, le sei, le nove e le dodiei note eollega-
te assieme per mezzo di una o piit trattine o segni che le uniranno; di modo che daila quantita de’ snd-
detti segni o trattine che avranno, si potri eonuseere il valore e ls qualita di ciascheduna figars musi-
als; ¢ nel tempo stesso qiuunte ne oveorreranno delle minori per pareggiare il valore delle maggiiri,
q 03g
nna ESEMPS
SEMIBREVE
“>
E
‘una bathata
ane
Minime
quattro
Semininime
ane baituta
otto
Crome
a battata
sedici
Semicrome
Tana battate
eg
45,
una
SEMIMINIMA,
—e-
un quarto ai
ane,
Crome
arto df battata,
quatiro
Semicrome
ed
=
fn quarto di bate
oito
Biserome
un quarto ai battata
una
cRoMs
2
un otfavo di battuta
trentadue
Biscrome due
— Semicrome
es |
Ss
tuna battata tn oftave a1 battuta
quattro
una Biserome
MINIMA
imezsa battuta
due
Seaniminime
“2
iwexra bata
quattro
Crome
—
—————
wucara battata
otto
Semicrome
#00 «2-0 20,
Pet
‘wczza battata
sediei
rmenaa battate
q e003
tun otiavo di batiate
una
SEMICROMA
ee
= ~—
‘tn sedicesimo df bateuta
due
Biserome
im sedicesime a
una
BISCROMA
‘un trentaduesimo i battute
una
Semibise
i6
UNDECIMA LEZIONE
PAUSE CORRISPONDENTI ALLE Frotre Mcsicat1
Quando si suona o si canta in compagnia c*é sempre qualéuno che,nella rispettiva parte, vocale 0 i-
strumentale, tiene delle battute, mezze battnte, quarti, ottavi, sedicesimi ¢ trentaduesishi d aspetto.
Quelle e quelli si chiamano pause.
La parola Pause d’ aspetto, significa lo stare in silenzio senza suonare o cantare, sino a tanto che non
& passato il tempo di quel tal numero di batftite, che vien segnato nelle parti cantanti o a’ Orche-
stra, du chi compone musica, o riduce, per pir vori o strumenti, qualche pezzo @ Opera.
ESEMP) DELLE PAUSE CORRISPONDENTI ALLE FIGURE MUSICALL
Semibreve Pausa Minima Pansa Semiminima Pansa
> —_— ==
= - = =t
una battuta ‘mezza battuta Tai battata
TT
Croma Pausa Semicroma Pisa Biseroma Pansa
= * : =
:
Vi sono pure delle Pause di due, tre, quattro, einque, sei, Sette ¢ otto battute d’ axpetto che trovans! seg
te nella maniera seguente:
Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto
S= S22] 26 4= 325 Fe
Battute Battute Baitute Battute Battute “Bgftute Battute
Oggi giorno perd per facilitare maggiormente al lettore di Musica il calcolo delle pause d aspetto, si po-
ne semplicemente il numero i quella tal quantita di battute che esiger potesse Pintenzione del muo-
stro compositore; a tale effetto trovano al pit delle volte le 10, 20, 30,40, 50, 80, 90. 100, 150,
200 © pit battute d’ aspetto segnate pit: co’ numeri che colle sopra marcate cifre.
Det Pryto presso La Nota
Tl punto dopo la nota aumenta della meta il valore della medesima; per esempio,se una Semibreve vale
quattro quarti o una battuta, col punto appresso vale sei quarti o una battuta ¢ mezza. La Minin
che vale due quarti o mezza battuta, col punto vale tre quarti. La Scmiminima di un quarto di bat
tuta, col punto vale un quarto e mezzo. La.Croma ai un ottavo di battuta, col punto vale un ottavo
mezzo. La Semicroma di un sedicesimo di battuta, col punto vale un sedicésimo © mezzo. La Bis-
croma. che vale nn trentuduesimo di battnta, col punto aumenta anch’ essa la meti del suo valore,
e questa meta si chiama allora Semibiseroma
ESEMPS
Semibrese col punto Minima emiminima Semicroma __Biseroma
‘Sel guard
Dattuta e merea
1 1
tre guertt on quartoemetzo Le mezzo ee mez
9 * t
yes og
AT
Der Tepr
1 Tempi pili usati sono otto © i loro nomi sono i segnenti
Ordinario, 2° alla Breve ossis a Cappel-
la, 3° Dupla, 4% Sestupla, 5¢ Tripola, 6% Tripoletia, 7? Nomupla, 8° Dodicupla.
11 primo ha rapporto con la Semibreve e si.marea colla mano o col piede in quattro quarti: due in bat
tere e due in levare.
Il secondo ha rapporto pure con la Semibreve; ma
ero valore della Semibreve suddetta.
H terzo ha rapporto con In Minima e
deve mareare uno in battere e uno in levare I'in-
j marea in due quarti; uno in battere e uno in levare.
Tl quarto ha rapporto a sei Crome e si marea in due quarti: uno in battere e uno in levare, prendendo
tre crome per quarto.
Tl quinto ha rapporto con Ja Minima ed il punto ¢ si marea in tre quart
; due in battere e uno in levare.
I sesto ha rapporto con In Semiminima ed il punto e si mare come fossero tre Crome; due in battere
e una in Jevare,
Il settimo ha rapporto a nove Crome © si marea in tre quarti; due in battere e uno in levare, prender
do tre crome per quarto.
L ottavo ha rapporto a dodici Crome e si marea in quattro quarti; due in battere e due in levare, pren-
dendo tre erome per quarto.
I DETTI TEMPI SONO FATTI NEL MODO SEGCENTE
Tempo alla Breve .
Tempo Ordinario ossia a Cappel Tempo Dupla Tempo Sestupla
————— 2
ai quattro quart Ai quattro quarti fa due a due quart
‘temply ano in batiere
uno! in Tevare
=——
41 sel Crome in due quarti
Tenino Tripwh Tempo Tripoletta Tempo Nonupla Tempo Dodicupta
i
6: ESE = ———— 8
di tre guarti i tre Crome In wn quar. i nove Crome in tre quarti ‘Crome in quate
foe mease to quarth
In tanth
ime maniere Spud eon
av,celle figure musicali, eoi punti e Te trattine a tre
dei tompis por
04 pid no-
te cellegute ins empio una Minima, una Semiminima e dve Crome
jeme. i valore
formano gust quarti.
ESEMPIO
You might also like
- Plantilla de Plan de Marketing Musical PDFDocument8 pagesPlantilla de Plan de Marketing Musical PDFScribdTranslationsNo ratings yet
- Lezioni private - La chitarra: Guida all'ascolto del repertorio da concertoFrom EverandLezioni private - La chitarra: Guida all'ascolto del repertorio da concertoNo ratings yet
- Юзефович В. - Арам Хачатурян - 1990Document297 pagesЮзефович В. - Арам Хачатурян - 1990KhaolNo ratings yet
- Bugs Team 1 Audio CDs Lista SciezekDocument5 pagesBugs Team 1 Audio CDs Lista SciezekAniaNo ratings yet
- Tamo Daleko Serbian Folk SongDocument1 pageTamo Daleko Serbian Folk SongGato 09No ratings yet
- La Traversata: Un invito a scoprire i principi dell'imprenditorialità e della leadershipFrom EverandLa Traversata: Un invito a scoprire i principi dell'imprenditorialità e della leadershipNo ratings yet
- Chitarre Visionarie Conversazioni con chitarristi alternativiFrom EverandChitarre Visionarie Conversazioni con chitarristi alternativiNo ratings yet
- Diccionario TehuelcheDocument18 pagesDiccionario TehuelcheGato 09No ratings yet
- Chants Populaires ArmeniensDocument31 pagesChants Populaires ArmeniensGato 09No ratings yet
- Sexto Orden Nº8Document34 pagesSexto Orden Nº8Gato 09100% (2)
- Sexto Orden Nº9Document22 pagesSexto Orden Nº9Gato 09No ratings yet
- El Arado Nº44Document44 pagesEl Arado Nº44Gato 09No ratings yet
- Martin Journal Vol. 6Document76 pagesMartin Journal Vol. 6Gato 09100% (1)
- Elizabethian Lute by George WeigandDocument36 pagesElizabethian Lute by George WeigandGato 09100% (2)
- Jacob Dont Etudes ViolinDocument46 pagesJacob Dont Etudes ViolinIneska333100% (13)
- Ravi ShankarDocument1 pageRavi ShankarGato 09No ratings yet
- El AradoDocument44 pagesEl AradoGato 09No ratings yet
- Minuetto, Luigi Boccherini. Arr. T. PomilioDocument4 pagesMinuetto, Luigi Boccherini. Arr. T. PomilioGato 09100% (1)
- Funf GesangueDocument16 pagesFunf GesangueGato 09No ratings yet
- German Folk SongsDocument106 pagesGerman Folk SongsGato 0989% (9)
- Kilo Metro 11Document5 pagesKilo Metro 11Pedro ParamoNo ratings yet
- La Donna E' MobileDocument1 pageLa Donna E' MobileGato 09No ratings yet
- MadreselvaDocument1 pageMadreselvaGato 09No ratings yet
- Inno Di GaribaldiDocument4 pagesInno Di GaribaldiGato 09No ratings yet
- Deberes Ejercicios Lineas Segundo ParcialDocument13 pagesDeberes Ejercicios Lineas Segundo ParcialCriss PáezNo ratings yet
- American Popular Music 2008Document100 pagesAmerican Popular Music 2008Fernandes0% (1)
- Flauta 1 - Por Los 100 AñosDocument1 pageFlauta 1 - Por Los 100 AñosEduardo RetamarNo ratings yet
- Review of Terahertz and Subterahertz Wireless CommunicationsDocument23 pagesReview of Terahertz and Subterahertz Wireless CommunicationsГлеб АвдеенкоNo ratings yet
- Medley Wedding - Score and PartsDocument41 pagesMedley Wedding - Score and PartsYorworband HatyaiNo ratings yet
- Presente Perfecto InglesDocument5 pagesPresente Perfecto InglesKatherine MenaNo ratings yet
- GE Dash 3000,4000 V4 Monitor - User ManualDocument478 pagesGE Dash 3000,4000 V4 Monitor - User ManualLogicLife50% (2)
- Canticos Barra Peru - Trumpet in BBDocument1 pageCanticos Barra Peru - Trumpet in BBHarold Garcia De La Cruz100% (3)
- St. John-Hill Academy: Calero, Morong, RizalDocument2 pagesSt. John-Hill Academy: Calero, Morong, RizalAaron Manuel MunarNo ratings yet
- Impedance and Absorption of Acoustical Materials by Impedance Tube MethodDocument9 pagesImpedance and Absorption of Acoustical Materials by Impedance Tube MethodAlejandro EspinosaNo ratings yet
- Shreddage 3 Stratus Free Manual - En.esDocument16 pagesShreddage 3 Stratus Free Manual - En.esvicent vargasNo ratings yet
- Mon Tieng Anh - Megabook - de 11 - File Word Co Ma Tran Loi Giai Chi Tiet - (Hoctaivn)Document8 pagesMon Tieng Anh - Megabook - de 11 - File Word Co Ma Tran Loi Giai Chi Tiet - (Hoctaivn)Ngân NguyễnNo ratings yet
- Lista de Canciones de Los BeatlesDocument5 pagesLista de Canciones de Los BeatlesOmar SolanoNo ratings yet
- Comunicaciones Industriales - 2Document57 pagesComunicaciones Industriales - 2asdffadNo ratings yet
- Zoomer's Toy Robotic Dog - Shadow PDFDocument16 pagesZoomer's Toy Robotic Dog - Shadow PDFBill N.No ratings yet
- 02 Cas Trillo SampedroDocument26 pages02 Cas Trillo SampedrojorgeNo ratings yet
- Trumpet G4 Music ScoreDocument14 pagesTrumpet G4 Music Scorealvarogc_207923No ratings yet
- Lopez Fuentes IreneDocument32 pagesLopez Fuentes IreneCesar Osvaldo VidalNo ratings yet
- Guns N' Roses, Bon Jovi, Metallica, ACDC, U2, Queen, Aerosmith - Classic Rock 70s 80s 90s Full Album - YouTubeDocument2 pagesGuns N' Roses, Bon Jovi, Metallica, ACDC, U2, Queen, Aerosmith - Classic Rock 70s 80s 90s Full Album - YouTubesegurancadotrabalhoNo ratings yet
- Informe Jardines MaternalesDocument7 pagesInforme Jardines MaternalesEducacion InicialNo ratings yet
- Adoro Te DevoteDocument1 pageAdoro Te DevoteLaurenne YaoNo ratings yet
- SEMANA 19 DÍA 2 Indago Sobre Las Manifestaciones Artístico-Culturales para Mejorar Mi ComunidadDocument5 pagesSEMANA 19 DÍA 2 Indago Sobre Las Manifestaciones Artístico-Culturales para Mejorar Mi ComunidadMaribel RiveraNo ratings yet
- Aeronave Solar No Tripulada de Larga Autonomía para Retransmitir Internet en El Caserío de Sapchá, Asunción, ÁncashDocument194 pagesAeronave Solar No Tripulada de Larga Autonomía para Retransmitir Internet en El Caserío de Sapchá, Asunción, ÁncashKentner Chavez CorreaNo ratings yet
- New PURCOM MODULE AY 2020 2021.separate With Cover PagedocxDocument36 pagesNew PURCOM MODULE AY 2020 2021.separate With Cover PagedocxSimon Benson FloresNo ratings yet
- Libro - UdúDocument69 pagesLibro - UdúSergio ReyesNo ratings yet
- TRB 2Document1 pageTRB 2Cem GüngörNo ratings yet
- AMARAL, Adriana. Categorização Dos Gêneros Musicais Na InternetDocument15 pagesAMARAL, Adriana. Categorização Dos Gêneros Musicais Na InternetCarlos CavalliniNo ratings yet