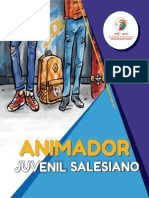Professional Documents
Culture Documents
6
6
Uploaded by
...0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views24 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views24 pages6
6
Uploaded by
...Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 24
«Video meliora proboque deteriora sequor» serive il poeta latino (Ov).
Solo il Signore agisce direttamente sulla volonta con la grazia adiuvante
gostenendola a volere e a decidere il bene. a‘
Quali alfiancatori o succedanei, talora assai utili, si prospettano i
motivi ¢ i mezei naturali, come la lealta con se stessi, il rispetto di se
stessi, la piena occupazione, la distrazione, la fuga dell'ozio, 1a discipli-
na dello sguardo e in genere 1a mortificazione, Ia quale d'altronde par.
tecipa anche del piano di azione divino, come accenneremo tosto.
2. NON SOLO AMORE, MA ANCHE TIMORE
Il timore 2 via all’amore: initium sapientiae timor Domini (Ps.
110, 10, e Eccli. 1, 16), e pitt chiaro ancora: timor Det initium dilectionis
eius (Eccli. 25, 16). Occorre dunque il timore; occorre soprattutto per su-
perare difficolta notevoli e vincere attrattive che promettono monti di fe-
licita. Con la sola raccomandazione di buon cuore e di affetto al Signo-
re non si arriva, in molti casi,
Vien detto di non spaventare I'adolescente col richiamo dellinfer-
no, perché il groviglio in cui si agita gli é gia gravoso: ma se ha respon-
sabilita, perch? non prospettargli la situazione vera nell’eternita e il pe-
ricolo di dannazione? Se parla male apposta, se apposta accetta compa-
gnie, stampe e divertimenti cattivi, e peggio ancora se li acquista o li
promuove, perché non mettergli innanzi I’effettiva tragedia dell’anima?
Gesi ha insegnato cosi. E’ un fatto che se non c’era in gioco la vita, —
la vera Vita, — molti santi non avrebbero fatto getto della vita quaggit.
Basti pensare ai motivi di combattimento e di resistenza di una Santa
Maria Goretti, per convincersene.
Daltronde @ bene dire che 'innato amore alla verita e alla chiarezza
¢ il nativo stimolo all'ideale ¢ all’eroismo, fa desiderare ai giovani questa
decisione categorica e questa fortezza combattiva: essi non sono con-
tenti di coloro che compassionano fuori modo e che tendono a scusare
situazioni e soprattutto intenzioni davanti al tribunale della coscienza:
essi anelano alla autentica liberta di spirito, alla conquista di se stessi,
alla liberta interiore, e non fanno questione di fatiche o rinuncie per
il raggiungimento di tali beni, una volta conosciuti.
In pratica come indurre ¢ favorire il timore di Dio? ie
Coi fanciulli si ami Vassoluto: essi non discutono di responsabilita,
Perch accettano la legge da fuori, che Ii aiuta a chiarire la legge inte:
lore, A loro percid si parli francamente di castigo e di inferno per i
cattivi, per color cio& che vogliono fare ¢ fanno il male.
Aali adolescenti Vappello al timore del castigo, ¢ quindi delfinfer
juando si tratta di mancanza
No, pud e deve essere del pari categorico 4! strata
Piena responsabilita. Quindi se parlano male di iniziativa, se acqut
Stano 0 detengono giornali o figure inopportuni, se si recano a diverti-
afr)
menti esclusi o sconsigliati, se accettano o peggio promuovono azionj
cattive con altri o con se stessi, non ci si balocchi in falsa pieta: sj
dimostrino e si mostrino le conseguenze di pena interiore, di sconten.
tezza, di disgusto e di sfiducia, e si manifesti il pericolo 0 la condanna
dell'inferno, se Ia mancanza fu grave. Cosi fece Gesit, e cosi al seguito di
Lui Maestro operarono i Santi, ottenendo risultati di santificazione
pacificazione che nessun altro mezzo é in grado di condizionare.
Per Ia sensibilita al pudore, e quindi al timore da vergogna, si pos.
sono aiutare fanciulli e adolescenti ad ascendere alla liberta interiore
col richiamo al pensiero dei grandi, dei genitori, dei superiori. «Che di-
esti se lo sapesse papa? L'avresti detto o fatto davanti a mamma?s,
Dicono di solito di no: ma intanto viene reso presente alla coscienza
quel Dio che & presente sempre per l'essenza; ¢ il timore di Dio segna
Yinizio della sapienza, D. Bosco richiamd speso il pensiero: «Dio mi ve
de>, E invero non c’é pensiero che penetri pitt universalmente nel tempo
€ nello spazio, e pit profondamente nella coscienze.
9. NON IMPORTA TANTO IL SAPERE QUANTO IL FARE
certo che le idee governano lazione. Ed 2 del pari certo che pro-
fondita di pensiero € nesso logico di verita irrobustisce i caratteri ge-
nuini nella coscienza, nella fortezza, nella libert e nella letizia. Tuttavia,
per il tema che andiamo analizzando e relativamente ai soggetti che con-
‘sideriamo, illustriamo alcuni punti essenziali.
a) E il st che forma ¢ non il no.
Cid & da ribadirsi con chiarezza, Quindi una volta intuito il mirabile
piano di Dio nella creazione e nella diffusione della vita, basta. Non oc
corre affatto, a maggior fermezza di virti, la conoscenza del male e dello
scandalo e delle vie tortuose che conducono all'uno e all‘altro. Tutto cid
& almeno perditempo, perché il tempo, anche occasionale, impiegato al
Yacquisizione di tali cognizioni, poteva essere speso meglio, Ma & pitt che
perditempo: & deposito di materia esplosiva che pud scoppiare nelle
circostanze piit impensate, in circostanze addirittura innocue e limpide
per i puri di cuore.
Quindi non plus sapere quam oportet sapere (Rom. 12, 3), conclude
remo applicando opportunamente una raccomandazione paolina, intrisa
di umilta, fiducia, fede e semplicita,
b) - Non fermarsi alla contemplazione ma arrivare alla decisione, a
proposito chiaro e fermo.
L’adolescente ritiene spesso risolta una sit
intravvide o analizzd ta linea di soluzione. Va di
sione.
izione morale perch? ne
cantato da questa ile
- A
im
Avviene cosl anche nella vita: il progetto di un palazzo, per quanto
dettagliato, chiaro ¢ perfetto, non & ancora il palazzo, Quindl simpegnt
Yadolescente all’azione conseguente ¢ coerente, anche se costar
Si pud cominciare con l'obbedienza, per la quale egli pone quesiti vivi
ed ardui; ma si arrivi esplicitamente all'analisi delle occasioni, solitarie 0
sociali, che minacciano la purezza, e a prendervi posizione contro. Si fa
intendere che & certo questione di grazia, fondamentalmente, perché la
natura non si supera senza questo aiuto dall’Alto; si fa intendere anche
che gli incentivi e i pretesti, subdoli o sfacciati, si moltiplicano e pre.
mono ovunque, e che la purezza é virta pitt di difesa, custodia, fuga, —
i buona salute interiore insomma, — che di conquista mediante atti
positivi al pari di altre virti.; ma si fa pure intendere che, per questa sua
natura, virti di totalita, di sintesi, di conseguenza. Cid importa mor-
tificazione.
¢) La mortificazione cristiana.
E’ tanto difficile farne comprendere la necessit ¢ la portata ai gio
vani, perché la ritengono un limite o addirittura una decapitazione della
gioia. Essa @ invece l'ordinario appanaggio e custode dell’ideale. Se lo
ideale @ alto e fermo, la Ppotatura dell'inutile o del pericoloso ne conse-
gue logica ¢ facile; diversamente si va incontro a continue nostalgie,
fluttuazioni, ritorni che angosciano e scoraggiano.
Per stimolarla nella sua portata di difesa si presenta come il grande
mezzo proposto da Gesit insieme con la preghiera (cfr. Mc. 9, 28): chi
Yaccetta rimane saldo nel carattere cristiano.
Essa & doverosa in varie occasioni; ed é facile, perché si tratta di
ose distinte dalla persona, che si decidono con un atto di volonta.
«Un giornale, una rivista, una conversazione, un film, un ambiente,
sono distinti da te: tu puoi allontanarli o allontanartene. Se indulgi, se
Scherzi, accetti di inquinarti le ali, e finisci per impeciarti e non essere
contento, :
«Lo sguardo soprattutto va disciplinato, perch? "immagine accolta
on intenzione cattiva (cfr. Mt. 5, 28) agisce quasi deterministicamente
im te, a causa dei complessi legami nervosi che esistono nel piano cere-
ale tra vista e vie neurovegetative. Osserva gli animali: essi che non
‘anno ragione, reagiscono fatalmente in determinate occasioni. Cos) a
Viene per l'adolescente, il giovane, I'tomo quando il loro sguardo ao ia
Suidato da motivi superiori, di soccorso per esempio, come in medicina.
Pettanto nessun compromesso, né in pubblico né nella solitudine, quan-
Manca la motivazione adeguata. é
idee’ Pe Tiuscire con maggior garanzia, riempiti Ja mente di grandi
idee: con esse ergi in te un formidabile parapetto invisibile ¢ un
2utomati i ie del mondo. Hai provato ta-
lore matico, che blocca e seleziona Je scorie ee ales ale
‘ta una grande gioia o un grande dolore? Not
=
‘un automa anche in mezzo al trambusto cittadino, senza ac.
Corgerti di nulla? Ebene quanto in tali cireostanze vivesti per emozio.
he, fa di viverlo per furbizia di organizzazione interiore e per convin
Hone. Non girare senza una meta o un proposito: V'animo sia sempre
pieno di occupazione metodica, se non proprio di una preoccupazione:
Cosi sara difeso come una fortezza. Se invece ti périti di andare a zon.
20 con ali occhi e i desideri schiusi a quanto I'ambiente offre, sei un
wioto, e percid sei gia un lordato ¢ un ferito in partenza. Pertanto non
considerare riposante lo spasso ozioso senza meta in ambiente equivo.
co: & invece spossante, pericoloso e opprimente, ¢ significa rinuncia
al proprio governo, pigrizia, vilt& ».
gare come
Un ulteriore sistema disciplinatore da risultati mirabili ed & la mor
tificazione preventiva. Essa @ un allenamento dello spirito ¢ si fonda
sull'unita, ciot sul riconoscimento della propria debolezza intrinseca.
Consiste nel dirsi di no quotidianamente in qualche cosa di lecito; ren
de pronti e generosi al no che si impone per la vita della grazia. Quanti
che faticavano nella vittoria su se stessi vi giunsero con facilita e rapi-
dita per questa via illuminata dalla fede e sostenuta dalla ragione! Si
tratta di piccole rinuncie volontarie, dagli astanti non solo inavvertite
ma anche inavvertibili.
Eccone qualche suggerimento. «Hai molta sete? Attendi a bere, ¢ Pol,
quando sorbirai la bevanda, centellina e sii sobrio. — A tavolino siedi co
scante e pigro? Proponiti per un quarto dora d'essere eretto e agile. —
Ti arriva una lettera o il giornale? Attendi un po’ prima di aprire ¢ leg:
gere, — La preghiera del mattino recitala in ginocchio, adagio. — Aspetta
a rispondere a una parola seca, e, a tuo parere ingiustificata, di pap)
© mamma o di un familiare o di un compagno. — Socchiudi un mo-
mento gli occhi davanti ad una scena cinematografica briosa e serena»
Quanti esempi analoghi lungo la giornata, se si ha buona volonta di sc”
prirli ed attuarli: cosi si acquista il dominio di sé e si educa 1a volom
ta, della quale Ja custodia della purezza pud considerarsi, com'e di fatt®,
un aspetto particolare e conseguente,
Volendo riassumere in una conclusione chiara e metodologica °
linee d'azione ribadiamo: 1) il ricorso mentale alla preghiera, — speci#
mente mariana, di valore affettivo immenso, nell’economia dela Rede
ione, — il ricorso alla distrazione ¢ alla compostezza personale, quand?
si tratta di prove o tentazioni di fantasia e a riposo; 2) Ia sveltezca et
peeps a sé nelle prove lungo la giornata; 3) la disciplina dello sguar
toe yn Suge cel ae all ambienti equivoci nelle circostanze norms
rnc en a ea ee
4
13 —
4) La Confessione in funzione detia purezza,
E' il mezzo sovrano per il ricupero e la
te cattolico. Ha il vantaggio di essere segno
sieme eflicacie, anzi il pit efficacie strument
alla vita soprannaturale.
Si volge ai singoli come ogni sacramento;
do la parola — ch’ mezzo di comunicazione abituale, — ad un valore
altissimo, sacramentale: diventa veicolo di verit somma e di scoperta
di Dio, Formatore originario, perché fonte della verita, della bellezza
e della bonta cui anela ogni anima .
Afinché attinga i fini che le sono intrinseci ottenga i beni che rag-
giunsero i Santi, ai rilievi delle pagine precedenti affianchiamo alcune
brevi osservazioni sulla sua portata nella formazione positiva dei giovani
alla purezza.
1) La confessione é tanto piit formativa quanto piit @ frequente. Per-
cid si animi alla confessione settimanale o quindicinale, secondo le ani-
me, i problemi e i momenti.
2) Sia sincera. La sincerita non consiste nel dettaglio superfluo, ma
nella manifestazione delle circostanze responsabili che Permettono un
indirizzo terapico. D'altronde essa, per le mancanze gravi, @ di essenza
per il Sacramento, perché rappresenta la genuinita della materia come
Ja naturalita dell’acqua per il battesimo.
3) Sia dallo stesso confessore, possibilmente, perché cosi ascende au-
tomaticamente a direzione spirituale, la quale mira a scoprire e correg-
gere le tendenze ¢ non si limita alle mancanze, che sono episodi; per di
Pitt dispone di un piano d’azione in vista di una meta.
4) Si insista sul proposito chiaro e definito. Questo versi su una vir-
ti aperta, che cementi attorno a sé l'ideale attraverso un motto; non si
trascurino perd le virti: strumentali di cui dicemmo dianzi.
E’ un fatto che il Sacramento della Penitenza, per la soprannatura-
lita propria e la dovizia di elementi educativi primari, é lo strumento
Pitt prezioso a disposizione dei sacerdoti, — della Chiesa, — per la po-
sitiva formazione dei giovani alla purezza, e in generale per l'educazio-
ne spirituale delle anime. Esso é preziosissimo momento di distribuzione
dei misteri di Dio (1 Cor. 4, 1), per Ia benignita del Signore Gesi, del
‘ale siamo sempre ministri per gli altri (cfr. Ebr. 5, 1).
D. GEREMIA DALLA NORA S.D.B.
fortificazione, E’ tipicamen-
€ veicolo della grazia, ed in-
'0 di formazione delle anime
ma in pitt si volge elevan-
Abituati e recidivi
di Alfredo Boschi
importanza tutta speciale, che il capi li "abitue 0
divi” ha nella teologia morale e nella pratice deen eae reat
certamente a nessuno. Chiunque ha qualche esperienza delle
anime, consente senz’altro con S. Alfonso, il quale osserva (’): « La mas.
sima parte della buona direzione de’ confessori affin di salvare i lore
penitenti consiste nel ben regolarsi con coloro che son nelloccasione
di peccare 0 pure che sono abituati o recidivi, E questi sono i due sco-
gli (occasionari e recidivi) dove la maggior parte dei confessori urtano
mancano al loro dovere ».
Di qui Vopportuno e, in certo modo, naturale e quasi obbligato in-
serimento di questo tema nella presente "Tre Giorni’ di Teologia Mo-
rale dedicata quest’anno a "problemi morali e pastorali nella luce di S.
Giuseppe Cafasso”. E questi due aspetti, morale e pastorale, non sol.
tanto sono presenti nell'argomento degli abituati e recidivi, ma hanno
in esso un particolarissimo rilievo. Si tratta, dal punto di vista morale,
che il confessore si assicuri, quanto moralmente gli & possibile, delle
sufficienti buone disposizioni del suo penitente — dolore e proposito —
ed eventualmente lo aiuti ad acquistarle, cosi da poter applicare nel suo
caso le regole fondamentali circa il dare o negare o differire V'assolu-
tione. Dal punto di vista pastorate, si tratta soprattutto di quell'arte
psicologica e pedagogica con cui il confessore deve saper accostare le
anime, sia per prepararle e disporle a ricevere fruttuosamente il sacra-
mento del perdono, sia per impegnarle a lottare contro il peccato ¢ ad
attuare nella loro vita cristiana il programma di Gesit "ut vitam habeant
et abundantius habeant” (').
Questi semplici accenni spiegano la difficolta, sottolineata da S. Al
fonso, che molti confessori provano di fronte ad abituati ¢ recidivi.
Alcuni, troppo facili ad assolvere, instaurano un lassismo pratico che
non giova a nessuno, e meno che mai al penitente stesso. « E’ cosa da
piangere — scriveva §. Alfonso — il vedere la gran ruina che cagionano
tanti mali confessori nell’assolvere indistintamente questi recidivi i qua-
i, vedendosi cos) sempre facilmente assoluti, perdono Yorrore al pec:
(©) Pratica det confessore. Bdiz. a cura det Can, Gius. Plstonl, Modens 194%
2. 90,
© Giov,, 10, 10.
— 126 —
cato seguitano a marcire ne’ mal'abiti sino alla morte» (*). Dattra
parte c il pericolo che un confessore severo rigorista indispong,
maggiormente il penitente, esasperandolo o facendolo cadere nello soo.
raggiamento ¢ nella disperazione ¢, ad ogni modo, allontanandolo dal
Signore e dai sacramenti.
Ci vuole un giusto mezzo ed un senso di equilibrio morale che sap
pia evitare questi due eccessi, agire "fortiter ed suaviter”, a somiglianza
del buon samaritano che, chinandosi pietosamente sull’'uomo trovato fe.
Tito e mezzo morto sulla strada, ne fascid le ferite, versandovi sopra
olio e vino (") «Con questi malati — commenta il Gaume (°) — con,
viene soprattutto usare il balsamo fatto dellolio della compassione ¢
dell'incoraggiamento, perch? non si disperino; ma ci vuole anche il vino
generoso dei paterni richiami, perch? essi non si trascurino e non Ia.
scino smorzare lo slancio e impegno per emendarsi, Perch? costoro so-
no contemporaneamente soggetti a due mali tra loro contrari: alla di-
sperazione per motivo della grande difficolt che incontrano, o alla
presunzione cercando di scusare la loro fiacchezza quasi una reale ¢ in.
sormontabile impossibilita ».
Di tale senso di equilibrio morale ci hanno dato luminoso esempio
i santi: tra gli altri S. Giuseppe Cafasso, specialista del confessionale ¢
nella direzione delle anime. E’ caratteristica, a tale riguardo, la risposta
che egli diede un giorno a S. Giovanni Bosco. Questi gli parlava dei si
stemi duri forti di un confessore con uno dei suoi penitenti, abituato
€ recidivo. I Santo lo lascid dire ¢ si limitd poi a commentare: « Tutto
aceto? Niente olio? » (*). E soggiunse: « Quando siamo seduti in confes
sionale, esercitiamo 'ufficio di Dio misericordioso e bisogna sempre escr-
itarlo come un buon padre che riprende il suo figlio disubbidiente ¢
tenta ogni mezzo per richiamarlo al dovere prima di cacciarlo di casa ».
Sara in questo spirito, ¢ su questa medesima linea direttiva di un
prudente e giusto equilibrio morale, che svilupperemo noi stessi Var-
gomento affidatoci da trattare. Degli abituati ¢ recidivi cercheremo in
nanzi tutto di fissare la nozione e la psicologia, cosi da poterne com-
prendere meglio il grado effettivo di responsabilita e le difficolta che
endono loro piti duro il cammino da percorrere per liberarsi dal pec-
cato e dalla sua pesante schiaviti e riprendere quota nello spirito. Tale
conoscenza del penitente permettera, poi, di studiare e stabilire lattes:
giamento ¢ la condotta del confessore a suo riguardo, sia quanto ak
Vopportunita di dargli oppure di negargli o differirgli Vassoluzione, sia
quanto al paziente e intelligente lavorio da intraprendere per curarne
Te piaghe e guarirlo dai suoi mali.
©) Op. ett, a. 68.
() Lue. 10, 30 seg,
(©) Manuet des consesseurs, 10 éd., Paris 1872, n, 504,
©) Mons. Angelo Grazioli. La pratiea det confessori nello spirito det Beato
Cafasso, Colle Don Bosco (Asti), 1914, p. 235.
Per maggiore chiarezza e precisione & bene notare che il nostro
studio riguarda direttamente e in primo piano il caso classico degli abi-
tuati € recidivi, che & quello di chi ripettamente ricade negli stessi pee
cati mortali. Ai recidivi in peccati veniali accenneremo in seguito, a
parte, Ed egualmente riscrviamo a parte il caso a st stante dei candidati
al sacerdozio, secondo Y'osservazione che viene fatta esplicitamente
dallo stesso S. Alfonso, il quale cosi serive (): « Cid...che sie detto par-
Jando comunemente per gli abituati e recidivi, non corre gia per ordi
nandi abituati in qualche vizio (specialmente nel peccato dimpurita)
che vogliono ascendere a qualche ordine sacro: poich? per costoro cor,
re altra ragione »,
Premessi questi cenni introduttivi, possiamo senz'altro entrare in
argomento, chiedendoci innanzitutto quali elementi concorrano a for-
mare i cosi detti abituati e recidivi
I - CONSUETUDINARI 0 ABITUATI E RECIDIVI
1 - Consuetudinari (0 abituati e anche abitudinari) vengono generi-
camente chiamati dai moralisti coloro che hanno una consuetudine 0
abitudine di peccato, nei quali, cioé, una data inclinazione cattiva, in
seguito al ripetersi delle medesime colpe, é diventata come una secon-
da natura, cosicché é per essi certamente pit difficile il correggersi.
iit precisamente — con concetto pitt rigorosamente esatto dal pun-
to di vista filosofico — il nome di abitudinario indica colui che commet-
te con una certa frequenza gli stessi peccati sospinto ad essi da una
cattiva inclinazione interna. Ma, dal punto di vista pastorale, si pud
anche considerare come abitudinario colui la cui frequenza nel peccare
consegue e¢ risulta dalle occasioni in cui si trova: elemento, questo, co-
me vedremo, assai importante nella pratica, e del quale il confessore
deve tener conto soprattutto nell'imporre e far presenti gli eventuali
obblighi ai quali il penitente deve impegnarsi perche il suo dolore e il
suo proposito siano sinceri ¢ meritevoli dell'assoluzione. eae
Tenendo conto di queste osservazioni possiamo dire che 2 abitudi:
nario colui it quale, per un notevole periodo di tempo, cade frequente-
‘mente nei medesimi peccati senza che intercorra tra l'uno e Valtro un
lungo intervallo, sia che a tali cadute venga sospinto dalle sue cattive
inclinazioni aggravate dalla stessa abitudine viziosa, sia che cada trasci-
Nato da cattive occasioni.
Non é peraltro facile stabilire quale
basti per creare un'abitudine di male. S.
atti esterni sotitari in un mese, commessi
‘mesi) con un certo intervallo tra I'uno ¢ altro,
tiva abitudine, e che basta anzi un minor numero
———
© Op. cit, n. 70.
frequenza di atti si richieda e
Alfonso & di parere che cingue
per un tempo notevole (34
possono formare la cat-
di cadute (per es. una
is
volta al mese, per un anno) trattandosi di peccati esterni commessi con
altri, come 2 la fornicazione. Altri moralisti, tuttavia, richiedono ung
maggior frequenza: cid che ci sembra da ritenere almeno per colpe gj
sola pensiero (fantasie o desideri cattivi, ecc.) 0 anche semplicemente
di parole (bestemmie, ecc.). Per una determinazione concreta su tale pun.
to bisogna tener conto di vari elementi.
Un primo e fondamentale elemento é il temperamento. Quanto pit
uno @ naturalmente propenso ad un vizio (impurita, ira, ecc.), tanto
pit facilmente egli contrae I'abito cattivo, e basta un minor numero di
atti.
Un secondo elemento é l’adesione, piit 0 meno intensa, al peccato
in cui si cade: quanto essa & maggiore, tanto pitt rapida e facile & la
formazione dell'abito peccaminoso, e tanto maggiormente questo affon-
da e allarga le sue propaggini nello spirito. Si comprende cos! 1a forza
di quegli abiti che hanno per oggetto cose sensibili, per le quali Yap-
petito inferiore suol provare molto trasporto, come sono la lussuria, la
golosita, l'ubriachezza. Al contrario, pit difficilmente riescono a radi-
‘arsi ¢ pitt facilmente si possono correggere quei vizi che hanno scarsi
punti di appiglio nell'appetito inferiore e risiedono piuttosto nella vo-
lonta, perché, immessi quasi per imperio e a forza senza una solida
base appoggio, possono egualmente dalla medesima volonta venir
rimossi senza strappi troppo dolorosi.
Altro elemento @ la qualita della colpa: si tratta di peccati di solo
pensiero 0 di parola, oppure anche di opera; di peccati commessi da soli
‘oppure invece con altri? Si pud dire che il numero di atti richiesti per
contrarre un'abitudine cattiva cresce in proporzione della facilita che
si ha nel fare il male. Cosi si richiede un numero maggiore di atti per i
peccati interni, che non per quelli esterni; per le azioni che si commet-
tono da soli, che non per quelle che si commettono con un complice.
Altro elemento ancora é lo sforzo, maggiore o minore, di resistenta
¢ reazione alla tentazione ¢ al peccato. E’ evidente che chi pit resiste ¢
combatte pid rende difficile al vizio di dominarlo.
Infine conta molto anche la durata del ripetersi delle colpe 0 ¢#
dute, Altra forza ha un abito cattivo formatosi solo da qualche settim=
na, e altra, ben pitt grande, un vizio che tiranneggia ormai da mesi ©
da anni.
E’, del resto, opportuno osservare che non necessariamente né scl
pre il cadere molte volte in un medesimo peccato costituisce un Ver?
© proprio abito vizioso: cid pud, infatti, avverarsi soltanto in un limita!
periodo di tempo per circostanze del tutto particolari (crisi spiritual,
ambiente, ecc...) senza che si ripeta pit in seguito, almeno per hungo te
Po € quale strascico continuativo delle precedenti cadute.
2. - Analoghe osservazioni valgono per i cos} detti "recidivi”;
costoro, V'aggravante di ricadere dopo che, nella confessione, gid « Sut
illuminati, gustaverunt etiam donum caeleste, et participes facti sU™
aa
= 129
gpiritus Sancti > (°), esige una pity attenta cat
se anne, sot, una categoria a parte,
‘Materialmente parlando, pud essere Weegee,
cade nel medesimo peccato,fosse pure uns sola rer unaue t
i prescinden-
do dalla circostanza se cid avvenga prima o dopo la confessione. In
tal senso, saa ogni consuetudinario 2 anche necessariamente un re-
cidivo; non perd viceversa, potendo uno ricadere una 0 qualche volta,
senza che con cid egli contragga propriamente un abito cattivo.
Formalmente, tuttavia, e in senso proprio si chiama "recidivo” co-
Ini che, dopo 1a confessione, ricade nella stessa o quasi stessa maniera
senza emenda ("). Anzi, secondo una pitt comune e pit esata defi
sono veramente recidivi soltanto coloro i quali ricadono spesso — si di.
rebbe continuamente — nei medesimi peccati (impurita, bestemmie, ecc.)
gia piit volte confessati, senza dare nessun segno, 0 quasi, di emenda-
zione anche solo iniziale, che dica, da parte toro, un qualche sforzo di
buona votonta.
Accettando noi stessi quest'ultima definizione, possiamo ritenere in
pratica — proprio al contrario di quanto dicemmo sopra per l'accezione
semplicemente materiale del termine recidivo — che ogni recidivo sia,
o finisca almeno per essere, un abitudinario, ma non viceversa. In altre
parole, i recidivi formali non sono che un sottogruppo degli abitudinari,
che appunto si distinguono in abitudinari semplici oppure recidivi. Que-
sti ultimi, oltre ai due elementi che essi hanno in comune con gli abitu-
dinari semplici (frequente ripetersi dei medesimi peccati — per un no-
tevole periodo di tempo), ne hanno un terzo, proprio e caratteristico,
che il ricadere nelle medesime colpe, senza nessun o quasi nessun segno
diemendazione, dopo ripetute confessioni. Abitudinario semplice & ad es.
chi, presentandosi la prima volta a confessarsi, si accusa del vizio della
bestemmia: egualmente chi ritorna a confessarsi di questo vizio, senza
Presentare miglioramenti, per le prime confessioni. Ma, se costui conti-
nua nella sta abitudine cattiva, nonostante che pitt © pit volte vada a
confessarsi (sia pure a lungo intervallo di tempo tra una confessione €
Taltra, come @ il caso dei cos) detti «pasqualini»), certamente si deve
considerare recidivo. ‘
Ma ci sembra inutile insistere su questi conceti, tanto pit che, ute
Questione chi debba ritenersi recidivo, esistono frai toate ee
4 pensiero dottrinale e, nella valutazione concreta ¢ pratica, Vt Pi) Te
Sere benissimo diversita di giudizio in questo 6 sel Se aan dw
1a difficotta, perd, non @ tanto qui — dove, in fin Se rat oa
duce a una semplice questione di icasellamento a i quest able
tenti — quanto piuttosto nell’afferrare 10 stato psicologiee fr
‘hati e recidivi, perch® da esso dipendono le disposy
a
© cr. Ebr, 6, 4 se.
© Cf. 8, Afonso, op. city n. 65.
tutela, tanto che i moralisti
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Cartilla Animador Juvenil SalesianoDocument17 pagesCartilla Animador Juvenil Salesiano...100% (1)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Lo Spirito Santo E La Chiesa: Risposte Di Congar E Del Vaticano Ii Al Problema Carisma E IstituzioneDocument19 pagesLo Spirito Santo E La Chiesa: Risposte Di Congar E Del Vaticano Ii Al Problema Carisma E Istituzione...100% (1)
- 2023 Strenna Rettor Maggiore ItaDocument48 pages2023 Strenna Rettor Maggiore Ita...No ratings yet
- Bosco FS079 090 Lettere Arcivescovo Torino GastaldiDocument21 pagesBosco FS079 090 Lettere Arcivescovo Torino Gastaldi...No ratings yet
- 100 Años de Presencia Salesiana en HondurasDocument12 pages100 Años de Presencia Salesiana en Honduras...No ratings yet
- 8-Moniciones Décimo Noveno Domingo-2020Document3 pages8-Moniciones Décimo Noveno Domingo-2020...No ratings yet
- KJDocument2 pagesKJ...No ratings yet
- Oraciones para El RosarioDocument4 pagesOraciones para El Rosario...No ratings yet
- Preguntas EncuestaDocument1 pagePreguntas Encuesta...No ratings yet