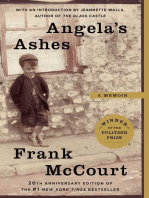Professional Documents
Culture Documents
Giuseppe Turbessi - Apocalisse
Giuseppe Turbessi - Apocalisse
Uploaded by
Bindaroi Alexandru0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views45 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views45 pagesGiuseppe Turbessi - Apocalisse
Giuseppe Turbessi - Apocalisse
Uploaded by
Bindaroi AlexandruCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 45
ee tla ehe OS
wean Je obras 4 &
Oh Ne eT ale
SEAS pate
a
Aull ¢
1 At. ahaa
=) |
=
ae
p=
\
[ee 3.423. |
Klbcw veils coon Tok ue |
Prseon, a gal ole net he |
We ~ Lebbraro VISTO ~ |
Whine Tecore, eat
Be hsle ch de pu Cleve | |
1A PAPUA Aseodarn i |
A) de Flex pe
‘The mel
2)lue = (Amey glt'othe
2) Feu & vebudic of Dro ‘am
orcas ial wae cote
4 Goateelens ches Posy, |
repels ee a
via arose pion sole 5h |
ffi in|
pork Arwee pms o18.0
. | Prins tesura
ciclo .
Apocalisse 7,2-4.9-12
UNICO | GIUSEPPE TURBESSI
I redenti come
sacerdoti dell’Altissimo
1/ IntRopuZIONE
Il brano della prima lettura biblica 2 preso dall’Apo-
calisse (7,2-4.9-12). Questo libro sacro oggi & poco noto
alla massa dei cristiani, i quali — in generale — cono-
scono abbastanza bene il primo libro della sacra Scrittura,
© per lo meno gli episod pitt caratteristici in esso conte-
rnuti, In realta tra i due libri esiste una evidente relazione,
Nel primo si parla delPorigine d'ogni cosa dalle ma
del?Onnipotente; nell’Apocalisse si discorre prevalente-
mente della sorte degli e la acitt’ celeste». E questo stato di ten-
sione durera per tutto il tempo della chiesa. I battezzato
non s‘illuda di poter tranquillamente e senza sudore
sangue corrispondere alla propria vocazione. Perfino nel
proprio intimo esperimenta motivi di contrasto trail
«vecchio» ed il «nuovo» uomo; tra la «carne» ¢ lo «spi-
tito». I] fatto stesso della crescenza cristiana comporta
un quotidiano sforzo nel districarsi dalle conseguenze del
peccato originale ¢ da quel che resta della concupiscenza
degli occhi, della carne e della superbia della vita, Il
«muoio ogni giorno» di s. Paolo, non & un lusso pet il
credente; ma un imperativo categotico.
Ci vuole molto amore di Dio per non abbattersi nel-
ora della prova, ma & necessaria una fede incrollabile di-
nanzi al sarcasmo d'un mondo incredulo, ebro del san-
gue dei «martirin; & anche vero che il credente fin da que-
sto mondo ha la caparra dei beni eterni, rappresentata dai
doni dello Spitito ¢ dalla gioiosa speranza, che fanno tra-
salize Panima di un gaudio inenarrabile perfino in mezzo
alle prove pitt dolorose e mortifican
Il ciclo liturgico, gravitando intorno al misteio pa-
squale, ricorda al fedele il suo esodo dal mondo del pec-
cato ¢ la sua partecipazione al banchetto divino, I sacra:
menti ano un contatto «fisico» con la vita eterna,
quale ragaiunge Tso seme nella lobraane sen
S. Danse noe Se ee Passato
stica.
bibliograf 139
¢ viatico per il tempo della traversata del mondo; ma an-
che 2 il sacramento dellattesa gioiosa di Cristo ¢ quello
della sua_presenza_reale in_mezzo_alle membrs ua
chiesa. Ogni celebrazione eucaristica anticipa in un certo
modo la «parusia» ed & segno della vittoria del Signore su
tutte le potenze ostili. Non a caso il grido: «Vieni, 0 Si-
gnore Ges» (che compare alla fine dell"Apocalisse), &
Tegato alla celebrazione eucatistica, che rinnova il mistero
pasquale: Gesit vive glorioso ¢ intercede perpetuamente
per In sua chiesa. E percid il fedele assapora gia i doni del
secolo futuro anche in mezzo alle pitt penose tribolazioni
del secolo presente. Egli sa che la sua preghiera s'unisce a
quella degli angeli e dei beati in una liturgia che unisce
la chiesa militante con quella trionfante. La chiesa del-
PApocalisse appare come una comuniti di adoratori, i qua-
Ii, soprattutto nella celebrazione eucaristica, prendono
coscienza d'essere estranei al «secolo» malvagio ¢ d’essere
cittadini del «mondo» che verri. Quando percid il cri-
stiano ha gustato il cibo degli angeli, non pud fare altro
che giubilare (specie nel giorno del Signore), prorompendo
in salmi, inni ¢ cantici spitituali, proseguendo con gioia
il cammino incontro al Signore che viene
IL suo sospiro, specie nei momenti culminanti della
persecuzione, non’ potri essere diverso da quello delle
prime generazioni cristiane, ritmato con quello della chie-
sa: «Passi questo secolo! Venga il tuo regno! Vieni, o
Signore Gesi!».
BIBLIOGRAFIA
W. Bousser, Die Ofenbarung Jobannis, Géttingen 1906.
HB. Swine, The Apocalypse of St.John, London 1903
E. B. Axio, Saint Jean, L’Apocalypse, Paris 41933.
KH Guaiss, ‘Chea! ‘and excel Commentary on the
Revelation of St. Jobn, 2 voll., imburgo 1920.
M. E. Borsmarp, L’Apocalypse (Bible de Jérusalem), Paris 1950.
I. Bein, Die Ofenbarung, ds Jobannes, Gdtingen #1953.
P. Kerrer, Die Apokalypse, Friburgo 11953.
140 bibliografa
E, Louver, Die Offenbarung des Jobannes, Tubinga, 1953.
C. Bruzrscit, Clarté de ’Apocalypie, Gentve 1955
Li Ceneaus:J. Casurn, L’Apocalypse de S. Jean lue aux cbré
siens, Paris. 1955,
HM, Fenet, L’Apocalisse di S. Giovanni, visione cristiona della
‘storia, Roma 1957.
A. Wikenuausen, Ofenbarung des Jobannes, Ratishona *1959
(ed. it, Brescia 1960).
H. Luuse, L’Apocalypse, Le dernier liore de la Bible (tr. 5 ed.
‘ted.), Baris 1959,
CM. Maystox, The Book of Revelation, Nashiville 1960.
Hi. Troapec, Le message de saint Jean, Paris 1962, pp. 85-234.
A, Frunuter, L’Apocalypse, Bruges 1963.
F. Moxtacnint, Problem deli’Ap. in alcuni studi degli ultimi anni
(1955-1961), in Riv. Bibl, 11 (1963), 400-424.
J. Havor, L’Apocalypse de "Jean et les christianismes primitives,
in Rew. Unio. Brax., 18 (1966), 190-217,
A. Lancentorni, L’Antico T. nell’Apocalisse, in Riv. Bibl, 14
(1966), 369-384.
AxWv, L’Apocalisie, Studi biblici pastorali, Brescia 1967.
G. Tanstnt, Alpha ct Omega, Meditazioni sull’Apocalisse, parte T,
‘cc. 1-13, Treviso 1967
A. Pout, Die Offenbarung des Jobannes, t. 1, cc. 18, 1969.
_ Siow Nexto, Il lbro-delAp. in Metsggio dell sivezs,
5, Torino 1968, 1069-1137
Quattg gpere devono consierasi come complemento del n0-
sto, articolo:
G. Tunsesst, Angustia ¢ speranza negli aultimi tempin, in Riv
‘Asc. Mist, 34(1965), 135143. (Liahima. parte del nostro artic
colo & tributaria di questo scrito).
J. Commun, Le rassemblement de VIsraél de Dieu, in Assembl
du Seign., n. 89(1963), pp. 14:33. (Rimandiamo 'a questopera
Ber lo solgimento det ent della seconde pane Sc nono
C. Avan, La vision de te foul innombrable: Ap 74047
Non c'é stato possibile avere tra mano. quest’opera).
A. Lippe, L’Apocalisse, (ed. ital), Modena 1969. (Ci & stata
utile per la parte introduttiva)
. | salmo responsoriale
ciclo
Salmo 23(24),1-2.3-4ab.5-6
unico
FRANCESCO URICCHIO
I perfetti adoratori di Dio
1/ CONTESTO DEL SALMO
Nel.nuovo Iecionaio festivo il samo (a4 8 adow
perato in gran parte come responsorio. Difatti le prime
due parti (vv. 1-2: inizio innico: Jahvé Signore, perché
creatore; vv. 3-6: requisiti per partecipare al culto) fanno
da responsorio nella solenniti dei Santi (eccettuato il».
4c), mentre Ja terza parte (vv. 7-10: ingresso trionfale del-
Parca nel tabernacolo), limitatamente ai vv. 7c-r0b,, figura
nella 1v dom. d’Awvento (ciclo A). Sebbene Je prime due
parti sembrino meno arcaiche, nel complesso il salmo clas-
sificato fra «i salmi di Sion»? da considerarsi una liturgia
“Cf G. Castenuino, II Libro dei Salmi, Torino 21960, pp. 644-
49; C. A. Braces, The Book of Psalms, 1, TEdimburg 1960, pp. 212.
219; M. Danoop, Pscims, 1, Garden City 1966, pp. 150153; A. Guor
‘cr, Prier les Psaumes,, Paris 1966, pp. 3639; P. Gutcuou, Les
Psaumes conmentés par Ia Bible, 1, Patis 1958, pp. x50153; H. J.
Kraus, Psalmen, 1, Neukirchen 1966, pp. 193-206; V. Vitax Hueso,
El Salmo 24: unidad literaria_y ambiente historico: Estudios Biblicos
122, 1963, 243.2533. J. Bonsiavix, L’Apocalisse di San Giovanni, Ro-
ma 1963, 157-64; J. Commun, Le rarsemblement de I'Tsrael de. Dieu,
in Asseniblées du ‘Seigneur, x série, n. 89 (1963), 15-33-
2} G. Castetuno, It Libro dei Salmi, 64449; A. Rous, It
Messaggio della Salverze, 3,490.
140 bibliografa
E. Louver, Die Ofenberung des Johannes, Tubinga, 11953.
C. Bruersc, Clarté de W'Apocalypie, Gentve 1955.
Li CenravxeJ. Casauee, L’Apocalypse de S. Jean lue aux chré-
tiens, Patis 1955.
HM. Freer, L’Apocalisse di S. Giovanni, visione cristina della
‘storia, Roma 1957.
A. Wikestiauser, Offenbarung des Jobannes, Ratisbona *1959
(ed. it. Brescia 1960).
H. Lanse, L’Apocalypre, Le dernier liore de la Bible (tx. 5 ed.
ted.), Paris 1959.
CM. MarMon, The Book of Revelation, Nashiville 1960
HE, Troavec, Le mestage de saint Jean, Patis 1962, pp. 85.234,
A, Feuer, L’Apocalypse, Bruges 1963.
F, Monsaowin, Problems dell’Ap. in alcuni studi degli altimi anni
(1955-1961), in Riv. Bibl, 11 (1963), 400-424
J. Hapor, L’Apocalypse de "Jean et les cbristianismes primitives,
in Rev. Univ. Brus, 18 (1966), 190-217.
A. Laceusorn, L’Antico T. nell’Apocalisse, in Riv. Bibl, 14
(1966), 369.384.
AaWy, L’Apocalisse, Studi biblici pastoral, Brescia 1967.
G. Tatsint, Alpha er Omege, Meditation sull’Apocalsse, parte I,
ee. 1-13, ‘Treviso 1967.
A. Pout, Die Ofenbarung des Jobonnes, tI, ce. 1-8, 1969
Siagoe DA NeasDno, If libro dell’Ap, in Messeggio delle saivecza,
5, Torino 1968, 1069-1137.
Quatto apere devono considerasi come complemento del no
stro_ artical:
G. Turnesst, Angustia e speranza negli aultimi tempio, in Riv,
‘Asc. Mist,” 34 (1965), 135-143. (L'ultima parte del nostro arti-
colo 8 tributaria di questo seritto),
J. Compuin, Le rassemblement de VIsraél de Dieu, in Assembl.
du Seigr., 0. 89(1963), pp. 14:33. (Rimandiamo ‘a quest opera
Ber lo svogimento det em della stconda pate del nostro
C. Ausra, La vision de la foule innombrable: Ap 7,9,140-17.
(Non c' stato possibile avere tra mano quest'opera)..
A. Lippe, L’Apocalisse, (ed. ital.), Modena 1969. (Ci & stata
utile per’ la parte introduttiva).
salmo responsoriale
ciclo
: Salmo 23(24),r-2.3-4ab.5-6
unico |
| FRANCESCO URICCHIO
I perfetti adoratori di Dio
1/ ConTESTO DEL SALMO.
Nel nuovo lezionario festivo il salmo 23(24)! 2 ado-
perato in gran parte come responsorio. Difatti le prime
due parti (v0. 1 io innico: Jahvé Signore, perché
creatore; vv, 3-6: requisiti per pattecipare al culto) fanno
da responsorio nella solenniti dei Santi (eccettuato ill v.
40), mentre Ja terza parte (vv. 7-10: ingresso trionfale del-
Parca nel tabernacolo), limitatamente ai vv. 7c-r0b,, figura
nella rv dom. d’Avvento (ciclo A). Sebbene le prime due
parti sembrino meno arcaiche, nel complesso il salmo clas-
sificato fra «i salmi di Sion»,?& da considerarsi una liturgia
"Cf G. CasteLLino, I! Libro dei Salmi, Torna *960, pp. 6.
49; CA. Briccs, The Book of Psalms, 1, Edimbure 2960, pp._273-
219; M. Dantooo, Psalms, 1, Garden City 1966, pp. 150-153; A. GEOR:
‘ct, Prier les Psounes,” Patis 1966, pp. 3639; P. Guiciou, Ler
Psaurnes conmentés par la Bible, 1, Paris 1958, pp. 150-133; H. J.
Kraus, Psalmen, 1, Neukicchen 1966, pp. 193-206; V. Vitax HUESO,
EI Salmo 24: wnidad literaria y ambiente bistorico: Estudios Biblicos
22, 1965, 245253; J. Bowsieven, L’Apocalisse di San Giovanni, Ro-
‘ma 1963, 157-645 J. Conanian, Le rassemblement de UTsrael de Dieu,
in Assemblées du Seigneur, 1° série, n. 89 (1963), 3533.
2 Cf G. Casteuino, I Libro det Salmi, 64449; A. Rous, It
Mesraggio della Salverza, 3,440.
142 Opnissnté
connessa con Ia traslazione dell’arca (II Sm 6). Difatti il
primo e terzo tema — Jahvé Signore della terra e re della
gloria che entra nel inbernacolo — sono collegati fra
loro, giacché 1a signoria divina, fondata sulla creazione,
appare in situazione quando & ricordata una vittoria (cf
Sal 92[93],1-2). Patimenti la prima e seconda parte (vv
1-2 € 3-6) armonizzano fra loro perché i titoli di «Signore»
© «creatore» sono alla base del suo potere di imporre la
legge. Finalmente, la punizione di Uzza che, avendo osato
toccare V'arca fu fulminato da una morte improvvisa, pro-
vocando un grande timore in David (II Sm 6,6-9), fa
bene da sfondo all’esame di coscienza dei vv. 3-6.
2/ ESposizioNe E ATTUALIZZAZIONE LITURGICA
‘A motivo della sua terza parte, finora nella messa
questo salmo ® stato considerato un’salmo di ascensione
(cf antifona al Magnificat dei 1 vespri dell’Ascensione) ¢
di Avvento (1 graduale del mercoledi delle tempora di
Avvento ¢ offertorio della vigilia di Natale), quindi per
affermare la regaliti di Cristo, che viene nel mondo ed
entra in cielo,
». 6: Invece il ritornello attuale: Questa é la stirpe
eletta che cerca il volto di Dio, sembra voler additare nei
santi — i mondi di cuore e di mani — coloro che hanno
cercato il Signore e lo hanno trovato, i veri adoratori che
esercitano il loro sacerdozio con le vesti bianche lavate nel
sangue dell'Agnello (Ap 7,9-10). Classificando {ra gli
uomini che cercano il volto di Dio, cercano Dio, il salmi-
sta di quasi la definizione del fedele perfetto, del vero
israclita, del genuino adoratore. Difatti ’espressione «cer-
care il volto di Dio» (come Ia parallela «cercare Dio»)
equivale a pellegrinare al tempio di Dio (Am 5,53 Os 5,15)
con lo scopo di partecipare al culto, Benché possa essere
3 Cf G. Casretiio, op. cit, 644; H. J. Knaus, Psalmen I, 194
salmo responsoriale 143
di origine pagana — giacché Jahvé non ha figura (Dt 4,
12) —, essa manifesta Tintenzione di consultare Dio
(I Sm 21,2), chiedere la sua protezione (Sel 411 421,3) ¢
soprattutto, ‘mettendosi in atteggiamento di ascolto’ per
obbedize (Am 5,4-6; Sal 26[271,8'5.), di tornare a lui
con tutto il cuore (Sal 79[80,4.8.20)+ I desidetio di
vedere il volto di Dio, innato nell'uomo, & inappagabile
sulla terra (Es 33,20), nonostante le specialissime vision!
concesse ad aleuni (Es 33,11.20-25; [5 6,1-6). Solo Gest,
TUnigenito del Padze, vede Dio e attesta quello che vede
(Go 1,18). E da lui, che ® penetrato oltre il velo per ap.
parire’davanti a Dio per noi (Eb 9,24), i discepoli hanno
Ficevuto la promessa di vedere Dio (Mz 5,8), quando la
fede si cambieri in visione (I Cor 13,10-11). Essi, ‘che
erano perduti e sono stati cercati e trovati da Dio in Cti-
sto (Lex5,43 19,0), avranno come programma la ricerca
del regno di Dio e della sua giustizia (Mr 6,33), ¢ sic.
come il regno praticamente si identifica con Gesit (Me 10,
14-15), saranno costantemente alla ricerca di Cristo nella
fede alla maniera di Maria Giuseppe, dei magi e det
discepoli (Le2,41-50; Me 2,1-12; Go 13,33). 1 santiy i
servi fedeli, appaiono’ appunto come quel pellegrini cere
tori di Dio'che sono giunti Ia dove & il maestro, presso |
Padre, a contempare Ia sua glo (Go 12,6; 24,5317,
24).
¥. 1-2: Questo uomo si rende pellegrino al tempio,
perché & animato da una grande fede: egli & convinto, ¢ lo
afferma con vigore, concisione ed entusiasmo, della signo-
ria universale di Jahvé, fondata sulla creazione della terra
€ del suo contenuto,’ del mondo e di tutti gli esseri vi-
4 Anche Ia frase acercare Dio» presenta sgnicati ansloghi di pe
leyrinare al tempo (Os_ 5.133 Es 3,7), pregare (MF 7.7), trequentare
1 santuai ¢ i profei (Er' 18,5; 1 Re 233) pet conorcere Ia volont
4k Dio ed sepia, ghangendo' cost alla conversione (Ger ag.ttt4)
SIL salmisa espuime questa persusione in termini tradisonali¢
itv: la tera, a parte del globo sepaata dalle acque, fertile ©
(Gen 19; Pe 8.29; Gb 27855), mediante colonne (Gb 38455
144 Opnissantt
venti, specialmente degli uomini, Questo universalismo
del dominio di Dio, locale e personale, che non impedisce
di considerare 1a Palestina ¢ il popolo eletto come eredita
speciale di Jahvé (Es 15,17; I'Sm 10,x), & sempre. pre~
sente alla coscienza di Istaele, ma con lesilio, che deter
mina una spiritualizzazione della terra, del re, del tempio ¢
‘quindi della regalita divina, diventa meno territoriale e pid
personale, Nel N.T. esso timane ancorato alla creazione-
prowvidenza (Ar 17,24 s8.; Rat 4,19-20) ed & basato an-
che sulla redenzione (I Tm 2,6). La prima lettura, por
alludendo ai privilegi e alla missione di Israele (Ap 7,4),
rileva questa universalita degli eletti lavati nel sangue
dell’Agnello ¢ segnati col sigillo di Dio — probabile ac-
cenno al battesimo (Ef 1,13-r4), estendendola agli angeli
(Ap 7,985).
v. 3: Nonostante l'affermazione della signoria univer-
sale di Dio, il fedele & cosciente che Dio ha voluto porre
il suo nome in Sion (I Re 8,16.29), quale segno tangibile
della sua presenza e protezione per Israele. Questo monte
del tempio, riallacciandosi pitt tardi alla montagna del
Sinai, unira in sé i temi delValleanza ¢ del culto (Sal 9,12-
15; 83[84],5-8). Nel N-T. Gest, prega volentieri sui
monti e lontano da Sion (Le 6,12; 9,28; Gu 6,15), pro-
cede sulla montagna alla scelta dei Dodici, fondamenti del
nuovo Istaele, ¢ alla promulgazione della Legge nuova
(Me 3,13; M¢'5,1), tivela il suo vero essere con la trasfi-
gurazione (Mc9,2) e ascende al cielo (Af 1,12), facendo
della sua umanita gloriosa il nuovo tempio (Gv 2,19). Per
questo la chiesa spiritualmente si 2 avvicinata alla monta-
gna di Sion (Eb x2,22) e Pha gid raggiunta nelle sue pri-
mizie — i santi, specialmente i martiri — che sul monte
Sion si trovano intorno all’Agnello esercitando il culto
perfetto in bianche vesti davanti al trono di Dio ¢ del-
T’Agnello (Ap 14,15 7,9 88.).
Po 8,55), poggia sul mare © sui Gumi sotterranei (Gen 7,11; Es
ans Dt 33,33)
salmo responsoriale 145
Muovendo i passi verso il monte di Dio (Is 2,3=Mi
4,2), al pensiero della signoria divina subentra quelio della
santitd di Dio. Percid il pio israelita passa dall’inno alla
liturgia della legge, dal giubilo all’esame di coscienza, in-
terrogandosi sui requisiti necessari per accostarsi a Dio ¢
partecipare al culto.
La risposta (v. 4a), molto stringata’’ li compendia nel-
Vinnocenza (Sal 9,29{ =r0,8]; 14[15],5), cio® nella pu-
titi di mani e di cuore, di azioni e di intenzioni, che
porta una perfetta coerenza fra Pesterno e Vinterno, il.
bando di qualsiasi finzione, cosicché Vesterno sia espres-
sione delTintemo. Lilterire specifazione, benché nega.
tiva, di non desiderare* cose vane’ e non giurare con i
ganno (v. 4bc), confermano V’impegno di armonizzare
Festerno con interno. Questa purita etico-morale, incul-
cata insisteitemente dai profeti (Am 5,21 88.5 Sal 50 51],
18-19), considerata un dono di Dio (Is 6,3 ss.) ed ef
fetto del suo Spirito (Ez 36,25 s.; Sal sol 5x ],12). Ges,
che addita nelle mani, piedi'e occhi possibili occasioni di
peccato (Mc 9,43-47), 1a fa risiedere unicamente nel cuo-
re. Essa, che & una conversione, & dovuta alla parola di Dio
in Cristo (Gv 13,10; 15,3), accolta con fede e al dono
dello Spirito santo (Af 15,8), ed & effetto della virti puri-
ficatrice del sangue di Cristo (Ap 7,9), nel quale i credenti
sono lavati mediante il battesimo (I Pt 3,21 ss.). I santi,
avvolti in vesti bianche, evidenziano il frutto maturo della
putificazione operata da Cristo e insieme la sinceriti della
loro jforversione provata nella grande tibolone (4p
7.14).
$ Salts: temine casio per indicare il pellgrnagslo al tem
pio (F Snr 13.33), 4 Geratalenime (Le 34a) oper la guida di ‘una
processione (IT Sm 6,12.15). pean
Ein questo il Sal 33(04) dileice dal Sal x42), che 2 pid par
vcolregito. Cf infai i avo commento, Ospi di Dio, di Bl. Rin
Sint in Le parole per Vsiombles esting, vol. 44, Dp. 116122.
“i sportare Ta sin animus: equvale sesterate, welere (f
Dr a4st3; OF 48; Po aout
9 Tents avait: alnl a siferiscono geneticamente al «mses;
altri Videntificano con gli «idoli». a :
x0: Pal n. 64
|
146 Opnisranti
». 5: Il fedele, accostandosi a Dio in stato di purita
€ con la consapevolezza che Ja liturgia del tempio @ la
sede normale della benedizione divina (Sal 83[84]; 121
[122]), 2 sicuro di riceverne i benefici.
Cosi la Benedizione, che & data da Dio ai primi esseri
viventi, particolarmente agli uomini (Gen 1,22.28-30) ¢
importa felicita e vita, nonostante la maledizione del pec-
cato (Gen 3,16), & stata promessa in modo speciale ad
Abramo (Gen 12,1-3; 22,15-18) ed_estesa esplicitamente
a tutto il popolo a condizione della fedelta allalleanza
(Dt 27-28). In seguito, pur essendo assicurata alla dinastia
di David (II So 7,12.16.29), essa si spiritualizza identi-
ficandosi con la presenza di Dio (Sal x31L132],13-153 132
[133]), e percid si riversera nella sua pienezza sul mes-
sia che sari pieno di Spirito santo (Is 42,1; 44,3). Il cri-
stiano sa che Gesii, il frutto benedetto di Maria, benedetta
come Giuditta (Le 1,42; Giudit 13,13-17) & la benedi-
zione di Dio per gli uomini (Gal 3,7-9) ¢ veicolo di ogni
benedizione (Ef 1,3). Egli, che Pha’ impartita al momento
dell’ascensione (Le 24,50-5x), Pattua gia sulla terra con
il dono dello Spirito Santo (Gal 3,14), in attesa di dare
quella definitiva (Mr 25,34-36). Per questo i credenti
benedicono Dio in lui, tanto nella vita quotidiana (Co! 3,
17; Ef 5,20) quanto ‘nel culto eucaristico (I Cor 10,16;
‘Me 14,22-24), sperando di unitsi ai santi del cielo i quali
cantano la benedizione (Ap 7,12).
Anche la giustizia (0 premio), che indica la prosperita
promessa ai pii (Pv 8,18; 21,21), & un nome diverso della
stessa salvezza divina. Considerata in Dio, essa denota la
sua attivita per conduzre P'uomo a prosperita, a ogni spe-
cie di benefici (‘Sal 64{651,6; xx0[ 111 ],3), anzi alla vita
(Sal 118[119],40.106.123), € percid ha origine nel suo
amore di tenerezza (Os 2,21). A un livello pitt alto essa
compendia i benefici della’ salvezza messianica (Is 56,3-8),
che comporteri il perdono dei peccati (Ber 2,6-r05 Sal 50
[51],16) ¢ la glorificazione di Israele (Is 45,23). Cost,
nel N.T., Dio & agiusto» perché, in Cristo, il giusto per
eccellenza (I Pr 3,18-22), perdona i peccati (I Gu 1,8-10)
salma responsoriale 147
ai credenti (Rov 3,4-6.21-26). Il cristiano, che accogli
questa giustizia, diventa partecipe della filiazione divina di
Cristo (Rnr 8,28-31), che poi si identifica con la santita
(Ren 8,19; I Cor 1,30). Per questo i santi, che godono il
frutto della giustizia di Dio salvatore, ringraziano per la
salvezza (Ap 7,9 5.)
3/ CONCLUSIONE
Come conclusione raccogliamo alcuni punti di com
tatto fra la prima lettura e il responsorio:
a/ Istaele, popolo sacerdotale, — impersonato dal
salmista pellegrino allarca partecipe della processione
della sua traslazione — trova il suo compimento nella
chiesa, particolarmente nei santi, i quali sono arrivati, gid
stanno, in atteggiamento cultuale davanti al trono di Dio
e dellAgnello notte e giorno (vv. 3 e Ap 7.9.15);
b/ questo popolo di santi, nuovo e vero Israele, eletto
e protetto da Dio (Ap 7,2-4), costituisce il vero dominio
universale di Dio, che perde’la sua connotazione territo-
riale riveste quella personale. I santi, pur venendo dalla
terra (Ap 7,1-2), sono indicati come persone di ogni tribi,
lingua e ‘nazione, connotati specificamente umani, che
significano che gli uomini in tutte le loro espressioni e in
tutta la loro ricchezza devono glorificare o rendere il
culto a Dio (vv. 1-2 € Ap 7,9);
¢/ inoltze, i santi, che indossano abiti cultuali di co-
lore bianco, ricevono la purita necessaria per avvicinarsi
a Dio in virei del sangue dell’Agnello (v. 4 e Ap 7,410.14);
d/ perd, nello stesso tempo, essi, ¢ specialmente i
martiti, nel loro pellegrinaggio verso Dio, si sono aperti a
questo’ dono passando attraverso la grande tribolazione
(Ap 7,14), cio® associandosi alla passione di Cristo;
¢/ finalmente questi santi, che si trovano gid nel tem-
148 Osniscantt
pio di Dio (Ap 7,15), che & Dio stesso e |’Agnello (Ap
21,22), sanno di aver ricevuto la salvezza ¢ la benedizione
(Sal 23241,5) — comprese le azioni giuste dei santi
(Ap 19,8) —, e percid esercitano il culto di adorazione
di lode (Ap 7,10.12) insieme con gli angeli davanti a Dio
e€ all’Agnello, ma non con l’Agnello.
Ver pro: riquardo allingresso dellarc. nel tabernacolo,_ nots
‘mo solo il titolo di are della gloria» (5 volte) e gli attibuti di «po-
fente_ed_eroe» (v. 8) € «Signore degli esersitin (v. roc), che ally:
dono alle Battaplie det periodo dellEspdo della conguista della
terra promessa. Considerandolo come un salmo di Ascensione e di
Avvento — TAvento liturgico 2 i tempo in cui il cristiano. guasda
verso Natale, ma soprattutto verso la Parusia, quindi verso il Re-
Signore che viene (cf Is 7,10-14; Mt 118-24) —, rileviamo che Gest
2 are della gloriay gid alla sua venuta nel mondo: nell'infania (Le
2,9-10.32), nel ministero pubblico — caratterizzato da parole, mira
colt (Gv" 1,045 2,01) © dalla, trasfigurazione (Le 9,28) — e anche
sulla croce, che “diventa un'elevazione del. Figlio’ delluomo (Go
12,2332). Tuttavia eli entra nella gloria a Pasqua (Le 24,26) diven-
tando il «Signore della gloria» (I Cor 2,8), Da allora Ia’ sua gloria
si rilete sui cristiani, i quali sono trasformati dal suo Spirito di glo-
ria in gloria (IT Cor 3,18) in attesa del suo ritorno in gloria (Me
13,26; Te 2435), quando quella ploria sari sivelata all'ntera crea
ione (Rr 8,19) € nella celeste Gerusalemme illuminata dalla glot
ddi Dio (Ap 21,25) sara cantata la gloria davanti al trono di Dio € del
VAgnello (Ap 7,12). La chiesa, e in essa ogni cristiano, che si pre
para ad accogliere il bambino, ‘Dio e re, lo contempla come re della
sloria, che viene per debellare il principe della morte (Eb 2,14), per
portare tutti alla gloria (Eb 2,10).
seconda lettura
ciclo | {Giovanni 3,1-3
unico | VALERIO MANNUCCI
Riscoprire
di essere figli di Dio
1/ IL CONTESTO DEL BRANO
1 ema proposto'da Giovanni nella sua prima lettera
€ compendiato nel prologo (I Gu 1,1-4) si definisce in ter-
mini di comunione: 1a comunione del credente con Dio,
che avviene con la mediazione del Verbo incarnato e re-
dentore ¢ con Ia mediazione dei primi testimoni, la media-
zione cio’ della chiesa,
L'apostolo indica una serie di criteri, onde verificare
Pautenticita di tale comunione: camminare nella luce, cioé
rnon peccare (x,5-2,2); osservare i comandamenti, soprat-
tutto quello della carita (2,3-r1); opporsi al mondo e ai
molti anticristi presenti in ¢sso (2,12-28).
Con 2,29 il tema della «comunione> viene ripreso
sotto l'aspetto della filiazione divina, che ha anch’essa i
suoi criteri: praticare la giustizia (2,29-3,10b), amare i
fratelli (3,r0¢-24), professare la vera fede (4,1-6).
Per questo, ci'sembra opportuno iniziare il commento
del brano liturgico con 2,29 che si ricollega con il conte-
sto seguente.
150 Ognissenti
2/ IL SIGNIFICATO DEL BRANO
a/ chi pratica la giustizia, @ nato da Dio
Il v. 29 introduce V’idea della generazione diving, idea
cardine dell’epistola sulla quale Giovanni torner’ spesso
(cf 3,93 4,73 5,%-4-18), € ne offre il primo criterio: [a
giustizia. Dio ® giusto: il cristiano che opera la giustizia
(il che significa — nel linguaggio della prima parte della
Jettera — vivere nella luce, camminare come Cristo ha
camminato, obbedire al comandamento dell’amore) deve
per forza essere nato da Dio.
Se voi sapete che egli & giusto, dovete riconoscere che
chiungue pratica la giustizia & mato da tui (2,29).
Dio 2 giusto (v. 29a): con «egli» pud essere indicato
soltanto Dio ¢ non Cristo.’ Si parla infatti subito dopo
(v. 29b) di «nato da lui», il che pud essere detto soltanto
di Dio e non di Cristo (cf Go 1,13; I Gu 3,9; 4,73 5.1.4:
18): Giovanni non conosce idea di una efiliazione da
Criston. Dio & giusto (cf 1,9; Gu 17,25; Ap 16,5), perché
vuole e fa sempre e soltanto cid che & retto (cf Sal 145,17;
Bar 2,9; Dan 9,14), ed esige la stessa settitudine dagli
uomini.
Osbene, quando il cristiano «pratica la giustizian vi-
vendo secondo le norme dettategli da Dio, dimostra di
avere nel nucleo del suo essere la caratterizzazione da Dio
€ quindi di essere generato da lui? In perfetta armonia
con il tradizionale insegnamento di Gest (cf Mt 5,45),
Giovanni insiste sulla connotazione etica della figliolanza
divina, La nuova nascita 2 un fatto che si & prodotto nel
passato, ma che ha determinato uno stato che resta, una
condizione stabile le cui conseguenze devono estendersi
fino al presente (vedi uso del «perfetton gegennétai nel
1 Cf J. Micin, Le lettere cattoliche, Brescia 1968, p. 292,
2 Micut, ibid., p. 293,
secondallettura 151
v. 296). Tale prodigio si & compiuto una volta per tutte
nel momento del battesimo (Gv 3,1 ss);} Ja arinascita dal-
Valto in virth delfo Spirito santo» rovescia completamente
la situazione religiosa ¢ morale dell'uomo, applicando al
singolo cid che & vero del mondo intero: in Gesit Cristo
che muore e risuscita, la creazione minata dal peccato
finisce e incomincia la nuova creazione. L'uomo «nato da
Dio» vive in comunioie con Tui I successo della giusti-
zia sul peccato gli & assicurato: “«Fa’ in modo che colui
che non pud essere vinto abiti in te; allora sei sicuro di
vincere colui (il demonio) che solitamente & vincitore».*
b/ Ja riscoperta del dono di essere «fii di Dio»
Dopo aver messo al sicuro il valore etico della «gene-
razione da Dio», Giovanni si sofferma ora sulla frase «fi-
gli di Dio» © scongiura i suoi lettori a considerare quanto
sia profondo il significato di un simile appellativo:
Considerate quale amore ci ba portato il Padre. Noi sia-
mo chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La ra-
gione per cui il mondo non ci conosce & che non ba co-
osciuto lui (v. x).
«. Non si tratta di una visione puramente intellet-
tuale, speculativa, bens|_di_una_presenza, di una_comu-
‘lone pertondle Tae di conovoenaa val sre, Ta quale ha
fvuto inky hela [ede-0itone aa compira llorguaiid
i «contemplanti» si riconosceranno nell’immagine del per-
fetto «glorificaton.
4/ Vimpegno alla purita di vita
Il v3, anche se formulato all'indicativo, costituisce
una svolta parenetica che si riallaccia a 2,28 ¢ serve di col-
Jegamento al v. 4 8s.:
Chiunque ba questa speranza e Vappoggia su di lui puri-
fica se stesso, come egli 2 puro (v. 3).
Si tratta di un corollario decisive della speranza cti-
stiana: se siamo destinati ad essere in futuro «simili a
Cristo» dobbiamo esercitare questa somiglianza imitando-
Jo qui ed ora, imitandolo in particolare nella purit’ di vi
ta? Cristo & ‘il puro», cio’ il «giusto» (cf 2,1; 3,7); il
comportamento dei credenti deve corrispondere all’essere
di colui al quale essi credono (cf 2,29); € per Giovanni,
7C. F. Dovo, 0. € pp. 7072.
secondallettura 155
essere puri significa tenersi «liberi dal peccato» (cf vv. 4-6).
Gest: Cristo, nella prima lettera di Giovanni, ® chia-
mato il giusto, il puro, il santo (cf 2,20). Rileggere questo
brano della lettera di Giovanni, oggi festa di Ognissanti,
significa riprendere coscienza della stupenda dignita che
deriva al credente dallessere realmente cittadini del
cielo & commentata evangelicamente dalla proclamazione,
da parte di Gest, della «beatitudines messianica dei
chiamati al Regno, Cocrentemente con la storia stessa
del testo, le , «misericordiosi»..., trasformandosi co-
si, proprio per la’ divisione che provoca (incredibilmente
accentuata dal testo parallelo di Luca, dove al «beatin de-
ali ammessi al Regno, si contrappone il «guain degli esclu-
si), in un vero e proprio anticipato giudizio escatologico.
Tl genere letterario della «beatitudine», ben documentato
nei testi pit recenti dell’A.T., e soprattutto frequente
nella letteratura apocalittica conferma queste caratteri-
stiche. .
Gest si & servito con una certa predilezione di que-
sto modo incisivo di esprimere Ja gioia escatologica, e
isognera tenere presente le «beatitudini» che compaiono
nel Vangelo anche al di fuori di questa pagina® per ca-
pirne lo spitito. Infine il testo di Matteo, pit sviluppato
di fronte al parallelo di Luca (che presenta solo quattro
(‘ayauin)* acquistera sempre
meglio definita fisionomia teligiosa: privi di beni e di
sicurezza, oppressi, messi al margine della societt e: re-
spinti, hanno imparato la fiducia in Dio, labbandono al:
la sua misericordia, Pattesa da lui solo della salvezza,
Partito da una situazione concreta, il concetto, senza mai
perderla di vista, & andato affinandosi ¢ spiritualizzan-
dosi, sino a definire Vatteggiamento religioso di creature
che, consapevoli della terrena miseria, fanno di questa
constatazione fondamento di speranza nella divina bonti.
Assai frequente nei salmi (40,18; 69,33-345 70,65 74.21;
86,r-2), ben noto a Qumran (r QH V,21-22), ha ormai
tuna portata essenzialmente religiosa; la situazione sociale,
sempre presente, @ perd ormai secondaria, mentre essen
ziale & Patteggiamento doloroso, umile, fiducioso di chi
si sente perduto e abbandonato nella vita, e spera da Dio
Ja salvezza. A queste creature per le quali un divino inter-
vento di salvezza @ urgente, Ges annuncia la «beatitu-
dine» messianica: a tutti gli uomini, dunque, che, delu-
si dal limite e dalla miseria della ‘vita presente, capi-
© Opera fondamentale sull'argomento 2 sempre quella di A. Getin,
Les pawores de Jabwé, Paris 1933; ef SCHNACKENBURG, 0. ¢, PP.
219353.
angelo x61
scono di non poter attendere una speranza se non in
Dio.
¢/ altre ).
7 Cf Bowwano, p. 35.
r-Paf a. 64
162 Opnissentt
2/ Le «searirupini> pt Gest
NELLA CATECHESI ECCLESIALE
a/ dall'annuncio gioioso alla parenesi attualizzante
Le «beatitudini» dunque documentano e annunciano
un fatto divino: la salvezza misericordiosamente offerta
agli uomini, L’annuncio originario di Gest, oltre aver
scosso i suoi contemporanei e aver iniziato un movimento
religioso, si ripercuotera nella vita della chiesa primitiva
senza perdere nulla del suo vigore originario, ma non
senza perd un sensibile spostamento d’accento. Cid &
provato dalle moderne indagini sulla storia del testo, non
solo per il nostro passo ma per molti altri del Vangelo.*
E naturale che la chiesa primitiva «vivesse» le parole di
Gesit, non soltanto riproponendole al mondo nel kérig-
ma, che continua ’'annuncio personale di Cristo, ma ser-
vendosene anche, all’interno, per la formazione spirituale
dei credenti. Questo piegare I’annuncio messianico di Ge-
st a uno scopo catechetico implicava: x) una grande fe-
delti alla sostanza dell’annuncio stesso, cadendo il quale
la stessa vita della chiesa perdeva ogni significato; 2) una
delicata attenzione alle implicazioni educative insite nello
stesso annuncio (& ben chiara in Gest V'intenzione, an-
nunciando il Regno, di ottenere una trasformazione di vi
ta); 3) un’accentuazione, o magari un’esplicitazione degli
aspetti educativi e catechetici, ottenuta magari con rife-
timento ad altri spunti dell’insegnamento di Ges, In
questo proceso, ben documentabile, la chiesa, sollecitata
dalle sue stotiche, e provvidenziali, necessiti (istruire i
fedeli) era certa, non di tradire, ma di approfondire lo
stesso insegnamento personale di Cristo, e quindi di tra-
smetterlo con ancor maggiore fedelta?
* Vedi leunt exempi in I. me 1a Porras, Come impostre on
4 probiome del Gesh storia}, In Clo. Catt, 5 Boga 1965, BP-
Oy .
Tl fenomeno 2 studio sistematcamente per le parsbole da J.
| jenestas) Le perbole di Gerh (vers. dal ted), Brescia 3567.
ange 163
Questo passansiodalVannuncio_ alla_catechesi, lo st
rileva anche nelle «beatitudinin; e persino nef testo pitt
arcaico di Luca, nel quale alle prime tre «beatitudini»
estinate a tutti gli uomini «poverin, «aflltti» e «affama-
tin, si contrappone la quarta dei «perseguitati» che ri-
guarda ormai la categoria ben determinata dei discepoli.
Questo scivolamento da un uditorio universale a
po ben preciso, fa sentire gia ben viva Ja presenza della
chiesa (i aperseguitati» sono evidentemente coloro che
credono in Gesii). Ancor pitt chiaro il passaggio in Mat-
teo: non si tratta pid soltanto di «poveri» (Le), ma di
«apoveri secondo lo spitito», ciot non per uno stato, ma
per una decisione spirituale’ motivata da un religioso im-
pulso interiore; non si tratta pid di «affamati» (Lc), ma
Gi gente che cha fame ¢ sete di giustiziar, che ciot ha
superato i problemi terreni, ed @ dominata dall'ansia del-
Ja salvezza escatologica-(cf la” giustizia”del-Regnow:—Me
6,33) € dalle necessatie condizioni di vita per raggiun-
gerla, Per di pitt non si tratta soltanto di persone che si
trovano, 0 si pongono, in una certa situazione, sia pure
spitituale, ma di persone alle quali @ richiesto un preciso
dinamismo morale, un nuovo ritmo di vita, tutto orien
tato verso _la_manifestazione fattiva della bonth_¢ del-
Pamore («amisericordiosin, ... ).
“E cosl Pannuncio sorprendente di Gesit si & trasfor-
mato in un piccolo catechismo, prezioso ¢ particolareg-
giato, che elenca aspetti della nuova vita del discepolo, se
vvuol ‘rovarsi in condizione (Ja «condizione») di meritare
Ja «beatitudine» proclamata da Gesit. Non che ci si trovi
cormai di fronte a un elenco di virti, come talora si so-
stiene, certo perd che Paccentuazione sulle condizioni di
vita richieste al discepolo & innegabile. La stessa terza
persona preferita da Matteo («beati i poveri, beati gli
alliti») che smorza la veemenza delle originarie esclama-
ioni di Ges in seconda persona, ancora percettibile in
Luca («beati voi, poveri.. beati voi che ora piangete>),
conferma ulteriormente Fevoluzione in senso comunitario
¢ catechistico.
164 Onnisant
b/ poverta ¢ bonta; i perseguitati
L’annuncio primitivo della salvezea ai poveri si tra:
sforma cosi, con. tutta naturalezza e aderenza ai motivi
profondi delle parole di Gesit in un invito alla «poverta
secondo lo spiriton, alla bonti verso i miseri e i divisi
dallodio («misericordiosi», «pacifici» nel senso di «paci-
ficatori»), e infine alla fedelt& perseverante al Vangelo f-
rno ad accettare il rischio supremo della persecuzione.
D'altra parte, il Gesti che aveva riservato ai «poveri»
la predicazione messianica, aveva anche amato, personal-
mente sceltae praticata, ed infine insegnata la poverta scelta
come ideale religioso;" anzi, Paveva tichiesta come neces-
saria condizione per far parte del gruppo dei suoi disce-
poli. Invieri i Dodici in missione apostolica imponendo
Joro una totale poverta (M¢ 10,9-10 e par.), un totale
stacco dai beni terreni chiedera al giovane ricco (Mf 19,21 °
e par.), ma a tutti i discepoli senza distinzione aveva
imposto, fin dal discorso della montagna, di «non racco-
«gliere tesori in terra... ma... in cielo» (Me 6,19-21), di
«non servire a due padroni.. Dio... e il danaro» (Mt
6,24), di non affannarsi nemmeno per le cose necessarie
alla vita (Ms 6,25-34), € infine nella preghiera di accon-
tentarsi di invocare giudaiche.
3/ LinrerPRETAzIonE TEOLOGICA pt Margo
a/ le «beatitudinin e il discorso della montagna di
Matteo
Delle «beatitudini», in cui ancora suona vivo l'annun-
cio di Gest (sopra 1/) e che avevano assunto portata
catechetica nella prima comunita (sopra 2/), si setve Mat-
teo pet impostare, e non solo pet introdurre come fa
Luca, il discorso della montagna. La differenza, anche in
questo, fra i due evangelisti @ notevole, benché I'uno ¢
Paltro ‘inizi con esse il rispettivo discorso: Luca affida
alle vivamente proiettata verso il Regno
(ssaranno consolatin,.... «vedranno Dio»...) prepara in
modo assai aderente L'impostazione escatologica che il
scorso dari alla preghiera («venga il tuo Regno»). Que-
sta volonta di sintesi che spinge Matteo (perché questo &
lavoro suo), a trasformare le ebeatitudini» in una specie
di miniatura dell’ampio discorso, si sitrova persino docu-
mentata nella preghiera del «Padre nostro», in cui i te
temi ritornano: tensione al Regno («venga...»), distacco
(il «pane quotidiano»), carita (arimettiamo ai nostri debi-
orin). Per quest'ultimo poi il contatto con le «beatitu
dini» & assai stretto: chi perdona & perdonato («Padre no-
stro>), chi fa misericordia riceve misericordia («beatitu
dini)».
Insomma, coerentemente col suo spitito schematico €
completo, Matteo ha fatto delle «beatitudini» una sintesi
della spiritualit evangelica tutta tensione al Regno.
b/ «beatitudinen presente dei discepoli
E giusto tuttavia chiedersi se la funzione delle «bea-
titudini> si risolva semplicemente in un anticipo, sia pu-
re vigoroso, di temi che poi saranno sviluppati, o se
qualche tema viene affidato da Matteo a questa pagina
170 Osnissanti
jniziale del discorso. Qui si pud proporte la discussione,
se intendere come futura, oppure come presente, la «bea
titudines annunciata; ciot se bisogni supporte il verbo sot-
tinteso al futuro («beati saranno i poverin) o al presente
(«beati sono»). Sembra che vada senz’altzo scelta questa
seconda possibilita,” che non solo & suggerita dalla prima
e ultima beatitudine» le quali, presentando un verbo al
presente («di loro & i Regno») difficilmente possono far
supporre una prima copula implicita al futuro; non solo
% confermata dalla forte impostazione al presente del te-
sto parallelo di Luca («voi che ora piangete»); ma 2 aper-
tamente deciso dal commento alla «beatitudine» finale, in
cui Ia gioia (escatologica) & chiaramente attualizzata: «Go-
dete ¢ rallegratevi» (v. 12). Molto pitt tardi s, Giovanni
parlera della vita eterna come di un fatto gid attuato, an-
che se non in forma piena né definitiva, nel presente at-
traverso la fede (Gv 5,243 6,47), preceduto dalle lettere
della cattiviti di Paolo che deseriveranno Ia vita celeste
con Cristo fin d’ora inaugurata (Ef 1,20; Col 3,1-4); €
tutto cid, beninteso, senza escludere né attenuare Ja fu-
tura realizzazione escatologica alla parusia e alla risurr
zione. Timidamente ma con chiarezza gia Luca, fra i
nottici, afferma la presenza del Regno «in mezzo a voin
(Le x7,21). Fra tutti gli evangelisti, Matteo sembra quel-
lo pitt fermamente legato alla concezione futura della sal-
vezza. E tuttavia anche in lui, se l'esegesi sopra proposta
& quella buona, Ja tensione verso il futuro non esclude
affatto un’esperienza attuale gid fin dora «beatificantens
anzi, proprio quella tensione, operando efficacemente nel
presente e assorbendolo, col pensiero, il desiderio, Patte-
sa, nei beni futuri della’salvezza, in qualche modo ne ai
ticipa V'esperienza e la partecipazione. La dottrina del di-
scepolo di Gest: come «beato» cittadino del cielo trova
dunque il suo primo abbozzo proprio nella martellante
proclamazione delle sue beatitudini: «beati> sono, ora!
1b, agsag4; TRILLING, p. 77
angela 171
c/ dimensione cristologica delle 2 una chiara partecipe-_
zione agli eventi cristologici della Passione. Attraverso Ta
ctoce, Gesti € giunto alla gloria detlatistrrezione; attra-
verso la «persecuzione», il discepolo giunge alla gioia
della «beatitudine» escatologica. Lo schema troppo tipi-
camente evangelico, per non ticonoscerlo, Gest stesso,
d'altronde, non manca, mai, parlando della persecuzione
della chiesa, di istituire il parallelo con la sua sofferenza
(cf Me 10,24-25; Gv 15,20).
Tnoltre, fin dalle prime righe del testo, si nota in Mat-
teo la preoccupazione di legare strettamente alla persona
di Gest la proclamazione delle «beatitudini»; questa
innominata «montagna» seduto sulla quale Gest pronun-
cia il discorso (v, 1), & senza dubbio da identificarsi in uno
dei rilievi montagnosi che sovrastano il lago. Eppure la
scena risulta egualmente sottolineata in modo strano; lo
ha sentito s. Luca, nella cui descrizione Gest «scende»
% P, Bonwaro, a p. 53 sottolines Ja dimensione cristocentrica delle
abestitudinis.
172 Ognissanti
dal monte per pronunciare il discorso (Le 6,12.17; per il
terzo evangelista si parler dunque di «discorso della pia
nura», e non, come per Matteo, «della montagna»), E ra.
gionevole pensare che Matteo voglia suggerire un'idea,
magati provocando un collegamento; coloro che hanno
visto nelle sue righe un discreto accenno al Sinai, sembra-
no averlo percepito. I] «monte» & il nuovo Sinai, ai cui
pisdL_si forma il nuove _popole- di Dio, che prende Te ide Te
er il suo nuovo pellegrinaggio verso Ia salvezza
‘ricorda Ta terza abetitudines, in cui «la terra», ciod
Ja Palestina, termine del pellegrinaggio d’Istacle, sta a
simboleggiate Ja patria celeste); sul «monte» il nuovo
Most, Gest, proclama Ja nuova «legge» (ricorda nel di-
scorso le antitesi tra la legge antica e la legge nuova: «fu
detton da Most, ma «io vi dico»: 5,21 55).
La figura di Gesi: campeggia dunque vigorosamente al
centro delle singole «beatitudini», che si rivelano_un_in-
contro_personale con Cristo, in una specie di_anticipata
sparusian_escatoogica: epl_Cristo_«povero» (MF 8,20),
SOR Seale i-auore (WF 11,29), col Cristo
‘persegultato (Mf 10,24-25). Se si guarda a fondo, nelle
Cbeatitudinin & Gesu. stesso che si cela;_accogliendole
nella sua vita, il discepolo ha realmente, ed escatologica-
mente, accolto Cristo." Percid & salvo.
ConcLustone
Questa pagina di Matteo — come tutti i brani della
letteratura sinottica — ci rivela il suo messaggio filtrando
attraverso il triplice livello della tradizione: dalla procla-
mazione gioiosa di Gest, allimpiego catechetico della
primitiva comunita, all’interpretazione teologica dell’evan-
felista, Ed 2 a questo triplice livello che la liturgia la ap-
plica ai santi: creature «mitin ¢ «povere>, «assetater di
alvezzay che hanno accolto Pannuncio di Gest, che su di
21 Kaniteretn, pp. 3r32t «Gest il povero, dalla parte dei poverin.
angela a7
lui hanno modellato la propria vita, trasformandola, at
traverso la «poverti» volontaria, la ticerca amorosa della
«bonti», la fedelt’ eroica, in una tenace tensione al mon-
do divino; che infine sono riusciti a far della vita terrena
‘un’anticipo dell’esperienza escatologica, vivendo il mes-
saggio delle «beatitudini» in unione d'amore e di fede
con Cristo. E proprio per questo proposti dalla Chiesa al-
la nostra attenzione, alfinché impariamo da loro, ed otte-
niamo da loro di accogliere con umile gioia l’annuncio, di
adattarvi coraggiosamente la vita, e di viverlo «in Cristo».
. | note di teologia pastorale / x
ciclo
. EMILIO GANDOLFO
unico
| Santi nell’amore
Vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare (Ap 7,9). Notiamo anzitutto la corrispondenza
che c'& tra questa folla dell’Apocalisse ¢ la folla che, se-
condo il Vangelo, ascolta Gest in Galilea sul monte do-
ve egli proclama’beati quelli che accolgono il regno di
Dio che, nella sua persona, & gia presente in mezzo a noi.
T santi sono quelli che sono stati chiamati. La santita &,
infatti, una risposta ad una chiamata divina, E in virta
di questa chiamata che Ta folla anonima prende volto
diventa-popolo,Popalo- di Dio. Ges sottolinea questa
iniziativa, in cui essenzialmente consiste la grazia divina,
quando dice nelPultima cena ai suoi discepoli: «Nom siete
voi che avete eletto me, ma io che bo eletto voin (Gv
15,16).
Si tratta di una chiamata personale, perché ciascuno
& chiamato per nome. Lo sguardo del Signore si & posato
su ciascuno in particolare come se fosse unico: «Assai
ptima della nostra nascita, il Signore ci ha incontrati da
qualche parte, a Betlemme, a Nazareth, sulle strade della
Galilea, che ne so? Un giorno tra i giorni i suoi occhi si
sono fissati su noi e secondo il luogo e V'ora, la congiun-
tura, Ja nostra voeazione ha preso il suo carattere partico-
ares (Bernanos). Un po’ come accadde al giovane ricco.
note di teologia pastorle |x 175
Gest, fissando il suo sguardo sopra di lui, lo amd e gli
disse: «Vieni e seguimin (Mc 10,21).
Chiamati perché amati. Amati da Dio, chiamati santi
(Rm 1,7), Santi, dunque, perché chiamati, chiamati per-
ché amati, anzi'trasportati nel regno del Figlio del suo
amore (Col 1,13), € predestinati ad essere conform all’im-
magine del Figlio, affinché egli sia primogenito fra molti
fratelli (Rm 8,29). Nel Figlio siamo stati eletti prima an-
cora della fondazione del mondo, afinché fossimo santi
dinanzi a lui nell'amore (Ef 1,4). Siamo, infatti, opera di
Dio, essendo stati creati in Cristo Ges, per compiere le
opere buone, che Dio ha predisposte, affinché noi le pra-
ticassimo (Ef 2,x0). Si, dobbiamo anzitutto riconoscere
Viniziativa di Dio, il dono di Dio, che Dio 2 stato il pri-
mo ad amarci e quindi il primo a sceglierci; ma & altret-
tanto vero che noi siamo stati innestati in Cristo pet pro-
durre frutti abbondanti, e che lo scopo per cui siamo stati
creati & Pamore e Dio: non vuole altro che amore.
‘Siamo stati chiamati e dobbiamo dare la nostra rispo-
sta, siamo stati chiamati ad amare perché Dio che ci ha
chiamati 2 amore: si, siamo stati eletti affinché fossimo
santi nell’amore; ¢ non santi ai nostri occhi, ma santi agli
occhi di Dio, ciot secondo le esigenze del suo amore infi-
nito. L’amore & lo scopo dell’universo, e sull’amore sare-
mo giudicati. Siamo santi nella misura in cui, credendo
alamore che Dio ha per noi, ci amiamo a vicenda come
Dio ci ama. La santitd, dunque, consiste nell’amore, per-
ché Dio 2 amore. La santita @ una vocazione d'amore, ¢
quindi una risposta d’amore.
Ma per dare un’autentica risposta di amore, per sa-
pere come dobbiamo amare, bisogna anzitutto sapere co-
me siamo stati amati. Considerate quanto amore ci ba
portato il Padre. Noi siamo chiamati figli di Dio e lo
siamo realmente, Ecco come & € manifestato amore di
Dio verso di noi: ci ha comunicato la sua stessa vita; ci
ha fatti figli nel Figlio del suo amore. Noi siamo figli di
Dio, non per modo di dire, ma realmente. Si, ora siamo
176 Oguissantt
figli — afferma Giovanni —, ma non 2 stato ancora rive-
lato cid che saremo. Siamo realmente figli, ma non lo sia-
mo ancora pienamente. Dobbiamo diventare quello che
Cio, dobbiamo camminare, dobbiamo crescere.
Lesistenza in Cristo, la santita, caratterizzata da questa
tensione fra il «gia» e il «non ancora». Tensione che na-
sce dalla coscienza che noi siamo gid realmente figli di
Dio, ma_in cammino, in_crescita, ¢ insieme dall’espe-
rienza della nostra povetti che alimenta Ja speranza € ac-
cetta la pazienza dell'attesa.
In altti termini, come dice s. Paolo, noi siamo salvi
nella speranza. Una speranza che si riferisce al futuro, ma
ad un futuro che & git presente, ed &, secondo un’altra
espressione densa ¢ forte di Paolo, Cristo in noi speranza
della gloria (Col 1,27). Quando siamo stati battezzati in
Cristo, Dio ha preso possesso di noi segnandoci col suo
sigillo, Questo sigillo impresso in noi, & lo Spirito santo,
che lo Spitito della promessa, perché & caparra della no-
stra eredita per la redenzione’piena (Ef 1,13); ed & al-
tresi lo Spirito del Figlio, perché ha il compito di perfe-
vionare e portare a compimento la nostra vita di figli di
Dio.
Dello Spirito santo non abbiamo ancora ricevuto la
pienezza, ma soltanto le «primiziey. Le primizie, per®,
annunciano ¢ in qualche modo gid contengono la pienezza,
C’ un’infinita sproporzione fra noi e Dio; percid lo Spi-
tito di Dio viene in aiuto della nostra debolezza: unen-
dosi al nostro spitito, ci attesta che noi siamo figli di Dio;
ci libera dalla paura e intercede per noi con gemiti inef-
fabili, Sensibilizaati in tal modo dallo Spirito, anche noi,
che abbiamo ticevuto le primizie dello Spirito, anche noi
sospitiamo in noi stessi, aspettando l'adozione, la reden-
ione del nostro corpo, che & la sintesi dell'universo. Noi
sappiamo — dice , Paolo — che, fino ad ora, tutta quan-
ta la creazione sospira insieme con noi ¢ soffre le doglie
del parto (Rm 8,16-27). Deve venire alla luce I'uomo
nuovo nell’universo rinnovato.
note di eologia pastorale | x 177
E in questo contesto cosmico che si colloca il nostro
destino glorioso. Siamo salvi nella speranza, legati insie-
me con un vincolo di solidarieta che si estende a tutto
i genere umano, anzi all’intera creazione. La nostra voca-
zione alla santiti, 0 si realizza in questo contest, 0 non
si realizza. Nel senso pitt vero, primizia & Cristo, che con
a sua risurrezione dai morti ha inaugurato la creazione
nuova: in lui, dice sant’Ambrogio, & risotto il cielo, & ri
sorta la terra, & risorto il mondo; ci saranno infatti nuovi
cieli e nuova terra. Dunque, prima Cristo, poi quelli che
sono di Cristo (I Cor 15,23). Dio vi ha eletti — diceva
s. Paolo ai primi cristiani — quale primizia, per essere
salvi (II Ts 2,13), Egli ci ba generato per mezzo di una
parola di veritd — diceva a sua volta s. Giacomo —
affinché noi siamo come le primizie delle sue creature
(Ge 1,18).
I primi cristiani avevano una profonda coscienza
questa loro digniti © responsabilita di fronte a tutti gli
altri uomini, Gia nell’A. T. Videa di «primizian aveva un
chiaro significato liturgico. Nelle primizie offerte a Dio
eta incluso e santificato Vintero raccolto. Cosi nei cristia-
ni, abitualmente chiamati «santi» nel N.T., in qualche
modo & gia santificato e offerto a Dio Vintero genere uma-
no, anzi lintera creazione. E per questo che l’intera crea-
zione partecipa al travaglio dell'uomo e in qualche modo
alla sua speranza, E tutta la sofferenza umana deve essere
accolta nel cuore dei cristiani, per essere tramutata in spe-
ranza, in quella speranza che non delude perché l'amore
di Dio ¢ stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spi-
rito santo che ci @ stato dato (Rm 5,5).
In una lettera scritta nel 1966 a Nadia Neri, don Mi-
ani dice: «Quando avrai perso la testa, come Iho persa
io, dietro poche decine di creature, troverai Dio come
premio. E una promessa del Signore contenuta nella para-
bola delle pecorelle, nella metaviglia di coloro che sco-
prono se stessi dopo morti, amici e benefattori del Signo-
te senza averlo nemmeno conosciuto: Quello che avete
fatto a questi piccoli...». Dio non @ una conquista dei pitt
178 Ognissantt
forti, ma il premio riservato a quelli che lo amano. E sic-
come nessuno ha mai veduto Dio, uno non pud dire di
amare Dio che non vede se non ama il prossimo che vede.
E Pappuntamento di ogni giorno, nelle cose di tutti i
giomni, Si cammina nella fede e non nella visione, nella
oscutita ¢ non nella luce. Un giorno perd il velo cadza e
Dio si fara vedere. Ci accorgeremo allora che Dio era nel
nostro amore. Quello che facciamo al pit piccolo dei suoi
fratelli lo facciamo a lui. Vuol dire che noi possiamo dare
a Dio qualcosa che non abbia? Vuol dire che egli facen-
dosi uomo & diventato uno di noi perché noi, amandoci
com'egli ci ha amato, avessimo lui come premio e lui
fosse tutto in tutti.
Sappiamo che quando egli sard manifestato — dice
Giovanni — saremo simili a lui, perché lo vedremo cost
come egli 2. Essere come Dio, 2 stata la tentazione che
ci ha perduti, perché abbiamo preteso d’essere come Dio,
senza Dio, al posto di Dio. Saremo come Dio per sua
grazia, © quindi a lode della sua gloria (Ef 1,12). Perché
Dio ci ha cletti affinché fossimo santi dinanzi a lui nel-
Vamore. E la via che ci ha aperto nel Figlio nel quale ci
amd sino alla fine. Pitt ameremo e pitt saremo come Dio,
¢, in qualche modo, saremo Dio.
A questo & chiamato P'uomo. Questa & la grazia, €
questa & la gloria che Puniverso attende. Cosi si realizza
il disegno di Dio, il quale ci elesse nel Figlio suo affinché
questi fosse il primogenito fra molti fratelli, e la primi-
zia in cui Pintero raccolto & gid santificato e in qualche
modo anticipato. Cosi si compie Ia volont che il Figlio
ha espresso nel momento in cui passava da questo mondo
al Padre, ¢ quindi nel suo testamento: «Padre, io voglio
che quelli che tu mi bai dato siano con me dove sono iow
(Gv 17,24). Lo hanno ascoltato e Jo hanno seguito; so-
no stati con Iui nella prova ¢ nella morte; hanno reso te-
stimonianza della sua risurrezione ed ora sono con lui
nella gloria, Il Padre & glorificato nel Figlio, ¢ il Figlio &
lorificato nei suoi frateli.
| note di teologia’ pastorale / 2
ciclo
| DAVID TUROLDO
unico
| Festa degli anonimi
-«
You might also like
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5808)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Storia Della Chiesa Negruzzo 1800-1965Document20 pagesStoria Della Chiesa Negruzzo 1800-1965Bindaroi AlexandruNo ratings yet
- Giordano Stella - Daniele ComboniDocument234 pagesGiordano Stella - Daniele ComboniBindaroi AlexandruNo ratings yet
- Edward Schillebeeckx - Il MatrimonioDocument362 pagesEdward Schillebeeckx - Il MatrimonioBindaroi AlexandruNo ratings yet
- Breve Esposizione Del Cristianesimo, Sandro Maggiolini PDFDocument125 pagesBreve Esposizione Del Cristianesimo, Sandro Maggiolini PDFBindaroi AlexandruNo ratings yet