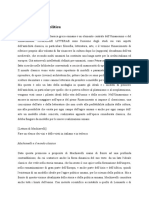Professional Documents
Culture Documents
Lemieprigioni PDF
Lemieprigioni PDF
Uploaded by
Angelo Pagliardini0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views16 pagesOriginal Title
LEMIEPRIGIONI.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views16 pagesLemieprigioni PDF
Lemieprigioni PDF
Uploaded by
Angelo PagliardiniCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
LE MIE PRIGIONI
Memorie di Silvio Pellico
da Saluzzo
acura di Aldo A. Mola
introduzione di Giovanni Rabbia
manoscritto fotografato da Giancarlo Durante
SECONDA EDIZIONE
Opera premiata con Targa d’Argento
dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi
Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo
Us InsBRUCK.
+C208767301
Bastogi
Editrice Italiana
cando di cancellare “ad un tempo”, omise il seguito: “ed
il timore che tenea tante turbe rispettose verso i nostri
conduttori. La molteplicita degli armati, distribuita al-
lora per tutti que’ paesi, produceva quella tranquillita”
Codesta osservazione suonava critica nei confronti del-
la repressione usata dalla machina poliziesca asburgi-
a anche nei riguardi dei principi evangelici e sarebbe
risultata insopportabile a Vienna, ma stonava anche in
quegli esordi di regno albertino, allinsegna dell'ordine
militaresco, della spietata repressione di qualsiasi dis-
senso interno e della persecuzione sistematica (sino al-
Tinvenzione di supposte responsabilita) dogni forma di
settarismo, massime se di spirit repubblicani, sobllati
dallinviso "Masini", come i sovrano denominava nei suai
appunti il ventiseienne repubblicano Giuseppe Mazzini
(Genova 18085 - Pisa, 1872), gid ascritto alla Carbone-
ria, massone per ¢aso ed esule in Francia.
Fa da antifona a questo pasto la conclusione del ca-
pitolo 71 ove Pellico, con vena di commediografo, ricor-
dale sentinelle che consentivanoi dialoghi tra lui e Oro-
boni, le mani strette alle inferriate delle rispettive cel-
le: "Signori patroni, adesso potere, ma piano pitt che star
possibile.” Perché e quando, con tratto leggerissimo, can-
celld il passo seguente? Travisato da Bellorini, poi rieal-
cato da Curto, esso suonava: “Vene furono, che per com-
patirei protestavano d’amare gli Italiani, dimenticava-
xo ogni riguardo, e diceano tutto cid che il malcontento
ud dire di pia bilioso contro i potenti.” Con poche ica-
stiche parole, Pellico espresse la profonda avversione
‘verso ogni forma di tirannia che da decenni ribolliva in
Europa: contro il dispotismo napoleonico prima, poi con-
tro gli spocchiosi sovrani che dall'esilio erano tornati
senzavere nulla dimenticato e nulla appreso. Quanto si
conciliava quello sdegno con la mansuetudine cui decise
dattenersi ancor prima della liberazione dallo Spielberg?
Bene si comprende, dunque, chéegli abbia rinunciato a
dar voce, nelle Memorie, a un'indignazione sempre meno
contenibile, come andavano mostrando insurrezioni ©
moti che nessun patibolo era pittin grado di frenare e di
spegnere (fu il caso di quello voluto da Francesco IV di
Modena per Ciro Menotti).
Tl saluzzese era perd alieno dal dare scandali, Percid
non sollevd aleuna protesta nei confronti delle manipo-
lazioni del suo testo: molto di pit glimportava che il suo
libro fosse accolto come testimonianza sincera anche fra
i non eredenti. Proprio pereid ron cancelld dal mano-
seritto il lungo passo conclusivo del eapitolo 54, che nel
1832 Bocea, poi seguito dai suoi emuli, non dette alle
stampe. Quando da una lettera del padre capi che 'in-
quirente Salvotti non aveva affatto spedito la missiva
con la quale egli gli comunicava la condanna alla pena
capitale e la sua commutazione in quindiei anni di car-
cere duro, Silvio montd in furore contro quel “raffina-
mento di barbarie”, sicché avretbe voluto “poter versa-
re un mare di sangue, per punire questa sognata inu-
manita", Non sapeva che tante del
‘io cuore; ed allamor filiale debbo questo beneizio.
(Anteriormente) Per Yaddietro, senza essere avverso alla
religione, io poco e male la seguiva. Le volgari obbiezioni con
ccui suole essere combattuta non mi parevano un gran che e
‘tuttavia mille sofistici dubbi infevolivano la mia fede. Gid da
ungo tempo (?) questi dubbi non cadevano pitt sull'esistenza
i Dio, e mandava ridicendo che se Dio esiste, una conse-
‘guenza necessaria della sua giustizia ¢ un’altra vita per Tuo-
‘mo, che (visse) patl in un mondo oosi ingiusto: quindi la som-
‘ma ragionevolezza (?) di aspirare ai beni di quella seconda
vita: quindi un culto d'amore di Dio e del prossimo, un perpe-
tuo aspirare a nobilitarsi con generosi sacrifizi. Gia da lungo
tempo m’ andava ridicendo tutto cid, e soggiungeva: - E che
altro @ il Cristianesimo se non questo perpetuo aspirare a
nobilitarsi? - E (mi) meravigliava come s1 pura, si filosofica,
‘1 inattaceabile (epparendo) menifestandosi Yessenza del
CCristianesimo, fosee venuta (un fampo che ) un‘epoca in cui la
filosofia osasse dire: - Fard io d’or innanzi le sue veci - Ed in
‘qualmodo farai tu le sue veci. Insegnando il vizio? No certo.
TInsegnando la virti ? Ebene sara amore di Dio e del prossi-
‘mo; sara cid che appunto il Cristiamesimo insegna,
"Ad onta, ch’io cos) da parecchi anni sentissi, sfuggiva di
‘conchiudere: Sii dunque consegtentel sii Cristiano! non ti
seandalezzar pit degli abusi (della Chiesa)! non malignar pitt
‘su qualche punto difficile della (sua) dottrina della Chiesa,
‘iacché il punto principale @ questo, ed 2 lucidissimo: Ama
Dio ed il prossimo.(?)
In prigione (2) deliberai finalnente di (?) stringere tale
‘conelusione, ela (?)strinsi. Usitai alquanto, pensando che se
taluno (mi) veniva a sapermi pit religioso di prima, si crede-
rebbe in dovere di reputarmi (bigctto) bacchettone ed avvilito
dalla disgrazia. Ma sentendo ch'io non era né (bigotto) bac-
chettone, né avvilito, mi compiaequi di non punto curare i
possibili biasimi non meritati e formai dessere e di dichia-
rarmi d'or in avanti Cristiano.
cAPO4
(Presi stabilmente) Rimasi statile in questa risoluzione pit
tardi, ma cominciai a ruminarla ¢ quasi volerla in quella pri-
rma notte di cattura. Varzo il mettino le mie smanie erano
a2
ccalmate, ed io ne stupiva, Ripensava a’ genitori ed agli altri
amati, ¢ non disperava pid della loro forza d’animo, e 1a me-
rioria de’ (Joro..?)virtwosi sentimenti, cio aveva altre volte
‘conasciuti in essi, mi consolava.
Perché dianzi (tanta) cotanta *desolazione* in me, imma-
‘ginando la loro, ed or (fanta) cotanta fiducia nelMaltezza del
Toro coraggio? Era questa felice cangiamento un prodigio? era
‘un naturale effetto della mia ravvivata credenza in Dio? - E
che importa il chiamar prodigi,o no, i reali sublimi benefizii
della religione?
‘A mezzanotte, due secondini (cosi chiamansi i carverieri
dipendenti dal custode) erano venuti a visitarmi, e m'aveano
trovato di pessimo umore. Allalba tornarono, e mi trovarono
sereno e cordialmente scherzoso.
“'Stanotte, signore, ella aveva una faccia da basilisco, dis-
se il Tirola; ora é tuttaltro, e ne godo. Sogno che non & - per-
‘doni espressione - un birbante: perché i birbanti, io sono vee-
chio del mestiere e le mie osservazioni hanno qualche peso, i
birbanti sono pit! arrabbiati il secondo giorno del loro arresto,
che il primo, Prende tabaceo?
= Non ne soglio prendere, ma non (voglio) vo" ricusare le
‘vostre grazie. Quanto alla vastra osservazione, scusatemi, non.
@ da quel sapiente che sembrate, Se stamane non ho pitt fac-
cia da basilisco, non potrebb'egli essere che (fosse) il muta-
mento fosse prova d'insensatezza, di faclita ad illudermi, a
sognar prossima la mia liberta ?
Ne dubiterei, signore, sella fosse in prigione per altri
motivi; ma per queste cose di stato, al giorno Zoggi, non &
possibile di eredere che finiscano cosi su due piodi. Ed ella
non @ (tanto) siffattamente gonzo da immaginarselo. Perdoni
sa: vuole un‘altra presa?
= Date qua, Ma come si pud avere una faccia casi allegra,
come avete, vivendo sempre fra disgraziati?
“= Credera che sia per indifferenza sui dolori (2) altruisnon
lo so nemmeno positivamente io, a dir vero; ma lassicuro che
‘spesse volte il veder piangere mi fa male. E talora fingo d'es-
sere allegro, affinché i poveri prigionieri sorridano anch’essi
= Mi viene, buon vomo, un pensiero che non ho mai avuto:
‘che si possa fare il carceriere ed essere (galantuomo) dottima
pasta.
- ILmestiere non fa niente, signore. Al dil di quel voltone
ch'ella vede, oltre il cortile, vi un altro cortile ed altre earce-
1i, tutte per donne, Sono... non occorre dirlo.. donne di mala
vita, Ebene, signore, ve n’é che sono angeli, quanto al cuore.
E sella fosse secondino.
+10? -(e scoppiai dal ridere)
‘Tirola resto sconcertato dal mio riso, enon prosegui. Forse
(2) intendea, che so fossi stato secondino, (?) mi sarebbe riu-
scito malagevole non affezionarmi ad alcuna di quelle disgra-
iate,
‘Mi chiese ci ehvio volessi (da) per eolezione. Usei, e qual-
che minuto dopo, mi portd il caffe.
To lo guardava in faccia fissamente, con un sorsiso mali-
zioso, che voleva dire: ?) ‘Porteresti tu un mio viglietto ad un
altro infelice, al mio amico Piero?" Ed egli mi rispose con un
altro sorriso, che voleva dire: "No, signore, e se vi dirigete ad
alcuno de’ miei compagni, il quale vi dica di si, badate che vi
tradira,
‘Non sono veramente (ben) certo, chegli mi capisse né ch'io
capissi lui, So bons, chiio fui deci volte sul punto di diman-
dargli un pezzo di carta ed una matita, e non ardii, perché
vera aleun che negli ocehi suoi, che sembrava avvertirmi di
non fidarmi di aleuno, e meno d'altri che di lui.
CAPO
Se Tirola, colla sua espressione di bonta, non avesse an-
che avuto quegli sguardi cos| furbi, se fosse stata una fisiono-
mia pit nobile, io avrei ceduto alla tentazione di farlo mio
ambasciatore, ¢ forse un mio viglietto giunto a tempo all'ami-
co gli avrebbe dato la forza di riparare qualche sbaglio, - e
forse cid salvava, (2) non lui, poveretto, che gid troppo era
seaperta, ma parsechi altri e mel
‘con 2ssa un malvagio edi ritrarlo dall'iniquita,
Forse si danno smanie di natura diversa da quelle chio
‘eoncsco, (2) e meno condannevoli, Ma quella che m’avea fin
‘llora fatto suo schiavo, non era una smania di pura afflizio-
ne: vi si mescolava sempre molto odio, molto prurito di male-
dle, di dipingermi la societa, o questi o quegl'individui, co
‘color pitt eseerabili, Malattia epidemica nel mondo! Liuomo
‘sireouta migliore, ahborrendo gli altri. Pare che tutti gli amici
‘sidisano allarecchio: “Amiamoci solamente fra noi; gridando
‘ehe tutti sono (canagtia) ciurmaglia, sembrera che siamo se-
mide."
‘Curioso fatto, che il vivere arrabbiato piaecia tanto! Visi
pone una specie deroismo. Se loggetto contro cui jeri si fre-
‘meva ® morto, se ne cerca subito un altro. - Di chi mi lamen-
terdogsi? chi odier®? Sarebbe mai quello il mostro?... Oh giojat
Thotrovato, Venite, amici, laceriamolol-
Cosi va il mondo: e senza lacerarlo, posso ben dire che va
male.
CAPO 18
Non vera molta malignita nel lamentarmi delPorridezza
ella stanza, (che m‘aveano dato) ove m'aveano posto. Per
buona ventura, restd vota una migliore, ¢ mi si fece Tamabile
sorgresa di darmela,
Non avrei io dovuto esser contentissimo a tale annuncio?
Eppare - Tant’; non ho potuto pensare a Maddalena, senza
rinerescimento, Che fanciullaggine! affezionarsi sempre a
qualche cosa, anche (2) con motivi, per verita, non molto fortil
Useondo di quella eameraccia voliai indietro lo sguardo, ver-
sola parete alla quale io mera si sovente appoggiato, mentre,
forse un palmo pit in 1a, vi s'appoggiava dal lato opposto la
rmisara peceatrice. Avrei voluto sentire ancora una volta que’
ue patetici versi:
Chi rende alla meschina
La sua felicita?
‘Yano desiderio! Keco una separazione di pid nella mia scia-
‘gurata vita. Non voglio parlarne lungamente, per non far ri-
dere di me, ma sarei un ipocrita se non confessassi che ne fui
esto per pit giorni,
Nell'andarmene, salutai due de’ poveri ladri, miei vicini,
ch'erano alla finestra. Il caporione non vera, ma avvertito
dai sompagni, vaccorse, e mi risalutd anch'egli. Si mise quin-
ai acanterellare Paria: “Chi rende alla meschina. Voleva egli
bur.arsi di me? - Scommetto che ee facessi questa dimanda a
cinquanta persone, quarantanove risponderebbero: “S.” Eb-
bens, ad onta di tanta pluralita di voti,inclino a eredere che il
‘buon ladro intendea (?) di farmi una gentilezza. Io a ricevet-
ti, come tale, e gliene fui grato, e gli diedi ancora un‘occhiata;
ed egli sporgendo il braccio fuori de’ ferri col berretto in mano,
faceami.ancor cenno, (2) allorch'o voltava per discendere la
scala
Quando fui nel cortile, ebbi una consolazione. Vera il mu-
tolino sotta il portico. Mi vide, mi riconobbe, e volea corrermi
inecntro. La moglie del custode, chi sa perché? Vafferr pel
collare e Io eaccid in casa. Mi spiacque di non poterlo abbrac-
ciare, mai saltetti ch’ fece per correre a me, mi commossero
deliziosamente. E cosa si dolce Vessere amato!
Bra giomnata di grandi avventure, Due passi pitin la, mossi
vicino alla finestra della stanza gid mia, e nella quale ora
stava Gioja. - “Buon giorno, Melehiorre!” gli dissi passando.
‘Alzd il eapo, e balzando verso me, grida: “Buon giorno, Si
‘Ahi! non mi fu dato di fermarmi un istante, Voltai sotto il
portone, sali una scaletta, e venni posto in una cameruecia
pulita, al di sopra di quella di Giojs.
Fatto portare il letto, ¢lasciato solo dai secondini, mio pri-
‘mo affare, fu di visitare i muri. Verano alcune memorie serit-
te, quali con matita, quali con carbone, quali con punta inci
va, Trovai graziose due strofe francesi, che or m'incresce di
non avere imparate a memoria. Erano firmate le due de Nor-
218
mandie. Presi a cantarle, adattandovi alla meglio Varia della
‘mia povera Maddalena, ma ecco una voce vicinissima che le
ricanta con altr'aria. Com/ebbe finito, gli gridai “Bravo!” Ed
gli mi saluta gentilmente, chiedendomi sio era Francese.
= No; sone Italiano, e mi chiamo Silvio Pellico.
* Lautore della Francesca da Rimini?
+ Appunto.
E qui un gentile complimento, e le naturali condoglienze,
sentendo ch'o fossi in earcere.
‘Mi dimandd di qual parte d'Italia fossi nativo.
= Di Piemonte, dissi; sono Saluzzese.
E qui nuovo gentile complimento sul carattere e sull'inge-
‘gno de’ Piemontesi, e particolare menzione de’ valentuomini
Saluzzesi, ein ispecie di Bodoni.
‘Quelle poche lodi erane fine, come si fanno da persona di
‘buona educazione.
- Or mi sia lecito, gli diss, di chiedere a voi, signore, chi
siete.
~Avete cantata una mia canzoncina.
= Quelle due belle strofette che stanno sul muro, sono vo-
stre?
Si, signore.
-Voi siete dunque.
+ Linfelice duea di Normandia.
CAPO 19
T1Custode passava sotto le nostre finestre, ci fee tacere.
Quale infelice duea di Normandia? andava io ruminando.
Non & questo il titolo che davasi al figlio di Luigi XVI? Ma
«quel povero fanciullo®indubitatamente morto.-Ebbene.(que-
sto) il mio vieino sara uno de’ disgraziati che si sono provati a
farlorvivere.*E sefosse realmente col chi dice? ~ Quan
te cose pajono e non sono! Se uno che non conosco, mi dice “Io
sono tale” ¢ chio non abbia prove per dimostrare il contra-
Flo, con qual ditto affermerei chegh ® un impostore?®
‘Chuttaviay Gia parecchi si spacciarono per Luigi XVI, e
furono riconosciut impostor: qual maggior credenza (potreb
+b) dovrebhe questi ottenere?
Sebibene io cercassi di stare in dubbio, un invinebile in
eredulita prevaleva in me, ed ognor continud a prevalere.
Nondimeno determinai di non mortfieare 'infelice, qualun-
‘que frttola fosse per raccontarmi.
Pochi istanti dappo, rcomincid a cantare: ind rpigliam-
ro la conversezione
‘Alla mia dimanda sullesser suo, rispose, ch'egli era ap-
punto Luigi XVI, esi diede a declamare con forza contro Luigi
XVII suo zo, usurpatore de’ suoi diritti
~ Ma questi diritti, come (?)non Ii faceste valere al tempo
delle Ristorazione?
=o mi trovava allora mortalmente ammalato a Bologna.
‘Appena risanato volai a Parigi, mi presentai alle Alte Poten-
20, ma quel ch’era fatto era fatto: Finiquo mio 2io non volle
iconoscermi; mia sorella s'uni a lui per opprimermi. Il solo
‘buon principe di Condé m'accolse a braccia aperte, ma la sua
amiciia nulla poteva. Una sera, per le vie di Pargi, fui assa
lito da sicari, armati di pugmali,ed a stento mi sottrasst a’
loro colpi. Dopo aver vagato qualehe tempo in Normandia,
tomai in Italia, emi fermai a Modena. Dil, serivendo inces-
santemente ai Monarchi d'Buropa, e particolarmenteallim-
peratore Alessandro, che (almeno) mi rispondea colla massi-
rma gentilezza, io non disperava dottenerefinalmente giusti-
se, per politica, voleano sacificare i miei diritti al trono
4 Francia, che almeno mi slassegnasse un decente appan-
naggio. Venni arrestato, condotto ai confini del ducato di Mo-
‘ens, ¢ consegnata al governo austraco, Or, da otto mesi, sono
‘qui sepolto, e, Dio sa, quando uscd!
Non (gli) prestai fede (2) a tutte le sue parole. Ma ch’ei
foe l sopolto era una vert, emspird una viva compassio-
‘Lo pregai di accontarmi in compendio a sua vita. Mi dis
se con minutezza tutti particolari cho gia sapeva intorno
Luigi XVII, quando lo misero collo scellerato Simon, calzo-
Iajo, quando lo (fecero) indussero ad attestare un'infame ca-
unnia contro costumi della povera regina sua madre, ec. e.
E finalmente che essendo in (prigione) carcere, venne gente
una notte a prenderlo; un fanciullo stupido per nome Mathu-
rin fu posto in sua veco, ed ei fu trafugato, Vera nella strada
luna carrozza a quattro cavalli, ed uno de’ eavalli era una
‘machina di legno, nella quale ei fu celato. Andarono felice-
mente al Reno, e passati i confini, il generale... (mi disse il
home, ma non me lo ricordo) che T'avea liberato, gli fece per
qualche tempo da edueatore, da padre, (2) Lo mandd 0 con-
dusse quindi in America. Lail giovane re senza regno, (eoffer
se) ebbe molte peripezie, pat la fame ne’ deserti,milita, visse
‘onorato e felice alla corte del re del Brasile, fu calunniato,
ersoguitato, costretto a fuggire. Tornd in Europa in sul fini
re dellimpero napoleonico, fu tenuto prigione a Napoli da
Giovacchino Murat, e quando si rivide libero ed in procinto di
riclamare il trono di Francia, lo colpl a Bologna quella fune-
sta malattia, durante la quale Luigi XVIII fu incoronato.
CAPO 20
Ei raccontava questa storia con una sorprendente aria di
verita. Io non potendo crederlo, pur Vammirava. Tutti i fatti
della rivoluzione francese gli erano notissimi; ne parlava con
molto spontanea eloquenza, ¢riferiva ad ogni proposito aned-
doti curiosissimi. Vera aleun che di soldatesco nel suo dire,
‘ma senza mancare di quella eleganza ch’e data dalPuso della
fina societa,
- Mi permetterete, gli dissi,ch'o vi tratti alla buona, ch'io
non vi dia titel
- Questo ¢ cid che desidero, rispose. Dalla sventura, ho al-
meno tratto questo guadagno, che so sorridere di tutte le va-
nita, Wassicuro, che mi pregio pitt @esser uomo che d'esser
‘Mattina e sera, conversavamo lungamente insieme; e, ad
conta di cid ch’ riputava esser commedia in lui, anima sua
‘mi parea buona, candida, desiderosa dogni bene morale. Pitt
volte fui per dirgli: Perdonate, io vorrei credere che foste Lui
gi XVIT, ma sinceramente vi confesso che la persuasione con-
traria (prevale) domina in me. Abbiate tanta franchezza da
Finunciare a questa finzione. - E ruminava tra me una bella
predicuccia da fargli sulla vanita d’ogni bugia, anche delle
Dbugie che sembrano innocue.
Di giorno in giorno differiva; sempre aspettava che Vinti-
‘ita nostra crescesse ancora di qualche grado, e mai non ebbi
ardire deseguire il mio intento.
Quando rifletto a questa mancanza d'ardire, talvolta la
scuso come urbanita necessaria, onesto timore d’affiggere, e
che so io. Ma queste scuse non m’accontentano, e non posso
dissimulare, che sarei pitt soddisfatto di me, se non mi fossi
‘tenuta nel gozzo lideata predicuocia, Fingere di prestar fede
ad unfimpostura, & pusillanimita: parmi che nol farei pit,
Si, pusillanimital Certo, che per quanto s'involva in del
cati preamboli, & aspra cosa il dire ad uno: “Non vi eredo,” Ei
si sdegnera, perderemo il piacere della sua amicizia, ci cole
mera forse dingiurie, Ma ogni perdita é pid onorevole del
‘entire. E forse il disgraziato che ci colmerebbe d'ingiurie,
vvedendo che una sua impostura non é creduta, ammirerebbe
oscia in secreto la nostra sincerita, e gli sarebbe motivo di
riflessioni che il ritrarrebbero a miglior via
I secondini inclinavano a credere ch'ei foase veramente
Luigi XVII, ed avendo gia veduto tante mutazioni di fortune,
non disperavano che costui non fosse per ascendere un giorno
al trono di Francia, esi ricordasse della loro devotissima ser-
vita. Tranne il favorire la sua fuga, gli usavano tutti i(2) ri-
guardi ch’ei desiderava,
Fui debitore a eid, delonore di vedere il gran personaggio.
Bra di statura mediocre, dai 40 ai 45. anni, alquanto pingue,
difisionomia propriamente Dorbonica. Bgl verusimile, che
‘un'accidentale somiglianza coi Borboni V'abbia indotto a rap-
presentare quella trista parte,
|
219
capoat
Diunaltro indegno rispetto umano bisogna chiio m'aceusi,
Il mio vicino non era atzo, ed anzi parlava talvolta de’ senti-
‘menti religiosi, come uomo che li apprezza e non vé atranic-
+o; ma serbava tuttavia molte prevenzioni irragionevoli con-
tro il Cristianesimo, (ch'ei non’ il quale ei guardava meno
nella sua vera essenza, che ne’ suoi abusi. La superficiale flo-
sofia (2) che in Francia precedettoe segui la riveluzione, Taveva
abbagliato. Gli pareva che si potesse adorar Die con maggior
ppurezza, che secondo la religione del Vangelo. Senza aver gran
cognizione di Condillac e di Traey, li venerava come sommi
pensatori, e simmaginava che quest/ultime avesse dato il com-
pimento a tutte le possibili indagini metafisiche.
Ioche aveva spinto pit oltre imiei studi filosofici, che s
tiva la debolezza della dottrina sperimentale, che conosceva i
grossolani errori di critica con eut il secolo di Voltaire aveva
(©) preso a voler diffamare il Cristianesimo; io che avea letto
Guéng ed altri valenti smascheratori di quella falsa critica; io
ch’era persuaso non potersi con rigore di logica ammetiere
Dio e ricusare il Vangelo; io che trovava tanto volgar cosa il
sequire la corrente delle opinioni antieristiane, e non sapersi
elevare a conoscere quanta il eattalicismo, non vedto in ca-
ricatura, sia semplice e sublime; io ebbi la vilta di eacrificare
al rispetto umano. Le facezie del mio vicino mi confondevano,
ssebbene non potesse sfuggirmi laloro leggerezza. Dissimulai
la mia credenza, esitai, riflettei se fosse, 0 no, tempestivo il
contraddire, mi dissi ch’era inutile, e (2) volli persuadermi
essere giustificato,
‘Vila! vilta! Che importa il baldanzoso vigore opinion
‘eccreditate, ma senza fondamento? E vero che uno zelo in-
tempestivo & indiserezione, © pud maggiormente irritare chi
non crede, Ma il eonfessare con franchezza, e modestia ad un
tempo, cid che fermamente si tiene per importante verita, il
confessarlo anche laddove non & presumibile d'essere appro-
vato, né d'evitare un poco di scherno, (2) egli& preciso dovere,
E siffatta nobile confessione pud sempre adempirsi, senza (aver,
{intenzione) prendere inopportunamente i carattere i mi
sionario,
Egliédovere, di confessare un‘:mportante verita,(?) in ogni
‘tempo, perocché se non @ sperabile che venga subito ricono-
sciuta, pud pure dare tal preparamento all'anima altrui, il
quale produca un giorno maggiore imparzialita di giudisi ed
il conseguente trionfo della luce.
CAPO 22
‘Stetti in quella stanza un mese e qualche di. La notte dai
18 ai 19. di febbrajo (1821) sono svegliato da romore di cate-
nacei e di chiavi; vedo entrare parecehi uomini con lanterna:
la prima idea che mi si presentd fu che venissero a scannar-
‘mi, Ma mentre io guardava perplesso quelle figure, ecco avan-
zarsi gentilmente il conte B. il quale mi dice ch'io abbia la
‘compiacenza di vestirmi presto per partire.
Quest'anniunzio mi sorprese, ed ebbi la follia di sperare
che mi si eonducesse ai confini del Piemonte. Possibile che si
gran tempesta si dileguasse cos!” Io racquisterei ancora la
dolce liberta? Io rivedrei i miei carissimi genitor, i fratell, le
sorelle?-
Questi lusinghevoli pensieri miagitarono brevi istanti. Mi
vestii con gran celerita, ¢ seguil i miei accompagnatori, senza
pur poter salutare ancora il mio vieino. Mi pare d'avere udito
Ja sta voce, e mincrebbe di non potergli rispondere,
«Dove si va? dissi al conte, montando in earrozza con lui e
con un ufficiale di gendarmeria.
Non posso significarglilo, finché non siamo un miglio al
dil di Milano,
Vidi che la carrozza non andava verso porta Vervellina, €
Je mie speratice furono svanive!
‘Tacqui, Era una bellissima notte con lume di luna, To guar-
dava quelle care vie, nelle quali ;o aveva passeggiato tanti
‘anni, cos felice; quelle case, quelle chiege. Tutto mi rinnova-
va mille soavi rimembranze,
Nondimeno, allultima mia lettera sul Cristianesimo, ei
dicea che mi stava apparecchiando una lunga risposta. Aspet-
‘tai pit d'una settimana, ed intanto ei mi seriveva ogni giorno
di tuttaltro, e per lo pit d’oscenita.
‘Lo progai di ricordarsi la risposta di cai m'era debitore, e
sli raccomandai di voler applicare il suo ingegno a pesar ve-
ramente tutte le ragioni ch’o gli avea portate.
"Mi rispose alquanto rabbiosamente, prodigandosi gli at-
tributi di filasofo, d'uomo sicuro, d'uomo che non avea biso-
.gno di pesar tanto per eapire che le lucciote non erano lanter-
‘ne. E torn a parlare allegramente d'avventure scandalose.
CAPO 40
To pazientava per non farmi dare del bigotto e deltintolle-
rrante, eperché non disperava che, dopo quella febbre d'erot
che buffonerie, venisse un periodo di serieta. Intanto gli an-
dava manifestando la mia disapprovazione alla sua irrive-
renza per le donne, al suo profano modo di fare all’amore, e
‘compiangeva quelle infelici ch’ei mi diceva essere state sue
vittime.
i fingeva di creder poco alla mia disapprovazione, e ripe-
‘teva: Cheoché borbottiate dlimmoralita, sono certo di diver-
tirvi co’ miei racconti;- tutti gli uomini amanoil piacere come
(me) io, ma non hanno la franchezza di parlarne senza velo; -
ve ne dird tante che Vincanterd, e vi seatirete obbligato in
coscienza d’applaudirmi
‘Ma di settimana in aettimana, ei non desisteva mai da
‘queste infamie, ed io (sperando sempre ad ogni lettera di tro-
vvare altro tema, elasciandomi attrarre dalla curiosita) logge-
vva tutto, e Yanima mia restava, - non gid sedotta, - ma pur
conturbata, allontanata da’ pensieri nobili e santi, Il conver-
sare eogli Uomini degradati degrada, se non si ha una vrei
molto maggiare della comune, molto maggiore della mia.
- Eecoti punito, diceva io a me stesso, della tua presunzio-
ne! ecco eid che si guadagna a voler fare il missionario, senza
Ja santita da ci.
Un giorno mi risolsi a scrivergli queste parole
= Mi sono sforzato finora di chiamarv: ad altri soggetti, ©
voi mi mandate sempre novelle, che vi dissi schiettamente
digpiacermi, Se vaggrada che favelliamo di cose pitt degne
continueremo la corrispondenza, altrimenti tocchiamoci la
‘mano, e ciascuno se ne stia con se. -
Fui per due giorni senza risposta, e dapprima ne gioi. -
‘Oh benedetta solitudine! andava sclamando, quanto meno
amara tu sei d'una conversazione inarmonica e snobilitante!
nvece di crucciarmi leggendo impudenze,(?) invece di fati-
‘carmi invano ad oppor loro l'espressione d’aneliti che onorino
Vumanita, tomerd a conversare con Dio, colle care memorie
della mia famiglia e de’ miei veri amici. Torner® a leggere
(eempre) maggiormente la Bibbia, a serivere i miei pensieri
sulla tavola studiando il fondo del mio cuore, ¢ procacciando
di migliorarlo, a gustare le doleezze d’una melanconia inno-
‘cente, mille volte preferibili ad immagin:liete ed inique.
(2) Tutte le volte che Tremerello entrava nel mio carcere,
mi dioeva: - Non ho ancora risposta. - Va bene, rispondeva io,
I terzo giorno mi disse: - I sig. N.N. 2) mezzo ammala-
to.
-Che ha?
{Non la dice, ma a sempre staan sl lett, non mangia, non
‘bee, ed @ di mal’ umore.
‘Mi commossi, pensando ch’egli pativa e non aveva alcuno
che lo confortasse. Mi sfuggi dalle labbra,o piuttosto dal cuo-
re: - Gli seriverd due righe.
«Le porterd stassera, disse Tremerells;e se ne and.
Toera alquanto imbarazzato, mettendomi al tavolino. - Fo
jo bene a ripigliare il carteggio? Non benediceva io dianzi la
solitudine come un tesoro riacquistato? Che incostanza ® dun-
que la mia! - Eppure quellinfelice non mangia, non bee; sicu-
ramente & ammalato, B questo il momento @abbandonarlo?
Lultimo mio viglietto era aspro: avra contribuito ad afllig-
gerlo. Forse ad onta dei nostri diversi modi di sentire, ei non
favrebbe mai disciolta la nostra amicizie. Il mio viglietto gli
28
sara sombrato pitt malevolo che non era; ei 'avra preso per
un assoluto sprezzante congedo.
CAPO 41
Serissi cost
Sento che non istate bene, e me ne duole vivamente. Vor-
reid tutto cuore esservi vieino,e prestarvi tutti gli uffici d’ami-
co. Spero che la vostra poco buona salute sara stata l'unico
‘motivo del vostro silenzio, da tre giorni in qua. Non visareste
si offeso del mio viglietto dellaltro di? Lo serissi, vassicuro,
‘senza la minima malevolenza, e col solo scopo di trarvi a pit
serii soggetti di ragionamento. Se lo scrivere vi fa male, mar
datemi soltanto nuove esatte della vostra salute: io vi scrive~
19 ogni giorno qualcosetta per distrarvi, e perché vi sovvenga
che vi voglio bene.
‘Non mi sarei mai aspettato la lettera ch’el mi rispose. Co-
rminciava eos: - Ti disdico Tamicizia; (mezza riga cancellata)
se non gai che fare della mia, (2) io non so che fare della tua,
Non sono uomo che perdoni offese, non sono uome che, riget-
tato una volta, ritorni, Perché mi sai infermo, ti riaccosti ipo-
critamente a me, sperando che la malattia indebolisca il mio
spirito, e mi tragga ad ascoltare le tue prediche... E andava
innanzi di questo modo, vituperandomi con violenza, scher-
nendomi, ponendo in carieatura tutto eid chiio gli avea detto
direligione e di morale, protestando di vivere e di morire sem-
prelo stesso, (?) cio’ col pid grand'odio e col pit gran disprez-
420 contro tutte Ie flosofie diverse dalla sua,
Restai (?) sbalordito!
= Le belle conversioni ch'io fot dicev‘io con dolore ed inorri-
dendo, - Dio me testimonio se le mie intenzioni non erano
‘pure! - No, queste ingiurie non le ho meritate! - Ebene, pa-
zienza; é un disinganno di piu. Tal sia di colui, se simmagina
offese, per aver la volutta di non perdonarle! Pit di quel che
ho fatto non sono obbligato di fare.
‘Tuttavia, dopo aleuni giorni, il mio sdegmno si mitigd, e pen-
sai che una lettera frenetica poteva essere stato frutto dun
esaltamento non durevole, - Forse ei git se ne vergogna, dice-
‘vaio, ma 8 troppo altero da confessare il suo torto. Non sareb-
be opera generosa, or ch'egli ha avuto tempo di ealmarsi, lo
scrivergli ancora?
‘Mi costava assai far tanto sacrificio d'amor proprio, ma lo
foci, Chi s'umilia senza bassi fini, non si degrada, qualunque
ingiusto spregio gliene torni.
‘Ebbi per risposta una lettera meno violenta, ma non meno
insultante, Limplacato mi diceva ch'egli ammirava la mia
‘evangelica moderazione.
= Or dungue ripigliamo pure, proseguiva egli, la nostra
corrispondenza; ma parliamo chiaro. Noi non ci amiamo. Ci
scriveremo per trastullare ciascuno se stesso, mettendo sulla
carta liberamente tutto cid che ei viene in capo: voi le vostre
‘immaginazioni serafiche ed io le mie bestemmie; voile vostre
estasi sulla dignita dell'uomo e della donna, io Fingenuo rac-
conto delle mie profanazioni; sperando io di convertir voi, e
voi di convertir me, Rispandetemi, se vi piaccia il patto.
Risposi:- Il vostro non ® un patio, ma uno scherno. Abbon-
dai in buon volere con voi. La coscienza non mi obbliga pit’ ad
altro, che ad augurarvi tutte le felicita per questa e per 'altra
vita,
Cos! fini Ja mia clandestina relazione con quell'womo - chi
sa? - forse pit inasprito dalla sventura e delirante per dispe-
razione, che malvagio.
CAPO 42
Benedissi un‘altra volta davvero la solitudine, ed i miei
«giorni passarono di nuovo per alcun tempo senza vicende.
Fin} la state; nell'ultima meta di settembre, il caldo sce-
maya, Ottobre venne; io m’sllegrava allora d’avere una stan-
za che nel verno doveva esser buona. Eeco una mattina il cu-
stode che mi dice, avere ordine di mutarmi di carcere.
= E dove si va?
A pochi passi, in una camera pitt fresca,
~E perché non pensarei quand’io moriva del ealdo ¢ Varia
era tutta zenzare ed il letto era tutto cimiei?
~Ieomando non @ venuto prima
- Pazienza, andiamo,
Bench'io avessi * assai * patito in quel earcere, mi dolse di
lasciarlo; non soltanto perché nella fredda stagione doveva
essere ottimo, ma per tanti perché, fo Vavea quelle (2) formi.
che, ch'io amava e nutriva con sollecitudine, se non fosve
espressione ridicola,direi quasi paterna. Da pochi giorni, quel
{aro ragno di cui perlai, era, non so per qual motivo, emigra-
‘0; ma io diceva: - Chi sa che non si ricordi di me e non vitor,
ni? Bd or che me ne vado, ritornera forse e trovera la prigio.
ne vota, o se vi sara quaich’aliro ospite, potrebb'essere un
‘nemico de’ ragni, e raschiar git colla pantoffola quella bella
tela, e schiacciare la povera bestia! Inoltre quella trista rit
stone non mera stata abbellita dalla pieta della Zanze? A.
Quella finestra s‘appoggiava si spesso, ¢ lasciava cadere go-
nerosamente i briecioli de’ buzzolai alle mie formiche. Li so.
ea sedere; qui mi fece il tal raconto; qui il tal altro lA sin.
chinava stl mio tavolino e le sue lagrime vi grondarono!
Tluogo ove mi posero era pur sotto i Piombi, ma a traimon-
tana e ponente, con due finestre, una di qua Taltra di la; cog.
siomo di perpetui raffreddori, ¢ d'orribile ghiaueio ne" inesi
rigid.
La finestra a ponente era grandissima; quella. tramonta-
na era piceola ed alta, al di sopra del mio letto,
‘Maffacciai prima a quella, e vidi che metteva verso il pa-
lazzo del patriarca. Altre prigioni erano presso la mia, in un'ala
i poca estensione a destra, ed in uno sporgimerto ili fabri.
ato, che mi stava dirimpetto. In quello sporgimento stavano
due carceri, una sull'altra, La inferiore aveva un finestrone
enorme, pel quale io vedea dentro passeggiare 1m uomo si.
gnorilmente vestito. Bra il sig. Caporali di Cesena. Questi ini
vide, mi fece qualche segno, e ei dicemmo i nostr! nomi,
Volli quindi esaminare dove guardasse Valtra mia finestra,
Posi il tavolino ul letto e sul tavolino una sedia, m'arrampi.
cai sopra, e vidi (che) essere a livello d'una parte del tetto del
Palazzo, Aldi la del palazzo appariva un bel tratto della citta
e della laguna,
Mi fermai a considerare quella bella veduta, eudendo che
S‘apriva la porta, non mi mossi. Era il custode, ilquale scor.
gendomi lassi. arrampicato, dimentied ch’io non poteva pass
Sare come tn sorcio attraverso le sbarre, pensd clio tentassi
i faggire, ¢ nel rapido istante de] suo turbamento saltd sul
letto, ad onta d'una sciatica che lo tormentava, ¢ malferr®
per le gambe, gridando come un’aquila
~ Ma non vedete, (2) gli dissi, o smemorato, che non si pud
fuggire per causa di queste sbarre? Non capite che sali, per
sola curiosita?
Vedo, sior, vedo, capisco, ma la oali git, le digo, la cali;
‘queste le son tentazion de seappar.
Emi convenne di scendere,e ridere.
CAPO 43
Alle finestre delle prigioni laterali, conobbi sei altri dete-
‘uti per cose politiche.
Ecco dunque che, mentre io mi disponeva ad una solitudi-
‘ne maggiore che in passato, io mi trovo in una specie di mon.
do.A principio m'increbbe, sia che illungo vivere ronito avesso
ia fatta alquanto insocievole Vindole mia, sia che il disp
cente esito della mia conoscenza con Giuliano mi rendesse
diffidente.
Nondimeno quel poco di conversazione che prezdemmo a
fare, parte a voce e parte a segni, parvemi in breve an benefi-
cio, se non come stimolo ad allegrezza, almeno come divaga.
‘mento, Della mia relazione con Gitliano non feei motto eon
aleuno, Ceravamo egli ed io dato parola d’onore, chil secre.
toresterebbe sepolto in noi. Se ne favello in queste carte, gli
® perché, sotto gli occhi di chiunque andassero, gli sarcbbe
‘impossible indovinare, chi, di tanti che giaceano in quelle
‘earceri, fosse Giuliano
229
Alle nuove mentovate conoscenze di concaptivi, s'aggiun-
‘se un’ altra che mi fu pure doleissima
Dalla finestra grande, io vedeva, oltre lo sporgimento di
carceri che mi stava in faceia, un estensione di tetti, ornata di
cammini, daltane, di campanil, di cupole, la quale andava a
erdersi colla prospettiva del mare e del cielo. Nella casa pit
‘vicina @ me, ch’era un'ala del patriareato, abitava una buona
famiglia, che acquistd diritti alla mia riconoscenza, mostram,
domi co’ suoi saluti la pieta ch'io le ispirava. Un saluto, una
Parola d'amore agl'infelici, @ una gran carital
Comincid colt da una finestra, ad alzare le sue manine
verso me un ragazzetto di nove o dieci anni, ¢ Tintesi gridare.
; Mamma, mamma, han posto qualeheduto lassi ne Piorn,
Di. O povero prigionero, chi sei?
= Io sono Silvio Pellico, risposi
Un altro ragazzo pit grandicello corse anch’ egli alla fine-
stra, e grido:
= Tu sei Silvio Pellico?
~8i, € voi, cari fanciulli?
~ Tomi chiamo Antonio S *amueli t,e mio fratello, Giusep-
pe.
Poi si voltava indietro, e diceva: - Che cos'altro debbo di-
mandargli ?
Ed una donna, che suppongo essere stata lor madre, e stax
‘ya mezzo nascosta, suggeriva parole gentili a que’ cari figiuoli,
‘ed essi le diceano, ed io ne li ringraziava colla piu viva ten.
Quelle conversasioni erano picsiola cosa, e non bisognava
abusare, per non far gridare il eustode, ma ogni giorno ripe.
tevansi con mia grande consolazione, all'alba, a mezzodi ea
sera. Quando accendevano il lume, quella donna chiudea la
finestra, i fanciulli gridavano: -*Buona notte, Silvio! ed ella,
fatta coraggiosa dalloscurita, ripeten con voce commossa:
“Buona notte, Silvio! eoraggio!”
Quando que’ fanciullifaceano colezione o merenda mi di-
ceano: - Oh se potessimo darti del nostro caffe e latte! Oh se
Potessimo darti de' nostri buzzolail 11 giorno che andrai in
iberta, sowvengati di venirci a vedere! Ti daremo de" buzcola
belli e caldi, e tanti baci!
CAPO 44
1 mese ottobre era la ricorrenza del pitt brutto de’ miei
anniversari. loera stato arrestata i 13 di esso mese, dell'an-
no antecedent. Pareechie tristi memorie mi ricorrevano inol.
‘re in quel mese. Due anni prima, in ottobre, s'era per funesto
‘accidente annegato nel Ticino un valentuomo ch'ia molto ono.
ava, Tre anni prima, in ottobre, sera involontariamente ue-
«iso con uno schioppo Odoardo Briche, giovinetto ch'io amava
‘quasi fosse stato mio figio, A’ tempi della mia prima gioven
‘3, in ottobre, un‘altra grave, (7) afllizione mvavea eolpito,
Bench'io non sia superstizioso, il rincontrarsi fatalmente
in quel mese ricordanze cosi infelici, mi rendea tristissimo,
Favellando dalla finestra con que’ fanciulli e co’ miei con-
mai del labbro cosa simile, ma qui
siamo nel sepolero, e ae enche tu ne uscissi, so che posso fi-
darmi di te
‘Quell onestissim'anima taceva,
= Perché non mi rispondi? gli diss.
Alfine prese a biasimarmi seriamente della violazione del
seereto. II suo rimprovero era giusto. Niuna amicizia, per
quanto intima ella sia, per quanto fortificata da virta, non
ho autorizzare a tal violazione.
‘Ma poiché questa miacolpa era avvenuta, Oroboni me ne
deriva un bene. Bgli aveaconosciuto Giuliano, e sapea parec-
chi tratti onorevoli della sua vita, Me li racconta, e dicea: -
Quell'uomo ha operato s: spesso da Cristiano, che non pud
portare il suo furore anti-religioso fino alla tomba. Speriamo,
speriamo cnsi! E tu bada, Silvio, a perdonargli di cuore i suoi
mal'umori, ¢ prega per lu!
Le sue parole m'eranosacre.
CAPO 64 (71)
(2) Le conversazioni é: eui parlo, quali con Oroboni, quali
con Schiller o altri, (2) occupavano tuttavia poea parte delle
mie lunghe ventiquattr’ore della giornata, e non rade erano
levolte, che niuna conversazione riusciva possibile col primo,
‘Che faceva io in (quella) tanta solitudine?
Ecco tutta quanta la mia vita in que’ giorni, [o malzava
sempre allalba, ¢, salito in capovdel tavolaccio, m’aggrappava,
alle share della finestra,e diceva le orazioni. Oroboni gia era
alla sua finestra o non tardava di venirvi. Ci salutavamo; e
Yuno e Paltro continuava ...pensieri) tacitamente i suoi pen-
sieri a Dio. Quanto erano orribli i nostri covili, altrettanto
‘era bello lo spettacolo estarno per noi. Quel cielo, quella cam-
agna, quel lontano mosersi di creature nella valle, quelle
‘vor! delle villanelle, quelle risa, que’ canti ei esilaravano, ci
faceano pi caramente sentire (?) la presenza di Colui ch’® si
‘magnifico nella sua bonta, e del quale avevamo tanto di biso-
no.
Veniva la visita mattutina delle Guardie. Queste davano
unvoechiata alla stanza per vedere se tutto era in ordine, ed
osservavano la mia catena, anello per anello,a fine d’assicu-
rarsi che qualche accidente o qualche malizia non V'avesse
spezzata; o piuttosto (dacché spezzar(la) la catena era impos-
sibile) (perché) faceasi questa ispezione () per obbedire fedel-
‘mente alle preserizioni di disciplina. S'era giorno che venisse
il medico, Schiller dimardava se si voleva parlargli, e pren-
dea nota.
Finito il giro delle nottre carceri, tornava Schiller ed ac-
compagneva Kunda, il quale aveva 'ufficio di pulire ciascuna
stanza,
‘Un breve intervallo, ¢ ci portavano la colezione. Questa
‘era un mezzo pentolino di broda rossiecia, con tre sottilissime
fettine di pane: io mangiava quel pane e non bevea la broda.
Dopo eid mi poneva « studiare. Maroncelli avea portato
@'ltalia molti libri, e tutti i nostri compagni ne aveano pure
portati, chi pi, chi mene. Tutto insieme formava tna buona
bibliotéchina. Speravamo inoltre di poterla aumentare, (?)
colluso de’ nostri denari. Non era ancor venuta aleuna rispo-
sta dell'Imperatore, sul permesso che dimandavamo di
(pot... eggere i nostri libri ed acquistarne altri; ma intanto il
governatore di Brinn ci concedeva provvisoriamente di tene-
re ciascun di noi due libri presso di se, da cangiarsi ogni volta
che volessimo.
(2) Verso le nove, ven'va il soprintendente, e se il medico
cera stato chiesto, oi Yaccompagnava.
(2) Un altro tratto di tempo restavami quindi pero studio,
fino alle undici, ch’era Tera del pranzo.
Fino al tramonto non avea pil visite, e tornava a studiare.
Allora Schiller e Kunda venivano per mutarmi V'acqua, ed un
istante appresso, veniva il soprintendente con alcune guat-
die, per 'ispeaione vespertina a tutia la stanza eda’ miei ferti
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Il Viaggio in Italia Di Enrico IIIDocument382 pagesIl Viaggio in Italia Di Enrico IIIAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Prediche Quaresimali Del Padre EmmanueleDocument499 pagesPrediche Quaresimali Del Padre EmmanueleAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Programma Brochure MODDocument2 pagesProgramma Brochure MODAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Introduzionestorica RisorgimentoDocument61 pagesIntroduzionestorica RisorgimentoAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Materiali MarinoDocument5 pagesMateriali MarinoAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Nomi Personaggi MandragolaDocument18 pagesNomi Personaggi MandragolaAngelo PagliardiniNo ratings yet
- Machiavelli e La Politica: PremessaDocument4 pagesMachiavelli e La Politica: PremessaAngelo PagliardiniNo ratings yet