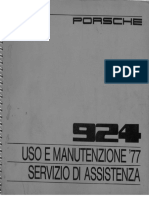Professional Documents
Culture Documents
Amtron UK112 - Reverberation Preamplifier
Amtron UK112 - Reverberation Preamplifier
Uploaded by
gabiprossi0 ratings0% found this document useful (0 votes)
14 views5 pagesOriginal Title
Amtron UK112 - Reverberation preamplifier
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
14 views5 pagesAmtron UK112 - Reverberation Preamplifier
Amtron UK112 - Reverberation Preamplifier
Uploaded by
gabiprossiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 5
UK 112
PREAMPLIFICATORE RIVERBERATORE
‘dalla rete con due tensioni «:
i: 117/125 eppure
220/240 V
Frequenza di alimentazione:
50 Hr
Ingresso audio:
Da trasduttore magnetico o piezo:
dletirico
1 mV per ingresso magnetico
200 mV eff, per ingresso piezo
Uscita a vuoto:
Banda passante a 6 di
per ingresso piezo da 70 Hz =
18 kHz per ingresso magnetico da
150 Hz = 18 kHz
‘Tempo di ritardo della linea: 25 ms.
Tempo di riverberazione: 18s.
Talvolta si rende necessario nell’effettua-
1 registrazioni ad alta fedelta ottenere
particolari effetti quali si avrebbero Ia-
vorando in ambienti dotati di particolari
caratteristiche acustiche. Non sempre
questo & possibile, e percid per ottenere
Teffetto desiderato bisogna ricorrere a
Allo seopo Ia Amtron ha studiato e mes-
so a punto un efficace apparecchio che
ottiene Meffetto deco con grande natu:
ralezza,
Esiste Ia possibilita di regolare le inten-
it del suono diretto € di quello river-
berato.
I sistema usato per ottenere T'effetto di
riverbero & quello che impicga una I
nea di ritardo a corda vibrante che &
sede di oscillazioni st
Particolari_accorgimenti
per rendere ill segnale di uscit
ppendente dal trasduttore di ingresso (ma-
{gnetico 0 piezoeletirico)..
Il riverberatore & stato reslizzato i
contenitore di legno scuro, con fron-
tale lineare in alluminio diamantato e
sanodizzato.
WeLIo — 1973
rediamo che il fenomeno del-
eco sia noto a tutti. Quando
si emette un grido davanti ad
uuna parete roceiosa, si sente prima il
grido. stesso trasmesso. direttamente ¢
quindi T'eco rriflesso dalla parete, dovu:
fo alle onde sonore che hanno viag-
siato nell'aria, hanno raggiunto Ia pare:
te, vi si sono riflesse, e sono ritornate,
piuttosto attenuate al nostro orecchio.
Il fenomeno & dovuto al fatto che le
onde sonore non si propagano nell’aria
a velocita infinita, ma ad una velocitt
finita che & di circa 300 m al secondo,
In teoria, considerando lo spessore d'aria
cche ci separa dalla parete come omo-
eneo, misurando ill tempo che intercor.
re tra il segnale e l'eco, si potrebbe de-
terminare con precisione la distanza del-
la parete roceiosa. Con tale sistema si
determina Ja distanza, per esempio, del
fondo marino, mediante l'ecoscandaglio,
che emette onde sonore e ne misura il
tempo impiegato per ritornare alla na:
ve. Il fenomeno avviene, sia pure a ve~
focita immensamente superiori anche con
Te onde clettromagnetiche, ed il feno-
mene & utilizzato, come si sa, nel radar.
ra torniamo all’eco. Se invece di una.
paret:, abbiamo varie pareti variamente
disposte, ed ad una distanza minore di
quanco ‘prima ammesso, avremo il fe-
nomen che si riscontra’ nei grandi ai
bient: chiusi, comunemente chiamato ri-
verbero, che non @ altro che un’eco mul
tipla che si ode dopo un tempo molto
breve dal suono primario. Sia nel caso
del’ez0, che nel caso del riverbero, che
nel caso del radar, il mezzo in cui si
propiga la vibrazione a velocita finita,
costituisce una linea di ritardo
Hl problema da risolvere per concen
trare in poco spazio quanto avviene in
tun grande spazio basandosi sulla trasmis:
sione diretta, consiste solamente nel tro.
vare sn mezzo di trasmissione del suo-
,entro il quale esso si propaghi molto
pitt lentamente che nell'aria,
Per risolvere il problema penso non
saranno inutili alcune conoscenze dia
ceustica applicata
La yelocita del suono in un mezzo
dipende da alcune caratteristiche del
mezzo stesso. Anche Vattenuazione che
il suono subisce dipende dalle caratieri
stiche del mezzo. Facendo un paragone
elettrico, una corrente alternata, anche
essa di natura ondulatoria, subisce lungo
una linea un’attenuazione dovuta alla re-
sistenza elettrica del materiale, ed un
ritardo di fase dovuto alle caratteristiche
reattive.
Tale ritardo & dovuto alla cosiddetta
velocitd di fase. Il fenomeno & noto a
chiungue si occupi di lince elettriche,
La velocita di fase della corrente elet
trica nei conduttori e net_componenti
reattivi concentrati & troppo elevata per
To scapo che ci interessa;,noi vogliamo
oitenere ritardi di frazioni di secondo,
965
r
}
Ricorreremo percid alle onde sonore che,
gia per la loro natura, si spostano con
Yyelocita molto minore. Tale velocita pe
FO & ancora molto forte e non tale da
permetterci di ottencre il risultato volu-
to nel poco spazio di cui disponiamo.
Bisognera quindi usare aleuni accor.
gimenti particolari per ottenere una li-
nea capace di provocare un forte ritardo
su_una lunghezza molto breve.
Nell’apparecchio che vi presentiamo,
troverete una molla d’acciaio molto
flessibile. Le considerazioni che svolge-
remo in seguito, tralasciando Je cono-
scenze generali della propagazione sono-
ra che ognuno pud facilmente procurarsi
Teggendo un qualsiasi testo di acustica,
saranno riferite a questa molla.
La propagazione del suono avyiene
prineipalmente per mezzo di due tipi di |
onde: le onde di pressione, che si for-
‘mano nelVaria e ci permettono di udir=
Ia nostra voce, ¢ le onde trasversali che
si propagano per esempio lungo una fu-
ne scossa ad un estremo.
Le onde trasversali si propagano mol-
to pit lentamente di quelle di pressione,
enon dipendono tanto dalle caratters
che del materiale quanto dalla costitu-
Zione geometrica del mezzo lineare che
le propaga (per esempio, la corda, 0 la
nostra. molla)
‘Mentre per la propagazione delle on:
de di pressione sono importanti la den-
sita e Telasticita, del mezzo dalle quali
le velocita (detta «yelocita di fase
«Us) esclusivamente dipende, 1a velo-
ita di fase delle vibrazioni trasversali
della corda tesa sara data dalla seguen-
te formula
u aie
dove + @ la tensione della corda ed m,
2 una particolare grandezza detta «massa _
Tineica della cordas, che dipende da
vari fattori di natura in gran parte spe.
rimentale, e dal peso della corda per
uunita di iunghezza
Jn sostanza la nostra molla si com.
porta come la corda di una chitarra, ¢
come la stessa diventa sede di oscillazio
ni stazionarie ma di frequenza estrema
mente basa. La frequenza delle onde
stazionarie e 1a velociti di propagazione
sono intimamente collegate, Come sia
bassa Ia frequenza delle onde staziona- |
rie nella Tinea di ritardo, si pud verifi
care pizzicando la molla ed osservando
ne le oscillazioni
Ripetiamo che la caratteristica di que
sto tipo di vibrazione dipende solo in
minima parte dal materiale con cui la
corda & fatta (si sa benissimo che una
corda per chitarre della medesima nota
ud essere sia di acciaio che di mate
iale organico). La molla, comportan
dosi come la corda di una chitarra, con-
tinuera a vibrare ad ogni eccitazione ri
mandando avanti e indietro gli echi suc
cessivamente attenuati da un'estremita
all'altsa, provocando quindi nel trasdut
tore di uscita lo stesso effetto di un ru
more 0 suono emesso in un locale di
ampie dimension, nel quale Varia so-
stituira la nostra linea di ritardo.
Fig, 1 « Schema elettrico.
966 3 LUGLIO — 1973,
U tempo di durata di questa ripet
ne di echi fintanto che la loro intensita
fon & pitt avvertibile, si chiama tempo
di riverbero, ed & ovviamente superiore
al tempo di ritardo proprio della linea.
Come si vede dalla formula che prima
abbiamo dato, la frequenza di vibrazione
propria della corda, che a noi servira da
ritardo, crescera con la tensione della
molla, ¢ diminuird con la densita linea-
re della stessa, ossia col suo peso al cm.
Per diminuire il ritardo dobbiamo quin-
i allungare le molla per aumentare la
frequenza di vibrazione. In questo modo
‘avremo raggiunto contemporaneamente i
due scopi di aumentare la tensione © di
Giminuire la densith per uniti di Tun-
ghezza in quanto abbiamo aumentato la
distanza tra le spire
Nell'apparecchio che. presentiamo, 1a
lunghezza della molla é fissa, quindi i
tempo di ritardo & pure fisso, e caleo-
Tato’ in modo che possa produrre un ef-
fetto gradevole senza sdoppiamenti di
note dovute ad echi distint
Un altro effetto interessante del com-
portamento della corda yibrante, & che
questa trasmette molto bene anche la
forma dell’onda che & impiegata per ec-
citaela allestremita
Tornando alla corda tesa tra le meni
i due persone, questa trasmetier’ an-
che vibrazioni di frequenza differente
dalla frequenza propria della corda, ed
anche di forme complesse, ciod rieche di
armoniche. Al limite, usando le ben
note scatole di conserva del telefono a
spago dei bambini, la corda trasmettera
anche le modulazioni, della voce del
bambino trasmittente, ‘che giungeranno
Fitardate ma fedeli al bambino riceven-
te, La ragione per cui non si pud dimi-
nuire troppo la tensione della corda &
che questa deve lavorare comungue in
regime elastico, in quanto non & vero
che la voce arriva per trasmissione
stica ello. spago come si legge in al
cuni testi approssimativ
‘Abbiamo parlato finora in modo al
quanto succinto del principio acustico
che permette di ottenere il nostro scopo.
Ma isulta intuitivo che ei sono. altri
problemi da risolvere. Prima di tutto co-
Ime faremo a far vibrare questa nosira
mollacorda di chitarra, senza far uso
delie dita?
E? evidente, piazzeremo ai suoi estre
mi l'equivalente elettrico delle scatole di
conserva sopra nominate, Ossia un tra-
Sduttore per ogni estremita. Il compito
del trasduttore & quello di trasformare
tun segnale elettrico di forma qualsiasi
in un movimento meccanico di forma si-
nile il pit possibile @ quello elettrico, ©
viceversa
La capacita def trasduttore di trasfor-
mare grandezze meccaniche in elettriche
e viceversa, modificandone il meno pos-
sibile Ta vatiazione nel tempo, si chiama
fedelta, e questo costituisce il pitt gros
s0 problema dei costruttori di tall ag
geagi. Bisozna curare al massimo che le
frequenze proprie di risonanza di cia-
seun elemento mobile meccanico e di
ciascun elemento elettrico, si trovino ben
LUGLIO — 1973
Fig. 2 » Serigrafia del circuito stampato.
lontane dalla banda di frequenze che il
trasduttore deve trasformare,
I trasduttori presenti alle estremita
della nostra molla rispondono bene a
‘queste caratteristiche, e ne spiegheremo
in breve la costituzione.
‘TRASDUTTORE DI INGRESSO
© TRASMITTENTE
Un nucleo laminato aperto di for
particolare & eccitato da un avvolgi
mento che lo magnetizza in maniera
proporzionale al segnale elettrico di in-
‘gresso. Tale campo magnetico variabi
Ie provoca il movimento di un'ancoretta
in materiale ferromagnetico collegata ri-
sidamente alla molla, ed invece in ma-
niera molto labile al telaio.
Per la parte ricevente il processo & in
verso, ma il trasduttore & uguale,
CIRCUITO ELETTRICO (Fig. 1)
IL segnale proveniente dal microfono
o dal pick-up o da gualsas| altro le
vatore acustico, viene applicato all’
gresso di un preamplificatore formato
dal transistore TR1, che svolge due com:
piti: Pilota uno stadio di potenza in
controfase che servirk a comandare il
trasduttore d'ingresso della linea di ri-
tardo, e contemporaneamente manda u-
nna parte del segnale amplificato verso
Jo stadio mescolatore amplificatore di
uscita formato dal transistore TRS. La
alimentazione & stabilizzata,
Passiamo ora a descrivere il circuito
nei suoi particolari
Liingresso avviene attraverso te due
prese per ingresso magnetico © piezo-
elettrico, a due diverse impedenze. In-
fatti, Pingresso magnetico avviene diret
tamente sulla base del transistore ossia
a bassa impedenza, mentre il trasduttore,
piezoelettrico che, come & noto, presenta
‘una elevata impedenza, entra attraverso
le elevate resistenze R5 ed R10 che, insie
me a C5 costituiscono un filtro ‘pass
basso che attenua le frequenze troppo
alte
I segnale d'ingresso, perzializzato da
R15 che funziona da regolatore di vo:
‘TRI montato in emettitore comune in
classe A, R20, R25, R30 costituiscono
a rete di polarizzazione e di stabilizza-
zione termica in corrente continua. Il re-
sistore di emettitore bypassato da una
forte capaciti per presentare una bassa
impedenza in corrente alternata
Il carico di collettore & costituito, per
a corrente alternata dall'avvolgimento
primario di T1, ¢ alimentato attraverso
una cellula di ‘filtro costituito da R35
e da C10. Una parte del segnale di u-
scita viene prelevato al collettore ed in-
viato, attraverso C25 ed R55 al punto
in cui avverra Ia miscelazione con il se
gnale riverberato,
Il trasformatore TI, oltre ad abbassare
Vimpedenza per adattarla agli ingressi
di TR2 e TRS, & fornito di una presa
centrale. Tra questa presa e le estremi-
{8 dell'ayvolgimento troviamo due segna-
i analoghi ma in opposizione di fase,
adatti a pilotare il gruppo in controfa-
se formato da TR2 e TRS, R40, R45, R50
costituiscono a rete di polarizzazione e
di stabilizzazione. La presenza d'una po-
fatizzazione non’ sarebbe necessaria in
uno stadio in classe B.
‘Ma l'amplificatore in classe B presen-
fa pure una forma di distorsione detta
di crossover», dovuta all'applicazione di
parte del segnale d'ingresso in una z0-
hha non lineare della caratteristica d'n-
gresso. Tale inconveniente si elimina ap-
plicando una piccola polarizzazione ai
transistori montati in controfase.
Tale polarizzazione vale anche per la
corrente alternata, infatti R50 e priva
di condensatore di bypass. Tale accorgi-
mento sposta il punto di funzionamento
su una parte pitt lineare delle carat
stiche d’ingresso. Allyscita dell'amplifi-
catore controfase si trova un altro tra
sformatore (T2) che costituisce il ce
rico di utilizzazione.
La bassa polarizzazione di base per-
mette che solo Ia resistenza ohmica del:
Vayvolgimento possa costituire il carico
in corrente continua. L'avvolgimento se-
condario di T2 che costituisce anche
dattamento dimpedenza, ® direttamente
accoppiato all’eccitatore’ del trasduttore
dentrata della linea di ritardo,
907
All'uscita della linea di ritardo, me-
diante un cavo schermato, si fa arrivare
parzializzatore, R60. Il cursore
potenziometro manda il segnale riverbe-
ae
iretto, ossia al polo posit
condensaiore C30, Riepilogando si pos-
metri RIS ed R60
comandi, sia Yampiezza del segnale di-
Feito che quella del segnale ritardato.
iscelati_ vengono man-
dati alla base del transistore TR4 che
funziona in emeltitore comune a bassa
pedenza di entrata per le tensioni al-
ternate. La rete di polarizzazione e di
stabilizzazione termica in corrente con-
tinua & del tipo classico, formata dai
resistori R70 R75, R85. La resistenza di
emettitore & bypassata dal_condensato-
re C35 e quindi non c’® praticamente
controreazione. L'uscita viene prelevata
sul resistore R80 di collettore, e passa
alfuscita attraverso il condensatore di
accoppiamento C40 ed al filtro con
tore formato da C45 e da R9O che ta
eggermente i toni bassi, con effetto anti
Lialimentazione dell‘intero sistema &
stabilizzata elettronicamente,
Araverso la spina di rete con con-
nettore di massa, si passa al trasforma-
tore principale ‘alimentazione,
terponendo il fusibile di protezione
O41. A e Vinterruttore principale INT 1.
Tl primario del trasformatore @ a due
ayvolgimenti ¢ pud funzionare alle. ten-
sioni da 117 a 125 V collegando gli av-
yolgimenti (uguali) in parallelo, Colle-
gando gli avvolgimenti in serie, si ottie
ne il funzionamento a 220-240 V. I
compito di variare il collegamento &
svolto dal deviatore doppio INT. 2.
La tensione di uscita del trasformato-
re, a 12,7 V corrente altemata, viene
raddrizzata dal ponte di Graetz, monofa-
se RP. Lluscita raddrizzata subisce un
primo livellamento mediante C60, ¢ vie-
ne quindi applicata attraverso il resisto-
re R100 di limitazione al collettore di
TRS che funziona da stabilizzaiore di
potenza.
Il gruppo formato dal diodo Zener
ZI e dal resistore R95 forma la tensio-
ne di riferimento che comanda la base
di TRS. Il condensatore C55 livella la
tensione di di conseguen-
za Ia tensione stabi
‘moltiplicato, All'uscita della tensione sta-
lizzata troviamo un altro condensatore
di livellamento ad alta capacita C50. La
Fig. 3 - Vista interna dell'UK 112 @ montaggio ultimato.
ENP, avremo il postive dellalimentazio.
ne amass.
IL guadagno complessivo del pream-
plificatore sara di circa 36 4B di tensione
per entrata da trasduttore magnetico,
mentre per T'ingresso_ piezoelettri
ca 2,7 dB.
Tale termine attenuazione non deve
trarre in inganno, in quanto si riferi
soltanto alla tensione mentre, come si
sain un amplificatore a transistoria-
‘yremo un guadagno in corrente, per c
Ja potenza all'uscita sari comunque su-
eriore a quella presente allentrata.
Vale Ja pena di dire qualche parola
sul modo di ealcolare i guadagni in de-
cibels. I nome deriva dal noto fisico
AG. Bell che era in definitiva uno stu-
dioso di acustica. Quindi, siccome Van-
damento della sensibiliti dell’orecchio &
di tipo logaritmico, noi percepiremo un
aumento lineare dellintensita sonora,
‘mentre il valore assoluto di questa au:
mentera con curva logaritmica (questa
& per esempio Ia ragione per cui i po-
tenziometri di regolazione del volume
sono a legge logaritmica).
LUGLIO — 1973,
Tornando ai nostri rapporti tra en
trata ed uscita di un amplificstore, il
nostro, se alimentato con trasduttore ma-
gnctico, ricevera all’entrata una tensione
di 1 mV, mentre alluscita troveremo u
na tensione di 64 mV quindi Pampli-
ficazione di tensione sara di:
v.68
—=—=6
vot
La formula per trasformare
questo
rapporto di tensioni in dB & Ia se
guente:
v. vi
— 4B = 20 tog —
vi v.
= 20 log 65 = 36,258
Nel caso di entrata piezo il rapporto
delle tensioni sara di 0,525 quindi rifa
endo il medesimo.calcolo avremo. un
guzdagno di —9,762 ossia un’attenua-
zione
Il nostro riverberatore {unziona quin-
i anche da adattatore 'impedenza in
quanto fornisce alluscita caratteristiche
indipendenti dal livello di entrata
MECCANICA
Lraspetto estetico generale dell'appa:
recchio che vogliamo costruire, &
nea con i criteri modernament
ti per la presentazione delle apparecchia-
ture di alta fedelta, 11 mobile in legno
di forte spessore, il quadro Jineare, i
comandi razionali con potenziometri a
cursore, fanno in modo che TUK 112
ossa trovare Ia sua giusta sistemazione
accanto alle apparecchiature gia da voi
possedute. All'interno del mobile in le
go e da questo completamente sfilabi
Ie, c’ un robusto telaio in acciaio zin
ato che sostiene tutti i componenti ed
il circuito stampato. La parte di ingres
so del segnale. molto sensibile ai di
sturbi induttivi, & adeguatamente scher-
mata, Gli attacchi per i segnali sono di
tipo normalizzato anche nei collegamen:
4i, quindi la sua inserzione nella catena
di alta fedelta non presenta problemi di
La maggior parte dei componenti
sistemata sul circuito stampato, ma il
collegamento dei componenti ‘che su
‘questo non sono montati, non presenta
difficolt, in quanto la lunghezza dei col
legamenti in cavo 2 ridotta al minimo, ¢
comunque chiaramente mostrata in una
apposita tavola allegata alle istruzioni di
montaggio.
Lieleganie pannello anteriore in all
minio anodizzato porta serigrafate tut
te le indicazioni per i comandi del ri
verberatore, e la spia indicatrice dell'av
venuta accensione dell'apparecchio. La
alimentazione avviene dalla rete eletirica
& mezzo di cordone con presa di terra
MONTAGGIO
II montaggio di questo apparecchio &
semplificato. dalle istruzion’ riportate
nell'opuscolo allegato al kit,
LUGLIO — 1973
proteggete la vostra
automobile
con Il’allarme
capacitivo
Cans
unau
cane
TTD
LU) Grécle}
Cro ry Cree ee ey
ccc
ee Reece)
Se ee ee at
stato progettato per consen:
tire Ia facile sostituzione dei veechi grup-
pi VHF-UHF, a comando meccanico, or
mai_praticamente irreperibili, impiegati
i televisori a valvole.
Unito ad un gruppo varicap VHF-UHF
che viene fornito a richiesta, esso. con
sente di modernizzare gli apparecchi TV
UK 955
969
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Grundig Pa2 Pa3 SMDocument98 pagesGrundig Pa2 Pa3 SMgabiprossiNo ratings yet
- Grundig TK 46 TK 47 Service Manual PDFDocument33 pagesGrundig TK 46 TK 47 Service Manual PDFgabiprossiNo ratings yet
- Grundig TK 47 Owners ManualDocument26 pagesGrundig TK 47 Owners ManualgabiprossiNo ratings yet
- Skoda Service Bulletin 1980 - 1 PDFDocument16 pagesSkoda Service Bulletin 1980 - 1 PDFgabiprossi100% (1)
- Vascocuplajul MasiniiDocument5 pagesVascocuplajul MasiniigabiprossiNo ratings yet
- Skoda Service Bulletin 1980 - 1Document16 pagesSkoda Service Bulletin 1980 - 1gabiprossiNo ratings yet
- Hfe Pioneer Sa-301 Service PDFDocument18 pagesHfe Pioneer Sa-301 Service PDFgabiprossiNo ratings yet
- LOEWE - DocumentDocument64 pagesLOEWE - DocumentgabiprossiNo ratings yet
- Hfe Philips rh590 Service en de FR PDFDocument9 pagesHfe Philips rh590 Service en de FR PDFgabiprossiNo ratings yet
- Hfe Dual Hifi Speaker Systems Catalog en de FR Es PDFDocument12 pagesHfe Dual Hifi Speaker Systems Catalog en de FR Es PDFgabiprossiNo ratings yet
- Hfe Dual CV 1460 Schematic PDFDocument1 pageHfe Dual CV 1460 Schematic PDFgabiprossiNo ratings yet
- Hfe Grundig Tape Recorders Autumn Winter 1969 en PDFDocument9 pagesHfe Grundig Tape Recorders Autumn Winter 1969 en PDFgabiprossiNo ratings yet
- Grundig+HF 550 MSDocument27 pagesGrundig+HF 550 MSgabiprossiNo ratings yet
- Technics sh-8030 PDFDocument21 pagesTechnics sh-8030 PDFgabiprossi100% (1)
- Hfe Dual 75th Anniversary 1975-76 enDocument67 pagesHfe Dual 75th Anniversary 1975-76 engabiprossiNo ratings yet
- Dual HS 135 Service Manual PDFDocument10 pagesDual HS 135 Service Manual PDFgabiprossiNo ratings yet
- Amtron UK112 - Preamplificatore - RiverberatoreDocument16 pagesAmtron UK112 - Preamplificatore - RiverberatoregabiprossiNo ratings yet
- Hfe Blaupunkt A-5300 Service en de PDFDocument7 pagesHfe Blaupunkt A-5300 Service en de PDFgabiprossiNo ratings yet
- Akai Av-M313lDocument46 pagesAkai Av-M313lgabiprossiNo ratings yet
- Home HTTPD Data Media-Data B FX2000 P0A3P OI EN ES FRDocument14 pagesHome HTTPD Data Media-Data B FX2000 P0A3P OI EN ES FRgabiprossiNo ratings yet
- Troubleshooting Guide: CD Stereo SystemDocument8 pagesTroubleshooting Guide: CD Stereo SystemgabiprossiNo ratings yet
- Realistic Stereo Frequency Equalizer 31-9081 SCH PDFDocument1 pageRealistic Stereo Frequency Equalizer 31-9081 SCH PDFgabiprossiNo ratings yet
- Porsche 924 1977 User Manual PDFDocument62 pagesPorsche 924 1977 User Manual PDFgabiprossi0% (1)
- Teleton SAQ 408 SchematicsDocument2 pagesTeleton SAQ 408 SchematicsgabiprossiNo ratings yet
- Lancia - Fulvia - 1966 Workshop ManualDocument56 pagesLancia - Fulvia - 1966 Workshop ManualgabiprossiNo ratings yet
- Lancia Flaminia 1960 Workshop ManualDocument51 pagesLancia Flaminia 1960 Workshop Manualgabiprossi100% (1)
- Microcassette System: DH 2028 Portable Digital Dictation DeviceDocument3 pagesMicrocassette System: DH 2028 Portable Digital Dictation DevicegabiprossiNo ratings yet